chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Andrea Olivo
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
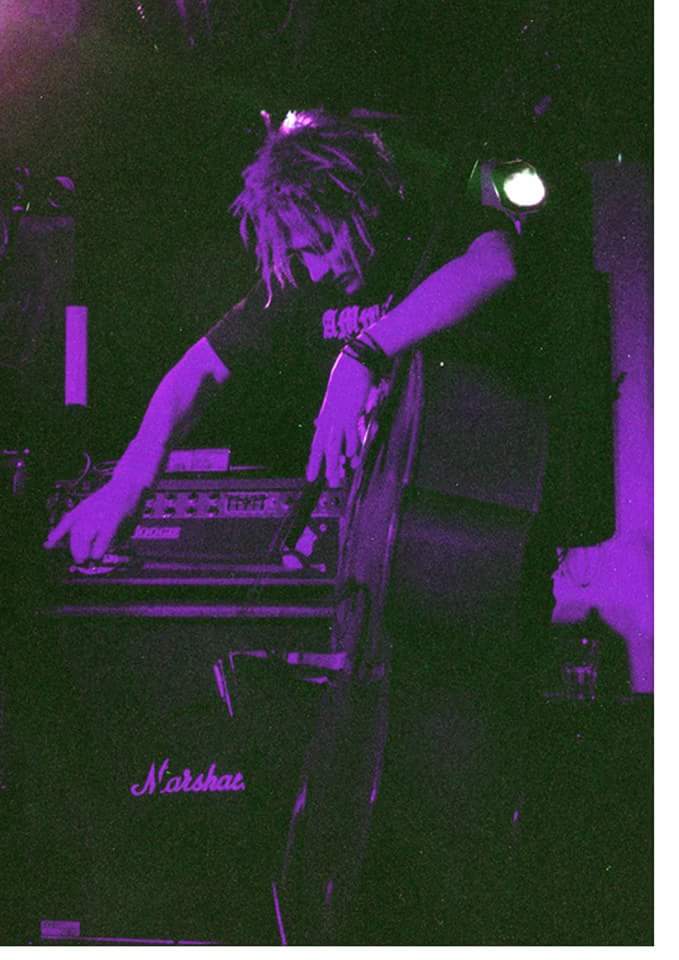
*
L’eredità
L’EREDITA’
Nella stanza cadeva una bava di luce e allungata come un’ombra nel letto giaceva la contessa Lodovica Rabbia Trincavelli, che, a dispetto di ogni buonsenso, aveva continuato a fare scialo della ricchezza, come della vita.
Ritto in mezzo alla stanza stava il medico. Si schiarì la voce e poi parlò; ad ascoltarlo le nipoti della contessa, il suo alano Hugo, e la nuova cuoca insieme al figlio, un bambino di nome Osvaldo.
Non appena il medico ebbe finito di raccomandare aria fresca e medicine, s’aprì la porta; e l’ultimo cameriere in servizio introdusse il notaio, un uomo atticciato e ansante, che a passo spedito si avvicinò al letto della contessa; e provando a fissare quegli occhi di cemento, con il cappello in mano gettò una supplica come carne a un lupo:
– Contessa, ormai non le è rimasta che questa villa, qualche gioiello e il suo violino. Per l’amor del cielo la smetta di giocare o perderà tutto.
– E le pare poco? Solo il mio violino vale quanto un castello, e poi ciò che perdo mi appartiene. Giusto, care?
Le due nipoti annuirono con vigore, guardando quel viso di pergamena con la bocca aperta.
E se in gioventù era stata giudicata un miracolo di bellezza, grazia, e un eccellente violinista, era nell’età anziana ch’era emersa una personalità viziata, armata di una sottile crudeltà; aspetto che si era andato affilando negli anni, tanto da meritarsi l’epiteto di Trinca Rabbia.
Da quando il medico si era espresso la prima volta, dandole ancora pochi giorni di vita, erano passati mesi; durante i quali le nipoti avevano bandito una gara ad assecondare ogni suo capriccio. Ed era con celata soddisfazione che contemplava gli sforzi in cui le due donne si lanciavano nell’adularla e covarla di attenzioni; e avendone ormai il polso, dosava con malizia le richieste, per prolungare quel suo ultimo divertimento. Quando le dolevano i piedi, alzava una mano sibilando un “ah” perpetuo e immobile nel tono; se era un braccio a darle noia, alzava un piede creando una piccola montagna di lenzuola in fondo al letto, dando il via a una litania di singulti, cui rispondevano cori di celestiali Oh Signore, povera donna, che tradotti erano Povere noi, quanto durerà questo strazio? Ma la paura di essere diseredate era una frusta che schioccava obbedienza.
Il notaio era stato chiaro a riguardo: “Quando sarà il momento, la contessa scriverà il nome di quella che tra di voi l’avrà meglio soddisfatta.” E con questo capestro, la Trinca Rabbia si faceva accompagnare al casinò, quasi ogni sera, senza che l’una sapesse niente dell’altra; poiché a entrambe, a sere alterne, allungava la minestra con del sonnifero. Così, mentre una nipote strizzava l’occhio all’eredità, l’altra dormiva con lo stesso sentimento nascosto sotto il cuscino.
La Trinca Rabbia aveva ben compreso da quale interesse fossero mosse le nipoti. Appena arrivate alla villa, le due giovani si erano precipitate dal sarto: “Ancora più gonfio quel guardinfante, avanti, dobbiamo distinguerci noi, non badi a spese, paga la contessa.” Avevano ottenuto gonne talmente larghe da non passare più dalle porte.
Ma con il correre del tempo, mentre la Trinca Rabbia pareva risorgere a nuova giovinezza, i visi delle due donne sembravano armi spuntate dalla guerra; e persino il medico non riuscì a comprendere il segreto di quella donna, che sembrava aver detto alla morte: “Se esce testa vinco io, se esce croce perdi tu.”
Svegliatosi a mezzanotte, per i morsi della fame, Osvaldo si era diretto in cucina, luogo a lui proibito, se non di giorno, e al seguito della madre. Quando sentì le ruote della carrozzina calcare la ghiaia sul vialetto, e prima che la porta strepitasse sui cardini, si fiondò dietro la tenda e sbirciando vide una delle nipoti spingere la carrozzina, cercando di ricondurre alla ragione la contessa.
Poi le voci si allungarono nel corridoio.
– Mi era parso di essere stata chiara, decido io cosa farne del mio patrimonio. E poi voi non siete qui per quello, vero?
– Certo che no…è solo che…sarebbe un peccato perdere tutto. Lo dico nel vostro interesse, zia.
– Il mio interesse è affar mio. Maledetto zero, se solo fosse uscito. Che sfortuna!
Osvaldo stava per sgusciare fuori, quando Clotilde rientrò. Gettò gli occhi di là dalla tenda e la vide nascondere delle posate d’oro dietro una credenza. La nipote si guardò alle spalle come una ladra. Incrociò lo sguardo del bambino, e in due passi lo raggiunse.
– Che ci fai lì nascosto? Guarda che… - disse tra i denti mimando il gesto di uno schiaffo.
Ma Osvaldo, per niente intimorito e forte di quello che aveva visto, le fece capire, con gli occhi pieni di furbizia, che la carrozzina l’avrebbe raggiunta in pochi passi, e che la bocca l’avrebbe aperta non per far entrare le mosche, ma per far uscire il suo segreto. Quando Clotilde comprese di essere nelle mani di quel moccioso, gli chiese cosa volesse.
– Una forchetta d’oro, - bisbigliò Osvaldo.
– E che te ne fai?
– Affari miei.
– D’accordo, domani però.
– No, no, io la voglio adesso, - rispose mostrando il palmo della mano.
– E va bene.
A Osvaldo piacevano i pirati; e soprattutto amava costruire navi improvvisate con la fantasia dei bambini. Di tutte le imbarcazioni che aveva costruito, quella con la bandiera rossa era la migliore. Sosteneva che potesse anche volare. Gli mancava, però, oltre a un nome, qualcosa che le desse una certa personalità, soprattutto a prua.
L’indomani s’aprì con un concerto di mugugni soprani e lamenti baritonali, che la Trinca Rabbia inscenava ogni mattina per sfinire le nipoti. Poi, con una voce rauca e forte a dimenarsi in quel collo lungo e avaro, ordinò che le fosse portato il suo Maréchal Berthier e una coppa di champagne.
Osvaldo, che si trovava a passare di lì, attaccato alla gonna della madre, capì di aver scovato il nome per il suo veliero, e ripeté scandendo bene: “Ma-ré-chal Berthier.” Mollata la presa, corse per il corridoio, corse giù dalle scale, corse attraverso il giardino, e con Hugo che lo seguiva festante, entrò nel capanno degli attrezzi ormai abbandonato. Da sotto il banco prese la scatola di legno, e con il solo alano a far da testimone, la nominò: Maréchal Berthier.
Sebbene non lo potesse più suonare, a causa dell’artrite, la contessa riusciva ancora a impugnarne l’archetto; e ogni mattina lo voleva toccare e udire: due colpi d’arco sulle corde vuote, come la sua vita. Poi lo puliva dalla pece e lo chiudeva a chiave nella teca. Chiave che lei stessa custodiva intorno al collo e da cui non si separava mai.
La Trinca Rabbia passava le ore ad ammirarne la fiammatura, a perdersi nel profumo del legno che riapriva le porte dei teatri, dei balli di primavera, degli amanti e dei mariti cui era sopravvissuta fino a quel giorno. Era in quei momenti, e in quelli soltanto, che un sorriso le attraversava il grigio degli occhi, come un lampo.
Per le due nipoti, invece, quello era solo un oggetto di venale interesse, che da lì a breve la Trinca Rabbia avrebbe perso al gioco.
Dedicata la mattina al rituale del violino, celebrato con champagne o chianti, secondo il tempo, la Trinca Rabbia trascorreva i pomeriggi di novembre a fumare Vésuviennes sulla terrazza, contemplando l’immenso giardino: al centro c’era una fontana di marmo bianco, cinta da siepi e platani di un verde drammatico.
In uno di quei pomeriggi, in cui le nipoti l’avevano appena ricondotta al letto, chiese che i piedi le fossero puliti; calciò le coperte e mise in luce un’unghia nera come il nulla; poi domandò un altro cuscino.
Fu allora che scoppiò in una risata che partì bassa, dallo stomaco, e, attraversando il torace come a frantumarlo, sgorgò dalla gola sproporzionata, risuonando nei corridoi.
Clotilde, la più giovane delle due nipoti, si guardò le dita, tremule come foglie, e senza parlare afferrò un cuscino in fondo al letto, affondandovi le unghie, come a volerne strappare la trama; e con il volto accartocciato, si diresse con passi vicini verso la Trinca Rabbia. Ma Angelica, compreso il gesto estremo, anticipò la sorella, alzò con una mano la testa della vecchia contessa; sistemò un altro cuscino; e l’adagiò come un’urna.
Preso commiato, le due uscirono dalla stanza.
– Ma sei impazzita? Cos’è, non hai sentito il notaio? Se muore prima d’aver firmato, la villa e i beni rimasti, compreso quel maledetto violino, andranno…
– Lo so, lo so…ma sentila come ride di noi. E’ il demonio.
Le due sorelle si strinsero in un abbraccio e poi confessarono di essersi ingannate a vicenda. Poco dopo, davanti a un servizio di maiolica e due tazze di tè fumanti, decisero di rubare il violino, nasconderlo dove nessuno lo avrebbe cercato, e passare al ricatto.
Dopo cena, la Trinca Rabbia beveva sempre un bicchiere d’acqua calda allungata con l’Anesone triduo; le conciliava il sonno, diceva. Lì, finirono le due dosi di sonnifero.
Appoggiato il bicchiere sul comodino, la Trinca Rabbia cadde in un sonno pesante. Angelica le rubò la chiave, aprì la teca e consegnò il violino a Clotilde che l’andò a nascondere nel capanno degli attrezzi, mentre la sorella riponeva la chiave intorno al collo della contessa.
La mattina era arrivata tiepida di sole e Osvaldo, avvezzo a menar vita da pirata e a tendere arrembaggi alla schiena di Hugo, per poi trovar rifugio nelle aree più dimenticate della tenuta, aveva deciso che il galeone doveva essere finito entro la giornata, non solo perché era un bambino assai volitivo quando si trattava di giocare, ma soprattutto perché la madre lo aveva avvisato: quella sarebbe stata la loro ultima giornata alla villa.
A mezzogiorno il sole cadeva a picco sulla fontana, bianca da ferire gli occhi. Intorno al letto a baldacchino le nipoti osservavano la Trinca Rabbia: era buttata nel letto come uno straccio e un rivolo di saliva le scendeva all’angolo della bocca. Sembrava priva di vita. Le due giovani donne si tesero tutte in avanti. Angelica portò l’indice sotto il naso della contessa, per sentire se respirasse ancora. In quel momento aprì la bocca e parlò.
– Ho deciso. Andate a chiamare il notaio, ma prima vestitemi e portatemi sul terrazzo, e dite alla cuoca di preparare le mie omelette.
Le nipoti si scambiarono un’occhiata d’intesa e, allontanatesi dalla camera, cominciarono a parlare a fil di labbra.
– E ora il violino? – chiese Clotilde.
– Dopo, dopo, ora non c’è tempo. Corri dal notaio, presto, - rispose Angelica.
Clotilde si precipitò a chiamare il notaio; Angelica si occupò del resto.
Le omelette non arrivarono, ma dopo un’ora Clotilde tornò accompagnata dall’uomo che già impugnava il testamento e una penna. Le due ereditiere mordevano l’attesa della firma, quando la Trinca Rabbia chiese di vedere il suo violino e per la prima volta, con un gesto tra il sacro e il profano, si tolse la chiave dal collo e l’allungò verso le nipoti.
– Ma-ma certo, zia, - disse Angelica, battendo col tacco il piede della sorella – su, vai Clotilde, non hai sentito?
– Ah no, vacci tu, anche tu sai dov’è.
E nel dirlo restituì un calcetto alla sorella, che rispose con una spinta e dalla spinta a un pizzicotto e dal pizzicotto finirono ad attaccarsi per i capelli lanciando gridolini belligeranti come coltelli nell’aria.
– Silenzio! lasciatemi sola, basta! - intimò la Trinca Rabbia, - Fuori tutti! Guarderò il panorama con il mio binocolo, nell’attesa.
Dopo aver scrutato l’orizzonte, seguì il volo di un passero fare capolino sul bordo della fontana, dove Osvaldo, arrivato di corsa con Hugo a traino, giocava offrendole la schiena. Quando il bambino si voltò, alla Trinca Rabbia si drizzarono le gambe, il binocolo le cadde di mano, e lei si fece rigida d’un tratto.
Dalle acque caraibiche si alzò nel cielo e fu inondato dal sole: i raggi baluginavano sull’albero d’oro da cui spiovevano quattro stralli di seta e acciaio; un refolo gonfiò le vele fruscianti come carta, e il suo profilo iniziò a delinearsi: prima sbucò la ricciola prua, con quattro pirati d’ebano, e poi i fianchi con le f scroscianti d’acqua; finché la forma si rivelò nella voce fanciullina del capitano:
– Vola Maréchal Berthier, vola.
Quando la porta fu aperta, la stanza era avvolta dal silenzio come da un sudario. Le due nipoti, disperate per non aver trovato il violino, entrarono insieme al notaio come in un corteo funebre, trovando la contessa in un precoce rigor mortis.
Gli sguardi agghiacciati dei tre si spostarono dalla morta al giardino e da lì, veloci come lepri, all’erede dell’intera tenuta, che alzò una zampa per segnare la fontana come suo territorio; per poi scappar via con la lingua penzoloni, inseguito da un capitano e dal suo galeone, in una giornata piena di sole.
Id: 3507 Data: 24/03/2017 08:48:50
*
La nuvola
LA NUVOLA
C’era un grido che tutti temevano: Savoia.
Quel mattino, un soldato con un viso bianco quanto la luna e gli occhi verdi e disperati decise che non sarebbe morto per mano del nemico. A quel grido uscì dalla trincea, mirò come un fucile di là del pendio e cominciò a correre: pensando che se avesse raggiunto il fiume con il favore della nebbia, una possibilità di scampare a una morte sincera e generosa forse l’avrebbe avuta.
Il desiderio del ritorno a casa lo aveva tenuto sveglio tutta la notte: si era immaginato ad attenderlo il profumo del caffelatte preparato dalla madre e il crepitio del camino. Così le sue gambe prontissime avevano compiuto quel salto fuori dalla trincea, come se fossero nate solo per quello, e mentre correva tra fango e speranza, non fu raggiunto dal suo nome, urlato con forza da un commilitone “Giovanni, ma dove vai? Torna indietro…” ne dal cognome, sbraitato con ferocia dal Maggiore “Soldato Belmonte, figlio di un cane, le ordino di tornare a combattere”, ma da un proiettile.
Quando fu colpito sulla spalla dalla mano dell’amico Annunziato, Giovanni Belmonte si trovava davanti alla casa del piacere delle sorelle Spadafora, luogo che prometteva massima riservatezza, pulizia e discrezione, oltre a sconti per il giovanotto di primo pelo, qual era Giovanni: un ragazzo di appena vent’ anni, che nella vita si arrangiava come aiuto scarparu; lavoro in cui si dilettava, soprattutto se le scarpe da riparare erano delle donne del paese: ai piedi della Sila.
“Spicciati, Giuvà, lo vuoi suonare il campanello?”
“E mo lo suono, un attimo, pinsu ca…”
“Ma che devi pensare, stiamo ‘mbriachi e domani parti militare.”
“Fortunato te che sei zoppo.”
“E lo zoppo suonò,” disse Annunziato, prima di pigiare il campanello.
Aprì la maitresse, una donna vestita di nero, sulla quarantina, piccola, ma con un grande seno, e li fece accomodare in un salottino, caldo, con le tende di velluto rosso carminio.
“Annunziato, io di fare la guerra nu nd’ aju geniu.”
“Vedrai che durerà poco, come dicono.”
“Spaccami una gamba con un bastone, se sei amico, così non parto”, disse Giovanni Belmonte afferrando la mano di Annunziato.
“Ma che stai dicendo, Giuvà? Ora arriva una femmina con due minne così, che la guerra te la dimentichi,” e dicendolo Annunziato mimò con le mani le presunte rotondità.
Ma ad arrivare fu solo la maitresse, scuotendo il capo. Disse che le dispiaceva, ma le sue ragazze erano tutte impegnate, e c’era d’attendere, ma poiché di aspettare non era mai stato capace, Giovanni Belmonte non se lo fece ripetere due volte; si alzò, ringraziò, e uscì seguito da Annunziato che gli rimproverava l’impazienza: ricordandogli che era meglio se la togliesse la verginità, prima di indossare la divisa.
I due infilarono i portici, poco illuminati, dove tirava un vento di ferro che cavava fischi gelati come la cima della Sila. Giovanni Belmonte si sentì come una casa abbandonata, nella quale il vento aveva spinto un ospite indesiderato; con la fronte in avanti e il mento basso, lasciò cadere due parole.
“Ho paura.”
Annunziato non disse nulla, appoggiò il braccio sulla spalla dell’amico e lo trasse a sé, dandogli un bacio sulla testa.
Prima di partire Giovanni Belmonte era andato alla bottega. Si era svegliato che era ancora notte, si era vestito, ed era rimasto in piedi in corridoio come un’ombra a contemplare i genitori ancora addormentati nel letto. Decise di salutarli con un gesto senza suono. La madre non glielo avrebbe perdonato, ma per Giovanni Belmonte un suo abbraccio sarebbe stato ancora più doloroso. Così decise, e prese la porta.
Entrato, quasi fosse un ladro, si era seduto davanti al banco di lavoro mentre l’alba imbiancava i vetri. Afferrata la scarpa di donna Maria, la mise sul ginocchio, infilò il piede nel pedale, e impugnato il tira-suole, incise un piccolo cuore sul cuoio, quasi invisibile: come l’amore mai confessato a quella donna di molte primavere più avanti di lui. Rimase ancora un po’ con lo sguardo nel silenzio delle cose, come se potessero proteggerlo. E dopo aver pregato San Crispino, patrono di tutti gli scarpari, di uscir vivo dalla guerra, Giovanni Belmonte era salito sul primo treno in partenza.
Per il cambio era sceso alla stazione di Taranto, dove madri e fidanzate di giovani soldati si muovevano e parlavano come un unico corpo, un unico bacio, un unico pianto, un unico saluto. Giovanni Belmonte si calò il cappello sugli occhi, e sentendosi di colpo bambino, provò a non piangere.
I tre mesi di addestramento erano trascorsi in fretta. Giovanni Belmonte aveva scritto una lettera di scuse alla madre e all’amico Annunziato, sapendo che il padre, uomo brusco come l’aceto, non apprezzava i passi indietro.
A scrivere gli aveva insegnato padre Ceraudo, su insistenza della madre, quando Giovanni Belmonte, con la prima lanugine tra il naso e il labbro, una trincea tra il bambino e l’uomo, cominciava ad allenare le mani all’uso delle pinze sul cuoio; non avrebbe mai immaginato che avrebbe dovuto scrivere una lettera con la parola scusa a un parente o a un amico lontano; quando lontano da lui significava una camminata sui saliscendi del paesello o un fischio di apprezzamento lanciato dalla finestra alle caviglie delle femmine di passaggio, o un “Uè Giuvà, calati”; e perché mai gli sarebbe dovuto tornare utile, se il postino con la panza da pellicano mulinava le gambe su una bicicletta con la catena lenta e le ruote sgonfie, che anche i piccirilli riuscivano a sorpassare; e le lettere, se arrivavano, sapevano del suo alito di taverna.
Sceso dal treno insieme ai canti goliardici degli alpini, di passi Giovanni Belmonte ne aveva fatti: tutti in fila e in salita, tre giorni di cammino, fino su a un monte a forma di corno, con gli altri soldati del suo Reggimento e con quegli scarponi di cartone che definiva un insulto al suo lavoro, e un primo passo verso la sconfitta.
Il sinibbio del gennaio lo aveva accolto al suo primo giorno in trincea. “Pietriscu, liddu e jazzu: un terreno dove non crescerebbero neanche le patate, friddu e vastardu”, aveva sentenziato Giovanni Belmonte. Si era sentito rispondere che l’Italia era come una poesia, bella anche negli spazi bianchi: anche quel pezzo di terra era Italia, come le punte delle sue dita erano parte di lui e come tali gli appartenevano. “Dell’Italia si tiene tutto”, aveva proseguito un altro soldato, cui Giovanni Belmonte aveva risposto che dalle sue parti solo del porcu non si buttava via niente, e dal canto suo ne avrebbe offerti a decine agli austriaci pur di far cessare la guerra, che Giovanni Belmonte aveva definito cosa da minchiuni. “Abbassa la voce o ti farai fucilare come sovversivo”, gli andavano ripetendo.
La primissima cosa che Giovanni Belmonte aveva compreso nelle notti passate in trincea, era la presenza del più paziente tra i soldati: il freddo. Era sempre stato lì, prima di lui, degli austriaci, di quella guerra, e del mondo. I soldati più fortunati si facevano spedire indumenti pesanti da indossare sopra a quelli in dotazione. Giovanni Belmonte non avrebbe mai pensato che le mutande e le calze di lana, ricamate dalla madre, sarebbero state così importanti per la sua sopravvivenza in trincea.
“Devi saltellare, altrimenti congeli.”
“Grazie,” aveva risposto, “io sono Giovanni Belmonte.”
“E a me non interessa minga, tanto domani sarò morto, ” gli aveva bisbigliato l’altro soldato.
“E allora perché mi stai aiutando?”
“Oh, non ti sto aiutando, è solo che non voglio fare la veglia a un morto stanotte.” Lo aveva detto estraendo la pipa da sotto il mantello.
“E tu non saltelli?” Aveva chiesto Giovanni Belmonte, poi aveva notato che il soldato se ne stava in piedi su un pietrone.
“Dicevo io, tu non tieni i piedi nel liddu.”
“Ah, è così che lo chiamate il fango, voi altri?”
“A me altro, di nchianari fino a qui, non m’importava proprio. Non salivo neanche sui monti di casa mia.”
Il soldato si era rannicchiato. “Dai, abbassati che ti offro da fumare; se sarai fortunato, domani questo pietrone sarà tuo.”
Il soldato gli aveva passato la pipa.
“Ma come la tieni?”
“E’ che non fumo.”
“Allora è bene che inizi. Ridammela, che ti faccio vedere.”
“Dì, Giovanni, hai da accendere? I miei cerini si sono bagnati cadendo nel fango.”
“Sì, quelli li tengo, mi sono stati regalati dal tenente.” E mentre lo faceva accendere nel buio della notte, il fuoco aveva illuminato per un attimo i due visi giovani e imberbi.
“Sei anche tu del novantasei?”
“Sì.” Aveva risposto Giovanni Belmonte, mentre la fiammella si andava spegnendo.
“Hai già ucciso?”
“Solo una volta, la gallina dei vicini, ma era malata. Io ero scarparu al mio paese; lo dissi al signor tenente, e lui mi mise a riparare gli scarponi, almeno i primi giorni. E tu?”
“Hai voglia,” rispose il soldato, muovendo la mano, come a buttar fuori acqua da un catino, “uè, ma le mia una cosa bela. Soprattutto quando devi infilzare il costato del nemico con la punta della baionetta.”
Giovanni Belmonte, vedendogli simulare l’attacco, si ammutolì.
“Dai, accendine un altro, che ti mostro una cosa.”
E così dicendo il soldato trasse una foto dalla tasca della giubba.
“Non è bellissima? Si chiama Rosina. Voglio che la tenga tu, insieme alla mia pipa. Il Maggiore mi manderà a tagliare il reticolato,” disse lanciando uno sguardo, come fosse un dado, verso la trincea austriaca.
“Io con le pinze tiegnu una certa esperienza, ma di murì…” disse Giovanni Belmonte agitando il dito nell’aria.
“Allora, quando toccherà a te, perché stai sicuro che quella carogna di Ranieri ti ci manderà, tu dì che ci sei già andato. E’ nuovo, noi siamo arrivati con lui a darvi manforte; non ti conosce, non ti manderà due volte.”
Così Giovanni Belmonte aveva preso in consegna la foto. Poi aveva aggiunto che lui le calze e le mutande le aveva di lana. Non sapeva il perché di quella frase, ma era sembrata dargli una certa affidabilità.
Il soldato gli aveva sorriso. “Io sono Marcello, e facevo il cantante lirico prima della guerra.”
Giovanni Belmonte era sempre stato indifferente alla musica ma quella sera sentendolo cantare si era commosso. Cantava in tedesco “Freude, Freude”; Giovanni Belmonte non aveva creduto possibile prima di allora che una lingua così ostile potesse avere un suono così dolce. Nessuno fra gli italiani aveva osato interromperlo, e nessuno tra gli austriaci aveva sparato un solo colpo; mentre quella voce, bella e nostalgica, riempiva la trincea, il cielo sopra di loro sembrava il tetto di una sola casa.
Alle prime luci del mattino, Giovanni Belmonte, dopo aver salutato Marcello con un abbraccio fraterno, lo aveva visto svanire nella nebbia. Una raffica di mitragliatrice aveva squarciato il silenzio.
“Se sopravvivi promettimi di andare a Milano a far visita alla mia Rosina, fa la maestra, ho scritto l’indirizzo dietro la foto.”
Giovanni Belmonte aveva fatto di sì con la testa, com’era abituato con Annunziato, quando da piccoli gli proponeva ogni sorta di avventura nei vicoli del paesino. A dire di sì era sempre stato bravo, era come fare entrare il nemico in trincea senza opporre resistenza; un no, al contrario, costava fatica, andava motivato, arginato, difeso, e alla fine deludeva. L’affabilità in Giovanni Belmonte finiva sempre consumata come le suole delle scarpe.
Per onorare almeno in parte la promessa fatta, il giorno stesso in cui Marcello era morto, aveva scritto a Rosina di quanto coraggioso fosse stato il suo Marcello; ma spaventato dagli errori di ortografia, come se ne andasse della vita stessa, aveva convinto il tenente Pinna a dare una forma presentabile al suo scritto. E quando aveva riletto la lettera ripulita e ritoccata dal tenente, si era sentito subito poeta.
Io ho avuto la fortuna di conoscerlo solo per una notte, ma mi è parso subito fraterno e amico come mai ne avevo avuto un altro, e che voce il tuo Marcello, sembrava potesse placare anche la guerra e convincerla a cessare. Per una notte, almeno, io me ne ero convinto.
Grazie, aveva risposto Rosina. Spero che almeno tu farai ritorno dai tuoi cari.
La lettera di Rosina era arrivata dopo solo quattro giorni, durante i quali erano state aperte delle brecce nei reticolati austriaci a colpi di: Sergente. Comandi. Le pinze. Fuori un fante. Ta-pum e poi ancora: Sergente. Comandi. Le pinze. Fuori un fante. Ta-pum e ra-ta-ta-tà.
Quando era toccato a Giovanni Belmonte uscire, ormai i volontari erano finiti, e il Maggiore Ranieri aveva avvertito: “Finché non avrete creato sufficienti brecce da poter muovere l’attacco, continuerete a uscire tutti”. Il tono stentoreo di quell’uomo dai capelli d’acciaio e gli occhi affilati come baionette muoveva all’inquietudine e a un’ubbidienza senza voce; così i soldati si erano decisi a procedere attraverso una conta macabra di cui si era fatto latore un sottotenente della provincia di Como, diplomato ragioniere del caso.
“Alura, chi le che dis de sì, mi conto vun, du,…”
“Ma cos’è sta roba, mona?” Aveva obbiettato un fante più anziano. “Va chi è di turno, e di turno c’è il negus.” E così dicendo, indicò Giovanni Belmonte, con il dito che pareva un fucile.
A Giovanni Belmonte si vuotarono le vene dal sangue, come camminamenti senza soldati; le gambe si piegarono e il pomo d’Adamo si dimenò, come avvolto nel filo spinato, per fuggire dalla gola.
“Su, moves, negus, da quando te se chi, ta fa nagot,” lo aveva rimbrottato il sottotenente Molteni.
“Ho riparato le vostre scarpe,” riuscì a dire Giovanni Belmonte, facendo cadere gli occhi nel fango.
“E il Faliero c’ha rammendà le giubbe, il Raucci c’ha fa la zuppa e il to amis Marcello ci cantava le bele canzoni: penserai mica di essere speciale, tu?”
Giovanni Belmonte tornò per un attimo a incontrare il rumore dei tacchi delle donne che entravano nella sua bottega; riusciva a riconoscerle solo dal suono: un suono che gli raccontava se donna Carmela fosse di fretta, o la madre di Annunziato fosse arrabbiata con lui perché passava il tempo alla taverna, o se donna Maria fosse di buon umore per una bella giornata d’estate; quantunque quelle cose se le immaginasse, Giovanni Belmonte sapeva quando le pinze dovevano essere usate con onestà e quando solo per guadagno.
Ma ora, in tutta onestà, non ci vedeva un guadagno per nessuno. E di gettare il cuore nella trincea nemica non ne voleva sapere. Marcello glielo aveva detto: “Guardaci, Giovanni, siamo carne da cannone; fanti analfabeti cui è stato raccontato che è per la patria che si muore.”
E di risposta al suo pensiero, come se nel suo sguardo tremulo vi fosse stata un’esplosione, sorse in piedi il Maggiore Ranieri, e innervosito da quella reticenza, esplose nella trincea.
“Basta con questa lagna! Soldato Belmonte, le ordino di andar fuori; di usare le pinze è pratico, mi pare…Vada.”
Giovanni Belmonte non provò nemmeno a dire di essere già andato; prese in consegna le pinze, s’issò sulla scaletta, e appoggiato il ventre a terra, cominciò a strisciare come una vermagghiu: uno di quei lombrichi per cui da piccolo provava schifo. La notte era calata come un coperchio e avanzare era cosa ardua in quella sozza poltiglia di fango, pietre e nevischio.
Quando gli austriaci spararono il razzo di segnalazione, Giovanni Belmonte si trovava distante dalla sua trincea, dietro una gobba spelacchiata come la coccia di suo padre; un punto che non riusciva a identificare. Poi, alla sua destra, riuscì a scorgere un pertugio riparato, era un canale di scolo per l’acqua, sembrava fatto apposta per strisciarci nel mezzo; di là del pendio nessuna trincea, solo della boscaglia rada; e dietro sicuramente il terreno dirigeva verso il fiume.
Il secondo razzo aveva illuminato il reticolato nemico: gli stava in faccia, in cima alla salita, una follia arrivarci; proprio sopra era posta una mitragliatrice tra le rocce e due obici di retroguardia. Non appena l’ombra tornò a confonderlo con il terreno, vide un soldato italiano incastrato in mezzo a quell’arrabbiatura di filo e punte di ferro: aveva le braccia aperte come un Cristo; era riuscito ad aprire un varco; le pinze rimaste attaccate al reticolato ondeggiavano tristemente, come a parlargli in modo che nessuno sentisse. Giovanni Belmonte decise che il gesto eroico di quel soldato sarebbe diventato il suo nelle parole riportate al Maggiore Ranieri.
“Le turnà,” disse il sottotenente Molteni.
“Alora, non aver i oci da pesse straco,” disse il soldato Visentin allungandogli della grappa.
“Soldato Belmonte, a rapporto. Siamo sicuri che queste pinze si siano strette sul reticolato nemico? ”
“Certo, Sergente Maggiore,” rispose Giovanni Belmonte, e nel raccontare le cose, le fece grandi, armandole del suo dialetto, cosicché fossero meno comprensibili; e quando furono richiesti maggiori dettagli, si limitò a dire che il buio della notte gli aveva inghiottiti, come topi nel guazzo.
Trascorsero i giorni in egual misura: i fanti analfabeti uscivano a due a due a tagliar il reticolato, e uno per volta erano sbranati dai colpi di mitragliatrice sputati da quella bocca tra le rocce; intanto continuava ad arrivare carne fresca da ogni parte d’Italia, ma la tattica non cambiava. “Cos’è, forse il Maggiore spera di vincere la guerra esaurendo le munizioni del nemico?” borbottò qualcuno, e a poco a poco la trincea si riempì di un nuovo sentimento con il corpo di una biscia.
Giovanni Belmonte era riuscito a rispondere ai genitori con un generico: zona di guerra…cari genitori, io sto bene… ogni tanto striscio come un vermagghiu tra le pietre, ma mi tengo in salute…però il cibo è schifo per i porci e il pane di muffa sa …vorrei qualche lira per farmi la foto…
Tuo padre è orgoglioso di te…racconta agli amici del tuo coraggio…
La lettera si concludeva con saluti anche da padre Ceraudo che nel frattempo, oltre a dir messa, aveva assunto la missione di scrivere e leggere la corrispondenza di guerra: un camminamento dove far incontrare genitori e figli.
Il coraggio in Giovanni Belmonte si era presentato con la faccia da nemico sin dai giochi d’infanzia, quando a ladri e guardie lui faceva il ladro, poiché, secondo una regola stabilita, Annunziato non l’avrebbe potuto uccidere, ma solo catturare.
Si chiedeva come il padre potesse essere orgoglioso di lui, se la sua lettera si concludeva con voglio tornare a casa. Certo, la sua missione con le pinze era stata ben raccontata, ma Giovanni Belmonte non si era risparmiato nel descrivere le condizioni in cui viveva per obbligo imposto e non per scelta; aveva scritto di quanto trovasse assurdo combattere per delle pietre, che sulla Sila abbondavano, e di quanto poco gliene fottesse di questi austriaci di cui prima d’ora non conosceva neanche l’esistenza.
“La censura, soldato Belmonte, la censura,” gli rispose il tenente Pinna, “dovrebbe scrivere in latino per sfuggirle, ma anche lì durerebbe poco, si è chiesto cosa succederebbe se il nemico venisse in possesso di informazioni sulla nostra situazione?”
Ma l’unica cosa che Giovanni Belmonte aveva voluto sentire era:
“Cazzu, il latino conosce, signor tenente?” lo chiese con gli occhi pieni di stupore.
Il tenente Pinna scosse il capo come a scrollarsi di dosso un fastidio dalla testa.
Giovanni Belmonte, persuaso che il dialetto calabrese fosse ignoto quanto il latino, scrisse una lettera ad Annunziato non tralasciando niente, e camuffando le parti più sensibili in un idioma così intricato che la censura avrebbe dovuto avere delle pinze speciali per venirne a capo.
Annunziato stette al gioco, e in quella lingua senza un esercito e senza una marina rispose:
T’arricordi quannu u zampaleu, se l’acceju accattiava, a scapituni in una neglia s’ammucciava.
Giovanni Belmonte comprese ciò che Annunziato gli suggeriva con quella filastrocca del moscerino che, quando l’uccello si avvicinava, a volo si nascondeva in una nuvola.
Si sarebbe nascosto giù al fiume, avrebbe atteso il placarsi della battaglia e quando tutto avesse taciuto, si sarebbe consegnato come prigioniero agli austriaci. Conosceva quella parola: Kamerad. Gliela aveva insegnata un soldato piemontese, a cui l’aveva sussurrata un veneto finito poi con la faccia nella terra. “Devi dirla alzando le mani prima di consegnarti”, si era sentito ripetere prima che il soldato scoppiasse in una risata di scherno. Giovanni Belmonte l’avrebbe gridata pensando a casa. Gli avrebbero risparmiato la vita, lo aveva sentito dire da altri italiani: “Gli austriaci, se ti consegni, non ti uccidono”. Era un’idea che agitava le notti di veglia di molti giovani soldati. E qualcuno, si era sentito dire, da prigioniero ingrassava pure. Giovanni Belmonte a questa immagine si era attaccato con tutto se stesso, e sopra ci aveva ricamato un respiro infinito.
Il marzo era arrivato lento come un mulo e con la ghirba vuota della primavera, spinto da un vento che si affilava sui cavalli di Frisia, annichilendo i soldati al crepuscolo penoso.
Due cose avevano tenuto in vita Giovanni Belmonte in quel mese da vedetta: la parola Kamerad, in cui sentiva il suono del mare come in una conchiglia, e la foto di Rosina.
Per molte notti si era immaginato di incontrarla, dimenticando l’infatuazione per donna Maria, per cui Giovanni Belmonte aveva celato un sentimento così segreto da non averlo confidato nemmeno all’amico di sempre.
La foto mostrava solo il viso di porcellana e il collo sottile che spuntava dalla camicetta; il resto lo aveva disegnato la fantasia. Rosina aveva una bellezza ingenua che aveva ammaliato Giovanni Belmonte. In quella bellezza aveva trovato rifugio per molte notti, e sognato di giacere in un letto di lana, profumato di lavanda, affamato d’amore, con quel corpo sodo e giovane, e quel viso che gli era parso la cosa più simile a un miracolo.
Ma pochi giorni prima della sua fuga era arrivata una lettera. “Soldato Belmonte?”
“Eccomi, sono qui.”
Volevo informarti che presto raggiungerò Marcello…sono malata di un male incurabile; attendevo la sua prima licenza per dirglielo, poiché non volevo scorarlo, … Non so nemmeno che viso tu abbia, ma lo immagino buono… e non so perché ti dica questo, in fondo sei solo uno sconosciuto, ma se sei stato amico di Marcello, un po’ lo sei stato anche per me.
Giovanni Belmonte si sentì abbandonato. Aveva nutrito con l’egoismo le sue notti di veglia, portando quella foto sotto a un mantello di solitudine.
“Ciullo, Giuvà,” gli sembrava di poter sentire la voce di Annunziato, “ma che ti eri immaginato? Sconosciuto, ecco cosa sei per lei.”
In fondo, il sentimento dell’amore lo aveva colto nei momenti più torvi della notte, dilatando lo spazio e il tempo, suscitando risvegli primitivi nel basso ventre. In quegli attimi di calore, era riuscito a dimenticarsi del freddo, della puzza di sangue raffermo, urina e polvere da sparo, che invadeva le narici fino a ghermirgli l’anima. Ma ora, afferrata la foto, la spostò dalla tasca vicino al cuore a quella del tascapane, come un oggetto smarrito, una promessa non mantenuta, un amore dimenticato.
La montagna respirava nebbia, sputava ferro e vomitava sangue. L’ordine del Maggiore Ranieri era stato perentorio: bisognava riprendere quella cima dove gli austriaci si erano incassati con un tale vantaggio, che gli attacchi lanciati alla baionetta da parte del Regio Esercito erano finiti in un naufragio di sangue.
Seguirono notti di silenzio, nell’attesa sfibrante dell’assalto successivo, dove i ricoveri diventavano lapidi senza nomi o altari improvvisati dove pregare un Dio senza misericordia.
Si era in aprile e il giorno pareva immobile. Un soldato con passi svelti attraversando la trincea ripeteva:
“Domani ghe sarà l’attacco, domani ghe sarà l’attacco.”
“Ta se sicur? ” un altro gli chiese.
“Per forza, al ghe il rancio doppio.”
In quel momento fece la sua comparsa il Maggiore Ranieri, preceduto dal tenente Pinna; poi bloccò il passo, alzò il mento, scrutò i volti dei soldati e annunciò:
“Soldati, è per la patria che si combatte ed è per la patria che si muore. Vittoria, soldati. Vittoria.”
E il rancio fu masticato, dilaniato tra i denti sbattuti, deglutito insieme all’angoscia, ingoiata a forza con vino e grappa, con l’intento di stordire, di far ritrovare il coraggio, ma con l’effetto di risvegliare alcuni pensieri dal sapore rivoluzionario; poiché le voci corsero senza far rumore, voci che bisbigliavano di ammutinarsi, voci che avevano illuminato il viso dei soldati di una certa malizia; passare a baionetta il Maggiore Ranieri più del nemico austriaco: un sentimento comune.
Giovanni Belmonte aveva ascoltato entusiasta un tenente parlare di socialismo e di potere al popolo, mentre un altro aveva ribattuto che a fare i filosofi erano tutti buoni, ma non avrebbero vinto la guerra con le belle parole.
Alle quattro, orario stabilito per l’ammutinamento, non era successo niente, qualcuno aveva fatto cenno di no con la testa, bisognava attendere; così al precipitare del giorno quella decisone gli aveva attraversato gli occhi finendo in una nuvola.
Un attimo prima che il nome dei Savoia fosse gridato, Giovanni Belmonte aveva visto il reticolato nemico assumere la forma di un ghigno di ferro, inciso con l’odio sulla pietra; una corona di spine che attendeva di essere indossata. Toccò il chiodo portafortuna nella tasca della giubba insieme alla lettera di sua madre; poi invocò l’aiuto di San Crispino; provò a pensare a qualcosa, a qualsiasi cosa
che non fosse l’attacco, la battaglia, la morte, ma i pensieri si accavallavano
nella testa in un vortice d’immagini, cui aggrapparsi era impossibile; sentì il sangue sparirgli dalle cosce, i nervi come stringhe rotte, i capelli drizzarsi, e poi il calore dell’urina scendergli nei pantaloni come in una forra senza fine. “Respira Giuvà, respira,” balbettava, prima di essere scaraventato fuori dalla trincea da un solo urlo.
La battaglia infuriava. Il Maggiore Ranieri, prima di esplodere lui stesso il colpo, aveva ordinato di sparare sul disertore, ma i soldati, troppo impegnati a non farsi uccidere, non avevano obbedito. Combattere un nemico che poteva guardarli dall’alto e sparare nel mucchio come su un branco di pecore era un suicidio e per molti il nome dei Savoia sarebbe stato l’ultimo ascoltato, insieme al ruggito nero dei cannoni.
Giovanni Belmonte ora sentiva il fuoco nel braccio: il proiettile lo aveva colpito di striscio lacerandogli la carne; le gambe erano diventate estranee al suo corpo e ogni respiro era una fitta nel petto.
Il terreno iniziava a montare, quando finì bocconi per un inciampo, e prima di riuscire a riprendere la salita, una schioppettata gli fischiò vicino all’orecchio, spaccando una pietra.
Echeggiarono altri colpi, ma di lontano, fitti come la nebbia che tutto avvolgeva, rendendo tutti uguali: ombre e sagome nel fragore della battaglia, barriti come di elefanti venivano sputati dalle trombe, e mentre il cielo sembrava abbassarsi a schiacciare la montagna, Giovanni Belmonte riuscì a distinguere tra la nebbia la sagoma del Maggiore Ranieri piombargli addosso.
Insieme alla speranza, in quel momento, perse l’elmo, sentì la vita sfuggirgli, e decise di levare le braccia in segno di resa: il Maggiore Ranieri, uomo ligio al protocollo, non gli avrebbe tirato addosso ancora, certo lo avrebbe fatto passare alle armi, ma almeno avrebbe vissuto ancora un giorno, fosse solo per un’ultima pipata guardando il cielo; ma appena s’issò sulle gambe, e prima ancora che fosse riuscito a proferir parola, proprio quando il Maggiore Ranieri era diventato reale, fu raggiunto dal boato di un’esplosione: lo spostamento d’aria lo fece finire in un fossato.
Si toccò la faccia: era bagnata; poi si guardò le mani: erano tutte nere di fango. Un fischio lancinante gli stava attraversando il cranio. Si girò sulla schiena e quello che vide fu il corpo di un soldato con le gambe troncate. Ma la morte non gli aveva deturpato il viso, tuttalpiù lo aveva sorpreso, lasciando gli occhi aperti, inespressivi come quelli di una bambola; stava proprio davanti a lui, coperto dalla terra, sbattuto lì contro il fosso, come un saccu vacanti che non teni all’ardita.
1. Si dice di un sacco vuoto che non sta in piedi.
Poi, di nuovo, alla sua destra, un altro corpo, e via un altro un po’ più in giù; sembravano abbracciati, alcuni solo addormentati; le facce gonfie, le teste piegate, le braccia disarticolate, le gambe affondate come radici nel terreno, le mani a indicare, come quelle di un bambino nella culla; il fango a insultare, offendere, coprire, nascondere.
Qui la vita sembrava essere stata cacciata via con forza, dopo aver provato in tutti i modi a rimanere aggrappata al corpo con i denti, frantumando le ossa, strappando gli arti, lacerando i capelli, scoperchiando le unghie, come tetti di capanni sotto raffiche di piombo.
“Respira Giuvà, respira…” rifriggeva, ma la gola si strinse fino a soffocarlo; si mise carponi e cominciò a gettare saliva e bile dalla bocca; “respira Giuvà, respira,” ma ora Giovanni Belmonte piangeva, piangeva lacrime disperate; poi esplose. Esplose in una risata folle che gli imporporò il viso.
La testa di Giovanni Belmonte spuntò dal fosso dove lo scoppio lo aveva cacciato. Del Maggiore Ranieri non vi era traccia, mentre l’erta che aveva tentato di risalire era ancora lì dov’era sempre stata. Scrutò la linea nemica e la vide lampeggiare; gli occhi si riempirono di bagliori muti; una nuvolaglia di pietrisco si sollevò a pochi metri da lui, e Giovanni Belmonte comprese di non sentirci più. La morte non era mai stata così viva, poteva vederla, ma privo dell’udito, gli parve ancora più crudele e grottesca.
Lasciatosi scivolare ancora nel fosso, e ripresa un’unghia di lucidità, cominciò a far partire un lavorio di mente per procurare di uscirne. Ciò che ne cavò fu la lucida follia di nascondersi sotto a una coperta di cadaveri. Ne spostò alcuni, affondando gli scarponi nel brago, laido come la guerra, abietto come l’odio; sollevando il corpo di un soldato da sotto le ascelle, ebbe l’impressione che le costole si fossero staccate, che le spalle fossero uscite dal loro posto. Si sforzò di non dare di stomaco. Quanto pesava un corpo privato della vita? Come se la morte in guisa di contropartita lo avesse riempito di piombo. Cadde indietro Giovanni Belmonte; il braccio cominciò a gettare sangue, ma trascinato quel corpo vicino ad altri, con sforzo tremendo, s’infilò nel mezzo.
“Respira Giuvà, respira”, lo ripeteva nella mente come una nenia a prova della sua esistenza; una ninna per potersi svegliare in un altro dove.
Per un attimo tutto sembrò morto. Era tornata la sera e la montagna aveva smesso di tremare. Giovanni Belmonte si levò di dosso il corpo del soldato che lo aveva coperto. Il cielo era privo di stelle; un cirro negro aveva inghiottito la luna e non si vedeva che a distanza di un braccio.
Giovanni Belmonte strisciò fuori dal fosso, e con il ventre schiacciato a terra e il core che gli batteva nelle orecchie, cominciò a risalire il pendio, allungandosi, afferrando i sassi, senza mai levare il capo, come fosse lui stesso una zolla di terra; digrignando i denti, arrancava, si trascinava silente come il buio.
Trascorse tutte le ore della notte ad arrampicarsi per quella salita, forse solo un centinaio di metri ma chilometri per la sua mente e il suo corpo che solo una volontà figlia della paura di morire e la solerzia dello scarparu erano riusciti a far muovere.
Una volta raggiunta l’altura, quando il core si fu calmato, sentendosi protetto dalla parete rocciosa, Giovanni Belmonte si levò in piedi, e cominciò a scendere il fianco della montagna fra guglie, forre e giravolte, mentre l’alba luceva illuminando un silenzio verde di abeti secolari: tutto era muto, non un uomo, non uno sparo nella Vallarsa, solo il mugghiare del fiume che lì in mezzo scorreva sicuro, come nel grembo di una madre.
Persa la cognizione del tempo, ma riacquistato l’udito, si ritrovò a camminare nel bosco. Il fiume era ormai visibile: due giri di sentiero e poi si sarebbe fermato per trovar ricovero.
E sebbene la retorica sull’amor di patria non lo avesse mai sfiorato, teneva la testa bassa, come se gli alberi lo potessero riconoscere, come se i compagni di trincea fossero lì a condannarlo per averli abbandonati; ma la guerra lui la schifava e di quelle canzoni piene di orgoglio da soldato, che non si sarebbe mai dato prigioniero allo straniero, lui se ne fregava le mani; e poco importava se ora i carabinieri lo avrebbero cercato per portarlo a fucilazione, lui si sarebbe ammucciatu; e davanti al soldato austriaco avrebbe gridato “KAMERAD”, e poi prigioniero per qualche tempo.
“Vile sì,” ora parlava con tono sprezzante, “ma ciullo no”; perché bisognava essere degli stupidi per morire così, mentre dei burattinai usavano i soldati come dei pupàtuli senza fili; e aveva ben inteso che se uno scarparu non avrebbe mai guadagnato un sordu dalla guerra, chi le armi le costruiva sarebbe uscito con il culo chinu di calamari, come si diceva al suo paese quando qualcuno si arricchiva.
Si fottessero tutti, brutte bestie senza core; che ci mandassero i loro figlioli a morire, che venissero loro stessi nel liddu a strisciare e a tirar u spacu, in quella guerra tra morti di fame; e che Caronte si portasse a quell’infame del Maggior Ranieri, con tutti i baffi e i corna; che lui solo ci sarebbe dovuto andare su quel cucùzzulu a tagliar il reticolato con quelle pinze, che manco per il cuoio.
Crollò in ginocchio sulla riva del fiume, in quel punto placido. Riempì la borraccia e si medicò la ferita come meglio poté. Il giorno si fece interminabile nell’angoscia di poter essere scoperto e fucilato. E se una volta consegnatosi nelle mani del nemico, gli austriaci lo avessero torturato per carpirne informazioni? Avrebbe confessato tutto? Ma poi cosa sapeva lui di tanto valore da poter essere barattato con la vita sua? Era solo un fante cui nessuno diceva niente.
Fiacco nell’anima e nel corpo, sfilò un pezzo di carne secca dal tascapane e lo addentò. Sulla sua testa il cielo si faceva costipato di nubi, lasciando gioco alle ultime ombre del giorno di allungarsi fra gli alberi.
Giovanni Belmonte si destò di colpo. Era mattina; il tempo era mutato d’umore e minacciava di tempestare. Decise di porsi in cammino sotto quel lastrone plumbeo; seguendo il torrente avrebbe raggiunto un villaggio. Era rischioso, ma quale scelta aveva? Aspettare per lui era uguale a morire.
Camminò stringendo il chiodo nella tasca, ci si pungeva le dita ogni volta che, ripetendo le storie da menzugnaro qual era, si sorprendeva a esitare. Cadde un lampo ed esplose un tuono, fragoroso, a ricordare la potenza della natura, e fu il temporale.
Guadagnata la strada carrabile, il rovescio cessò; e con la coccia battezzata mille volte dalla pioggia e i vestiti fradici d’acqua, Giovanni Belmonte si trovò a un tiro di schioppo da un paese.
Volò per la discesa come a raggiungere casa. “Ma dove curri, Giuvà? Non vorrai raccontare a tua matre che ti ho spinto nel torrente? Che vai trovando in quel paese dimenticato da Dio, Giuvà? ”
Non poteva fare a meno di portare con sé quella voce.
Tutto era distrutto. Sembrava fosse venuta giù una frana e avesse provato a costituirsi paese ma incompleto, come un gioco lasciato a metà. Le case erano per lo più senza tetti, senza finestre, i muri sventrati. Una ruina, pensò Giovanni Belmonte; eppure quanto somigliava a casa sua; anche le pietre parevano le stesse.
Avanzò fra i detriti, casa per casa, fino a trovarne una ancora intatta. Al pian terreno c’erano solo un tavolo con delle sedie e un paiolo ma nulla da mangiare. Prese le scale, ed entrò in una camera. Aprì un armadio: dentro trovò degli abiti da uomo. Si sbarazzò della divisa, come a volersi liberare per sempre dalla guerra, e l’indossò.
Salito all’ultimo piano, uscì sul balcone privo del parapetto, arrivò con le punte delle scarpe fino al bordo, come ubriaco, aprì le braccia e prese un lungo respiro.
Rientrato, si gettò sul letto coperto di calce ceduta dal soffitto; doveva essere appartenuto a un altro Giovanni, come lui figlio, e magari anche scarparu. Si decise a leggere la lettera.
Caro figlio, oggi è passato da noi Annunziato, si è trattenuto per pranzo; ho fatto le melanzane al sugo che ti piacciono tanto. Quando tornerai farò una teglia solo per te, così ti rimetterai in forze.
Giovanni Belmonte si mise sul fianco e rannicchiò le gambe.
Annunziato, però, mi ha detto di un’idea guasta che ti è passata per la coccia. Me l’ha portata all’orecchio quando ero sola in cucina, così che tuo padre non sentisse. Mi ha ripetuto la vostra filastrocca ed io mi sono dovuta tenere dentro quella cosa, e quasi il petto mi scoppiava.
Strinse la lettera con forza portandosela al petto tutta arricciata.
…quando da piccirillo tornasti a casa, fradiciu d’acqua, urlando che Annunziato si era fatto male alla gamba perché vi eravate presi per i denti, tuo padre te ne diede tante che non riuscivi più a star seduto a tavola, ma poi il male ti passò. Annunziato dice che li salvasti la vita perché ora lui la guerra non la deve fare. Ma con la pazienza Tutto s’aggiusta, Giovanni, anche la…
Un crocchiar di corvi si alzò in aria, e Giovanni Belmonte sobbalzò.
…sai che mi disse Salvatore, che si sente vecchio e vorrebbe ritirarsi dal lavoro dello scarparu, e così, sapendoti la cosa gradita, ci feci un’offerta e lui acconsentì a lasciarti la bottega. Tuo padre si sentì d’accordo e da parte un po’ di soldi li stiamo mettendo, ma tu levati quell’idea…
Giovanni Belmonte si levò in piedi per un rumore meccanico che in breve crebbe d’intensità andando a divorare il gracchiare dei corvi; i motori e le ruote degli autocarri fecero tremare le pareti. Giovanni Belmonte d’istinto corse al balcone: il cuore gli balzò in gola e i denti presero a sbattere come persiane picchiate dal vento. Quando i fari cominciarono a illuminare la strada, quella parola gli rotolò sulla lingua come un masso, e la spinse fuori con un filo di voce, come a testarne il suono, prima un pezzo e poi un altro: “Kam…Kamer…” poi con tutto il fiato che aveva in corpo in un crescendo: “Kamerad…Kamerad,” come gridava ora Giovanni Belmonte e con quale disperata gioia a deformargli il viso ripeteva “Kamerad”, agitando le braccia, e ancora più forte verso la vita; non smise nemmeno quando i motori si spensero; nemmeno dopo che il generale fu sceso dall’autocarro; nemmeno mentre i soldati salivano con i fucili spianati fino a raggiungerlo nella stanza; e nemmeno quando lo afferrarono da sotto le ascelle e lo trascinarono di peso sul balcone, mentre strusciava le suole delle scarpe, che aveva avuto cura di riparare; nemmeno quando il generale, dopo aver misurato con lo sguardo l’altezza, calò un sì marziale con il capo e risalì a bordo spingendo gli stivali sul predellino. Erano di un lucidissimo nero.
Il sole era alto. Ogni cosa era illuminata, quando passò un asino tenuto alla corda da un vecchio e insieme a lui un bambino: aveva la suola di una scarpa aperta, e per camminare apriva la gamba disegnando un arco, e poi la riportava dritta, in quella buffa marcia. Allontanatosi dall’animale e dal vecchio, caracollò verso il corpo di un uomo che stava pancia sotto, con la faccia girata verso il muro di una casa; frugò nelle sue tasche e trovò un chiodo.
Lo alzò verso il cielo e bucò una nuvola...
Id: 3323 Data: 18/09/2016 15:45:27
*
Non è tempo di bachi da seta
La stagione dei bachi da seta era quasi finita, quando mio padre tornò a casa dal consorzio portandone una discreta quantità e soprattutto annunciando, con insolita fiducia, che la guerra di lì a poco sarebbe terminata.
Quella notte, svegliata da alcuni rumori, mi accorsi di un mormorio al piano di sotto, così decisi di alzarmi e aprire leggermente la porta della mia camera per capire chi stesse parlando: una voce era di mio padre, ma l’altra non la conoscevo, apparteneva a una donna, e la cosa mi sorprese: da quando c’era la Repubblica avevo sentito solo voci maschili, sporche e stanche, entrare le sera nella stalla e sparire prima dell’alba. Ero curiosa, ma altrettanto sicura che se fossi scesa sarei stata battuta con la cinta. In quella casa ai margini del paese, sola con mio padre, avevo quattro semplici regole da seguire: dare da mangiare ai bachi, dire le preghiere, sputare sulla foto del duce prima di lavarmi le mani, e non scendere mai e poi mai al piano di sotto quando mio padre s’intratteneva con un ospite.
La sua severità era degna di un generale dell’esercito e, da quando mia madre se n’era andata, non ricordavo una sola volta in cui ci fosse stata un po’ di gentilezza nei suoi gesti; si limitava a farmi da mangiare, concedendomi meno attenzione di quella che impiegava per rastrellare l’erba secca del prato.
A colazione avrei voluto domandargli perché, a quell’ora della notte, avesse fatto entrare una donna in casa nostra, ma non appena alzai lo sguardo, incrociai il suo che mi fissava: era un muro di pietra che non me la sentii di scavalcare. Dietro c’era il mondo dei grandi, e a me era proibito.
- Sbrigati. Finisci il latte e poi vai a prendere le foglie per i bachi- disse con un tono che mi fece scattare sulla sedia.
Era incredibile vedere con quale voracità quegli esserini le divorassero, attività che interrompevano soltanto per dormire. Il mio era un compito di grande responsabilità: dovevo assicurarmi che non rimanessero mai senza, perché, come diceva mio padre, se mangiano loro, mangeremo anche noi. Così, sotto il peso di quel monito, andavo e venivo dall’albero di gelso alla stalla, senza badare agli eventi che avrebbero cambiato il corso della storia, alle notizie che avevano le gambe ferite dei soldati e agli aerei che volavano bassi, facendo tremare i tetti e scappare i gatti.
Per giunta con l’oscuramento verso sera, in paese c’era un fuggifuggi generale; tutti a rinchiudersi nelle proprie case fino al mattino seguente: persino gli uomini più robusti, della stazza di Pietro Fracassa il taglialegna, diventavano come topini di campagna al suono delle campane. Eppure quella voce, così piena di vita, tornò di nuovo in casa nostra, a notte inoltrata, quando nel silenzio assoluto solo i grilli si sentivano cantare.
Per la prima volta arrivai, con un coraggio insolito, in punta dei piedi fino al confine delle scale, spingendo la testa oltre lo spigolo del muro. La porta della cucina era aperta, quel tanto che bastava per vedere un’ombra invadere il pavimento e arrampicarsi sulla parete. Poi sentii quella voce così chiara e sicura di sé. Chiamava mio padre per nome.
- Franco, non ti preoccupare, andrà tutto bene, ce l’abbiamo quasi fatta.
Sentirlo chiamare per nome da una donna che non fosse mia madre, m’imbarazzò. Era come se quella voce mi avesse mostrato mio padre nudo. Me ne tornai in camera. Provai a pensare ai bachi da seta: mancavano poche settimane alla consegna, ed era importante che non ne facessi morire nessuno; ma il pensiero di quella donna mi stringeva la testa, e poi quella frase: “Quasi fatta”; a far che cosa?
All’esterno, sotto la luce del sole, i giorni passavano nell’incertezza, e in paese la gente si raccoglieva come in una preghiera davanti alla radio, nell’attesa di un miracolo che tardava ad arrivare mentre la sera, dopo un piatto di polenta e un padre nostro recitato senza troppa convinzione, io attendevo il ritorno di quella voce. Diventò per me una presenza familiare; entrava e usciva da casa come il vento di primavera, ma cosa più importante ne avevo scoperto il nome.
- Giglio Rosso, ho sentito che i gappisti si stanno dando da fare giù in città- disse mio padre con un entusiasmo composto.
- Sì è vero, ma anche noi. Tra qualche settimana è previsto un attacco a un camion tedesco carico di armi, che deve transitare dal lago. Ufficialmente è un camion che trasporta vino. La soffiata ci è arrivata dalla Gina, quella che lavora giù all’osteria.
- Ma chi, quella che se la filava con l’Uberto, il fascista?
Chiese seccato mio padre, che quando ne vedeva uno passare tirava certe ciccate per terra che parevano pozzanghere d’odio.
- Questo prima della guerra. Diciamo che sono rimasti amici e lui quando alza il gomito… ci siamo capiti?
- Certo - concluse tra i denti mio padre.
Poi si spostarono nella stalla accanto alla cucina, dove tenevamo i bachi. E non riuscii più a sentire niente di ciò che si dicevano.
Così, durante il giorno, vedevo crescere i bachi mentre la sera aspettavo il ritorno di Giglio Rosso. Una notte la sentii raccontare di un partigiano che era riuscito a disarmare un soldato tedesco, puntandogli alla schiena un solo dito. A difesa del tedesco però devo dire che fu colto di sorpresa: mentre la faceva contro un albero.
Dio solo sa quanto avrei voluto aprire quella porta e dire: “Ciao, io sono Aurora e la pipì la faccio da seduta.” Forse lei mi avrebbe preso nella sua squadra e saremmo persino diventate amiche, e io le avrei spazzolato i capelli, che immaginavo lunghi e setosi.
Tuttavia in quel corridoio in discesa, fatto di gradini scricchiolanti in legno che di più ripidi non ne ho più visti, ascoltai storie cattive e feci bottino di parole che suonavano come avventure: Squadra, Distaccamento, Brigata. Parole importanti, parole che al solo pronunciarle mi facevano sentire grande. Ce n’era una che Giglio Rosso aveva sempre in bocca: Resistenza.
- Ma è importante Franco, non capisci? Non ci si può chiamare fuori quando si vuole. Siamo tutti coinvolti. Anche noi donne. Bisogna dare un segnale forte per la Resistenza, come lo sciopero generale di marzo. Bisogna piantarla con questo attendismo. - Aveva un modo di parlare che avrebbe convinto anche un sordo.
Da sotto la porta sentivo entrare l’odore della pipa di mio padre. Mi aveva sempre fatto starnutire, perciò mi portai le mani a coppa sul viso nel tentativo di non respirarlo, poi mi tornò in mente il rumore della cinghia, quando, poco tempo prima, avevo fatto cadere un uovo, così il cuore prese a battermi come un tamburo.
- E gli americani? Dico gli americani stanno salendo? - chiedeva intanto mio padre con un filo d’apprensione.
- Franco qui gli americani non c’entrano nulla, è una questione di riscatto morale. Alcuni giù in paese iniziano ad appoggiarci sai? Anche il parroco, in segreto.
“Hai capito don Enzo, nonostante i suoi occhietti piccoli e vigliacchetti aiuta Giglio Rosso.” Pensai stupita mentre tentavo in tutti i modi di non respirare quel fumo che mi faceva pizzicare le narici; era questione di secondi e sarei esplosa. Forse mio padre non mi avrebbe fatto niente davanti a una donna, ma non appena saremmo rimasti soli, sarebbe stato anche peggio.
- Questa notte passerà il camion tedesco, Cartuccia e Alfredo stanno già battendo la zona per preparare l’imboscata. Nel camion ci sono anche delle granate, quelle le usiamo per la repubblica in paese. E’ ora di farci sentire.
- E io come posso aiutarvi?
- Stanotte verrai con me in montagna. Prenderai le granate e domani mattina… - ma non fece in tempo a finire che mio padre la interruppe bruscamente.
- Oh, aspetta un attimo! Una cosa è farvi entrare in casa mia, darvi pane e salame o farvi dormire nella stalla, e un’altra è trasportare delle granate. - Mio padre non era mai stato un uomo forte del coraggio.
- Porta con te anche tua figlia, darai meno nell’occhio. Quando sarai la ti verrà incontro Giorgio, lui sa già cosa fare- la voce di Giglio Rosso rimase calma e accogliente come una locanda d’inverno.
- Ah, questa poi- ribatté mio padre - credi che se mi scopriranno, chiuderanno un occhio perché ho una figlia? Se ti fermano con un’arma, quei vigliacchi ti fucilano sul posto, senza se e senza ma.
Seguì un lungo silenzio durante il quale trattenni il fiato, fino quasi a scoppiare. Poi, prima di uscire, mio padre fece cadere due parole di consenso. Fu l’ultima volta che sentii quella voce.
Rimasi per ore alzata ad aspettare il rientro di mio padre; inutilmente abbracciata al cuscino, faticavo a respirare in quel silenzio nero come il cielo; fuori si sentivano solo i gufi e l’ululare lontano dei lupi sembrava averlo inghiottito; poi lo sfregare sul pavimento dei chiodi, con cui aveva riparato le suole delle sue scarpe, mi arrivò all’orecchio con una dolcezza infinita. Mi girai su un fianco e crollai in un sonno pesante.
La mattina, con gli occhi ancora appiccicati dal sonno, andai nella stalla a controllare i bachi, ma non li trovai. Corsi fuori e vidi mio padre coprirne con un telo le ceste, caricate sul vecchio carretto.
- Aurora, sei pronta? Dobbiamo andare al consorzio per la vendita. - La sua voce era morbida e la ascoltai dire il mio nome come fosse la prima volta.
- Sì - bisbigliai, guardandomi le punte dei piedi.
- Forza, andiamo allora. - Una luce fioca bagnava la sua espressione, diventata silenziosa e severa.
Si era alzato un forte vento e la porta della stalla aveva iniziato a sbattere più volte. Andai a chiuderla e la vidi enorme, tirai con tutta la forza il chiavistello: fece il rumore di un temporale. Mio padre già spingeva il carretto fuori dall’aia, quando mi misi dietro di lui, sforzandomi di non piangere mentre guardavo la sua schiena piegata portare il peso di quel segreto. Allora corsi in avanti e mi voltai a fissarlo, volevo fargli capire che sapevo, che potevamo ancora tornare indietro, ma i suoi occhi sembravano laghi scavati in quel viso magro e spigoloso, avvolto da una barba ispida e nemica. Mi superò senza dire una parola e io rimasi a guardare la nostra casa, e l’albero di gelso che frustava l’aria.
Arrivati in paese, incontravamo gli sguardi duri della gente e i volti che diventavano scuri al nostro passaggio, mentre il sole andava nascondendosi.
Il consorzio era in fondo a una ripida discesa a forma di serpente, un ragazzo tentava di risalirla a zig-zag, spingendosi in piedi sulla bicicletta; mancavano solo due tornanti e se ne poteva intravedere il tetto. Quando batterono le dieci sul campanile, desiderai che tutto si fermasse. Allungai la mano su quella nodosa di mio padre che era diventata un tutt’uno con il manico del carretto.
Iniziata la discesa, lo fissavo, tentando di non inciampare; volevo urlargli di tornare indietro mentre un vento prepotente ci prendeva alle spalle e le gambe acceleravano, e la sua espressione via via s’increspava per la fatica, facendolo sembrare più vecchio ad ogni passo.
Intanto la discesa aumentava e una ruota del carretto iniziò a cigolare. Una signora con la faccia da corvo si affacciò da una finestra: il nero delle sue pupille mi punse il cuore facendogli fare una capriola. Il carretto ora spingeva come se avesse avuto premura di arrivare, la ruota tremava e mio padre faticava a tenerlo mentre le gambe gli presero a correre in avanti spinte da quel cigolare che cresceva insieme alla discesa, diventando uno sferragliare maleducato che richiamò l’attenzione di molti; le ceste iniziarono a sbattere una contro l’altra, poi il telo che le copriva volò via come un aquilone sotto i colpi di una tempesta; i piedi di mio padre si avviarono al cielo, prima di ripiombare eroicamente a terra nel tentativo di puntellare il carretto, che s’inclinò sul fianco come una bestia ferita. Le ceste caddero e iniziarono a rotolare per la discesa, prendendosi gioco della fatica di mio padre che se ne gettò all’inseguimento. Subito dietro, gli correvo appresso, vedendo le suole delle sue scarpe rimbalzargli sui talloni, lasciando nudi i chiodi che minacciosi tornavano al loro posto; poi un buco e mio padre finì lungo disteso con le mani in avanti ad accarezzare la strada.
Con le lacrime agli occhi e le ginocchia che mi sbattevano, tentavo di raccogliere ciò che avevamo perso, ma non avevo forza nelle mani. I bachi volavano e le granate rotolavano. Mi misi gattoni sulla strada nel tentativo disperato di raccogliere tutto, anche se ormai ero cieca da quanto i miei occhi si erano stretti. “Dov’è Giglio Rosso, dove sono i partigiani? Siamo rimasti soli. Non è giusto.” Intanto la strada prese a vibrare: passi pesanti, a centinaia si muovevano verso di noi; mio padre giaceva ancora a terra.
Fuori dalla chiesetta, circondata dalla strada, si era formato un capannello di persone come fosse domenica, ma la prima voce che udii non fu quella piana del parroco ma quella roca dell’arrotino precipitarsi famelica su mio padre, per poi scavalcarlo.
- Guardate lassù. Li hanno presi.
Dalla strada in alto al paese scendevano decine di soldati in fila come formiche, con gli elmi calati sulle fronti, marciavano nelle loro uniformi grigie e, sotto il rumore dei loro tacchi, la terra sembrava dovesse spaccarsi per inghiottirci; con i volti paonazzi dallo sforzo, cantavano in modo violento ed esaltato facendo tremare l’aria; dalle loro bocche spalancate sembravano uscire nuvole nere cariche di pioggia. In mezzo a loro camminavano uomini con i volti pesti, gli occhi da bambini e le spalle da giganti, con vestiti che parevano stracci in confronto a quelle divise luccicanti.
Guardai verso mio padre e vidi salire, con passo veloce, un intero battaglione con i fucili spianati. Nel tempo di un respiro ci furono addosso, poi mi sentii sollevare per il collo e in un attimo mi trovai con la faccia a guardare un muro: da una crepa vidi uscire un ragno illuminato da un raggio di sole, e ne fissai le zampe.
Mio padre era accanto a me insieme agli altri partigiani. Uno di loro disse che una donna era riuscita a scappare. Non fece il suo nome, ma io capii che era Giglio Rosso, e in quel momento la odiai. Avrei voluto dire a un ufficiale che noi non c’entravamo, che era tutta colpa sua se ci trovavamo in quella situazione; noi al massimo avevamo sputato sulla foto del duce, ma mai e dico mai avevamo fatto del male a un fascista o a un tedesco che fosse uno. Iniziai a pensare che forse, se gli avessi regalato i miei bachi, ci avrebbero risparmiati. Poi sentii i soldati mettersi dietro di noi e caricare le armi. Urlai ma non mi uscì la voce.
Guardai le scarpe grandi di mio padre e le mie ancora così piccole; lui prese la mia mano e con il pollice cominciò ad accarezzarla, disegnando un cerchio, leggero… poi il rumore di un tuono, i piedi freddi, il mio corpo rigido e gli occhi spalancati: Era l’estate del 44’. E fuori pioveva che Dio la mandava.
[ Racconto quarto classificato al Premio Letterario Nazionale Il Giardino di Babuk - Proust en Italie ]
Id: 2775 Data: 28/04/2015 18:10:32