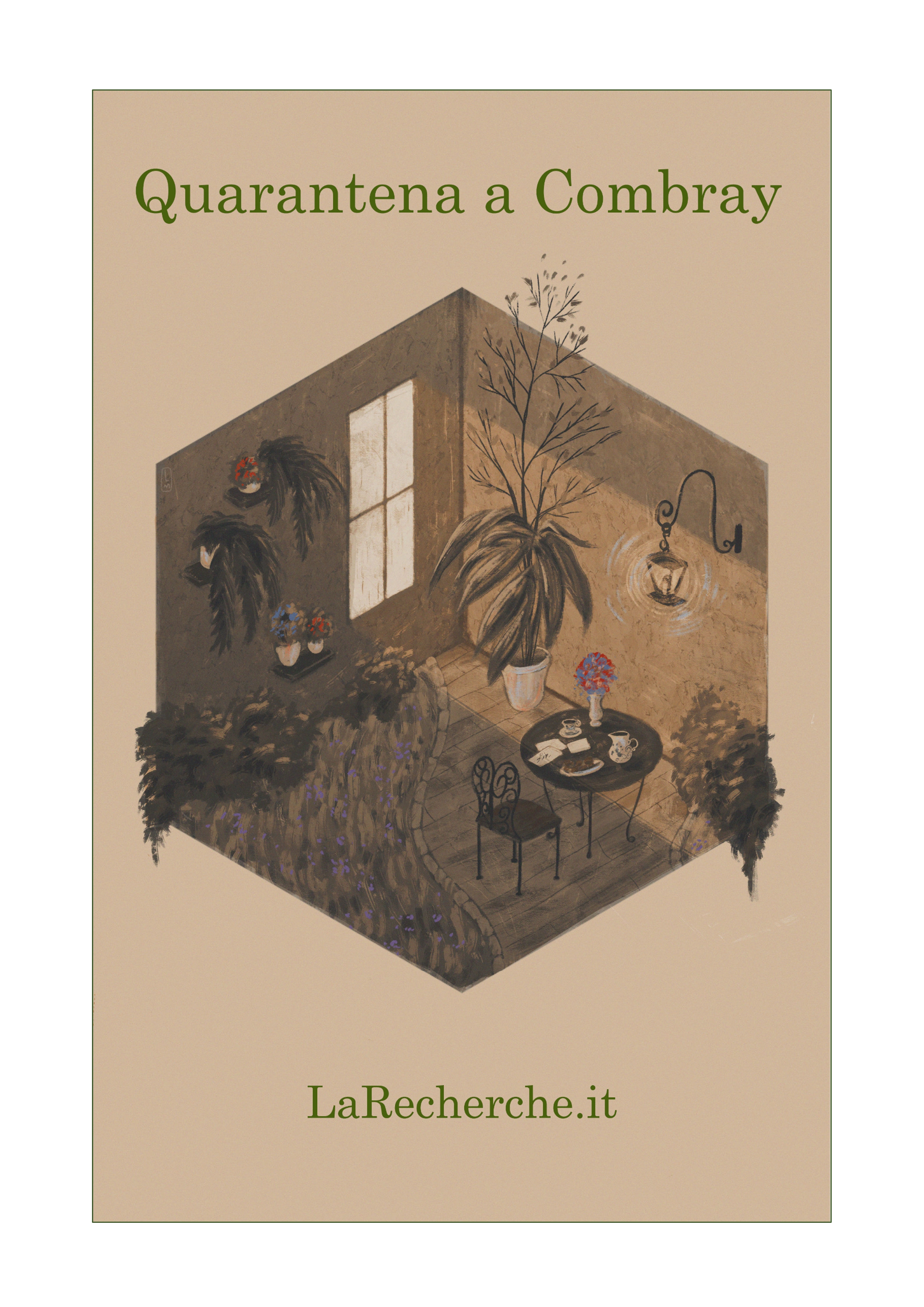chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Giuliano Brenna
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
Il dodo

mi sembrava di essere io stesso quello di cui
il libro si occupava: una chiesa, un quartetto…
M. Proust
Il giardino contiene le potenzialità inespresse di una abitazione.
La casa, la dimora di muri e suppellettili, rappresenta, in modo tangibile e concreto, l’ambiente di chi vi abita, i sentimenti e talvolta le contraddizioni. Le mura domestiche contengono il passato, il presente e creano le basi per il futuro. È il luogo che si sceglie per quello che riesce ad esprimere in termini di solidità, di concretezza, è l’alveo nel quale la vita scorre, tranquilla o tumultuosa ma comunque all’interno di un contenitore che si finisce per associare indelebilmente all’abitudine e da lì, per concretizzazione e stratificazione, all’essenza del sentimento legato al vivere. Invece il giardino, pur essendo cornice e sipario di ciò, resta, sia materialmente sia metaforicamente, esterno. Ma è ben lungi dal rappresentare un mero accessorio, esso incarna tutto l’inespresso e l’imponderabile. Dona una sfumatura, piuttosto decisa, di imprevedibilità, contraltare e contenitore più ampio del senso di abitudine. Il giardino è l’inespresso e l’imprevisto, ha una vita indipendente e propria rispetto alle mura domestiche e ai suoi abitanti, segue controvoglia le regole imposte, sia si desideri renderlo ben curato, o un semplice prato, aiole e alberi tendono a sfuggire all’ordine imposto da arredatori, architetti e appassionati. Nel giardino si annidano i sogni e le speranze: queste piante quando fioriranno saranno bellissime, oppure, avremo tanta ombra quest’anno. Ma il risultato è sempre differente dal previsto, c’è sempre un ramo che sfugge, una piantina che fa inopinatamente capolino. Così gli abitanti della casa si ritrovano con un inquilino che fa di testa sua, invade tutti gli spazi con la sua presenza o l’idea di essa.
Durante le ore della notte, quando la casa soggiace all’alternarsi di sonno e attività che i suoi abitanti impongono, i giardini diventano il luogo dove i sogni prendono forma, acquistano un corpo e un’esistenza tangibile e indipendente, gli abitanti delle ombre, escono allo scoperto e li animano di presenze inattese.
Un giovane francese, di una piccola città poco lontano da Chartres, una notte in cui il sonno, dopo averlo visitato ancor prima che i genitori finissero la cena, lo aveva abbandonato dopo poche ore, facendolo ritrovare desto e vigile nel suo letto nella casa silenziosa. Dopo qualche tentennamento aveva infilato le pantofole, deciso a prendere un libro da leggere per calmare i nervi che stavano iniziando ad essere imprudentemente sovraeccitati per l’improvviso risveglio. La rivalità fra due principî belligeranti stava abbandonando la mente del giovane e la realtà aveva preso la sua forma abituale, fatta di un caminetto, un divano e un alto scaffale colmo di libri. Come un richiamo da un mondo lontano, uno strano gracchiare aveva attirato l’attenzione del giovane, il quale, titubante, si era diretto verso la finestra, ma attraverso i listelli della persiana, la porzione di giardino che lo sguardo riusciva a percorrere, non aveva dimostrato nulla di strano. Visto che la notte era tiepida, aveva deciso di scendere le scale e uscire in giardino.
“Come si sta bene anche fuori con questa brezza tiepida.” I pesanti fiori delle ortensie sembrano salutarlo ondeggiando. Poi di nuovo il gracchiare, ancora più forte. “Proviene da quel cespuglio”, il ragazzo si dirige verso l’origine del suono, sente un frusciare e si ritrova di fronte uno strano uccello, il lungo becco ricurvo, le zampe tozze e corte e una livrea verde e arancione. “Un pollo gigante!” esclama. L’uccello emette di nuovo il suo verso gutturale, poi sembra schiarirsi la voce: “Pollo!?! A me? Come osi moccioso!” “Io ehm… scusa ma chi sei?” “Ma come? non mi riconosci? Sono un esemplare di Raphus cucullatus”. “Un che?” “Ma sì, dai, mi chiamano tutti Dodo, avrai sentito parlare di me…” Nella mente del giovane, in un turbinio di nebbiolina azzurra e parole sconnesse improvvisamente prendono forma i versi
«Il Dodo era solito andare in giro,
E prendere il sole e l’aria.
Il sole brilla ancora sul suo terreno natio –
Il Dodo non c’è più!
La voce che era solita starnazzare e squittire,
È ora per sempre muta –
Ma puoi vedere ancora il suo scheletro ed il suo becco,
Tutti nel mu-se-o.»
“Ma tu sei estinto?” “Cosa dici?” e col forte becco trancia un ramo di acacia con fare stizzito, “ma ti pare? Sono qua di fronte a te… sei uno sciocco e inoltre sei miope da far paura.” “Io ci vedo benissimo?”. “Sì, certo, ma non mi hai mai visto qua nel tuo giardino, ci abito da anni. Come il piccolo, si fa per dire piccolo, Gaspard.” “E chi sarebbe?” “Lui!” La punta dell’ala indica un buffo ometto che sta caracollando verso di loro. “Ah buonasera signorino Marcel”. “E voi, ehm, e tu chi sei?” “Sono Gaspard.” “Con quel berretto a punta e quegli stivali infangati, siete ben strano. Da dove venite?” “Da là” e indica l’aiuola della lavanda. “Sono un nano da giardino, il nano del giardino di questa casa.” “Io non vi ho mai visto.” Il dodo ridacchia sarcastico, “te l’avevo detto che sei miope.” “Cosa fai qua… nella tua vita nanesca? “Io sto apparentemente immobile a far compagnia a lumache e coccinelle, ma in realtà viaggio molto, ho fatto il giro del mondo varie volte.” “E oltre a quello cosa fai?” “Ah, la mia specialità è comune a quella di tutti i miei colleghi. Un nano da giardino vive in un solo giorno tutte le stagioni, perché avendole viste sempre dalla stessa prospettiva se le ricorda sempre tutte uguali ma sempre diverse ogni giorno in cui sorge il sole. Inoltre, come ti ho detto, viaggio molto.” “Com’è possibile con quei piedi di cemento?” “Tzé”, esclama il dodo, il nano riprende, “Viaggiare non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Insomma, per viaggiare non occorre spostarsi fisicamente, ma accostarsi alla realtà con occhi sempre nuovi.” “Ah!...” Marcel resta pensieroso a questa affermazione. L’arrivo di una tartaruga di gesso lo strappa dai suoi pensieri, “ohibò, eccone un’altra.” “Sì, infatti” lo rimbecca il Dodo, “ecco Mathilde.” “Sì sì, eccomi, anche oggi mi è toccato fare a gara con quel dannato Achille.” Gaspard la consola “Ma povera, ancora, dopo tutti questi anni?” “Ma sì, ma pure Zenone… non poteva usare un altro animale? Che ne so? Un’anatra?” Un vigoroso starnazzare proveniente dall’altro lato del muro di cinta ammutolisce Mathilde, “Ah è vero, Simone non gradisce, l’oca…” La voce ovattata giunge da dietro il muro: “Anatra, please…” “Sì sì…”. Improvvisamente il cielo si copre, si sente uno sferragliare di armi, urla e nitriti di cavalli. Gaspard e il Dodo sorridono con l’aria di chi la sa lunga, Mathilde si allontana lemme lemme, solo Marcel si stupisce: “Ohibò e chi sarà mai?” La campanella del cancello squilla a passo di carica, ecco Francesco I e Carlo V giungere duellando, alla vista di Marcel si fermano e inginocchiano, “Sire ci avete chiamati?” “Io io veramente…” le palpebre si appesantiscono, Mathilde, il dodo e i due principî si mettono a suonare un quartetto. Con una folata di vento una guida turistica entra dal cancello parlando con voce monocorde. “Il primo livello, è caratterizzato da archi a sesto acuto che sostengono il triforio (secondo livello), e nella parte superiore si trova la parete sulla quale compaiono le finestre, con sopra un rosone, che forniscono luce all’interno. Tali finestre presentano dei vetri colorati…” Il cielo si rabbuia velocemente, il giardino inizia a vorticare, tutto diventa grigiastro, poi nero. Si intravedono le braci di un fuoco, Marcel avverte il tepore delle coperte, la morbidezza del bacio del guanciale sulle sue gote e un peso sul petto… sorride fra sé, prende il libro che stava leggendo prima che il sonno lo cogliesse e lo posa sul comodino, cerca il lume cui spegnere la fiamma ma le membra si fanno pesanti e la coltre del sonno lo ricopre…
[ Racconto pubblicato in Quarantena a Combrat, LaRecherche.it ]
Id: 4888 Data: 11/07/2020 15:50:33
*
Il soffio del ricordo
Il vento fortissimo sembra essere il padrone incontrastato di Parigi, i viali sono pressoché deserti, anche gli alberi che da sempre li abitano sembra si vogliano sradicare e fuggire via. Quel che riescono a fare è solo flettersi paurosamente verso il terreno, agitare le chiome e gemere senza sosta. Fra le rade auto che si azzardano a percorrere le strade c’è una lunga e antiquata limousine nera, procede cauta flagellata da rami spezzati, fogli di giornale, tende strappate da chissà dove. Imbocca con un rombo sommesso Rue…. e si arresta quasi con un sospiro di sollievo di fronte al numero 26. Ne scende un giovane in livrea, il cappotto coi bottoni dorati ben serrati sino al collo, con una mano tiene fermo sulla testa il cappello che non riesce a contenere completamente la massa di capelli rossicci che iniziano ad agitarsi al vento e sembrano voler fuggire dal chepì scuro. Nell’altra mano il ragazzo ha una borsa rettangolare e piatta, di cuoio scuro, chiusa da due pesanti fibbie d’ottone; osserva i nomi sui campanelli e ne pigia deciso uno. Dopo qualche istante il portone si apre e il giovane può finalmente ripararsi dal vento, nell’androne semi buio e silenzioso. Sale la breve rampa di scale e con un vago sorriso apre la porta dell’ascensore. Si chiude nella gabbia di ferro e inizia a salire. Giunto a destinazione emerge dalle porte di metallo e bussa al portone che si trova di fronte. Scruta l’uomo che gli apre come se potesse trovare qualche traccia del suo nome nelle line del volto, si schiarisce la voce ed esclama “Devo consegnare una lettera al signor marchese Robert de Saint Loup en “Bray.” Aggiunge “siete voi, signore?” “No, non sono io, ma puoi dare la lettera a me, gliela consegnerò appena mi sarà possibile.” Il ragazzo apre la borsa e consegna la lettera. “Bene, i miei rispetti, signor…” “Morel, Charlie Morel, grazie a te, buon pomeriggio.” “Addio signor Morel.” Rientra nell’ascensore e sparisce ai piani inferiori. Morel rientra in casa, posa la busta sul coperchio del pianoforte e osserva la stanza in cui si trova. Tutti i mobili sono coperti da drappi bianchi, anche i lampadari sono chiusi in spessi sacchi di cotone grezzo, solo il pianoforte, addossato alla parete e scoperto e perfettamente lucidato. Su di esso un grande mazzo di tuberose colma l’atmosfera di una attesa calda e sensuale. Un divano è addossato alla parete, sulla quale le impronte dei quadri sembrano orbite vuote. Nello spazio lasciato libero dal divano, reso evidente dalla scoloritura del tappeto, sono posate due valige, una borsa ed un ombrello. Sulla parete in fondo alla stanza due porte, una socchiusa e l’altra, aperta, lascia indovinare una camera da letto. Un grande finestra coperta da leggere tende di tulle bianco illumina la stanza. Morel si siede al piano e inizia a suonare, dopo qualche minuto una delle porte si apre e appare sulla soglia un uomo abbigliato di una stoffa morbida e biancastra, di un tipo che raramente è dato vedere. Si ferma rapito ad ascoltare. Morel percepisce la presenza dell’uomo da una variazione dell’atmosfera, mentre le note del pianoforte sembrano il canto di una fenice che desideri liberarsi della necessità del fuoco. “Robert. Alla fine sei arrivato.” Si interrompe di colpo e le note che fino a quel momento riempivano l’aria della stanza sembrano scivolare tintinnando al suolo come una sottilissima lastra di cristallo andata in frantumi. Morel si alza, prende la lettera e la porge a Robert. “Ecco sei qui per questa, vero?” “Anche, per questa.” Lo corregge Robert mentre dissuggella la busta e legge svelto il biglietto che contiene. Morel si avvicina a Robert, lo abbraccia e le loro bocche si uniscono in un bacio appassionato. “Quanto ti ho cercato, Charlie, ho sfidato le linee nemiche con un coraggio che non mi riconoscevo per trovarti. Ma ogni volta sembrava che tu fossi appena andato via. O in procinto di arrivare ma che qualche fastidioso contrattempo ti impedisse di essere puntuale al nostro appuntamento.” “Sì, lo so Robert, e alla fine quello che non è giunto all’appuntamento sei stato tu.” Si stacca qualche centimetro da Robert e sfiora i buchi delle pallottole che punteggiano l’abito. Poi con un sospiro sfila la giacca dalle spalle di Robert, disfa il nodo della cravatta e con una calma solo apparente lo spoglia completamente, lo prende per mano per condurlo in camera da letto. Robert è piuttosto lento nel muoversi, forse stupefatto, o forse vuole frenare un’irruenza che sente nascergli nel petto. Anche qui tutti i mobili sono avvolti da drappi bianchi, solo quelli sui tavolini accanto al letto sono color malva, il letto, invece è completamente libero, perfettamente ed elegantemente abbigliato di morbida fiandra ricamata. Robert si stende sul letto mentre Charlie veloce si libera degli abiti poi si stende accanto all’amico. Il corpo di Robert è bianchissimo, nei punti in cui è stato trapassato dalla baionetta del nemico addirittura trasparente. Le labbra sono esangui, solo gli occhi lampeggiano dardi azzurri. Charlie abbraccia Robert, si baciano appassionati, iniziano ad amarsi con veemenza, un trasporto che ha l’intensità dell’ineluttabile screziato dalla consapevolezza che di lì a poco potrebbe non accadere più niente. Le membra di Robert diventano estremamente agili e sciolte, la pelle acquista un bel colore rosato, punteggiato di carminio qua e là, dove le attenzioni di Morel si sono fatte più decise. Fuori della stanza il vento si è fatto ancora più forte, si sentono persiane sbattere e comignoli ululare, dalle finestre filtra un lucore biancastro; i due amanti non se ne curano, esistono solo loro, al di là di tutte le epoche, tutte le dimensioni, dimentichi di pettegolezzi e fatti cruciali. Il loro orgasmo arriva prepotente e simultaneo, nello stesso istante un forte bagliore e un tuono fortissimo rubano il loro urlo di piacere. Appena i loro cuori si acquietano cadono in un breve sonno, Charlie è il primo a risvegliarsi, di soprassalto, allunga la mano e nel sentire il corpo di Robert ancora accanto al suo ha un sorriso di sollievo, spontaneo e che lo riempie di gioia. Percorre con un dito la linea che dalla fronte scivola verso la punta del naso, si ferma sull’estremità e sussurra in un sorriso, “il celebre profilo Guermantes.” Robert bofonchia nel sonno, poi lentamente il celeste del suo sguardo sembra risorgere da luoghi lontanissimi. “Si sta facendo tardi Charlie.” “Hai sempre preferito il piccolo Marcel, vero?” “Ma no, ma cosa dici, tu piuttosto non lo hai mai sopportato, perché?” “Mah, forse perché era sempre lì con quel suo sguardo pensoso che sembrava riandare a mio padre, che lui conosceva bene, per rinfacciarmi le mie origini.” “Io non credo abbia mai voluto farlo, forse era semplicemente curioso. Sai come amava capire il profondo delle persone.” “Sì, credo di sì, ma insomma lui sapeva un sacco di cose di me, e sembra che poi le abbia anche raccontate in giro, insieme ad un sacco di fandonie su tutte le persone più in vista di Parigi.” “Fandonie non direi, lui ha saputo, come nessuno, vedere l’animo delle persone, capire cosa albergava nel petto di ciascuno. È riuscito ad andare molto oltre titoli, dinastie e, perché no, gusti…” Guarda Morel e lo bacia affettuosamente sulla bocca, le loro lingue si inseguono per qualche momento mentre fuori il tuono brontola sommesso. Da lontano giungono i battiti di un campanile. “Il tempo corre mio caro Charlie. Ma insomma, alla fine non ci siamo trovati al fronte ma so che tu ti sei distinto.” “Inizialmente non tanto.” Ridacchia Morel. “Ma poi per non fare la figuraccia del disertore e per via di certi giri di persone sono stato inviato al fronte e pensa un po’, quella famosa onorificenza che il tuo caro zietto Palaméde voleva farmi avere per certi servizi, ehm… poco eroici, o…” Saint loup. “O, vista la sua mole forse ancor più eroici…” “Ma dai non essere crudele… Insomma, la croce di guerra alla fine l’ho avuta proprio al fronte.” “Forza, dobbiamo alzarci” Saint Loup si alza, scosta i drappi da un armadio, apre le ante per prendere l’abito da indossare. Morel nel frattempo si veste rapidamente e torna nell’altra stanza, imbraccia il violino. Inizia a suonare, dalla camera da letto gli giunge la voce di Saint Loup: “ah la piccola sonata… diavolo di un Vinteuil ne ha fatti di disastri con la sua musica. Una musica che ha accompagnato tanti bei momenti, le feste, le serate scintillanti, vero Charlie, come eravamo allegri e quanta vita pensavamo di avere davanti a noi.” Morel non risponde, è assorto nella musica e non bada a frenare le lacrime che gli scorrono sulle guance. “Eccomi!” Esclama Saint Loup entrando nella stanza con la divisa da ufficiale addosso. “Un attimo.” Charlie torna nella camera da letto a vestirsi. Dopo qualche attimo torna accanto a Saint Loup. “Ti manca una cosa…” Mette la mano nella tasca e la riapre davanti gli occhi attoniti di Saint Loup. “Ecco la tua croce di guerra, pensavi di averla persa, ma io l’avevo trovata.” Gliela appunta al petto e lo bacia sulla fronte. Sentono bussare alla porta, Charlie apre e fa entrare monsieur Aimé. “Buona sera signori. Ma cosa fate al buio?” Accende una lampada. “Signor Marchese l’auto la attende, andiamo.” Saint Loup si getta il mantello sulle spalle, calza il berretto si volta verso Morel al quale rivolge il saluto militare a Morel, i loro occhi sono fusi in una lacrima, poi l’incantesimo si scioglie. Addio Charlie, grazie…” si confonde, lo sguardo gli si vela di un indistinto colore grigiastro. Poi tornano fulgidi. “Addio Charlie. Andiamo Aimé.” I due escono dalla stanza, Aimé si chiude delicatamente la porta alle spalle. Dopo qualche minuto, Morel, da dietro la finestra chiusa guarda la strada ormai buia, una pioggia battente cade formando lunghe striature sui vetri. Le leggere tende mosse dagli spifferi della finestra lo accarezzano dolcemente, Morel se ne lascia avvolgere. Tra le volute mobili del tulle gli giunge una voce familiare. “Se n’è andato?” Nel lento movimento le tende gli rivelano la figura di una donna al suo fianco. “Sì, questa volta temo per sempre. Ma tu, Albertine non sei stata invitata?” “No, Charlie. So che ha quel dannato biglietto ancora in tasca, potrebbe ancora farmelo recapitare ma sa troppo bene che io sono pronta a tornare e questo mio essere qua per lui, ad aspettare un suo cenno, lo rende quasi insensibile a me. Allo stesso se io andassi ora da lui gli sarei indifferente. Egli mi ama solo nel mio essere irraggiungibile. Così io devo restare un fulgido astro incatenato in una eterna fuga.” Charlie apre la finestra e rapidamente trae a sé le persiane, richiude con cura la finestra, poi accosta anche gli scuri, si infila il cappotto. Albertine indossa il suo mantello Fortuny più bello, prende la mano di Morel e le aquile dei loro anelli per un istante guizzano nella luce per pochi istanti. Morel si infila il cappotto, calza il cappello raccoglie la sua valigia e il violino e spegne la lampada. La stanza rimane nell’oscurità per qualche istante, fino a che Morel apre la porta e la luce del pianerottolo disegna un rettangolo d’oro sul tappeto della stanza. Albertine lo percorre con le sue scarpe di raso, senza emettere alcun suono. Guarda Morel che l’attende per chiudere la porta, Albertine accosta l’indice al naso nel segno di chi richiede silenzio e si ferma. Charlie in un attimo capisce, si tocca la tesa del cappello e chiude la porta. Albertine ascolta le mandate del catenaccio, poi l’ascensore sferragliare e infine si lascia cadere su di una poltrona.
racconto pubblicato nell'antologia proustiana 2019 "Una notte magica"
Id: 4878 Data: 04/07/2020 13:33:32
*
Gare Avenue de Saint-Ouen – Louanges profanes
Attraverso rapido il Boulevard des Maréchaux lasciandomi alle spalle il chiacchiericcio di un bistrot e i quattro sfaccendati che si gustano i raggi del sole primaverile, insieme alle macchie d’inchiostro del quotidiano appena stampato e qualche goccia di Pastis, che colora appena l’acqua, come le vaghe nuvole che rappezzano stanche il cielo questa mattina. Oltrepasso la breve hall della stazione e proseguo a passo deciso sulla scalinata dritta che scende al binario. Controllo l’orologio, le 10:27, e già sento il piccolo convoglio sferragliare scivolando sotto la stazione mentre viene ad allungarsi ai miei piedi. Mi siedo accanto ad un finestrino, il cappello e il bastone si accomodano nella retina, i guanti li tengo, non si sa mai quali e quante mani sono passate qua prima di me, e i miei polmoni già sono in subbuglio per l’enorme quantità di polvere che si muove nell’aria, piccole volute minacciose si aggrovigliano placide nelle strisce di sole, filtrate dagli alberi lungo la ferrovia, mutevoli nel procedere del vagone mentre si avvicina ad un austero cartello che informa che il brutto edificio di mattoni che sta sorgendo all’orizzonte è solo la stazione di Saint-Denis. Mi sfilo i guanti ma non so risolvermi se posarli sulla retina, metterli nella borsa o continuare, come sto facendo, a muoverli qua e là nel pugno destro, come la corrente quando cerca di portar via le ninfee, forte della primavera che ne ingrossa la portata. Assorto in fuggevoli pensieri mi porto i guanti al viso e, da qualche luogo remoto dei viali parigini, da qualche salotto ancora sigillato dal maltempo, mi giungono soavi squilli di campanelli d’oro, è l’essenza di neroli che si stira di fronte i miei sensi stupiti, ne posso quasi avvertire il gusto liscio sul palato. La mente si affretta a trovare una collocazione a questo sentore, passa in rassegna pouf e divani, guarda incedere maestose aigrettes e zinali fuggire via discreti. Ai fiori candidi si affianca improvvisa la cremosità del giglio bianco, insieme evocano i biancospini; ma non quelli vivi e quasi sanguinanti delle siepi della mia infanzia, ne avverto i sospiri rinchiusi in un segretissimo sachet, li sento cinguettare fitti con il benzoino, rimbrottati solo il giusto, e per non essere dimenticata, dalla pimenta racemosa. Dietro le mie palpebre, appena appesantite da una invincibile spossatezza, s’affaccia l’origine delle spiraleggianti volute. Attraverso un flacone trasparente di angoli retti, dalle linee tese e contrassegnato appena da un numero, riappare quell’ultimo giorno: dietro le persiane trapuntate dalla luce del pomeriggio, la sua camicia di lino appena gualcita dal segno che ancora tentenna sul lenzuolo, neanche scostato dall’impellenza dell’incontro. Il braccio che mi porta da un passato che contiene tutti i tempi, tutte le genti, i guerrieri di Sparta, tutte le volute d’incenso che si sono levate per salutare vittorie o sconfitte improvvise, cedimenti, o vette conquistate con l’impudenza di un piano ben congegnato, la sua mano a schiudersi sul mio viso, le punte delle dita come una lingua inventata per celebrare con odi profane il momento. Il palmo della mano si apre come un anemone di mare sulla mia guancia che ne sugge tutto il calore, la pelle a leggere la fitta rete di misteri che scivolano con i globuli rossi nella circolazione, misteriosi ed invisibili convogli che si intersecano su minuscole ferrovie in grado di trasportare montagne, astri, sistemi di vite, segreti di esistenze obbligate a circolare in maniera interminabile, a nutrire un cuore che - come la stazione di Belleville-Villette, che si sta approssimando al mio viaggio, - ha bisogno di inferriate ed un cancello, pronti a proteggere chi sale e scende dal vagone. La polvere che sentivo negli occhi mi diceva che quei cancelli si sarebbero aperti di li a poco, il treno sarebbe ripartito tra fischi e sbuffi nel suo immutabile circolo attorno al cuore pulsante della città. Ma io me ne stavo allontanando per sempre, i cancelli non si sarebbero dischiusi rischiando di lasciar entrare il chiacchiericcio che accomuna serve e baronesse, il convoglio deve circolare su binari sgombri da immondizia, celandosi durante il suo tragitto in brevi gallerie, ma potendosi gloriare del pieno sole in altri tratti. E i raggi del glorioso astro sgranati dalle imposte stavano bruciando la mia guancia, quel pomeriggio in una stanza poco distante la stazione di Ménilmontant, accompagnati dall’effluvio della sua pelle, le cui misteriose particelle ancora punteggiano il mio guanto. Ogni volta che ne aspiro il ricordo, forte risale dai fondali dell’esistenza il ricordo doloroso. Dal paese dei Cimmeri riappare minacciosa quell’ombra che mi fa cenno di seguirla, ombra cui ho resistito solo nell’apparenza, ma che si è presa il respiro, oggi appena sufficiente ad alimentare il pensiero, i ricordi e qualche uscita pianificata con mille difficoltà e un anticipo talmente vasto da potervi far crescere la pianta velenosa dell’abbandono e della reticenza. Sbatto le palpebre per il sole che ora attraversa le fronde alla stazione di Charonne, rapida passa tra la rètina e i pensieri più reconditi l’immagine dei tigli sotto i quali passeggiavi svelto sul viottolo del bois verso il Jardin d’acclimatation, lasciando dietro di te particelle di aria profumate di gelsomino e menta, come se una folata di vento caldo, attraversando un accampamento di nomadi del deserto intenti a preparare un tè, ti avesse raggiunto e circondato festosa per accompagnarti in quella rapida passeggiata - quasi fuori stagione - ma che segnava l’inizio di un tempo ben più duraturo per i miei sensi. Lessi avido il tuo alito appena accelerato dalla camminata veloce e dalla paura di essere visti tra i cespugli in cui sbocciarono i nostri primi baci, e lo smarrimento nelle tue iridi clandestine, il dovere ti richiamava appena subito dopo l’averti congedato; io ti seguii, cercando di racchiudere nella mia mente quante più sfumature di aria, densità di colori, tonalità di silenzi che ti lasciavi dietro fendendo il pomeriggio. Quella buffa stazioncina che ancora ricordava l’allevamento di volatili utili allo svago di qualche testa coronata, molto pretenziosa, col suo bravo orologio e la cupola a scimmiottare ben altri sfarzi e ingegni architettonici, ti aveva inghiottito, ma le maglie del tempo, che - si sa - non sono tutte fitte e identiche, ci avevano regalato una sospensione di pochi attimi durante i quali eri riuscito in un soffio a sussurrare il tuo nome, o forse il nome di una stazione. O forse entrambi, tant’è che accanto a quella stazione ti ritrovai il giorno seguente e quello seguente ancora, sino a quello che non ebbe mai seguito, ma l’addio avvenne nei pressi di un’altra delle fermate della petite ceinture, quasi a preservare la purezza di quella che portava, storpiandolo, il tuo nome. Ed è qui che mi sto dirigendo con il tuo profumo sui miei guanti e una camelia nella mia borsa, e che non posso appuntare al bavero perché è destinata a te, a racchiudere il ricordo delle linee del tuo corpo, una sinuosa dall’orecchio al pomo d’Adamo, una più tesa che, agguantato dall’altra il testimone appena sotto il mento, scende tesa e maestosa lungo il petto, fende il ventre e si perde nella maestà della tua essenza più intima. Come al solito percorro a passi lenti il viale, poi svolto in Boulevard Picpus, costeggio il muro della antica e consacrata magione finché, riparato da una rientranza del muro, getto la camelia oltre il bastione. Da qualche parte, in un’altra vita, una fanciulla compiva lo stesso percorso per essere preservata e poter fiorire a tempo debito, così spero che anche il mio fiore protetto dalle insidie del mondo possa un giorno tornare a me, maturo e pronto per essere mostrato.
Indugio un poco e ripercorro i miei passi, dal giardino celato dal muraglione, giungono folate di iris e un vago suono, appena distinguibile, quando il vento gira in mio favore riconosco la voce familiare di qualche strumento e un rapido succedersi di note; in fondo, penso, non senza un sorriso che mi increspa appena il labbro ma riverbera con una certa forza nella mia mente, spesso la visione più bella che resta di un’opera è quella librata sulle stonature di un piano scordato strappate da dita maldestre*.
Il fischio austero e familiare mi avverte che sono giunto nei pressi delle orribili cisterne che costellano la piccola stazione il cui nome risplende a lettere d’oro, lanciate in cielo da una divinità dall’animo generoso a formare una costellazione, imperitura direzione per una esistenza. Nel mio cuore, solo lì.
* Dalla parte di Swann
[ Racconto secondo classificato al Premio Nazionale di Poesia e Narrativa "Città di Conza della Campania" V edizione 2019 - sezione racconto breve edito o inedito a tema libero ]
Id: 4679 Data: 10/10/2019 15:22:37
*
Interno parigino
Albertine venne ad aprirmi alla prima scampanellata, ma la cosa fu piuttosto complicata, perché Françoise era fuori e Albertine non sapeva dove accendere. Alla fine riuscì a farmi entrare, ma i fiori di filadelfo la misero in fuga. Li posai in cucina, così che la mia amica, interrompendo (non capii perché) la sua lettera, ebbe il tempo d’andare in camera mia, da dove mi chiamò e di stendersi sul mio letto. *
L’iris prigioniero
Mio caro Marcel,
se solo il tempo offrisse un’altra possibilità, diversa, non necessariamente migliore, o se all’interno di una unica scelta si potessero serbare delle parti e renderle immortali, slegate dallo sfacelo che colpisce le altre. E se non vi è un’altra possibilità vorrei poter salvare qualcosa, riuscire a trasformare qualche atomo di decadimento per far sì che tutto non si possa rivelare inutile. Mi accorgo che è giunto il mattino dalle strisce chiare che si incidono nel nero della finestra, ancora qualche momento e potrò smettere di fingere di dormire per ricominciare a fingere di vivere. Questa mattina la luce porta con sé qualche grado di temperatura, la primavera sta decisamente sciogliendosi nell’estate, gli iris staranno decomponendosi sui loro steli, là, da qualche parte nel mondo libero. Il loro colore sta sicuramente già scivolando verso sfumature cineree, gli steli si fanno gonfi e fragili come se l’aver prodotto un pezzetto di arcobaleno li abbia sfiancati, e il leggiadro profumo diventa quasi un veleno per i sensi, capace di ottundere le menti e portarle a sciocchezze inusitate. Ma loro serbano, in segreto, qualcosa che non si può cogliere, un segreto che chi strappa gli steli per farne composizioni non può notare; qualcosa che chi crede di ingabbiare il segreto della bellezza degli iris non sospetta. Proprio come me, fatta prigioniera, rinchiusa, recisa per ammirarne bellezza e fragranza; vorrei che almeno la parte più recondita di me, la mia radice di donna possa essere come la radice degli iris capace di celare un segreto insospettabile ed evocativo di ciò che sono stati, liberi da finzioni. Nei rizomi delle radici è racchiusa la loro forza e il loro segreto, quella peculiarità, oserei dire ricchezza, che non si nota, e per questo non si desidera cogliere o imprigionare, e invece è la cosa più preziosa ancorché sfuggente. È addirittura capace di farsi passare per straniero, gli si affibbia un nome che riecheggia il suo ed ecco fatto, da iris a Orris, il segreto è salvo e i tentativi di farlo prigioniero si fanno vani. Già, anche io ormai sto per sfiorire, tutto il miele e la bellezza che mi circondano consumano il mio ossigeno, mutano il mio colore in una tinta degna di Ade.
La mia stanza è ormai in piena luce, mi alzo e mi getto sulle spalle il mantello decorato con scene di una Venezia che appartiene solo all’oblio, giungo nel salotto al cospetto del suo popolo silenzioso, fatto di austere poltrone in pelle. Il sole, nel suo percorso, insinua le sue agili dita fra le tende giungendo a sfiorarle col suo calore luminoso e questo tocco le fa quasi trasalire e vibrare del loro sentore più animale. Che è il mio richiamo verso la natura libera, i miei polpastrelli ne seguono la liscia perfezione ottenuta dai conciatori e il ricordo della sella di un cavallo mi fa rabbrividire. Per il mio olfatto, e con esso le parti più recondite dei miei ricordi, questa fragranza animale richiama una corsa senza freni, non come la tuberosa o il filadelfo il cui sentore invece è per me come le sbarre di una prigione. E ricordo quella volta che me ne portasti un fascio e per poco non soffocai, ma riuscii a fare qualcosa di cui, finché non ti sono sfuggita, non hai mai sospettato, ma solo avendomi remissiva e docile hai iniziato a comprenderne la portata. Ora so di questi tuoi progetti di lasciarmi che si vanificheranno non appena saranno possibili, in un eterno rincorrersi di gelosia che nutre l’angoscia e con essa il legame, in alternanza alla tranquilla serenità che, come marea che si ritira, lascia intravvedere la striscia di sabbia che è la salvezza di chi resta imprigionato tra gli scogli. E non bastano l’ozono del mare, la luce del sole a dare la speranza della salvezza, serve l’ebbrezza del sentire la riva vicina. Il balsamo dei pini, il richiamo delle rose fiorite appena oltre la macchia che circonda la spiaggia, il sentore della vaniglia che colora di tenui tinte l’aria di una mattina carica di buoni propositi bastano a far sentire il prigioniero degli scogli con un piede già sulla soglia di casa. Però, appena la via di fuga è resa possibile dal moto della marea, risorge il panico, il terrore di essere proprio in quel punto e di avere rischiato di restare schiacciato tra i massi affiorati, soffocato dall’apporto acre delle alghe al già temibile sentore muschiato e salmastro del luogo E così è per noi, le nostre vite al sicuro ci incutono terrore, ci spaventa il poter stare bene, aver quel poco che ci può rendere felici ma che un nonnulla ci può strappare e gettare lontano. E allora tu scegli la via del dolore, sicura e affidabile, la sola che non può tradire perché di tradimento è lastricata, è il dolore ad essere immortale, capace di intorpidire la mente al punto da farla sentire sollevata anche dai lenimenti del più umile e blando balsamo. Tu credi che io non sappia di come mi fai spiare, di come ogni mia mossa sia passata al vaglio per tutte le interminabili ramificazioni della tua insonnia. Ma se tu mi avessi sarebbe ancor più doloroso doversi accontentare, dover terminare la ricerca della perfezione, cullati nella mediocrità della serenità. Come più è variopinta e cangiante la sofferenza della gelosia, si nutre di poco, di qualche seme di serenità che nel vuoto esplode fragoroso per poi ricostruire intatto ed ancor più forte il dolore che accorre a estinguere la fiammella della speranza con tonnellate di dubbi, di conferme dolorose, di sospetti esasperanti, elucubrazioni, corse a ritroso nella memoria. Sotto le mie dita questo cuoio della poltrona già freme come i finimenti di un cavallo in corsa verso l’unica cosa sincera, reale, completa, che non ha bisogno di sospetti, regge qualunque confronto con ciò che è stato e con ciò che avrebbe potuto essere. Nelle valige, anch’esse di cuoio, che Françoise mi sta portando metterò solo i profumi di questa mia prigionia, perché tra poco anche io sarò solo un ricordo olfattivo, ogni cosa che sarà stata in contatto con me e con la nostra vita insieme, ogni qual volta che passerà sotto il tuo naso, sarà in grado di ricreare tutto il mondo che abbiamo voluto distruggere per riuscire ad amarci. Sarò l’aria del mare e il decadere delle alghe sulla spiaggia di Balbec al mattino, il tabacco e l’assenzio delle matinée al casino, mischiato alla mimosa dietro la quale giocavamo a furetto con la piccola banda. Mi ritroverai in ogni pompelmo del mattino al tavolo dietro la vetrata del Grand Hotel, insieme al gelsomino e alla lavanda che illuminano di pulito la biancheria passata nelle mani di Françoise. Porto via con me il cuoio delle valige e il sentore dei miei amati cavalli, insieme al muschio e all’ambra di questa bella dimora in cui riecheggiano i richiami dei venditori ambulanti o il campanello dei tram, ma non riecheggia mai la parola amore. L’unico fiore che non è mai sbocciato in questo giardino rampicante cresciuto su delle rovine, come le cattedrali che mi portavi a dipingere per illuderti che una vita più spirituale avrebbe spento il mio lato ferino, pensavi che appiattendo il mondo su di una tela avremmo potuto privarlo di una dimensione, quella del dolore, che invece fiorisce in ogni angolo. Ed ora eccomi iris sfiorito, reso molle e pesante dall’estate che scalda troppo l’aria, ma nel fresco del sottosuolo c’è un rizoma che conserva la parte più preziosa di me e che resterà per sempre con te, dovrai aspettare, pulire la radice, saperla lavorare e vedrai che alla fine ti avrò donato qualcosa di immortale e che tutti ammireranno. Ti lascio ora che l’aria profuma di benzina, di motore, della velocità e dello spostamento che tanto bramavi e ti proponevi una volta che avresti trovato la forza di lasciarmi, io lo faccio invece lentamente, facendo maturare qualcosa che di me sarà sempre tuo, me ne vado con una valigia in una mano e il profumo di cuoio e legno lucido nei ricordi.
Ripenso a quella mattina che ti rese tanto felice; quella mattina la cui luce portava con sé qualche grado di temperatura, la primavera stava decisamente sciogliendosi nell’estate.
Addio, tua
Albertine
La bella stagione, quella notte, fece un balzo in avanti, come un termometro che il caldo fa salire. Quando mi svegliai, dal mio letto, in quelle mattine presto rideste di primavera, sentivo i tram passare attraverso i profumi nell’aria cui sempre più si miscelava il calore, sino ad arrivare alla solidificazione e alla densità del mezzogiorno.*
*Alla ricerca del tempo perduto – La prigioniera, Marcel Proust, I meridiani (Mondadori) Traduzione di Giovanni Raboni
Racconto pubblicato in "Proust N. 7 - Il profumo del tempo.
Id: 4242 Data: 18/07/2018 13:13:15
*
Thy Kingdom [of dreams] come
Angélique percorre con passo spedito il vicolo acciottolato, appena sbuca sulla piazza della cattedrale si abbassa la pesante veletta nera sino al mento e si stringe nel leggero scialle che le cinge le spalle. Socchiude gli occhi e inala i sentori imprigionati nei tessuti creando attorno a lei una sorta di amnio ronzante dei profumi che la fanno sentire a casa. Si sente circondata dal sentore delle rose che non mancano mai sul comò della camera da letto, accanto a un ritratto del suo povero Edouard, salpato una mattina come tante con il suo peschereccio con la speranza, che sempre lo accompagnava, di tornare con la stiva piena di pesci. Malauguratamente un pomeriggio di un anno prima il piccolo vascello era tornato senza pesci, come talvolta accadeva, ma anche senza pescatore, e così ad Angélique anziché saltare una cena da quel giorno le era toccato saltare una vita. Dalla veletta sente spandersi l’ambra appena talcata dei suoi cassetti che, chissà come, oggi sembra essersi mescolata con la cannella, che sta abitualmente riposta in un barattolo nella credenza, e con quel sentore di cedro e vetiver che sentiva addosso al suo defunto marito la domenica, quando si preparavano per la abituale passeggiata sul corso della città. Ora che lui non c’è, non restano che poche molecole imprigionate fra le fibre della sua veletta, forse anche sui guanti; il profumo acuisce il ricordo e, con esso, il desiderio che la tiene desta durante tante interminabili notti, ad ascoltare il rombo del mare, a desiderare che qualcuno torni, o che qualcuno arrivi. Angélique sa di essere in ritardo per la funzione, vede le ultime donne uscite dalla cattedrale attardarsi a chiacchierare in piccoli capannelli qua e là sul sagrato, come macchie di inchiostro sul marmo reso opalescente dal forte sole del tardo mattino. Al passaggio di Angélique alcune di queste donne la indicano mute con lo sguardo, altre si voltano per non dover essere toccate dal terribile dolore di quella donna che solo abbassa gli occhi stringendo le labbra, come a reprimere uno spasmo. Passando nota di sfuggita una figura seduta sui pochi scalini della cattedrale, la oltrepassa serbando nell’angolo della visuale un’ombra di colore scuro che per pochi fuggevoli istanti le richiama alla mente lo storace, poi è nel buio. Sosta accanto alla conchiglia di marmo in cui intinge le dita mentre gli occhi le si abituano alla mutata luminosità, osserva incantata fragili lamine di luce multicolore fendere l’oscurità, resa densa e massiccia da ampie volute di incenso che si muovono lente verso l’alto donando una diversa intensità alla penombra che permea il luogo. Alcuni frammenti di luce azzurra si posano sulle panche verso cui si sta avvicinando facendole fiorire dei mille ronzii della cera balsamica di ambra e pepe nero. Accompagnata dai sentori percorre la navata avvicinandosi all’altare, crede di essere sola, poi nota un sacerdote, avvolto di gabardine nera, allontanarsi svelto dal confessionale smuovendo le pigre volute di incenso con improvvisi luccichii di verde galbano e bergamotto, sparisce nella sacrestia lasciando Angélique sola, seduta su di una panca a cercare un po’ di pace che oggi sembra tardare tanto a portarle conforto. Dall’altare invece che l’elevazione dei pensieri le giunge, da iris e tuberose, il sentore dolciastro del decadimento che sembra far scivolare di continuo i pensieri della donna verso direzioni inattese. Cerca di sgranare le familiari parole delle orazioni, ma i suoi sensi sono stranamente vigili, nota i cambiamenti di intensità della luce, sente il rintocco dell’ora e la porta alle sue spalle chiudersi con un tonfo sommesso seguito da un grappolo di passi veloci che si arrestano poco distante da lei. Immagina sia la solita pia donna che viene a recitare il rosario per il marito malato o per il figlio lontano e non ancora tornato. Non è molto che la guerra è terminata e c’è ancora chi spera di potersi ricongiungere coi propri cari sbatacchiati qua e là per l’Europa martoriata. Vinta dalla curiosità si gira un istante e riconosce la sagoma che aveva notato entrando nella cattedrale, poi si volta, sistema la pesante gonna scura mentre si inginocchia per tentare di trovare la concentrazione necessaria per invocare la pace su di sé e sull’anima del marito. Un nuovo scalpiccio alle sue spalle e una improvvisa ventata di spezie esotiche, tra cui brillano violacei dei fiori di zafferano avvertono Angélique, che l’uomo si è seduto alle sue spalle, nel pulviscolo che la circonda si insinuano note di alberi con radici lontane e nomi inimmaginabili, così come gli strani pensieri che questi aromi le insinuano nella mente. D’un tratto sente la mano dell’uomo sfiorare la sua spalla, accompagnata da sillabe in un idioma incomprensibile, poi l’uomo s’alza e si dirige verso la fine del transetto. Lo guarda, ne soppesa l’andatura, le spalle robuste, il passo determinato, l’uomo si ferma a guardarla poi sparisce dietro la spessa e polverosa tenda viola del confessionale. Angélique si sente gelare il sangue, poi avvampare, la testa le ronza un po’ ma un istinto animale la spinge ad alzarsi e a guadagnare in fretta il confessionale, ne scosta appena la tenda e vi si insinua. L’uomo la sta aspettando, è di fronte a lei, la camicia sbottonata da cui si spande, mischiato ad un vago e caldo afrore maschile, il sentore degli abiti, ad Angélique giungono le deliziose note del patchouli tra cui emerge improvviso il sussurro del vetiver, che la riporta a qualche momento prima, lungo la strada, poi ancora più indietro, quel profumo le giunge dal passato, da Edouard. Tentenna, poi si getta fra le braccia dello sconosciuto. L’uomo le alza lesto le pesanti gonne nere e la fa sua, i movimenti stentano a contenere una urgenza imperiosa ma hanno una fermezza assorta, quasi di calma lustrale. Angélique gli si arrende, non può farne a meno, le loro carni sono unite, i loro profumi si mescolano mentre le pigre volute di incenso li avvolgono, celando il loro segreto. Dopo il piacere l’uomo lascia andare un lungo sospiro profumato di dolce cannella, la bacia sulle labbra e mentre si riabbottona la camicia Angelique nota sul petto dell’uomo un tatuaggio, la luce è flebile, aguzza la vista. Il disegno mostra una nave avvolta dai tentacoli di una piovra gigantesca, a incorniciare la scena un cartiglio col nome della nave. La donna si mette la mano davanti alla bocca, sgrana gli occhi, la nave si chiama Ambrosine. La nave di Edouard. Angélique esce rapidamente dal confessionale, a lunghi passi raggiunge l’uscita e si tuffa nella luce del primo pomeriggio, chi è costui?, si domanda, da dove giunge?, e cosa significa la sua apparizione? Attraversa il sagrato con il tatuaggio appena visto ancora negli occhi, non se lo può togliere dalla mente, come l’ombra di un maleficio, o il timore di esso. Il cartiglio con il nome della nave inciso nella pelle ambrata dell’uomo domina i pensieri tumultuosi di Angélique. Si riabbassa la pesante veletta, torna nella sua sfera di aromi familiari ma in essi si è insinuata la nota amara del pepe, così come nei suoi pensieri.
Racconto pubblicato in Proust N. 7 - Il profumo del tempo, di Aa.Vv.
Id: 4235 Data: 12/07/2018 09:16:54
*
L’orfanotrofio
Ho vissuto i primi anni della mia vita in un piccolo orfanotrofio di provincia, una casa modesta circondata da prati senza fissa dimora e terreni incolti, nonostante ciò la cosa più incolta dei dintorni era proprio quella casa. Ci abitavano, con uno spirito di stagnante provvisorietà, oltre a me, i miei genitori e mio fratello, tutti orfani, gli uni degli altri. I giorni trascorrevano lenti, privi di agilità, come un vecchio maglione infeltrito quasi impresentabile, molto pesante ma incapace di riscaldare. Il capo dell’orfanotrofio era – indiscutibilmente – mio padre, anche perché il più capace di conservare e preservare l’assenza di rapporti fra i vari membri del piccolo gruppo. Egli non aveva stabilito regole, perché il solo fatto di pensarle avrebbe significato prendere in considerazione l’altro, attribuirgli una presenza che non si riteneva possibile, o tollerabile. Alla fine l’unica regola, appresa per esperienza e per sopravvivenza, fu quella di scomparire. Non è facile scomparire fra tre locali angusti e un interminabile corridoio, simbolo della casa stessa: entri e percorri un lungo cammino senza andare in alcun posto. Cominciai a mimetizzarmi fra le poltrone, dietro una porta, talvolta sotto al letto. Trattenendo il fiato, per non farmi sentire, più spesso trattenendo i pensieri, prodotto pernicioso che avrebbe potuto turbare l’angusta stabilità dell’augusto consesso. L’unica via di fuga verso l’esterno era rappresentata dalle finestre, velate da tende, come sudari stesi su desideri in fin di vita, dietro le quali mi veniva concesso di sostare, come un monito. Le osservazioni del mondo esterno, fatte senza poter essere visto, accentuando una invisibilità che piano piano mi divorava, erano spesso accompagnate da autentiche lezioni di vita, durante le quali mi venivano additati - come mirabili esempi - monelli senza fantasia e senza storia, ma considerati, chissà perché, alla stregua di eroi spartiati. Ed io pensavo che se quelle nullità godevano di sì tanto prestigio agli occhi dei miei genitori, tutta l’enormità che mi portavo nel petto doveva essere cosa ben nefasta ed impresentabile. A punteggiare di vivacità le giornate ci pensava spesso mio fratello, con spaventosi sfoghi di acredine verso chi gli aveva sottratto chissà quali immensi tesori, mi vedeva e combatteva come si fa con un usurpatore. Ma siccome nulla vi era da usurpare – tutt’al più da restituire – il povero usurpatore si disfaceva egli stesso, riempiendosi di nulla, nel nulla si tramutava, avviluppato in spire di pensieri di dissolvenza nutriti a piene mani dal sedicente usurpato.
Oltre alla consegna all’inesistenza, vi erano regole “minori” che venivano applicate con ferrea intransigenza, corollari, ma più corone di spine, della regola della dissolvenza. Una di queste era la regola del fuori posto, ovvero, visto che comunque, malgrado gli sforzi congiunti degli altri abitanti dell’orfanotrofio mi ostinavo a non scomparire, dovevo almeno sapere – essere consapevole e certo - che dovunque mi collocassi non ero mai al posto giusto. E quindi ero perennemente o troppo grande o troppo piccolo, quasi una Alice schizofrenica e prigioniera delle pozioni, ero sempre troppo grande quando cercavo l’innocenza fanciullesca, troppo piccolo quando mi sforzavo di tenere il capo dritto e muovere qualche passo. Naturalmente questa indecisione, tenendomi occupato perennemente nel capire di fatto che età avessi, mi distoglieva da altri interessi, infatti ero spesso definito incapace di fare qualunque cosa, “imbranato” era forse il più bel complimento, almeno aveva un bel suono, meglio delle occhiate cariche di compassione, o di scherno, se attaccavo una figurina storta, o facevo un disegno che ben poco aveva del michelangiolesco. Per lunghi anni sono stato sinceramente stupito, del fatto che molti adulti mostrano compiaciuti i disegni dei propri figli in tenera età, i miei venivano perlopiù classificati come scarabocchi e gettati nel cestino della carta ancor prima che avessi avuto il modo di cominciarli.
Comunque anche io talvolta ci mettevo del mio ad incupire la gelida armonia che regnava nella casetta, talvolta osavo, preso da chissà quale senso di me, alzare la voce, o addirittura ridere, probabilmente avevo dei problemi seri davvero, anzi, a un certo punto iniziai a immaginare un mondo nuovo, con un linguaggio “parallelo”, che gettò nella costernazione più nera i miei conviventi. Non era proprio pensabile che la fantasia potesse apparire coi suoi colori in un film muto ed in bianco e nero, forse colpa di quei maledetti ed inutili libri che raramente mi capitavano fra le mani e letteralmente respiravo a pieni polmoni, in cerca di ossigeno, chiuso nella mia cameretta densa di gas soporiferi, e letali; forse bastava un mondo fatto di figurine ritagliate e casette, di carta ma in cui era possibile abitare, per riuscire ad arrivare al giorno seguente.
Viste tutte le mie malefatte, periodicamente venivano istituite le sedute per aggiornare il processo in corso a mio carico, le accuse erano davvero terribili, e sinceramente non sapevo come discolparmi, finendo di sentirmi colpevole in modo pieno e totale prima ancora che il verdetto venisse formulato, talvolta ancor prima del processo. Durante il processo mi veniva per esempio chiesto di rendere conto di cosa stessi dicendo quella volta che ero stato visto parlare con un amico a un angolo di niente, o perché mi era saltato in mente di ridere mentre camminavo tornando da scuola.
Col passare degli anni notai una spinta all’interno del petto, che si irradiava minacciosa verso i lombi e il ventre, in sogno andai a cercare di cosa si trattava e vidi uno strano bocciolo, come di un fiore che attenda di schiudersi. Sicuramente un altro dei miei misfatti, e certamente da estirpare. Sfidando le divinità e la sorte, decisi di tenermi quel piccolo segreto, lo imbalsamai e lo fasciai stretto, per poterlo riporre in un luogo che avevo costruito, tra l’anima e la mente, una stanzetta semplice, alla quale, nella fretta ed imperizia di costruttore improvvisato, avevo dimenticato di fare porte e finestre.
Un assurdo giorno di primavera giunse il giorno della fine del processo, bisognava esprimere il verdetto definitivo e con esso la condanna. Ma considerato talmente inutile da non essere neanche meritevole di un pensiero articolato, venni invitato a scrivere la mia condanna da solo, sotto dettatura da dietro una parete, donandomi così l’illusione di una certa autonomia dopo tanti anni, ma il dono era avvelenato, conteneva la mia terribile condanna che ignaro, inesperto e in buona fede scrissi, firmai e controfirmai con ampi svolazzi.
Così un giorno lasciai l’orfanotrofio. Qualche volta ci torno ancora per qualche visita inamidata, ma ogni volta che varco la soglia una cappa nera torna ad avvolgermi, le belle occasioni scoppiano come sfere di cristallo sotto la grandine, il sale delle lacrime torna a circolare nelle mie vene. E torna a tormentarmi l’unica parola che avrei dovuto dire ma che sottili legami, perfidie psicologiche e tranelli sentimentali, mi rendevano impronunciabile: “Perché?”

disegno di Roberto Maggiani
Pubblicato su L’area di Broca, n. 104-105 (luglio 2016 - giugno 2017): Solitudini.
Id: 3989 Data: 28/01/2018 17:02:07
*
La fumatrice
La piccola stazione di Saint-Pierre-des-Ifs se ne sta acquattata nel caldo ronzante dell’estate, il vago profumo delle magnolie ne increspa appena l’aria placida, un incessante ronzio nei dintorni delle fioriere che la circondano sottolinea l’unica attività visibile del pomeriggio. Dalla strada che congiunge la stazione con la piazza del vecchio campanile giunge una ragazza abbigliata in modo semplice ma accurato, con una lunga gonna di seta leggerissima e fluttuante stretta appena in vita da una fusciacca; ed una camicetta tutta pieghe, morbida sul corsetto rigido. Un ampio cappello protegge la pelle diafana del viso e da esso un vaporoso nastro si stende mollemente lungo la schiena della ragazza il cui movimento incita i lembi di tessuto a piccoli movimenti sincopati. La fanciulla ha con sé anche una piccola borsa rigida, quasi come un bauletto di forma trapezoidale, e stringe in pugno un grazioso ombrellino dal manico finemente cesellato. Il passo è non troppo svelto, scevro di disattenzione, il treno sta per arrivare e la fanciulla non ha nessuna intenzione di perderlo, eccola infatti già sul marciapiede pochi minuti prima del piccolo convoglio. Le porte si aprono con un sospiro ed ella sale, non trova uno scompartimento in cui stare sola, decide di aggiungersi a una buffa combriccola in gran pompa, i componenti del gruppetto sono tutti abbigliati da sera sebbene sia ancora pomeriggio. Appena la ragazza entra nello scompartimento ammutoliscono e le sorridono in modo galante, solo appena affettato per annosa abitudine salottiera. “Posso sedere qui?” “Ma certo signorina, si accomodi”, rispondono due di loro quasi in sincrono, poi si guardano e scoppiano a ridere, l’aria tra loro è piuttosto festosa, malgrado i paludamenti. Di nuovo la ragazza interrompe il chiacchiericcio degli imprevisti compagni di viaggio, rivolgendosi al più giovane tra essi, e anche l’unico senza soprabito, accenna al finestrino con una mano dal guanto di pizzo e chiede: “Non vi disturba l’aria, signore?” Il giovane resta leggermente abbagliato dallo sguardo limpido della ragazza, sembra cercare le parole per risponderle, tentenna, masticando qualche vocale sconnessa poi si fa più deciso, pone gli occhi scuri in quelli della ragazza “No, l’aria non mi disturba signorina.” Poi fa un cenno alla ragazza che gli siede accanto e dice in un sussurro “Vero Albertine che l’aria non ci darà noia?” Quella con uno sbuffo e le labbra arricciate risponde “no, certamente mio caro Marcel”. La ragazza apre appena il finestrino e si gode il refolo di aria che le giunge, mentre gli altri chiacchierano osserva la ragazza che ha appena parlato “uhm” pensa “quella è la giovane Simonet, così tutta elegante e tranquilla quasi non la riconoscevo, certo però che ne ha combinate delle belle… soprattutto con quelle sue quattro amichette parigine, si sono date ben da fare per scandalizzare mezza Balbec… E quel suo amico, sì certo quel tonto di Octave, chissà che fine avrà fatto, sarà di sicuro a sospirarle dietro mentre lei fa la civetta con questo bel giovane, come ha detto che si chiama, ah si certo, Marcel. Bel nome” pensa mentre lo osserva discreta, ne nota la perfetta eleganza ma lo trova appena malinconico con quel suo colorito pallido, i baffi ben curati gli danno un'aria vagamente solenne, ma ciò che colpisce la fanciulla è lo sguardo estremamente mobile ed attentissimo, ora si posa su di lei, poi vola lontano fuori dal treno, si perde nella campagna che digrada fino al mare, poi le pupille tornano rapide sul suo interlocutore. In quel momento l’attenzione del giovane Marcel è catturata da un buffo ometto non più giovane, dall’aria tronfia che sta raccontando qualche facezia riguardante una certa Madame de Cambremer che avrebbero visto di li a poco. “Poco male” pensa la fanciulla, “io non so nemmeno chi è, però questo dottor Cottard, - così sembra gli altri si rivolgano a lui - a lui basta il titolo, deve avere la sua baronessa, come in Marivaux, la baronessa di cui non si dice mai il nome e che nemmeno si sa se ne abbia mai avuto uno. Ma egli riflette la ragazza, è tanto più convinto di trovarvi compendiata l’aristocrazia (la quale ignora questa dama) in quanto più i titoli sono incerti e più spazio occupano le corone sui bicchieri, l’argenteria, la carta da lettera, i bauli. A proposito ma chi sarà questa vecchia carampana dall’aria un po’ tocca che tutti chiamano principessa. Non sarà una di quelle principesse da bordello che assumono nomi da nobildonne per esercitare la loro professione e poi questi nomi gli restano appiccicati addosso anche molti anni dopo che l’ultimo uomo ha cessato di desiderarle?”. “Diamine!” Riprende il buffo ometto, “la principessa Šerbatov”, ammiccando alla anziana silenziosa di fronte a lui, “il marchese e la marchesa di Cambremer “ ruotando gli occhi al cielo “Come vedete le cose si mettono bene”, ora rivolto al giovane Marcel, “tanto meglio: al vostro debutto, avete fatto centro. Sarà una serata brillante”, poi rivolto ad un altro membro del piccolo gruppo che sino a quel momento era rimasto assorto nella lettura del giornale “la padrona sarà furiosa Brichot, È proprio ora che arriviamo a darle man forte. La ragazza scuote impercettibilmente il capo, “chissà perché questa padrona sarà furiosa”, pensa, “forse non vuole vedere questa banda di pazzi scatenati, giusto quel Marcel che continua a guardarmi di sottecchi mi sembra a modo, certo questo Brichot mi pare uno di quei professoroni da operetta che non hanno mai opinioni proprie ma si limitano a sottolineare quel che leggono o che sentono dagli altri”. L’uomo in questione stava infatti vistosamente annuendo alle parole di Cottard. Ad un tratto tutti si mettono in allarme e subbuglio, di nuovo quel Cottard, la ragazza pensa che deve essere una bella seccatura averlo come ospite, sa sempre cosa dire e con frasi fatte e banali che vorrebbe far passare come perle di saggezza. Ora sta tuonando come Zeus dall’Olimpo, le guance rubizze per l’agitazione “Ancora nessuna notizia del violinista l’hanno sicuramente sbattuto in guardina, non c’è altra spiegazione della sua scomparsa. Diamine! da militari, sapete, con quei tipi, basta trovare un maresciallo scorbutico.” Ad un tratto anche Brichot si desta, scuote un poco il capo come per riordinare le idee, o i pochi capelli “Se non verrà neanche stasera” sussurra “sarà ancor più mortificante per madame Verdurin, dal momento che la nostra gentile ospite riceve per la prima volta a pranzo i vicini che le hanno affittato La Raspelière, il marchese e la marchesa di Cambremer.” La ragazza capisce ora tutto, “questa Verdurin affitta una villa per le vacanze dai Cambremer e per ingraziarseli, quasi certamente al fine di ottenere uno sconto, li invita a cena con questi quattro bellimbusti e offre anche un accompagnamento musicale. Hai capito la Padrona” sogghigna fra sé la fanciulla. Nota che Albertine la sta fissando, ne sostiene lo sguardo brevemente finché l’altra socchiude appena le palpebre con un aria sorniona tipica dei gatti quando vogliono creare un legame segreto con chi li guarda, “stai tranquilla giovane Simonet, i tuoi segreti sono al sicuro con me” pensa la ragazza, poi volge gli occhi al paesaggio, “certo che quella lavandaia ne sa di cose sul tuo conto e sulla tua biancheria sempre da lavare”, sorride appena, poi osserva Marcel che però è impegnato in una conversazione sull’affaire Dreyfuss, sempre in relazione ai Cambremer, “Perdipiù devono essere quanto c’è di più anti, e militaristi, aveva detto il signor Verdurin”. – Ah! quanto a questo, francamente, me ne importa ben poco, aveva aggiunto la moglie, è anche troppo che si parla di questa storia” Cottard interviene “Madame Verdurin essendo sinceramente Dreyfusista, avrebbe voluto tuttavia trovare nel predominio del suo salotto dreyfusista una qualche ricompensa mondana”. Poi si volta verso Brichot e gli lancia una sorta di ammonimento: “Vero?!?” Poi, a titolo di spiegazione verso la principessa, vera o presunta, “il signore” dice indicandolo col pollice e sottolineando con forza il titolo, poi, dopo una brevissima pausa, riattacca “l’universitario, infatti, è il solo tra i fedeli ad aver preso posizione per lo Stato Maggiore, cosa che l’ha fatto parecchio scadere nella stima di madame Verdurin”. Brichot arrossisce visibilmente e tossisce confuso. La ragazza nota il fitto velo di imbarazzo che cala sulla compagnia e con aria indecisa comincia giocherellare con la sua borsa, fa scattare più volte la chiusura in argento finché si risolve ad aprirla, subito appare la fodera in elegante raso di seta rosso che calamita l’attenzione del gruppetto. La ragazza si blocca per un momento, recupera qualcosa dal fondo della borsa poi con voce allegra, rivolta ai compagni di viaggio, ma guardando Marcel “Il fumo non darà noia ai vostri amici?” Senza attendere la risposta si accende una sigaretta ed espira la prima boccata di fumo con una chiara espressione di piacere sul volto, tutti la rassicurano che il fumo non dà assolutamente noia e riprendono a chiacchierare. Marcel riprende il filo della conversazione con quel Brichot che agli occhi della ragazza è un autentico cafone, “ma come fa a supporre” pensa “che Marcel non sia stato mai presentato ai Cambremer e a questa fantomatica Verdurin se è stato invitato a pranzo, e si porta quella smorfiosa della Simonet appresso. Tanto più che sicuramente non saranno neanche fidanzati ufficialmente”. Infatti Marcel risponde con eleganza “Mi hanno già presentato a Madame de Cambremer, sarò ancora più felice di vederla” – “che classe”, pensa la ragazza espirando una nuvoletta di fumo azzurrino che subito si disperde nella corrente d’aria – “perché mi aveva promesso di mostrarmi un libro dell’ex curato di Combray sui nomi di luogo di questa regione, e potrò ricordarle la sua promessa. Mi interessa quel prete e anche le sue etimologie” Brichot non sembra altrettanto entusiasta del libro in questione “Non fidatevi troppo di quelle che suggerisce; il libro, che alla Raspelière c’è e che mi sono divertito a sfogliare, non mi sembra un granché; è zeppo di errori”. “Ma cosa ne saprà mai questo vecchio spaventapasseri”, pensa la fanciulla, ma Brichot parte con gli esempi. “La parola briq entra nella formazione di una quantità di nomi di luogo dei dintorni. Il bravo ecclesiastico ha avuto l’idea discretamente strampalata che derivi da briga, altura, luogo fortificato. Lo vede già nelle popolazioni celtiche, Latobrigi…” la ragazza sbuffa, spegne compita la sigaretta nel posacenere e pensa “chi saranno mai questi Latobrigi, conosco i Simonet, ora ha sentito altri nomi di persone che mi sembrano strampalate, i Cambremer, i Verdurin, ma che sarà, un mercato?” Si domanda, poi con un sorriso pensa al camembert, ritorna con l’attenzione alla voce querula di Brichot che sta ancora elencando “Briqueville la casa sull’altura, Briquebec- dove ci fermeremo tra un istante prima di arrivare a Maineville…” “Briquebec è dove devo scendere!” Trasale la ragazza, si alza di scatto, sistema le ampie sottogonne dal tenue color ecrù, raddrizza la fusciacca verde, si pone sul capo il cappello di seta leggero ed impalpabile come una nuvola estiva, lo fissa con il nastro sotto il mento e sventolando la mano dal guanto color latte saluta e con un balzo scende dal treno. Marcel la segue con lo sguardo allontanarsi fra le siepi della stazione, poi scomparire in una strada laterale, pensa alle domande che avrebbe potuto farle, chiederle il nome, addirittura invitarla ad unirsi alla comitiva per il pranzo alla Raspelière. Il giorno dopo con Albertine, ripensandoci, Marcel riporta il discorso sulla bella fumatrice e la ragazza con una certa sicurezza gli dice “Non preoccupatevi, ci si ritrova sempre”.
Molti anni dopo, Marcel nella sua stanza di boulevard Hausmann, riandando indietro coi ricordi a quel fatidico pomeriggio improvvisamente rivede la bella fumatrice, e ricorda le parole profetiche di Albertine, con un sospiro fissa gli occhi in quelli del suo interlocutore, le lunghe ciglia indugiano verso il basso, poi si rialzano. “Vedete Robert nella fattispecie, si sbagliava; non ho mai trovato né identificato la bella fumatrice. Per molto tempo dovetti smettere di cercarla. ma non l’ho dimenticata. Spesso, pensando a lei, mi succede d’essere invaso da una voglia folle. ma questi ritorni del desiderio ci costringono a riflettere che, volendo ritrovare quella determinata fanciulla con lo stesso piacere, bisognerebbe anche ritornare a quell’anno, cui ne sono seguiti altri dieci durante i quali la fanciulla è sfiorita.”
Poco distante in Rue des Mathurins una signora sta prendendo un te con una amica, “e vedi”, sta dicendo “quell’anno fu la mia prima vera vacanza da adulta, era tutto quasi perfetto. Un pomeriggio durante un breve tragitto in treno conobbi l’uomo che avrei voluto ancor oggi al mio fianco, ma la situazione era troppo fuggevole, non ebbi il coraggio, o chissà, la sfrontatezza di proseguire con lui il viaggio in treno e finii col partecipare a quella noiosa merenda con le mie cugine. Ma il rimpianto mi segue ancor oggi”. Con un sospiro si accende una sigaretta ed esala lenta una nuvoletta azzurrina, l’amica posa la tazza ormai vuota, le accarezza leggera una mano e dice “Si può, a volte, ritrovare una persona, ma non abolire il tempo. E tutto questo sino al giorno imprevisto, e malinconico come una notte d’inverno, in cui non si cerca più né quella persona, né nessun’altra, in cui trovare ci farebbe persino paura”. Le due amiche annuiscono serie poi una spegnendo la sigaretta ormai consumata si volta a guardare l’acquaforte sopra il camino, ammira la cittadina che vi è raffigurata, e le labbra si increspano appena leggendone il nome: Briquebec.
Le parti in corsivo sono tratte da La Recherche, Sodoma e Gomorra, pagg 115/120
Id: 3615 Data: 10/05/2017 10:47:55
*
Gare Avenue de Saint-Ouen – Louanges profanes
Attraverso rapido il Boulevard des Maréchaux lasciandomi alle spalle il chiacchiericcio di un bistrot e i quattro sfaccendati che si gustano i raggi del sole primaverile, insieme alle macchie d’inchiostro del quotidiano appena stampato e qualche goccia di Pastis, che colora appena l’acqua, come le vaghe nuvole che rappezzano stanche il cielo questa mattina. Oltrepasso la breve hall della stazione e proseguo a passo deciso sulla scalinata dritta che scende al binario. Controllo l’orologio, le 10:27, e già sento il piccolo convoglio sferragliare scivolando sotto la stazione mentre viene ad allungarsi ai miei piedi. Mi siedo accanto ad un finestrino, il cappello e il bastone si accomodano nella retina, i guanti li tengo, non si sa mai quali e quante mani sono passate qua prima di me, e i miei polmoni già sono in subbuglio per l’enorme quantità di polvere che si muove nell’aria, piccole volute minacciose si aggrovigliano placide nelle strisce di sole, filtrate dagli alberi lungo la ferrovia, mutevoli nel procedere del vagone mentre si avvicina ad un austero cartello che informa che il brutto edificio di mattoni che sta sorgendo all’orizzonte è solo la stazione di Saint-Denis. Mi sfilo i guanti ma non so risolvermi se posarli sulla retina, metterli nella borsa o continuare, come sto facendo, a muoverli qua e là nel pugno destro, come la corrente quando cerca di portar via le ninfee, forte della primavera che ne ingrossa la portata. Assorto in fuggevoli pensieri mi porto i guanti al viso e, da qualche luogo remoto dei viali parigini, da qualche salotto ancora sigillato dal maltempo, mi giungono soavi squilli di campanelli d’oro, è l’essenza di neroli che si stira di fronte i miei sensi stupiti, ne posso quasi avvertire il gusto liscio sul palato. La mente si affretta a trovare una collocazione a questo sentore, passa in rassegna pouf e divani, guarda incedere maestose aigrettes e zinali fuggire via discreti. Ai fiori candidi si affianca improvvisa la cremosità del giglio bianco, insieme evocano i biancospini; ma non quelli vivi e quasi sanguinanti delle siepi della mia infanzia, ne avverto i sospiri rinchiusi in un segretissimo sachet, li sento cinguettare fitti con il benzoino, rimbrottati solo il giusto, e per non essere dimenticata, dalla pimenta racemosa. Dietro le mie palpebre, appena appesantite da una invincibile spossatezza, s’affaccia l’origine delle spiraleggianti volute. Attraverso un flacone trasparente di angoli retti, dalle linee tese e contrassegnato appena da un numero, riappare quell’ultimo giorno: dietro le persiane trapuntate dalla luce del pomeriggio, la sua camicia di lino appena gualcita dal segno che ancora tentenna sul lenzuolo, neanche scostato dall’impellenza dell’incontro. Il braccio che mi porta da un passato che contiene tutti i tempi, tutte le genti, i guerrieri di Sparta, tutte le volute d’incenso che si sono levate per salutare vittorie o sconfitte improvvise, cedimenti, o vette conquistate con l’impudenza di un piano ben congegnato, la sua mano a schiudersi sul mio viso, le punte delle dita come una lingua inventata per celebrare con odi profane il momento. Il palmo della mano si apre come un anemone di mare sulla mia guancia che ne sugge tutto il calore, la pelle a leggere la fitta rete di misteri che scivolano con i globuli rossi nella circolazione, misteriosi ed invisibili convogli che si intersecano su minuscole ferrovie in grado di trasportare montagne, astri, sistemi di vite, segreti di esistenze obbligate a circolare in maniera interminabile, a nutrire un cuore che - come la stazione di Belleville-Villette, che si sta approssimando al mio viaggio, - ha bisogno di inferriate ed un cancello, pronti a proteggere chi sale e scende dal vagone. La polvere che sentivo negli occhi mi diceva che quei cancelli si sarebbero aperti di li a poco, il treno sarebbe ripartito tra fischi e sbuffi nel suo immutabile circolo attorno al cuore pulsante della città. Ma io me ne stavo allontanando per sempre, i cancelli non si sarebbero dischiusi rischiando di lasciar entrare il chiacchiericcio che accomuna serve e baronesse, il convoglio deve circolare su binari sgombri da immondizia, celandosi durante il suo tragitto in brevi gallerie, ma potendosi gloriare del pieno sole in altri tratti. E i raggi del glorioso astro sgranati dalle imposte stavano bruciando la mia guancia, quel pomeriggio in una stanza poco distante la stazione di Ménilmontant, accompagnati dall’effluvio della sua pelle, le cui misteriose particelle ancora punteggiano il mio guanto. Ogni volta che ne aspiro il ricordo, forte risale dai fondali dell’esistenza il ricordo doloroso, dal paese dei Cimmeri riappare minacciosa quell’ombra che mi fa cenno di seguirla, ombra cui ho resistito solo nell’apparenza, ma che si è presa il respiro, oggi appena sufficiente ad alimentare il pensiero, i ricordi e qualche uscita pianificata con mille difficoltà e un anticipo talmente vasto da potervi far crescere la pianta velenosa dell’abbandono e della reticenza. Sbatto le palpebre per il sole che ora attraversa le fronde alla stazione di Charonne, rapida passa tra la rètina e i pensieri più reconditi l’immagine dei tigli sotto i quali passeggiavi svelto sul viottolo del bois verso il Jardin d’acclimatation, lasciando dietro di te particelle di aria profumate di gelsomino e menta, come se una folata di vento caldo, attraversando un accampamento di nomadi del deserto intenti a preparare un tè, ti avesse raggiunto e circondato festosa per accompagnarti in quella rapida passeggiata - quasi fuori stagione - ma che segnava l’inizio di un tempo ben più duraturo per i miei sensi. Lessi avido il tuo alito appena accelerato dalla camminata veloce e dalla paura di essere visti tra i cespugli in cui sbocciarono i nostri primi baci, e lo smarrimento nelle tue iridi clandestine, il dovere ti richiamava appena subito dopo l’averti congedato; io ti seguii, cercando di racchiudere nella mia mente quante più sfumature di aria, densità di colori, tonalità di silenzi che ti lasciavi dietro fendendo il pomeriggio. Quella buffa stazioncina che ancora ricordava l’allevamento di volatili utili allo svago di qualche testa coronata, molto pretenziosa, col suo bravo orologio e la cupola a scimmiottare ben altri sfarzi e ingegni architettonici, ti aveva inghiottito, ma le maglie del tempo, che - si sa - non sono tutte fitte e identiche, ci avevano regalato una sospensione di pochi attimi durante i quali eri riuscito in un soffio a sussurrare il tuo nome, o forse il nome di una stazione. O forse entrambi, tant’è che accanto a quella stazione ti ritrovai il giorno seguente e quello seguente ancora, sino a quello che non ebbe mai seguito, ma l’addio avvenne nei pressi di un’altra delle fermate della petite ceinture, quasi a preservare la purezza di quella che portava, storpiandolo, il tuo nome. Ed è qui che mi sto dirigendo con il tuo profumo sui miei guanti e una camelia nella mia borsa, e che non posso appuntare al bavero perché è destinata a te, a racchiudere il ricordo delle linee del tuo corpo, una sinuosa dall’orecchio al pomo d’adamo, una più tesa che, agguantato dall’altra il testimone appena sotto il mento, scende tesa e maestosa lungo il petto, fende il ventre e si perde nella maestà della tua essenza più intima. Come al solito percorro a passi lenti il viale, poi svolto in Boulevard Picpus, costeggio il muro della antica e consacrata magione finché, riparato da una rientranza del muro, getto la camelia oltre il bastione. Da qualche parte, in un’altra vita, una fanciulla compiva lo stesso percorso per essere preservata e poter fiorire a tempo debito, così spero che anche il mio fiore protetto dalle insidie del mondo possa un giorno tornare a me, maturo e pronto per essere mostrato.
Indugio un poco e ripercorro i miei passi, dal giardino celato dal muraglione, giungono folate di iris e un vago suono, appena distinguibile, quando il vento gira in mio favore riconosco la voce familiare di qualche strumento e un rapido succedersi di note; in fondo, penso, non senza un sorriso che mi increspa appena il labbro ma riverbera con una certa forza nella mia mente, spesso la visione più bella che resta di un’opera è quella librata sulle stonature di un piano scordato strappate da dita maldestre*.
Il fischio austero e familiare mi avverte che sono giunto nei pressi delle orribili cisterne che costellano la piccola stazione il cui nome risplende a lettere d’oro, lanciate in cielo da una divinità dall’animo generoso a formare una costellazione, imperitura direzione per una esistenza. Nel mio cuore, solo lì.
*Dalla parte di Swann
Id: 3586 Data: 17/04/2017 09:48:03
*
Il Forno
Pierre diceva che un sorriso sincero è la più pura delle monete
In carrozza
Qualche anno fa mi stavo recando a Bordeaux per risolvere delle questioni con certi vignaioli che avrebbero dovuto fornirmi vino decente ma che da qualche anno si ostinavano a mandarmi barili di aceto, e della qualità più scadente. Mentre tentavo di sonnecchiare per non far caso alle autentiche voragini che, sulla strada, mettevano a dura prova le ruote della carrozza e le zampe dei poveri cavalli, il cocchiere mi annunciò una imprevista sosta a Lamothe-Montravel. Sebbene il motivo della fermata non mi fosse ben chiaro approfittai volentieri per sgranchirmi le gambe e rifocillarmi. La stazione di posta era pulita e ben tenuta, dalle cucine si spandeva un profumo di carni in cottura davvero invitante. Purtroppo però il momento in cui le vivande sarebbero state servite era ancora lontano, per cui l’oste mi offrì una bella baguette appena sfornata ed una brocca di vino per placare i morsi della fame. Visto che la giornata lo permetteva mi accomodai sotto il piccolo porticato antistante la stazione, dal quale si poteva vedere il traffico della strada per Bordeaux, ben poca cosa, in verità, e le vigne che digradavano fino alla Dordogna che scorreva placida fra i campi. Oltre a me si godeva il tepore mattutino un'altra persona, un uomo più o meno della mia età ma evidentemente di più modesta estrazione, almeno a giudicare dall’abbigliamento. Lo sguardo acuto e pensatore invece avrebbe potuto far pensare ad un alchimista, comunque l’uomo era assorto a sbucciare con calma meticolosa una mela. Dopo aver sbocconcellato qualche spicchio del frutto l’uomo mi guardò dritto in viso, poi lo sguardo gli cadde sulla baguette, e uno strano sorriso gli si produsse negli occhi. Essendo stato in esclusiva compagnia di me stesso da lunghe ore avevo voglia di scambiare due parole con qualcuno, per cui mi presentai, in modo meno formale di quanto la mia posizione mi consentisse, tuttavia con un certo orgoglio. L’uomo, a sua volta, sfiorandosi appena il berretto si presentò dicendo: “Jacques, Monsieur, Jacques il fornaio”. Colsi subito l’accento sulla sua professione per profondermi in elogi per la squisita qualità del pane che stavo mangiando. “Non si faccia tante illusioni, Monsieur” tagliò corto Jacques: “Lei non si immagina neanche quanto dolore e quante cose strane vengono mischiate alla farina e all’acqua che servono per sfornare il pane ogni giorno”. La cosa mi insospettì, pensando a chissà quali veleni fossero impastati in un pane tanto delizioso. “Oh no, non parlo di veleni o chissà quali pozioni, ma quanta umanità si consuma armeggiando davanti la bocca di un forno”. La curiosità si stava facendo ormai strada nel mio animo, e spronai Jacques a raccontarmi la sua storia. Egli buttò nel prato le bucce della mela, asciugò il coltello con meticolosa cura, lo richiuse e lo pose nel taschino dei pantaloni, si lisciò un paio di volte la barba con fare pensieroso, si volse verso di me e iniziò il racconto.
Racconto di Jacques. I Mercier
Quando avevo 16 anni qua a Lamothe ci fu un anno di carestia, le vigne erano state avare e il tempo ce l’aveva messa tutta per togliere quel poco di raccolto che sarebbe stato lecito aspettarsi, i soldi erano finiti da tempo e le provviste scarseggiavano. I miei decisero di farmi imparare un lavoro che non fosse così esposto ai capricci del clima, così decisero di mandarmi a Bordeaux ad imparare una professione utile. Un lontano prozio aveva sposato la sorella della moglie di un fornaio che aveva bottega a rue Bourbon, poco lontano dal fiume, che avrebbe attutito la nostalgia di casa. Prese le mie poche cose, giunsi a bottega un mattino molto presto per le mie abitudini un orario invece normale per chi faceva il fornaio. Al forno lavoravano marito e moglie, i signori Mercier, presso i quali avevo anche alloggio, una specie di surrogato di famiglia. Il marito, Pierre, si occupava di impastare e cuocere pane e croissants, mentre la moglie, Annette, si occupava di tutto il resto, soprattutto della vendita dei prodotti. Compito che le risultava assai facile vista la leggendaria qualità delle cose sfornate da Pierre. Con i Mercier imparai ad amare il lavoro, svolgerlo con diligenza e passione, ma imparai anche ad amare la farina, riconoscere le qualità migliori, evitare i tentativi di truffa da parte dei mugnai e riuscii ben presto a trasmettere l’amore che ricevevo dai Mercier nelle bellissime e friabili baguettes che sfornavo. Spesso Pierre realizzava degli ottimi dolci, o dei pani speciali, che avevamo l’abitudine di condividere dopo il lavoro, sia per rifocillarci, sia per apprezzarne la qualità e trovare il modo di migliorare ciò che facevamo. I clienti erano felici e quasi tutti innamorati della gioviale Annette; i prezzi erano equi, anzi, per i più poveri c’era sempre qualche pagnotta in più che finiva nelle loro borse, quasi di soppiatto, senza attendere un ringraziamento o il pagamento, spesso Pierre diceva che un sorriso sincero è la più pura delle monete. Dopo qualche anno di lavoro sereno, di tante cose imparate, potevo ormai definirmi un bravo fornaio, i Mercier già parlavano di farmi loro socio, o forse di aprire un altro forno più in centro. Ma una brutta notte i sogni si dissolsero, portati via da una improvvisa piena del fiume che allagò il forno e costrinse i Mercier a chiudere bottega, tornarono a Mérignac, loro paese d’origine, e vissero modestamente coi pochi risparmi accumulati in tanti anni di fatiche. So che alcuni vecchi ed affezionati clienti ancora li vanno a trovare con qualche piccolo dono in ricordo dei buonissimi prodotti che quella coppia aveva creato nel corso degli anni, più per il piacere di dare gioia ai clienti che per arricchirsi.
Intermezzo
Jacques si interrompe mentre l’oste ci porta due belle razioni di cassoulet ed una caraffa di buon vino. Mentre medito sul racconto appena sentito col pensiero vado anche ai miei vignaioli, che devo incontrare di lì a poco. Jacques inizia a mangiare svogliatamente, gli chiedo se con l’esperienza acquistata coi Mercier trovò un altro forno disposto a dargli lavoro, l’uomo annuisce tristemente e ricomincia a raccontare.
Racconto di Jacques. Madame Violette
Dopo qualche giorno a passeggio per le vie di Bordeaux trovai lavoro presso un grande panificio, in una zona più centrale – ed asciutta – della città, vicino alla torre dell’orologio, il forno si chiamava, per via di quella ubicazione Les deux horloges. la proprietaria del forno era una donna segaligna di mezza età, Madame Violette, dai capelli grigi e sempre arruffati, e la voce stentorea, che teneva sempre ad un livello molto alto, sia per sovrastare i rumori del lavoro, sia per affermare la propria autorità. Il lavoro in quel forno era sempre tanto, tutti erano sempre di corsa e affannati per poter soddisfare le pretese di Madame, sempre più esagerate, tuttavia tutti erano molto dediti al lavoro e sia il pane che i dolci che sfornavamo erano sempre di ottima qualità. Va detto che la tirchieria di madame spesso ci poneva di fronte a prodotti veramente scadenti, ma la nostra bravura riusciva sempre a far sì che i clienti fossero pienamente soddisfatti. Non c’era l’atmosfera di calda cordialità che regnava nel forno dei Mercier ma ognuno faceva del suo meglio, i clienti, sebbene assai distratti, o infastiditi dai modi arcigni di Madame Violette, erano soddisfatti e tornavano sempre numerosi. Purtroppo, più il tempo passava, più Madame Violette scivolava verso la follia, i suoi modi erano sempre più scortesi ed ogni sua frase rivolta ai lavoratori era scortese e piena di insulti. La donna sembrava vittima della propria superbia, e i suoi moti e deliri di onnipotenza erano più legati a una amara solitudine che alla necessità reale di far funzionare le cose a dovere. Ci fu un anno in cui il maltempo flagellava le campagne e il raccolto non fu dei più fruttuosi, così che i parenti di noi lavoratori avevano necessità di aiuto e non potevano mandarci in città qualche provvista che di solito ci aiutava a tirare avanti, anche perché i salari che Madame elargiva non erano certo tra i più generosi, malgrado la floridità del commercio. Bisogna dire che Madame teneva molto alla qualità e alla freschezza dei suoi prodotti, così ogni sera tutti i pani rimasti invenduti sugli scaffali venivano caricati su di un carretto e portati ad un porcile fuori città. Quell’anno la fame cominciò a farsi sentire, per cui qualcuno cominciò a sbocconcellare qualche tozzo di pane avanzato prima che venisse gettato ai suini, pensando di non fare nulla di male, in fondo era per riempire un po’ lo stomaco, e i suini di certo non avrebbero risentito della mancanza di qualche baguette o di un croissant in meno. Quando Madame Violette capì che qualche baguette invece che nello stomaco di un maiale finiva nel nostro, non ci vide più dall’ira e dall’odio e cominciò a inveire, preda di una crisi di pazzia, urlando che nessuno, ma proprio nessuno doveva permettersi di mangiare anche una sola briciola di pane e che, sì, preferiva darlo ai maiali o anche buttarlo al fiume piuttosto che lo mangiassimo noi. Tutti erano costernati da questo comportamento assurdo e dissennato, ma ormai la pazzia di Madame aveva rotto gli argini e ogni giorno, con gli occhi iniettati di sangue, intimava a chiunque di non permettersi di mangiare alcunché. Un bel giorno il pane avanzato era davvero tanto. Un garzone, appena arrivato alle dipendenze di Madame, le chiese se poteva mangiare un piccolo pain au chocolat, di cui era particolarmente ghiotto, Madame Violette non ci vide più dall’ira e cominciò a gridare e minacciare tutti di non azzardarsi neanche a pensare di poter mangiare qualcosa, e che piuttosto avrebbe mangiato lei tutto il pane, che era suo e nessuno lo avrebbe toccato, se non lei. Detto fatto cominciò ad ingurgitare grossi bocconi di pane ma, ahimè, nella foga dimenticò di riprendere fiato e con un boccone più grosso degli altri in gola si fece paonazza, cominciò ad annaspare in cerca di ossigeno, ma il cuore già in tumulto per la scenata si fermò.
Noi chiamammo subito i gendarmi e il farmacista ma non ci fu niente da fare, Madame venne caricata sulla carretta, di solito destinata al pane avanzato, e portata al camposanto.
Noi non sapevamo più cosa fare ma ligi al nostro dovere continuammo a sfornare baguettes e dolci, come sempre. Dopo qualche giorno arrivò una giovane donna, che si presentò come Mademoiselle Louise Leduc, di Nantes, unica parente di Madame Violette. Mademoiselle incaricò un notaio di sua fiducia di fare un inventario dei beni di Madame e in breve vendette tutto, diede a ciascuno di noi una bella sommetta e se ne tornò a Nantes, ma prima di salire sul calesse ci salutò con questa frase: “Povera zia Violette, la sua avidità alla fine l’ha uccisa, se avesse seguito il mio consiglio di curarsi quando era in tempo, forse sarebbe ancora al suo posto alla cassa, ma per fortuna il buon Dio non permette che le ricchezze accumulate seguano il proprietario nel suo ultimo viaggio. Ora posso tornare a Nantes come una signora, dimenticherò presto la zia ma non la lezione che ha insegnato a me e a tutti voi. Buona fortuna e che Dio vi liberi dall’ingordigia”. Tutti noi salutammo, col berretto fra le mani, la signorina Louise, quando il calesse ebbe svoltato non ci restò che andarcene, e fu così che tornai a Lamothe-Montravel.
Verso Bordeaux
Il pasto stava per finire, così domandai a Jacques se avesse ripreso a fare il fornaio una volta tornato al suo villaggio. “Oh no, Monsieur, ne avevo abbastanza, coi soldi di Mademoiselle presi un orticello che mi dà ancora da vivere. Talvolta insegno a qualcuno come ottenere delle buone baguettes ma non accetto danaro in cambio, al massimo qualche regalo. Non voglio fare la fine di Madame Violette”. Annuendo presi commiato da Jacques, la mia carrozza era ormai pronta e i cavalli scalpitavano per poter riprendere il viaggio.
Grazie al lauto pranzo e al dondolio della carrozza, in breve mi assopii e in sogno mi apparve Madame Violette che si rimpinzava di pane e, come accade nei sogni, accanto a lei c’erano strani personaggi, tra cui i miei vignaioli e il fattore che curava le mie terre e si occupava di inviarmi, dopo ogni raccolto, i barili di quello che inevitabilmente diventava aceto ancor prima di festeggiare il suo primo compleanno. Dopo qualche ora di dormiveglia, agitato da questi fantasmi, giunsi alla mia tenuta dove ad attendermi c’erano il fattore Michel e il maître de cave Simon attorniati da tutti gli altri contadini. Dopo i rituali di accoglienza chiamai Michel e Simon nel mio studio, chiedendo loro di portare una brocca del vino che avevano intenzione di mandarmi quell’anno. Li feci sedere con me e li invitai a berne un sorso. Le loro facce disgustate valsero più di ogni altra frase. Li guardai per alcuni lunghi attimi e li vidi farsi paonazzi, di certo non per la quantità di quel che avevano bevuto, ma per la qualità. Decisi così di far loro questo breve discorso: “Vedete, miei buoni vignaioli, questa tenuta è della mia famiglia da qualche centinaio di anni, ma mai come ora la qualità e la quantità dei vini è stata così deludente. Lo avete visto anche voi, l’avete assaggiato. Io non penso che sia perché voi non sapete fare il vostro lavoro con passione ma perché forse non ne vedete l’utilità. Forse vi immaginate che io nel mio palazzo a Bergerac passi il tempo a scolarmi litri e litri di vino e a voi non lasci che qualche spicciolo e le uve più scadenti”. Forse è così, pensai, mentre dal fondo della memoria Madame Violette mi faceva un cenno ma forse si può cambiare. “Se il vino prodotto da questa vendemmia sarà superiore a quello dell’anno scorso, tutto il vino in più sarà vostro. E, pensate, se la qualità sarà buona, se non addirittura ottima, in fondo abbiamo le migliori vigne della zona, voi potrete vendere il vino che sarà vostro di diritto.”
Inutile dire che quell’anno, e quelli seguenti, il vino divenne fra i migliori della zona e se, ancor oggi, il vino con cui si volle in qualche modo ricordare il mio nome, è considerato uno dei migliori al mondo è grazie ad una povera panettiera avida e miope.
Id: 2558 Data: 05/01/2015 20:06:05
*
Oud
La chiave gira nel cilindro, la serratura si sblocca e la porta si apre, Amalia entra nell’appartamento e posa le chiavi nel cestino sul mobiletto accanto alla porta. Va nel soggiorno e abbandona con negligenza il cappotto sul divano, poi si avvicina al tavolo e accarezza con un gesto lieve la piccola urna che vi è posata. Le dita indugiano sulla modanatura che corre attorno al vaso, di semplice ma squisita fattura, poi Amalia si dirige in cucina mentre un pensiero le crea una sottile ruga sulla fronte; va all’acquaio e apre il rubinetto, lascia scorrere l’acqua per qualche istante, poi riempie un bicchiere di vetro turchese. La donna va davanti alla finestra e, osservando il piccolo giardino sul retro della casa completamente coperto da uno spesso strato di neve, beve a brevi sorsi; anche l’abete, che svetta al centro del fazzoletto di terra, è carico di neve fresca, tanto che i suoi rami sono incurvati verso il basso. Il cielo è cupo ma la fitta nevicata è terminata, il silenzio è compatto, sembra che l’energia, che abitualmente vibra nell’aria, si sia interrotta, nella casa e fuori non un volo, non un ronzio, non uno strisciare. Stasi. Amalia si avvicina alla porta che dà sul giardino, alla sua destra c’è un piccolo attaccapanni da cui prende la giacca a vento, il pesante berretto di lana e i guanti. Restano invece al loro posto un giaccone da uomo, il giaccone di Matteo, e una sciarpa, che non può fare a meno di stringere fra le dita. Dalla sciarpa si spande tenue il peculiare profumo di Matteo, una singolare miscela di Oud* e aria della mattina che la donna si sofferma brevemente ad assaporare, poi apre la porta e esce. Le impronte di Amalia sono le prime nella neve caduta durante la notte. La donna muove qualche passo titubante, poi si fa più decisa e si avvicina all’albero. Lo guarda, ne percepisce la freddezza, ma anche la linfa che scorrendo al suo interno lo mantiene in vita, poi allarga le braccia e si lascia cadere. Amalia resta così, sdraiata nella neve che, come uno spesso piumino, ne ha attutito la caduta, l’ha accolta e, quasi proteggendola, la circonda. Da quella posizione può vedere soltanto il cielo col suo lucore grigiastro, alcuni fiocchi ricominciano a cadere e appaiono ad Amalia come macchioline scure, sembrano danzare coi fosfeni che una sorta di dolore sordo, riecheggiando nella mente, le proietta sulla retina. Resta sdraiata per lunghi attimi, la neve, al contatto del suo corpo, si scioglie leggermente, assume la sua forma; senza rendersene conto cade in un profondo torpore, si assopisce e comincia a sognare un’auto che corre su una strada di montagna circondata da un fitto e oscuro bosco. L’auto sembra sbandare, improvvisamente Amalia si sveglia, perché sente l’aria vibrare di un profumo intenso, si solleva, dapprima sui gomiti, poi si alza e quando si volta verso la casa, per rientrare, vede un albero che non aveva notato e che, forse, non era mai stato lì, una Aquilaria. È da questa pianta che si spande l’intenso profumo che ha svegliato Amalia. La donna, vedendo che in casa le luci sono accese, rientra e trova la tavola apparecchiata festosamente per la cena della Vigilia di Natale. Dalla cucina giunge, insieme a un ottimo profumo, la voce di Matteo che la esorta ad accomodarsi perché la cena è pronta. Amalia, leggermente confusa, si siede; Matteo, dalla cucina, prosegue dicendo che ha preparato degli ottimi tortellini in brodo, sa che sono tra i suoi piatti preferiti.
Amalia sente la voce, un poco ovattata, vicina ma in qualche modo remota, e non riesce a vedere Matteo, non lo vede muoversi, non produce alcun rumore, non si è neanche affacciato dalla porta che dà sulla sala da pranzo quando lei è arrivata. Matteo continua a parlare descrivendo per il secondo una bellissima anatra all’arancia cotta al punto giusto, con la salsa caramellata in cui arancia e Grand Marnier sono legati alla perfezione. Amalia si perde nella voce del compagno, migliaia di scene si affastellano nella sua mente, forse chiude per un attimo gli occhi, d’improvviso nota la zuppiera fumante posta accanto al suo piatto. Il mestolo sporge incurvato e invitante dall’occhiello che interrompe la perfetta circolarità del coperchio. Dalla cucina continua a giungere la voce di Matteo che la prega di mangiare mentre lui ha ancora da fare per ultimare la cena. Amalia sfiora la zuppiera e cominciano a scivolarle delle lacrime sulle gote appena arrossate dal caldo della stanza. Le asciuga col tovagliolo, poi si schiarisce la voce e, tutto d’un fiato, quasi allarmata, chiede all’uomo perché ha voluto prendere la strada che passa dalle montagne, che d’inverno è sempre poco sicura.
Amalia si ritrova nel suo letto, circondata dall’oscurità, in quello stato di confusione che segue a un sonno pesante e precede un pigro e lento risveglio. La donna sa che aprendo gli occhi incontrerà lo sguardo ammiccante e un po’ sfrontato della lampada Fornasetti posata sul suo comodino, poi con la mano andrà a cercare la nuca di Matteo, che dorme raggomitolato su di un fianco, e vi poserà una carezza. Amalia vuole aprire gli occhi, vuole vedere gli arabeschi che la luce crea passando attraverso le tende colorate, vuole riaffacciarsi alla vita ma un peso sembra serrarle gli occhi. Nel risvegliarsi percepisce anche un’oppressione al petto, quasi il respiro si fosse rintanato in fondo ai polmoni e non volesse più uscire, le coperte si fanno pesanti, il letto improvvisamente inospitale: vuole alzarsi. Amalia, con grande sforzo, solleva le palpebre, ma rimane immediatamente accecata da una forte e bianchissima luce proveniente dal soffitto, invece del silenzio abituale della sua stanza, sente degli strani ronzii. Volta la testa da un lato e incontra gli occhi della madre, attenti e gonfi di lacrime, spalancati sopra una mascherina verde. Amalia, incredula, si guarda attorno, poi frammenti sparsi di memoria cominciano a ricomporsi, d’un tratto ricorda. “Matteo!”, urla, “Matteo dove sei? Dov’è, mamma?”
La madre non si scompone, lo sguardo rimane come assorto, o perso in pensieri lontani, sembra non sentire né percepire Amalia, come se una spessa lastra di vetro separasse le due donne. Amalia non riesce a muoversi. Serra le palpebre per trattenere le lacrime che sembrano imminenti, sente un brivido di freddo lungo la schiena, avverte il fruscio di un albero e poi un’esplosione di profumo di Oud. Spalanca gli occhi e avverte sotto di sé il morbido tepore familiare del divano di casa, la finestra del soggiorno è socchiusa a causa del filo di fumo che il caminetto produce con le prime timide lingue di fuoco che sembra non vogliano davvero aggredire i ciocchi disposti sul braciere. Oltre la finestra Amalia vede l’aquilaria muoversi dolcemente al vento; la neve, cadendo dai rami, produce un delicato fruscio, quasi a voler imitare il suono delle foglie. Dall’ingresso le giunge la voce di Matteo che sta raccontando, divertito, di come l’ha trovata addormentata nella neve, ora deve mettere ad asciugare il cappello e i guanti inzuppati di neve sciolta. Amalia chiama il compagno, una, due volte, vorrebbe chiedere se proprio non era possibile fare un’altra strada, evitare quella fra i boschi della montagna. Matteo non risponde, continua a raccontare di quella volta che da piccolo lui con la sorella si erano addormentati nella neve e la madre aveva faticato molto per ritrovarli. Al suono della voce di Matteo Amalia si assopisce, ora avverte una sensazione di tepore e di sicurezza che le avvolge le membra. Il suono improvviso della sveglia la fa sussultare, apre gli occhi e trova una buffa faccia in bianco e nero che le fa l’occhiolino, la lampada Fornasetti: “Ah ma è la lampada”, mormora. “Certo!”, d’improvviso esclama Matteo, “Cosa credevi, che te l’avessero rubata durante la notte?” La voce giunge dalla finestra, Amalia volta la testa e dirige lo sguardo in quella direzione. Vede Matteo che sbircia tra le persiane, il corpo arabescato dalla luce del mattino, resa colorata dal passaggio attraverso le tende. “Ha nevicato tutta la notte”, esclama divertito Matteo, “finalmente quest’anno avremo una vigilia di Natale con la neve. Ma ora alzati che dobbiamo andare da tua madre, e ancora non abbiamo incartato il suo regalo, ti ricordi quel bel vaso che abbiamo trovato a Praga e che è rimasto parcheggiato un mese sul tavolo? Forza Amalia, la strada è lunga e sai che sicuramente ci starà già aspettando impaziente… lo sguardo fisso alla strada ma riparata dietro le tende.” “Matteo!”, esclama allarmata Amalia, “che strada faremo?” “Ma che domande Amalia, la solita e unica.” “Quale?”, lo incalza Amalia sempre più allarmata. “Ma cara… la solita, quella che costeggia il lago.” “Ma… ma…”, balbetta Amalia, “quella che passa sulla montagna?” “Ma dai tesoro, stai ancora dormendo? Non ti ricordi la frana di qualche anno fa? Da allora quella strada è chiusa.”
Amalia si attarda un po’ ad armeggiare con la serratura, si infila i guanti e mentre si volta per raggiungere il compagno, che la precede di qualche passo, una folata di vento fa svolazzare la sciarpa di Matteo e le narici di Amalia si inebriano della misteriosa fragranza fatta di Oud e aria della mattina. “Cosa ne pensi Matteo, potremmo piantare una bella aquilaria nel giardino, magari accanto alla finestra della cucina, così non sarà troppo esposta.” Matteo sta aprendo la rimessa dell’auto, sembra cercare qualcosa in un angolo poi si gira tenendo un piccolo arbusto sul quale campeggia un gigantesco fiocco rosso. “Anche se riesci sempre a rovinare quasi tutto”, dice Matteo con un sorriso, “Buon Natale! Ecco la camelia che desideravi tanto.” Poi ripete, con più dolcezza: “Buon Natale Amalia.” Inclina un po’ la testa e fa quel sorriso buffo che ad Amalia piace tanto, inspira profondamente e quasi scusandosi dice: “Lo sai che l’Aquilaria non cresce alle nostre latitudini”, la guarda dolcemente negli occhi e aggiunge, “Se vorrai sentirne il profumo dovrai semplicemente stringerti a me.”
*L’oud (o Agarwood), è una resina tanto rara quanto pregiata, prodotta dagli alberi indiani Aquilaria e Gyrinops quando vengono infettati da un particolare tipo di muffa.
Id: 2543 Data: 24/12/2014 03:09:57
*
In rete!!
Testo pubblicato su L'aera di Broca - In rete
Semestrale di letteratura e conoscenza (già “Salvo Imprevisti”)
Anno XXXIX - XL, n. 98-99, luglio 2013 - giugno 2014
mattina
Gli occhi sono un poco appiccicati a causa del sonno appena interrotto, la tazza di caffè formato maxi è posta sulla scrivania, la voce non si è ancora sentita nell’aria di questa mattina, però le dita già viaggiano sicure sulla tastiera. Il pc è la mia finestra sul mondo, beh, mondo… su quella manciata di persone che mi conoscono. Oggi voglio chiamare tutti a raccolta: chiederò di inviare un testo inedito, e sottolineo inedito, da inserire nell’antologia che ho in animo di realizzare. Il tema mi frullava nella mente da un po’ di tempo ma solo oggi mi si è dispiegato chiaramente nei suoi risvolti, in fondo è facile – universale, direi – non sarà poi così complicato scrivere “a tema”. E su quest’ultima virgolettatura premo l’invio della e-mail, leggerò i componimenti che mi invieranno, ci vorrà almeno una settimana prima che i più veloci, analizzato e capito il tema, scrivano un testo adeguato… Ho tutto il tempo per mettere sul fuoco un’altra macchinetta di caffè. Mentre ritorno davanti al monitor, vedo che la e-mail lampeggia, urca! 4 nuovi messaggi. Allora, vediamo un po’ chi è. Mi scrive Anna Broglio da Cuneo, ottimi cioccolatini, penso, mentre la e-mail stenta ad aprirsi, “...ed ecco i testi che propongo per l’antologia” cinguetta la piemontese Anna. Ma dico io, come ha fatto a comprendere ciò che le ho chiesto, a pensare cosa poteva scrivere e a realizzarlo in una misera manciata di minuti? Chi può averle suggerito il tema? Ok, non l’ho messo in busta chiusa e depositato al ministero, ma diamine, ne ero a conoscenza solo io… i miei sospetti cadono sulla gattina che, placida, si gode un raggio di sole. Nel frattempo sto scaricando i testi. Gira la rotella… uffa… finalmente! Il primo parla della zia Gelsomina, ha il titolo “Una vita per i tajarin”, un racconto che col tema proposto non c’entra assolutamente nulla; vediamo il prossimo, una poesia, “Il mare di gennaio”, considerato che il tema proposto era inerente alle colline quando gli aceri arrossano e colorano il novembre, direi che siamo fuori tema, forse la cuneese gioca in fior di metafora… vediamo? Invece no, parla proprio delle onde del mare sulla battigia e di un amore che se n’è andato. Vista la logica che anima la cara poetessa, forse il fanciullo ha avuto un sussulto di coerenza ed è fuggito. Si sarà sbagliata nell’invio, ecco infatti un’altra e-mail dallo stesso mittente, ah ecco, mi chiede se ho ricevuto la e-mail scritta pochi secondi prima, invece nella terza e-mail, sempre targata Broglio, apprendo che l’autrice mi ha reinviato i testi perché temeva non mi fossero arrivati, e sollecita un riscontro e vuole saper se per caso ha vinto il “concorso”. Chissà quale, forse una mostra canina, visto che io di concorso non ho assolutamente parlato… Nel mentre giunge da Frosinone un’altra mail, di certa Concetta Loiacono, la quale, vista la mia richiesta di componimenti brevi ed inediti, mi invia, in formato pdf, il suo ultimo libro di 425 pagine appena pubblicato, certo, un piccolo sforzo ancora e ce la poteva fare a capire il senso del tutto. E va bè, sussurro, mentre sto per lasciare la pagina, ma un nuovo lampeggìo mi trattiene, bene, altri tre messaggi. In uno mi viene comunicato che ho uno sconto sul cialis del 35%, e diciamo che, visto l’inizio dell’antologia, mi sa che qualcosa che dia una bella scossa ci vorrebbe, ma forse così si va a esagerare un po’, l’altra e-mail mi promette novecentosessantamila euro, meno male, è quasi uno stipendio; visto che almeno due volte al mese mi arriva questa bella sommetta, fanno unmilionenovecentoventimila al mese/ventitremilioniquarantamila annui, che bastano appena appena per le spesucce correnti, tipo gli psicofarmaci per affrontare questa ultima e-mail che mi sto accingendo ad aprire. È di una mia vecchia conoscenza, Arturo Caprazzoli di Inverugo. Persona della quale ho sospettato per anni l’inesistenza, forse si tratta di qualche studentello buontempone, che vuole burlarsi di questo vecchio ed invisibile zietto che sulla rete urla e minaccia se qualcuno non si ricorda da che lato del giardino di Combray sta quel cancelletto di cui monsieur Adrien Proust serbava la chiave nel taschino del panciotto, pronto a estrarla al termine della passeggiata, quando a tutta la famiglia girava ormai la testa, preda dello smarrimento più totale, dopo ore di chilometri a piedi sotto scrosci di pioggia con continue citazioni di Saint Simon e Madame de Sevigné, mischiate a nozioni di araldica e botanica, spesso non disgiunte tra loro, e senza consultare Wikipedia. Mi pare quasi inimmaginabile, nella vita dell’umanità, un momento senza Wikipedia. Ma ora mi devo concentrare sullo scritto del fantomatico Caprazzoli, vediamo quali “perle” mi dedica oggi. Ah bè, devoto come sempre cannoneggia un bel “Impietosito assai nostro signore a quelle parole dopo aver allungo meditato decise” certamente ‘sto signore minuscolo ha “allungo” meditato, tanto “allungo” che ha bisogno di un numero doppio di spazi fra le parole. Questo testo richiede talmente tante correzioni che forse sarebbe meglio riscriverlo tutto da capo… Meglio chiudere la e-mail per oggi e incominciare con la vita reale: Facebook.
pomeriggio
Pare che Facebook in origine sia stato inventato per tenere collegate le persone, ora serve per lo più per mostrare animali domestici impegnati in nefandezze che non si sarebbero mai sognati di fare. Certo, non solo animali, anche i loro proprietari si sentono molto coinvolti nel diffondere un “animale” ideale nel web, infatti non perdono un solo secondo ad immortalarsi in ogni frangente della giornata. Dal mattino mentre si lavano i denti, al tavolo della colazione, all’uscita di casa con pantaloni e mutande bene in vista. L’importante è sporgere le labbra il più possibile, assumendo quell’espressione trasognata che va sotto il nome di aria da selfie, ma che un tempo, neanche tanto lontano, non si sarebbe esitato a definire bocca a culo di gallina. Ma è all’ora del pranzo che il popolo di Facebook si scatena a fotografare piatti a dir poco imbarazzanti, panini con affettati grigiastri, risotti collosi e paste allucinate, scaraventate nel piatto scotte, con condimenti prelevati da scatolame. L’importante è pubblicare la foto accompagnandola con espressioni da uomini delle caverne, tipo “slurp” o “yammy”. Accanto a ciò le balenottere, in preda alle diete da seguire pedissequamente fra uno spuntino e un Macdonalds, pubblicano foto di gallette asfittiche o insalatine cerulee, ma che possono sbandierare l’amato slogan del decennio: #maiunagioia, naturalmente preceduto dal cancelletto, lasciapassare per qualunque idiozia che, fregiandosi della dicitura di hashtag, è pronta ad assurgere nell’empireo delle citazioni più importanti, o meglio top trends, dell’anno. A fare da contorno a tutta questa paccottiglia si trovano fotografie di frasi celebri, scritte con caratteri polimorfi e con accompagnamento vegetale e fiorito, forse per distrarre – chi in teoria dovrebbe leggere – dall’assurdità delle frasi, che fanno arrossire il maresciallo Jacques de La Palice e mettere in ombra il coretto intonato dai suoi soldati a Pavia: “Ahimè, La Palice è morto, / è morto davanti / a Pavia; / ahimè, se non fosse morto / farebbe ancora invidia.” A questo punto la sera cala e per evitare i resoconti delle più svariate giornate lavorative descritte con pedissequi virtuosismi su twitter esco per un aperitivo.
sera
Mi accomodo al tavolo, e mentre attendo di essere servito da una cameriera che sta nascosta a inviare messaggi col telefonino dietro la cassa, osservo quattro simpatiche ragazze che marciano spavalde e sorridenti verso il loro tavolo. Noto che ognuna di esse impugna un telefonino, pardon, uno smartphone, il quale occupa il campo visivo della proprietaria in modo esclusivo. Appena le fanciulle si siedono, e subito dopo aver messo in mostra i lavori congiunti di tatuatore e chirurgo plastico, lo smartphone viene sistemato con cura e precisione di fronte a sé. Una volta in quel punto ci si poneva il piatto, ora no, ci sono Facebook e Instagram, molto più gustosi ed appetitosi. Le ragazze neanche si parlano, sono molto impegnate a digitare. Ma qualcosa improvvisamente turba il quartetto: arrivano quattro bicchieri di vino bianco. Attenzione, tutte in posa, boccuccia di ordinanza, bicchiere tra le mani, tutte vicine e via, una per volta scattano quattro foto pressoché identiche, che verranno inviate in poco meno di un secondo a tutti i contatti sparpagliati nei quattro angoli del Web. Considerando che le ragazze sono intime fra loro il parco amici sarà per molte parti sovrapponibile, ma è sempre meglio farsi ricordare, e se poi un’altra amica ha postato un bicchiere più bello, o più pieno, o magari con una traccia di rossetto appena stampata, ad ammiccare un bacio clandestino e segretissimo, visto solo da 2965 amici?. Stessa fotografica diffusione tocca ai piatti del cibo, scelto solo per i colori o perché il nome è facile da digitare: una chateaubriand giammai, come si scrive?, e se poi un mio follower non capisce cos’è e stizzito mi defollowa? Meglio andare sul sicuro: pizza, pasta, fragola… ecco, così all’ora di cena, come già accaduto nella pausa pranzo, il Web manda a nanna i cuccioli di gatti salterini o i cani cantanti, per pubblicare valanghe di piatti sbocconcellati in location supermodaiole ma inesorabilmente identici per non passare inosservati dall’ignoranza o dal disinteresse di chi surfa nel Web a velocità supersonica guardando “milioni” di foto al secondo, invidiando invariabilmente qualunque cosa veda, per il semplice fatto che appare su di un monitor, quindi sta in rete, ergo “esiste”.
Id: 2484 Data: 19/11/2014 01:04:36
*
Quasi perfetto
E’ appena iniziato il nuovo giorno quando la serratura della porta di ferro scatta nervosa lasciando aprire la porta, le quattro guardie accompagnate dal cappellano, entrano nella cella. L’uomo già sveglio li attende, in silenzio, uno sguardo beffardo fa capolino sul volto ben rasato, ma subito si spegne in una smorfia arrogante. “Andiamo” sibila fra i denti, mentre due guardie si accingono a riattraversare la porta, l’uomo e il cappellano affiancati precedono le ultime due guardie lungo gli umidi corridoi macchiati di muffa ed imprecazioni, paure e vendette. L’uomo non ha paura, la sua mente è fredda e lucida, niente affatto pentita per l’orrendo gesto commesso. Di lui avevano a lungo parlato i giornali, del suo omicidio cruento, inspiegabile, inutile, quasi, e per questo spesso accompagnato dalla parola perfetto nei titoli cubitali dei giornali. Certo, quasi perfetto medita l’uomo tra sé, il quasi svanirà davanti al plotone d’esecuzione, perfetto sarà il suo sacrificio, sa di immolarsi ai suoi astrusi principi, ma è così, morrà senza un sospiro, un lamento, senza un alito di paura a scomporre il suo volto, certamente senza pentimento. La sua inutile temerarietà cancellerà quell’infamante quasi che gli costò un lungo processo, gli insulti della folla, una detenzione tra il disprezzo generale. Ma lo dimostrerà a tutti, egli è un uomo – vero – e lo dimostrerà guardando in faccia la morte. Ora giunge sullo spiazzo in cui avranno fine i suoi giorni, il plotone è schierato, l’uomo passa in rassegna con lo sguardo i soldati che si apprestano a caricare i fucili. Ma qualcosa colpisce lo sguardo dell’uomo, un rivolo di sudore si materializza tra la sua schiena e la camicia nuova indossata per l’occasione. Mio Dio, non è possibile, mormora l’uomo, vorrebbe fuggire, rimandare quel momento. Le guardie pensano che si sia finalmente pentito, tema la morte, voglia fare un gesto estremo, chiedere in extremis la grazia sebbene sia troppo tardi. Nessuno sa cosa stia accadendo all’uomo, solo egli lo sa, il suo occhio acuto ha notato che la divisa di uno dei militi del plotone d’esecuzione ha una tasca strappata e manca anche uno dei lucidi bottoni d’ottone. Non è possibile, si ripete l’uomo, implora Dio di rimandare quel momento, una scena così perfetta, il plotone schierato in modo perfettamente simmetrico, un cielo terso, la temperatura, assolutamente perfetta, ma quel bottone mancante, una orrida macchia su di un foglio bianco, il segno che sancisce l’imperfezione della scena. L’uomo non può tollerare che la scena della sua morte ripeta quella temibile parola che l’ha perso: quasi perfetto, i proiettili escono dalle canne dei fucili e a velocità inarrestabile volano verso il suo petto, ma la sua faccia è sfigurata dall’orrore, la sua mente è disperata, la sua anima soffre per quel bottone mancante, per quella mancanza di perfezione, del suo ultimo istante terreno. Ha avuto paura, diranno, si è pentito, penseranno, nessuno saprà mai il perché di quella lacrima sul volto dell’uomo appena giustiziato.
Id: 2109 Data: 19/12/2013 13:56:29
*
Châtellerault
Simon si allaccia assorto la giubba, le sue mani rese un po’ ruvide dal lavoro si attardano sui bottoni, poi esitano incerte lisciando il tessuto, lo sguardo vaga, insegue il pensiero triste ed euforico, e insiste nel posarsi sul giovane che, appena discosto da lui, esegue gli stessi movimenti. Certo, le mani del giovane sono più bianche e curate, e, soprattutto, più veloci nell’eseguire i consueti movimenti di chi si appresta ad un addio. Simon vorrebbe parlare, chiedere il nome del bel giovane, farfuglia imbarazzato qualche veloce frase di circostanza. Banali parole che vorrebbero moltiplicare i minuti arrestandoli in quella luce pomeridiana che rende dorate le foglie primaverili al Bois de Boulogne. Il giovane sembra non capire, osserva, coi suoi occhi chiari, Simon, arrossisce, borbotta qualche parola, estrae l’orologio dal taschino, un guanto gli cade, lo raccoglie, è evidentemente confuso. Simon sfoglia i suoi ricordi, in tanti anni di servizio presso la principessa accenti ne ha sentiti tanti, abbastanza per dare una collocazione al giovane. Inglese, pensa, ma con un’aria familiare; forse fa parte del corpo diplomatico, oppure è il figlio di qualche nobile britannico, servito e ringraziato chissà quando in un salotto. Simon vorrebbe stringere le mani del giovane, un saluto, certo, ma anche un arrivederci, un non dimentichiamoci. Non vuole che gli attimi consumati con l’ansia ma non senza passione, con trasporto, sebbene in silenzio, vadano persi. Il corpo di Simon si è inteso alla perfezione con quello del giovane, le mute parole dell’amore erano comprensibili ai due, ma ora le parole sonore del mondo creano un divario tra loro. L’uomo vorrebbe poter donare qualcosa al giovane, ma non sa cosa, osserva il cappotto di ottimo tessuto, la catena dell’orologio e la canna da passeggio che trasudano ricchezza. Quella ricchezza che in genere significa sprezzo nei suoi confronti, lui, un povero lacchè la cui bellezza lo ha esonerato dai lavori più umili, ma non ha potuto evitare il suo confino al di là di un vetro: lui da una parte e il mondo dei nobili dall’altro, mondi incomunicabili ma contigui, e se qualche contatto c’è stato è sempre stato come la mezz’ora appena trascorsa, intenso ma furtivo, una parentesi entro la quale sigillare le proprie condizioni sociali per dare libero corso al desiderio. Il giovane ormai è pronto, le mani ancora hanno qualche momento di nervosismo, le labbra sono serrate in una smorfia acre, ma gli occhi tradiscono una profonda commozione, Simon intuisce che anche il giovane vorrebbe prolungare quei momenti, ma non può permetterselo. Il giovane si volta di scatto e si allontana seguendo la traiettoria del suo bastone da passeggio, Simon immagina la carrozza con l’equipaggio in attesa del signorino, pronta a trasportarlo nel suo misterioso mondo. Anche per l’uomo è ora di tornare, la fermata del tram è a qualche centinaio di metri, Simon copre la distanza senza rendersene conto, in preda a una malinconica felicità che gli farà compagnia, lo sa, per qualche giorno, in cui ogni possibile speranza si sbiadirà nel ricordo e nel rimpianto. Mentre il tram attraversa la città Simon osserva le carrozze che incrocia, immaginandosi il suo giovane amico di una manciata di attimi, adagiato sui cuscini, chissà, pensa, forse si affretta dalla giovane e titolata moglie, forse lo attendono al club, l’uomo tenta di calcolare quanti minuti impiegheranno la mente e il corpo del giovane per scacciare il suo ricordo, pronto a negare di essere stato al Bois quel pomeriggio, mormorando frasi di circostanza, adducendo forse un mal di capo, un improvviso invito.
Nel frattempo il giovane sta salendo sulla sua carrozza osservando distrattamente gli inchini dei lacchè, si siede e chiede di essere portato a casa, tira le tende e si immerge nei suoi pensieri. Rivive quel che anche Simon sta rievocando nella sua mente mentre entra nel palazzo della principessa, finché le sue mansioni non lo riporteranno bruscamente alla realtà, domani ci sarà un grande ricevimento e lui ha la responsabilità che tutti vengano accolti con il dovuto riguardo, senza confondere genealogie e titoli. Il giovane stancamente rincasa, e chiede di non essere disturbato, si barrica nelle sue stanze, ma ancor più sembra asserragliato in un pensiero, il sorriso timido ed imbarazzato di Simon. Il giovane ripercorre con il pensiero il tragitto delle sue mani sul corpo dell’uomo, ne sente la mancanza, si rammarica di non poterlo più vedere, vorrebbe condurlo con sé alla tenuta in campagna e vivere una vita desiderata ma proibita dalla società. Il giovane rinuncerebbe volentieri al suo titolo, alla sua posizione per non doversi più nascondere, ma sono pensieri dettati dal cuore in tumulto, ebbro di un sentimento sinora sconosciuto, ma di cui ha orrore a compitare il nome. Annulla tutti gli impegni, ma si sa costretto al grande ricevimento dell’indomani, in cui dovrà essere galante con le fanciulle, virile con le loro madri e sprezzante con tutti gli altri.
La sera del ricevimento sta per iniziare, Simon riceve le ultime disposizioni dalla principessa di Guermantes, mille raccomandazioni, su come sistemare i valletti lungo le scale, i più carini nei punti più luminosi; sa Simon, ripete la principessa, è uno degli eventi più importanti della stagione mondana e non possiamo fare qualche sbaglio, soprattutto Oriane è così inflessibile nei suoi giudizi, e tutti la temono. Io no, continua la principessa, ma non vorrei scontentare lei e Basin, che mi sono tanto cari, conclude – mentendo, pensa Simon – la scialba donnetta che tra qualche ora di paziente lavoro diventerà un delle più affascinanti dame del Faubourg. Simon procede alla disposizione dei valletti, e in ognuno ritrova uno dei tratti del giovane del giorno prima, in uno lo sguardo, in un altro il sorriso, in un altro la manciata di efelidi che si rincorrono da una guancia all’altra. L’uomo ormai si è persuaso di aver incontrato l’ennesima meteora, dove sarà, si domanda, forse sul ferry che lo riporta in Inghilterra, forse al Bois a cercare un altro Simon, un altro corpo, un altro momento di pace.
La carrozza entra nel cortile della residenza della principessa, questa sera ci sono proprio tutti, pensa il giovane osservando gli equipaggi che intasano l’angusto spazio, un vortice di stemmi, colori, livree, che però questa sera hanno un gusto diverso dal solito, sono venati di malinconia. Il giovane sale le scale osserva i valletti e in ognuno di essi ritrova qualcosa che gli ricorda l’amico troppo presto perduto al Bois: un naso impertinente, delle mani un po’ grosse, un sorriso allusivo ricompongono i tratti impressi nei suoi ricordi. E d’improvviso tutti i tratti esattamene al posto giusto, è lui, pensa imbarazzato mentre porge il cartoncino all’uomo. Simon ha un fremito, ma la sua professionalità ha la meglio mentre esclama con voce stentorea, accarezzando ogni sillaba: “Sua Altezza Monsignore il duca di Châtellerault!”
Id: 1375 Data: 15/02/2012 01:59:55
*
Domani
Id: 1329 Data: 01/01/2012 15:54:58
*
Ritorno a casa
Id: 666 Data: 16/07/2010 02:24:28
*
Mia Adorata
La mia signora cugina sfoggiava un abito di un arancione caldo, in cui la morbidezza del tessuto e l’abilità delle pieghe ricordava la dolce, trattenuta mollezza dei cachi ben maturi. Il suo aspetto curato ma un tantino rubizzo ricordava proprio la prontezza di quei frutti nell’attimo irripetibile in cui sono ben maturi ma non ancora sfatti. La signora duchessa, di lei madre, nonché mia venerata zia, invece indossava un abito candido, quasi vaporoso, ma di una vaporosità oserei dire friabile, come di farina appena setacciata, e qualche gemma che decorava l’abito faceva pensare a dei granelli di sale e bicarbonato, altrettanto candidi ma di un candore differente, più luminoso.
Il generale, augusto consorte della mia signora zia, presidiava dalla sua poltrona Aubusson, con aria marziale ma il candore quasi latteo dei suoi favoriti faceva sembrare meno minacciosa la sua divisa gallonata. Mentre tutti si abbandonavano ai pettegolezzi un po’ saporiti ma non del tutto piccanti, quasi di una speziata dolcezza, che ricordavano il chiodo di garofano e la noce moscata, il signor generale se ne stava sempre sulla sua poltrona tenendo fra le mani una coppa di ottimo cognac in cui si insaporiva della passolina di Smirne, a ricordare nel clima ormai gelido della nostra amata capitale il dolce sole delle devote colonie.
La marchesina, mia scialba cugina, come al solito stava in disparte mangiando gherigli di noce con aria accigliata.
Ad un invisibile cenno, l’orchestra appositamente giunta da Vienna, attaccò la prima polacca, a cui invitai la mia adorata cugina; mentre volteggiavamo nella stanza, un po’ per il caldo, un po’ per lo champagne bevuto, cominciai a sentire il profumo dei pettegolezzi mischiarsi con la polposità del frutto che l’abito della marchesa aveva evocato; i nostri piedi volteggiavano, quasi come se a questo frutto avessi aggiunto dell’olio di oliva.
Incrociando la signora zia col marito, fu come se la farina del suo abito, il latte dei favoriti del marito che con lei volteggiava, si fosse unito a noi, alla nostra polpa di cachi ben speziata. Anche la coppa di cognac si era venuta ad unire a noi, con la sua preziosa uvetta, la marchesina, stanca di stare in disparte si aggiunse al gruppo delle persone che danzavano, portando a questa miscela di elementi dissimili, anche la ruvidezza del suo carattere e delle sue amate noci. Al termine della danza passammo in un fumoir, caldo, per restarci almeno un’ora e mezza, e portare così a compimento la nostra serata, dolce e suadente come un pudding di cachi.
Ora, mia adorata, con questo mio omaggio mi auguro di potervi presto tenere fra le braccia e resto devotamente il vostro umile servo.
con l’affetto di sempre
…
Id: 51 Data: 25/01/2008
*
Parole
Un pomodoro, con quel metallo prezioso che racchiude è troppo importante per questa semplice storiella, togliamogli quindi l’abito lucido di cui è ammantato, diventerà così un po’ modoro, svuotiamolo anche dell’oro dei semi e avremo uno di noi, con poco oro e poche pretese, ma che sa di piacere sempre.
Della polpa di questo frutto ormai nostro simile, facciamo dei rombi, sommessi, ma che si sentano, che faranno ottimo contrappunto col rombo del mare. Lasciamo restringere bene il tutto, che sarà armonioso, un po’ troppo, forse, e allora ecco la zizzania: la doppia zeta del prezzemolo, che fa sempre un po’ incespicare, ma fa piacere incontrare in cucina perché getta una manciata di coriandoli color della speranza nelle pignatte.
Pronto da servire, ma no, servire è troppo servile, servirsi, ecco, ogni tanto bisogna provare a servire noi stessi con noi stessi, lasciare tutto da parte ed ascoltare il rombo lontano del mare.
Id: 48 Data: 19/01/2008
*
Lettera da Lisbona
Mio caro,
mi rammarico molto del fatto di essere partito all’improvviso, forse un po’ di soppiatto, con pochi bagagli e pochi saluti, ma l’opera che da tempo mi riprometto di comporre sento che richiede tutta la mia attenzione.
La vita che ho condotto negli ultimi mesi, i primi successi e le tante amarezze, sento, che mi portano sempre altrove rispetto al luogo in cui la mia mente si deve unire al mio cuore per poter descrivere con i giusti accenti l’omaggio che voglio dedicare a quel grande personaggio còrso, che tanto ha significato per il nostro vecchio e stanco continente.
Qua a Lisbona ho sistemato le poche cose che mi sono portato in una linda stanzetta nel quartiere di Alfama, una zona di pescatori che nulla sanno della mia vita e delle mie opere ma che con il loro continuo brusio ed andirivieni mi stanno dando, inconsapevolmente, il canovaccio sul quale iniziare a lavorare. Infatti, se la forma è già decisa da tempo, e il soggetto anche, lo spirito con cui fare da introduzione ancora latita nella mia mente, sebbene, il brusio, per l’appunto, credo che possa essere un buon inizio; un brusio, di menti confuse dagli avvenimenti che hanno preceduto l’ascesa dell’imperatore al potere. Brusio di sconcerto, ma anche di commenti insicuri, o già spaventati per la grande onda che stava iniziando a sollevarsi in Francia dopo i sanguinosi momenti della Rivoluzione.
Da un tessuto di brusii vorrei far levare sommessamente una voce che da indistinta si fa un poco più chiara, senza però, ancora, prendere il sopravvento, una voce che vorrei affidare agli oboe, far sussurrare loro di qualcuno che lentamente espone una sua idea, con tonalità simili ai primi raggi di sole che si affacciano dalle nubi dopo un temporale. Non voglio dare loro la cristallina voce di un sole mattutino, ma di un sole che è stato fortemente opposto dalla tempesta e si schiarisce la voce prima di tornare a splendere.
Ma in questa parte iniziale vorrei inserire anche una voce di addio per chi ho lasciato alla mia partenza, e sarà l’ultima cosa che gli avrò detto, prima di un imperituro oblio, affidata, credo, ad un pizzicato sostenuto da porre in contrapposizione agli oboe e accarezzato da due arpe (se me le concederanno); certo per i critici, se riusciranno a percepire le note di struggente addio le collocheranno nel tema generale del poema: sarà semplicemente un addio ad un vecchio mondo che si sta decomponendo, solo chi sa leggere nel mio cuore capirà a chi è rivolto l’addio. Aggiungo, sì con una certa amarezza, che probabilmente quell’unica persona che dovrebbe capire l’addio, non lo capirà, ma d’altronde, se fosse stato in grado di capire, ora non dovrebbe sforzarsi di capire quanto destinato solo ad esso, all’interno di una composizione destinata all’anonimato del pubblico.
Per il momento è quanto, devotamente
p.
Id: 42 Data: 11/01/2008
*
Una recensione immaginaria
Autore: F. Sarjenas
Editore: ed. N.E. del Veliero
Ho letto solo recentemente, con colpevole ritardo, questo ottimo libro, pubblicato qualche anno fa, credo fra il 1901 e il 1903, di un giovane autore di madre francese e padre lituano, alla sua seconda uscita, ma già con un suo stile ben definito e molto incisivo. Certo l’inizio risente di un incipit assai discutibile, e le prime frasi sono davvero insipide, quasi l’autore avesse iniziato a scrivere un po’ distrattamente appassionandosi poi alla sua opera mano mano che la costruiva.
E di costruzione si può ben parlare, visto che le frasi sono davvero ben cesellate, e formano pagine molto eleganti, alcune di una notevole incisività.
Il personaggio principale è davvero ben delineato, alcune descrizioni potrebbero dapprima sembrare solo prolissità ma hanno poi un notevole peso nel dipanarsi della vicenda, i personaggi secondari non sono mai piatte figurine di sottofondo ma hanno tutti la loro personalità e peso nello svolgersi della vicenda. Questo perché ormai capita spesso di incontrare, leggendo, certe persone messe lì giusto a scopo decorativo che poi repentinamente spariscono e chi è più attento termina il libro chiedendosi che fine avranno fatto.
In questo caso tutti contribuiscono a costruire un opera molto godibile, con spunti di riflessione davvero interessanti, oltre ad offrire uno spaccato della, per noi, poco nota, società lituana, con un effetto oserei dire alla Hugo, quando nei Miserabili ci offre uno spaccato della società parigina.
E il paragone con Hugo non è del tutto casuale, in quanto in questo libro ci si avvicina al tema della dolorosa redenzione dopo gli errori, ma una redenzione che non potrà essere completa, perché il personaggio principale, sebbene abbia espiato le sue colpe, matura un senso di colpa, questo mi pare a volte un po’ eccessivo, fin melodrammatico per certi versi, ma sempre molto umano e non incomprensibile. Si sa, e qui viene sottolineato in modo mirabile, la giustizia degli uomini e della chiesa non sempre coincidono con la giustizia a cui il nostro cuore anela, e il cuore del personaggio principale dell’opera giunge, dopo che la giustizia terrena lo ha perdonato, a desiderare una giustizia e un perdono che oserei definire “maggiore” a cui rivolge il resto della sua lunga esistenza.
Le pagine finali sono un assoluto capolavoro quasi come in una sinfonia riecheggiano le parti inziale, ma rese più mature, a volte aspre, dalla vita che ha lasciato la sua prepotente impronta in un cuore che si era affacciato al mondo candido di innocenza, che è stato insozzato, ma che ha trovato nel dolore e nell’amore un suo nuovo candore quasi innocente.
Id: 41 Data: 07/01/2008
*
Decadence e gli altri »
Questo testo è in formato PDF (51 KByte)
*
Una voce millenaria
Erano gli anni in cui Parigi era sotto l’assedio tedesco e io mi trovavo in sudamerica per respirare un’aria più tranquilla e sistemare certi affari lasciati in sospeso dall’improvvisa morte di un mio prozio. In una afosa giornata mi ero recato in città per incontrare alcuni fittavoli; ben dopo un polveroso tramonto mi misi sulla strada di casa ma l’improvvisa piena di un torrente, solitamente tranquillo, me la fece trovare sbarrata. L’avvenimento, vista l’ora tarda, mi costrinse a chiedere asilo a una silenziosa locanda che sonnecchiava nei pressi; dopo una frugale cena in compagnia di un pugno di guardinghi ma pacifici gauchos venni sistemato in un corridoio, tra pelli, bauli e mormorii, e fu subito l’oscurità più totale. Malgrado la stanchezza e l’essere avvezzo anche alle scomodità, il sonno mi era precluso da una voce, non forte, che pareva venire dal corpo di un vecchio, vecchio di mille e più anni, la quale raccontava di gesta antiche, di coraggio e di coltelli, di praterie e di sentimenti. Molto sommessamente, prima in sordina e via via più evidente, il suono di un bandoneòn cominciò ad accompagnare la voce, che, accordandosi al respiro dello strumento, si fece modulata, quasi un canto; da un altro punto dell’oscurità spuntò la voce di un violino a sottolineare i punti più intensi di quel racconto a due voci. Vinto dalla curiosità mi sollevai, con un cerino e quel che restava di una candela di sego, feci luce nell’oscurità dell’angusto corridoio e vidi, con sorpresa, ma come se me lo fossi aspettato, una coppia che ballava, stretta in un abbraccio, gli occhi serrati e le labbra increspate dall’emozione. Quale fu la mia sorpresa quando mi accorsi che la voce che credevo millenaria apparteneva ad un ragazzo poco più che ventenne, dalla pelle chiara ma abbronzata e gli occhi glauchi.
Poco dopo caddi in un sonno profondo popolato da sogni antichi; al mio risveglio non vidi più nessuno e nel mattino carico di vento me ne andai con qualcosa di inesorabile nel cuore.
Id: 21 Data: 05/12/2007
*
Marcel
Ebbi solo un’altra occasione di rivedere questo signore, fu qualche mese dopo, al Bois de Boulogne, dove ero andato a passeggiare per poter ammirare le signore eleganti che, come era allora consuetudine, facevano una passeggiata prima di colazione per farsi ammirare.
Lo vidi vicino ad una siepe di lauri che, assorto nei suoi pensieri, tracciava dei cerchi in terra col suo bastone da passeggio; quando mi vide, quasi mi stesse aspettando, cominciammo a parlare, o meglio, il suo sguardo mi faceva parlare, lui ascoltava ed annuiva. Quando gli dissi che volevo diventare uno scrittore sorrise mestamente, pose i suoi occhi direttamente sulla mia anima e disse che lui semplicemente avrebbe costruito una cattedrale in cui sarebbero state esposte delle grandi opere d’arte: le vite di ognuno di noi, poi abbassò gli occhi e, toccandosi la tesa del cappello, si congedò.
Non lo rividi mai più, dopo poco tempo tornai al mio paesello, con un grande tesoro, quelle poche parole, che nel corso degli anni hanno avuto il grande valore di un aureo monito, poche parole di una persona di cui so semplicemente il nome: Marcel.
Naturalmente non diventai uno scrittore.
Id: 20 Data: 05/12/2007