chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Paolo Melandri
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
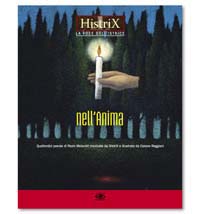
*
La pianura delle conchiglie
La pianura delle conchiglie
I rematori avevano ormai sollevato le pale e stavano accingendosi a remare verso la riva quando, quasi nel momento in cui stavano dando la prima vogata, Aquila di Mare emise un gemito: “Fossimo già approdati! Ah, se fossimo già a riva! Che freddo mi sta scendendo nel cuore. Figlio del Corvo, tu che stai in piedi, dimmi se riesci a vedere cosa sta facendo quella gente, laggiù, sulla terraferma. Dimmi, ne è giunta dell'altra?”.
Rispose Maniero: “No, non vi sono altri esseri umani in vista. Vedo però vacche e cavalli pascolare laggiù, nei prati. E quelle quattro persone… le donne si stanno togliendo i calzari e rimboccando le vesti, come se volessero entrare in acqua e venirci incontro; e anche l'uomo, che era già a piedi scalzi, ci sta venendo incontro, e la sua figura emerge dall'acqua perché le onde sono invero minuscole”.
Il vecchio non rispose nulla, ma emise un lamento d'impazienza; poi, ad un tratto, con l'acqua ancora alta, i rematori fermarono la barca e due di loro, scavalcato il bordo, scesero in mare e, sollevato tutti insieme il vecchio capo fuori dalla barca, compreso il letto, si diressero verso la spiaggia con lui in spalla. I nativi si fecero loro incontro dove l'acqua era bassa, lo presero dalle mani dei marinai, lo trasportarono sulla spiaggia dorata e lo adagiarono dove non lo potessero bagnare i pigri flutti increspati. Maniero, nello stesso momento, era saltato fuori dalla barca con un agile balzo e li seguiva a guado. Assolto quel compito, i marinai ritornarono a bordo della loro nave e un attimo dopo si udirono i loro cori mentre levavano l'ancora.
Ma quando Maniero fu giunto a riva e si fu avvicinato ai nativi, le donne, che lo guardavano di sottecchi, si misero a ridere e gli dissero: “Benvenuto anche a te, o giovane!”. Lui le guardò e vide che avevano gli stessi tratti delle fanciulle della sua terra. Avevano una pelle molto chiara ed erano assai ben fatte nel corpo, tanto che la nudità delle loro membra sotto le pudiche vesti, splendida nell'acqua del mare, era assai piacevole a vedersi. Ma Maniero si inginocchiò accanto ad Aquila di Mare per vedere come stava: “Come ti senti, grande capo?”.
Il vecchio, che sembrava addormentato, non pronunciò parola in risposta, ma a Maniero parve che le sue guance fossero diventate più floride e la sua pelle meno decrepita e grinzosa di prima. In quel momento parlò una delle donne: “Non temere, o giovane, egli sta bene e presto starà ancora meglio”. La sua voce era dolce come il verso di un uccellino in un mattino di primavera. La sua pelle era candida, corvini i capelli, e il suo corpo soavemente maturo. Rivolse un ampio sorriso a Maniero, ma non per derisione. E anche le sue compagne risero, come se fosse una cosa bizzarra la sua presenza laggiù. Poi si misero nuovamente i calzari e, con l'aiuto del loro compagno, presero il letto sul quale giaceva il vecchio, lo sollevarono e lo portarono più in là, sull'erba, procedendo sempre in direzione del bosco fiorito di cui si è già detto. Poi fecero un tratto di strada e di nuovo lo adagiarono per riposarsi. E così, poco per volta, lo portarono fino ai margini del bosco, mentre lui sembrava ancora addormentato. Allora la giovinetta che aveva parlato prima, quella dai capelli corvini, disse a Maniero: “Anche se ti abbiamo fissato a lungo con curiosità non è perché non desiderassimo conoscerti, ma perché, invero, sei bello e attraente. Ma ora attendici qui fino a quando non saremo tornati da te dal bosco”.
Detto ciò, gli strinse la mano e, sollevato ancora una volta il vecchio con l'aiuto del giovane e delle fanciulle, trasportarono il dormiente nel boschetto, lontano da ogni sguardo.
Maniero percorse alcune volte, avanti e indietro, i margini del bosco e, intanto, gettava uno sguardo a quei prati in fiore, pensando che non ne aveva mai visti di così belli. E in lontananza, fuori mano, in direzione delle colline, intravvide una grossa cupola elevarsi e si chiese se mai avrebbe avuto la possibilità di vedere anche degli esseri umani. Non lontano da lui c'erano delle vacche al pascolo; anche cavalli, alcuni dei quali, magnifici esemplari della loro specie, si avvicinarono a lui, stiracchiandosi il collo, per fissarlo. Poco distante, un quieto ruscello scorreva fuori dal bosco, attraverso i prati, giù verso il mare. Maniero vi si recò e poté constatare che vi era scarso riflusso della marea su quel lido. Infatti l'acqua del torrente era trasparente come vetro e l'erba e i fiori crescevano fin sul ciglio delle sponde. Si liberò allora dell'elmo, bevve nel torrente, vi immerse le mani, si lavò il viso, poi si mise di nuovo l'elmo e tornò ancora nel bosco, sentendosi ritemprato e fiducioso. Guardò in lontananza, in direzione del mare, e intravvide la nave dell'Isola del Riscatto farsi piccola in breve tempo, grazie ad un venticello sollevatosi dalla terraferma, che essi avevano sfruttato spiegando le vele. Poi si sdraiò nell'erba fino a quando i quattro del luogo non riapparvero dal fitto bosco, dopo essere stati via poco meno di un'ora. Aquila di Mare non era nel gruppo. Allora Maniero si levò in piedi e andò loro incontro. L'uomo lo salutò e se ne andò in direzione proprio di quella cupola lontana che aveva visto prima. Le donne, rimaste con Maniero, lo osservarono con insistenza e lui, appoggiato alla sua lancia, ricambiava quegli sguardi.
Parlò allora la giovinetta dai capelli corvini: “Vero è, giovane armato di lancia, che se non sapessimo nulla di te, il nostro stupore sarebbe assai grande nel vedere come un uomo così giovane e apparentemente fortunato sia arrivato fin qui”.
“Non capisco perché tu sia così stupita”, disse Maniero. “Dirò subito il perché sono giunto fin qui. Ma dimmi tu, prima, è questa la terra della Pianura Seducente?”.
“Ebbene”, rispose la fanciulla, “non vedi come brilla il sole su di essa? Brilla così anche nella stagione che altri popoli chiamano inverno”.
“Immaginavo che avrei sentito parlare di tali meraviglie”, rispose, “perché mi è stato detto che questa terra è invero meravigliosa. Però per belli che siano questi prati, non è che siano meravigliosi a vedersi, ora. Sono come quelli di altre terre, anche se forse sono più belli”.
“Sarà così”, rispose lei, “ma delle altre terre, non ci giungono che voci. Se mai le conoscemmo, ora le abbiamo dimenticate”.
© Paolo Melandri (1. 12. 2019)
*
Il sentiero nel bosco
Il sentiero nel bosco
Il sentiero conduceva attraverso boschi cedui. Che differenza rispetto ai boschi di abeti e conifere della nostra infanzia. Le foreste, in quella regione, erano rade dalla testa ai piedi, gli alberi – querce, castagni, faggi e betulle – crescevano a una certa distanza gli uni dagli altri, coi rispettivi rami e ramoscelli sdentati. Non c'era quasi sottobosco e, se c'era il sole, la sua luce splendeva attraverso tutta la foresta, anche se questa si estendeva a perdita d'occhio. L'espressione “luce netta” acquisiva così un altro significato. All'inizio quella luminosità non gli faceva piacere. Se in quella regione c'era il detto “vino bianco non è vino”, dal canto suo lui pensava che il bosco ceduo non fosse un bosco. Gli mancavano le tenebre, il buio, lo spazio ristretto, l'angustia, il fatto di non potersi orientare facilmente bensì di doversi aprire un varco. Oltretutto, con la loro luce netta, questi boschi di latifoglie gli sembravano poco puliti, anzi no, impuri; in altre parole, ciò che gli mancava era il sentimento della purezza, che un tempo aveva provato nei boschi di conifere, e proprio nei loro recessi più profondi, con tutto lo spavento che ne derivava – a sua volta legato alla purezza –; perfino i funghi attaccati dalle larve e perfino gli scheletri, così incredibilmente bianchi, dei cervi, delle volpi, delle lepri, irraggiavano un che di puro là in mezzo o sopra al muschio. A questo si aggiungeva che per molto tempo, forse fino a quel giorno d'estate, lui non aveva percepito i boschi cedui come luoghi in sé, come ambiente, come spazio e spazialità, bensì solamente come zona intermedia e come stazione di transito dal luogo di partenza A al luogo di destinazione B – a eccezione di quell'unica volta in cui, in viaggio con la sua futura moglie in una città ancora diversa, si era incamminato in un simile bosco di latifoglie e lei, inaspettatamente, non ricordava più se afferrandolo per la camicia o per la cintura – in ogni caso non per la cravatta e senz'altro non per i capelli – lo aveva trascinato via, quasi strappato, con un'espressione in volto come se fosse lei quella che avrebbe dovuto salvarlo.
Fino ad allora, nell'attraversare i suddetti boschi cedui egli non aveva ancora mai davvero guardato a terra. Ormai da molto tempo non lo faceva più da nessuna parte, così come da tempo ormai non guardava più il cielo – di nuovo a eccezione di quell'unica volta in cui il suo lavoro lo aveva portato in un paese dilaniato da una guerra civile, e soltanto nelle notti illuminate dalle stelle in cui le bombe cadevano a colpo sicuro. Lavoro o non lavoro, nella sua fase da uomo di mondo, puntava lo sguardo decisamente diritto davanti a sé, sempre ad altezza occhi.
E così anche in quel pomeriggio d'estate in cui, senza avere nessuno di fronte, con il cappello in mano, salì per i boschi cedui della collina. Doveva trattarsi di un punto molto erto nel sentiero, altrimenti come avrebbe potuto ritrovarsi ad altezza occhi ciò che da terra “inaspettatamente gli balzò allo sguardo” (queste le parole con cui in seguito mi raccontò l'episodio). Era un'altezza occhi alla quale prima di allora non si era mai trovato. In quell'istante non accadde niente di pregnante dal punto di vista storico, come per esempio nell'incontro tra due uomini di stato o tra due artisti; niente di fatale come ciò che a volte, al di là della storia umana, scocca tra un uomo e una donna (e non solo nei romanzi di Georges Simenon); niente di indescrivibile, come quello che più di una volta era accaduto a lui, l'avvocato penalista, a tu per tu con l'imputato. Eppure, eppure.
L'altezza occhi, stavolta, era certamente descrivibile. “Già, guarda qui!” L'oggetto, la cosa che gli stava davanti agli occhi, era descrivibile. Essa però, o esso, di per sé non aveva alcun nome, o almeno non ce n'era nessuno che in quel momento suonasse azzeccato. Perfino “cosa”, “oggetto” erano parole inadeguate. “Non ridere!”, così mi disse poi il mio amico: «Quel che allora improvvisamente – no, non improvvisamente, inaspettatamente – mi saltò agli occhi, sul momento io lo percepii come qualcosa che non aveva nome o, se avessi dovuto trovarne uno, sarebbe stata un'esclamazione silenziosa dentro di me: “Una creatura!”, con un “Oh!” davanti, come spesso avviene all'inizio delle frasi nei romanzi di Knut Hamsun: “Oh, una creatura!” E poi, non voglio dimenticarlo, prima ancora della mia muta esclamazione – soltanto ora che lo racconto mi torna in mente con chiarezza – ne emisi una se possibile ancora più silenziosa, che suonava così: “Adesso!”».
© Paolo Melandri (2. 11. 2019)
*
Il paese
Il paese
Durante i suoi anni di studio a G. aveva abitato su una collina, sul pendio rivolto verso la città e gli istituti universitari. Certo, la strada aveva costeggiato in tondo la cima dell'altura, ma il versante opposto, che volgeva le spalle al centro, o era stato sbarrato da case oppure lui non aveva mai guardato di proposito verso il basso, e ancor meno era stato tentato di fare un passo verso l'altro lato della strada e magari intraprendere la discesa; in tutti gli anni di studio quel dorso posteriore della collina non solo era stato per lui terra incognita, ma non era proprio esistito. In sogno però, nei sogni, molto, molto più tardi, il pendio rivolto alla città, insieme al paesaggio sul fondo – a una profondità vertiginosa –, gli era apparso appunto come un Altro Pianeta, e anche come sotto un Altro Sole. E a quel sogno – cosa abbastanza singolare – lui credeva. Così si mise in cammino verso la zona allora ignorata, desideroso di sapere, spinto addirittura da uno spirito di ricerca.
Di questa parte della sua spedizione non ebbe poi molto da riferire. (D'altronde, nel corso della notte, gli interessava davvero poco qualcosa come un resoconto.) Se c'erano state scoperte, erano state abbastanza comuni. L'aspetto sinistro che aveva colorato il sogno – l'Altro Pianeta avrebbe potuto perdere in ogni momento la sua atmosfera, il suo spazio aereo – era venuto a mancare. Era un giorno chiaro come pochi quello in cui il viandante, dalla strada in alto sul crinale, deviò verso il lato opposto della collina. Percorrendo in discesa le vie principali e laterali ricche di curve aveva sotto i piedi, lo sentiva sotto le suole, un terreno particolarmente compatto. Gli soffiava contro un vento ascendente, ancor più rafforzato dall'aria spostata dal suo corpo. Davanti a lui splendeva un sole primaverile, così tiepido come lo si poteva immaginare solo sul pianeta natio. Quello che del sogno continuava ad agire: la sensazione di essere immerso in un altrove. Persino la circolazione sanguigna, dal primo passo oltre il crinale, sembrò prendere un circuito diverso. Il lato posteriore del dorso collinare, a differenza di quello rivolto verso il centro, il lato nord, e anche in contraddizione con il sogno, dove era apparso del tutto disabitato, si rivelò invece densamente popolato. Lì le case piuttosto piccole, circondate da giardini di eguali dimensioni, erano spesso a un solo piano, più vecchie che nuove, e tutte di altezza diversa, a distanze irregolari, differenti anche nelle forme dei tetti, bellamente sparpagliate come dadi lanciati a caso. E questo fin dove arrivava lo sguardo, che arrivava lontano lì sul versante opposto, per così dire agli antipodi, non solo grazie al paesaggio, ma anche spontaneamente. A ogni passo si svelava una terra inesplorata, che era, estranea e familiare al tempo stesso, senza traccia dell'oscurità di un sogno: lui si sorprese mentre, alla lettera, diceva a se stesso, segretamente stupito, niente meno che: “Questo è il mio paese. Questo sarebbe il mio paese. Questo sarebbe stato il mio paese”. E in tal senso poteva forse parlare davvero di una scoperta. Influiva anche il fatto che le case, sebbene fossero quasi unicamente case d'abitazione, gli apparivano come luoghi di lavoro, là un mulino, lì una falegnameria, in mezzo una distilleria di grappa, una bottega di calzolaio, una segheria, uno scalpellino, un muratore, una lavanderia, da non dimenticare una, due fattorie e trattorie, e anche questa e quella piccola fabbrica, di qualsiasi cosa (ma non di armi), e in particolare un centro di ricerche e accanto la Casa dello Scrittore. La frase con “il mio paese” la dimenticò poi quasi subito, a dire il vero. Segretamente stupito sì, ma senza parole. Se, come un tempo era la regola, avesse preso appunti su ciò che gli passava per la testa e gli faceva sgranare gli occhi, o viceversa, il “segretamente stupito” sarebbe stato scritto tutto attaccato: segretamentestupito. I rumori, il fracasso, il frastuono erano infatti, anche in contrasto con il sogno svoltosi nella totale assenza di rumore, quelli consueti in tutto il mondo, come se ciascuno stesse inventando il suo personale radiodramma. Ma durante la discesa lo stupì segretamente, almeno in quel momento, il ronzio e il brusio, i boati e i rimbombi, l'ululato dei cani e il miagolio dei gatti, ovvero: i diversi generi di frastuono erano in funzione quasi al completo, eppure gli entravano in un orecchio e uscivano dall'altro. Lo stupore produceva una concentrazione che più istintiva e insieme più ampia di così non si poteva desiderare. Era un osservare con meraviglia, un essere concentrato unicamente su un oggetto, un fenomeno, un attimo. Ed era un imparare, gioioso, che gli faceva venir voglia di continuare ad imparare: solo così, e non così, mai più così come aveva imparato un tempo, già, nei suoi anni di studio sul versante anteriore, lì nella stanza angusta, oscurata, senza un barlume di esperienza e senza un'ombra o una traccia del presente, di validità, di qualcosa di importante per l'umanità in quello che era materia di studio. Stupire e imparare, adesso, e adesso, e adesso. Ma cosa imparò in particolare lì, sul versante posteriore della collina? “Concretamente?” Cosa di importante per l'umanità? Cosa per esempio? Per esempio lì un passero, piccolo come un colibrì, faceva il bagno in una buca polverosa. Due uomini erano fermi sulla porta di un giardino, uno dentro, uno fuori. Su un davanzale c'era un vaso. Una bicicletta cadeva a terra. Una donna aveva occhi grigioverdi. Un uomo aveva sulla guancia una cicatrice che non era uno sfregio. Un ramo scattava al levarsi in volo di un uccello. Il resto di un giornale spuntava dalla grata di un canale. Il sole splendeva. Un nero recapitava volantini pubblicitari. Un turco e un asiatico parlavano tra loro in dialetto veneto. Un aereo, atterrato, ululava lontano nella piana. Il cielo era com'era, ma sotto si muovevano uomini diversi, e anche lui, che lì camminava, era diverso. Se quello era imparare, al tempo stesso era un disimparare, non meno gioioso. E il pericolo dell'essere di nuovo fuori-di-sé, del non-più-ritrovarsi tornando dal Nuovo Pianeta sulla vecchia terra, nella vita? Non c'era quel pericolo nello stupore segreto, o c'era in minima parte. E cosa, e dove era vita lì? E, se c'era, allora provvedeva all'equilibrio, per esempio, entrare in un negozio qualsiasi e comprare qualcosa, non importa cosa, il pronunciare la cifra, l'offerta, la richiesta.
© Paolo Melandri (1. 11. 2019)
*
Georg Christoph Lichtenberg
Lichtenberg
Londra, autunno 1775. Lichtenberg si reca nell'elegante negozio del miglior costruttore di strumenti scientifici della metropoli. Quando mostra una lettera del re che garantisce per ogni acquisto, il proprietario gli consegna il primo esemplare della sua invenzione. È una macchina elettrostatica di ottone luccicante.
Giorgio III manda a Lichtenberg un invito per il tè nel palazzo d'estate di Kew. È interessato alla nuova scienza, la fisica. L'atmosfera è informale; è presente tutta la famiglia regnante. All'improvviso il monarca viene colto da uno strano attacco. Comincia a parlare in modo sconclusionato. Il principe ereditario si permette una battuta cattiva sul padre. La regina lo redarguisce. Lui se ne va furibondo. Il re si riprende; come se niente fosse accaduto, parla con il visitatore delle ultime scoperte nei mari del Sud.
Più tardi passeggia nel parco insieme a Lichtenberg. Vede in lui un uomo che sa cosa significa convivere con una minorazione.
Il boudoir di un'attrice, arredo decadente. Il principe racconta a Perdita della visita di Lichtenberg a Kew. Lei ha sentito dire che toccare un gobbo è un magico rimedio contro l'impotenza e propone al principe un esperimento. Vuole sedurre Lichtenberg. Nel momento decisivo il suo amante dovrebbe toccarlo. Il figlio del re vede in questo piano anche una possibilità di schernire suo padre, di cui disprezza la gretta vita familiare e di cui odia le ramanzine. Perdita è elettrizzata dall'idea di giacere con uno storpio.
All'ignaro Lichtenberg viene preparata una trappola. Fino a quel momento le sue esperienze erotiche si sono limitate a domestiche e sguattere. Con la bella Perdita ha gioco facile. Quando il principe esce dal suo nascondiglio, Lichtenberg si accorge di essere stato raggirato. In preda al disgusto lascia la casa e fugge da Londra a rotta di collo.
A Gottinga l'arrivo della macchina elettrostatica suscita grande scalpore. Il professor Lichtenberg alloggia in un vecchio edificio pieno di anfratti in cui ha allestito un laboratorio con svariati strumenti e apparecchi. È arrivato alla conclusione che l'energia dell'amore sia dovuta a un fluido sconosciuto che presenta somiglianze con l'elettricità animale. Su questo tema tiene una lezione all'università che ha uno svolgimento decisamente bizzarro. Quando arriva al punto critico, Lichtenberg cade dall'alto sgabello su cui è seduto. Gli studenti reagiscono con un misto di curiosità, scherno e inquietudine.
Lichtenberg si riprende dalla depressione e decide di dedicarsi a nuovi esperimenti. Stavolta si tratta dell'elettricità dell'aria. Per misurarla, costruisce un aquilone. Una gran folla si è radunata sui bastioni per seguire l'esperimento. Durante i preparativi, Lichtenberg nota una giovane fioraia. Le chiede quanti anni ha e da dove viene. Si chiama Dorothea Stechardin. Mentre l'aquilone si alza in volo, lui continua a girarsi verso di lei. Non si accorge delle nuvole temporalesche che si addensano sopra la città. Un fulmine colpisce l'aquilone, che è collegato a terra, e lo fa precipitare. L'esperimento è fallito.
Il giorno dopo il professore fa visita ai genitori di Dorothea. Vorrebbe assumere la ragazza come domestica. I genitori acconsentono, perché Lichtenberg offre un generoso compenso. Dorothea dovrà occuparsi della pulitura dei suoi strumenti scientifici. Ma segretamente lui persegue un piano ben diverso. Vuole produrre la prova delle sue scoperte. La quindicenne appare come ideale cavia umana. I due cominciano a osservarsi e a spiarsi a vicenda. L'intimità crea un'atmosfera di desideri inespressi. Lichtenberg le insegna a leggere e a scrivere. Riesce a documentare, anche senza un diretto contatto fisico, tracce di fluido erotico in base a fenomeni di fluorescenza e di risonanza.
Nel momento in cui l'amore inizia a far scintille, lo studioso è raggiunto da un invito del re inglese che equivale a un ordine. Non gli resta altro che partire immediatamente per Londra. Giorgio III gli mette a disposizione un alloggio in una palazzina nel parco di Kew. Lo colma di onorificenze. Lichtenberg diventa membro della Royal Society. A un ricevimento gli viene presentato Omai, che Forster ha portato con sé da Tahiti. Il polinesiano non comprende perché non possa abbracciare una donna che gli sorride solo perché si tratta della figlia del lord cancelliere. In Lichtenberg, questa naturalezza suscita una grande impressione.
C'è un colloquio con il re nell'ossevatorio astronomico di Richmond. È presente anche il medico personale di Giorgio III, che però si tiene in disparte. Lichtenberg mostra al re Venere e gli parla della spedizione di Cook nel Pacifico. Ma il re ha altro per la testa. A prescindere dalla guerra con le colonie americane, lo tormenta la paura dell'impotenza e di un nuovo attacco psicotico. Anche il pricipe ereditario gli è sospetto. Pensa persino che voglia attentare alla sua vita. Prega Lichtenberg di rimanere a Londra e gli offre una splendida posizione. Ma lui ha in mente solo una cosa: l'esperimento con Dorothea, che lo aspetta a Gottinga. Risponde in modo evasivo. Il re è offeso e gli impone di restare.
Il medico personale, che riguardo alla malattia del monarca non formula una prognosi favorevole e pensa addirittura alla sua interdizione, punta sul principe ereditario, con il quale è in contatto. Vede in Lichtenberg un pericolo per i piani dell'erede al trono e informa quest'ultimo sul colloquio nell'osservatorio.
Il giorno seguente Lichtenberg lascia Kew per recarsi a teatro. Nella carrozza che lo viene a prendere si trova di fronte una giovane donna che gli si offre in maniera inequivocabile. Ma questa volta non ci casca: minaccia di buttarla fuori dalla carrozza in corsa. Il cocchiere si volta verso di lui: è il principe. Invece della donna è Lichtenberg a finire in strada. È preso dal panico, ruba i vestiti a un giardiniere e fugge. Sotto falso nome raggiunge una nave che lo porta ad Amburgo.
Il re si mostra generoso. Lo perdona e ordina che gli spediscano a Gottinga un nuovo telescopio e il suo guardaroba. Lichtenberg cammina per strada in nuovi abiti eleganti e fa vedere a Dorothea le sue magnifiche parrucche. Parla soltanto inglese. Convince la ragazza a stabilirsi stabilmente da lui. Si dedica tutto alla costruzione della macchina che dovrà servire al grande esperimento. Una notte giunge il momento decisivo. L'unione dei due genera la prova lampante dell'esistenza della quarta forza elementare. Sono entrambi felici. Ora Lichtenberg è alle prese con un altro problema: si preoccupa della stabilità dell'amore. Realizza di nascosto un accumulatore che, alla maniera di una bottiglia di Leida, dovrebbe assicurare il potenziale delle forze d'amore anche per il futuro; in fondo ha ventitre anni più della sua amante.
Cede alla tentazione di presentare la grande invenzione agli studenti. D'improvviso interrompe la lezione a metà e scompare nel suo alloggio privato. Adirati, nonostante il severo divieto gli studenti fanno irruzione nell'appartamento. Lo trovano mentre copula con Dorothea dentro una macchina che miscela e accumula il fluido. La luminescenza e lo scintillio sono così forti che i guardoni restano accecati e si danno alla fuga.
Il rapporto tra gli amanti è cambiato. Per nulla passiva e arrendevole, Dorothea ha progressivamente acquistato coscienza del proprio valore. Allo scienziato sfugge il dominio sull'esperimento messo in atto. Si ha quasi l'impressione che, a modo suo, Dorothea esegua un esperimento su di lui. Ottiene il permesso di comparire nelle vesti di padrona di casa quando Lichtenberg invita i propri amici. Nella piccola città il fatto suscita scandalo.
Alla fine del semestre la situazione deflagra. I due partecipano al tradizionale ballo di chiusura, al quale sono invitati tutti i notabili e i più ricchi fra gli studenti inglesi. Uno sconosciuto in maschera invita Dorothea a un giro di danza. Lichtenberg, che non sa ballare, li osserva. Lo sconosciuto si apparta con Dorothea nel cortile interno, dove tenta di violentarla. Alle sue grida di aiuto accorrono tre studenti, che bloccano lo sconosciuto, lo minacciano con gli spadini sguainati e gli strappano la maschera. È il principe ereditario. Dopo avere pugnalato un rivale in un bordello londinese, ha dovuto lasciare l'Inghilterra per qualche tempo. Viaggia in incognito. Gli studenti, che lo hanno riconosciuto, non possono trattenerlo. Quando viene a conoscenza del fatto, Lichtenberg è furioso.
Nella piccola città girano voci sugli inquietanti esperimenti che conduce con la Stechardin. Si dice che con l'aiuto della sua invenzione possa sottomettere qualsiasi donna. Le supposizioni scatenano invidie, paure e ipocrisie. Tra gli studenti nascono due fazioni. Gli avversari di Lichtenberg vogliono metter fine alle sue pratiche, se necessario con la forza. Il loro mandante e finanziatore è lo straniero, che riesce a conservare l'incognito. È anche alla testa della masnada che una sera si presenta davanti alla casa di Lichtenberg.
Lui e Dorothea vedono dalla finestra la gentaglia che si avvicina e il caporione che istiga la folla. Hanno intenzione di distruggere il misterioso apparecchio. Lasciali fare, dice Dorothea al suo compagno spaventato. La macchina non ci serve più. I due si nascondono in un armadio a muro. La macchina viene fracassata. Ma quando il principe cerca di distruggere anche la grande macchina elettrostatica, crolla a terra colpito da una scossa. I suoi seguaci pensano che sia morto e lasciano precipitosamente la casa.
La situazione è pericolosa anche per Lichtenberg e Dorothea. La ragazza tenta di rianimare il principe con una respirazione bocca a bocca. Arriva il medico chiamato d'urgenza; l'erede al trono si salva e viene portato via su una barella. Furioso per l'umiliazione subita, sussurra a Dorothea: Tra noi non è ancora finita. Mi rivedrai!
Il principe è tornato in Inghilterra. Lichtenberg non ha più intenzione di esporsi ulteriormente all'atmosfera ostile di Gottinga. Si trasferisce con Dorothea in un'incantata casetta con giardino appena fuori città. Un nuovo sogno si è impadronito di entrambi: il volo. Dalla Francia arriva la notizia di macchine aerostatiche che si sollevano in aria. Da scienziato Lichtenberg si chiede se non esista una componente dell'atmosfera più leggera dell'aria. Grazie all'aiuto dei pochi strumenti che ha salvato riesce a isolare con metodi elettrostatici una piccola quantità di idrogeno. In un mattatoio si procura vesciche di maiale tasparenti che riempie di gas. Quando queste si librano toccando il soffitto Dorothea è entusiasta. Lichtenberg è riuscito a mettere in salvo anche l'elettroforo, il canocchiale e un paio di accumulatori. Dorothea non immagina che là dentro è conservata una riserva della loro energia amorosa.
Sette mesi dopo Dorothea muore di tubercolosi. Nei suoi vaneggiamenti febbrili le appare il principe ereditario che la minaccia. Al tempo stesso vede davanti a sé la scena in cui Lichtenberg è a letto con una sconosciuta, mentre il principe lo schernisce.
Il suo amato riesce a scacciare questo incubo. Apre la finestra e fa salire in cielo decine di palloni. Anche noi voleremo via come loro, dice. Le descrive i paesi e i continenti sopra i quali passeranno. Quando Dorothea cessa di respirare, lui libera gli ultimi palloni.
Al funerale partecipa da lontano. Il cimitero si trova nelle vicinanze della casetta. Con il canocchiale Lichtenberg segue dal tetto il percorso della bara. Poi scende di sotto e apre le bottiglie verdi nelle quali è immagazzinato il fluido. Ebbro d'amore come non mai entra nella grande stanza al pianterreno. Lì, sul divano, lo attende Dorothea. Ha l'aspetto che aveva al loro primo incontro. Non dice una parola. Lichtenberg le gira attorno e poi si siede con cautela sulla sedia accanto a lei. Dopo qualche istante dice: Sapevo che saresti tornata.
© Paolo Melandri (17. 10. 2019)
*
Il promontorio del tempo
Il promontorio del tempo
L'ospitante rifletté ad alta voce sul tempo. Era da sempre il suo problema o, ritradotto in greco, il suo impedimento, o “promontorio”. Già l'avevamo sentito spesso iniziare da quel tema e ogni volta con un sospiro se possibile ancora più profondo: “ahimè, tempo…”, “ah, tempo…”, “a-ha, tempo…”. E ogni volta era rimasto impantanato in qualche punto del suo cosiddetto “problema di fondo”, e così, con nostro quanto suo sollievo, avvenne anche stavolta. “No”, disse all'incirca, “per me il tempo non è stato e non è un problema, piuttosto un enigma. Nell'esistenza, nell'una vita, all'inizio un enigma assoluto, l'enigma più assoluto, l'enigma degli enigmi, l'enigma puro e semplice, poi, col tempo, no, contro il tempo, un enigma spaventoso, lo pseudonimo di morte o anche soltanto di noia, del non-saper-che-fare di me e del mio tempo. Nell'una vita, nell'esistenza, fino a oggi il tempo passa per me troppo velocemente o troppo lentamente. Invece nel raccontare, nella mia altra vita, il tempo, dall'inizio fino ad ora, e ora, e ora, mi apparve come un enigma fecondo, no, basta coi giochi di parole: come un enigma splendido. Anche qui, nel raccontare, non so come usare il tempo. Ma qui sento o insieme presagisco che lui, il tempo, santo cielo, è dalla mia parte, e io, appena nel mio raccontare le cose vanno nel verso giusto, mi muovo, no, mi baso su di lui. E questo fa sì, mi sembra, che nel tempo del raccontare, diversamente dal tempo del contare – per me nella vita quotidiana troppo spesso, in un modo o nell'altro, un tempo del contare forzoso –, invece di dati massicci, generalmente pretestuosi e imposti, si offrano forme o anche soltanto formule del tempo con l'aiuto delle quali io posso giocare, no, saltare, sì, ricercare e dimenticare il tempo vigente. “Nell'estate scorsa…”, “Nell'inverno seguente…”, “Quando scoppiò la guerra…”, “Quando mia sorella poteva ancora parlare…”, “Un anno dopo…”, “Poco prima di Pentecoste…”, “All'inizio del Ramadan…”, “La mattina del giorno dopo…”, “La sera del terzo giorno…”, o anche soltanto: “E poi… e poi…”, o addirittura: “E… e… e…”. Il tempo del racconto: splendido enigma? Oppure un problema, ma per l'appunto splendido? Oppure no, fantastico? Liberatorio? Conciliante? O tempo… Ehi, tempi! E voi cosa ne pensate?” Al che noi, non molto diversamente da lui, ciascuno al suo tavolo nel salone del battello, ci abbandonammo a un dondolio della testa da cui in verità non uscì nient'altro che un ronzio qui, un brontolio lì, un “ehm-ehm” là, un raschio, uno sbruffo, un sospiro: nulla che avrebbe indotto il padrone del battello a continuare il racconto. Cosa che riuscì poi a ottenere, finalmente, una detonazione, forte, nella cucina di bordo, anche se, oppure no?, ma certo!, proveniva solo dalla stappatura di una bottiglia, che un attimo dopo, come già nell'ora notturna precedente, ci venne servita dalla misteriosa sconosciuta. Il nostro ospitante, da sempre timoroso senza peraltro essere preoccupato (differenza), a quel rumore era trasalito, proprio come per un secondo (e un po' di più) erano ammutolite le miriadi di rane nei canneti lungo la riva del fiume, insieme alla civetta sul prato rivierasco che continuava a cantare con voce flautata, prevedibile nota dopo nota, e proprio come per un momento tutti i cani abbaianti sparsi nel lontano villaggio avevano emesso un uniforme ululato notturno. Poi però la sua voce tanto più calma e più profonda, anche se a volte, no, di quando in quando, un po' tremante, e quello che espresse, come già detto, con chiarezza, a volte più, a volte meno. “La sera del giorno seguente.” “Parecchio tempo dopo.” “Dopo molti altri guadi.” “Dietro le sette montagne poi.” “Entro tre giorni di cammino.” “In un'ora di macchina.” “Prima del decollo.” “Durante il proseguimento del volo.” “In un mattino tempestoso.” “Sotto un temporale.” “Nell'ora della sua morte.” “Al tempo del disgelo.” “E poi…” “E poi…” “E poi…”
Nel suo viaggio circolare dovette passare parecchio tempo prima che gli venisse più voglia di tornare al battello sul fiume. Nel primo periodo, di nuovo solo dopo il lungo tragitto assieme in corriera, contava non soltanto i giorni, ma anche le ore e a tratti persino i minuti; ah, finalmente me ne sono lasciato un altro alle spalle. Le prime notti, nei momenti di dormiveglia, pensava di essere ancora nel suo solito letto e nella solita stanza. Tanto più estraneo poi l'ambiente reale, diverso da una notte all'altra, così estraneo che non c'era più motivo di osservarlo con stupore. E furono necessarie più di alcune notti in quella sorta di estraneità perché non sentisse più la mancanza del suo letto. E solo dopo diverse false strade e peregrinazioni gli andò bene un posto per dormire qualsiasi, quando gli bastò potersi distendere da qualche parte. E dovette restare in giro parecchio tempo prima che arrivasse il momento in cui pensò: “Adesso comincia l'avventura!”.
© Paolo Melandri (13. 10. 2019)
*
Il sacrificio
Una solitaria nuvoletta bianca si gonfiò nell'azzurro assolato, prese colori trasparenti, fiabeschi, qualcosa di simile a una testa crebbe al suo interno, e mosse ali o un sottile vestito a pieghe. Una rosa che si schiudeva? No, una medusa che sussultava attraverso il cielo, più vicina, si gonfiava e si restringeva, e di nuovo si ingrossava. E il lungo filo di ragnatela, libero, che dal folto ondeggiava al vento proprio sopra di lui, si estese, si ritorse, assunse un riflesso argenteo, mostrò un disegno a losanghe e poi gli fece il solletico con l'estremità inferiore, come la punta di una pelle di serpente, impensabile qualcosa di più lieve e un contatto più delicato, e anche questo faceva parte del centro, era centro.
Gli occhi gli si chiusero, e sebbene li volesse riaprire, lo volesse davvero, non ci riuscì, no. Fiutava un pericolo, ma non per sé, disteso lì sul ciglio erboso, i piedi nel vuoto che sarebbe potuto essere un abisso. Non lo era. Si sentiva di nuovo imbozzolato nel vento estivo, costante, che attorno al punto in cui giaceva era un vento ascendente, da ciascuno dei centri di sotto, e i rumori della metropoli, sonorità uniforme, lo avvolgevano da ogni lato e in più lo proteggevano.
Il pericolo minacciava qualcun altro, e precisamente suo figlio. Che però era un giovane uomo in grado di pensare a sé stesso, o no? E se aveva bisogno di aiuto, meglio che venisse da terzi. Non era forse circondato da persone come lui, che col tempo erano diventate i suoi veri parenti e in caso di bisogno sarebbero venute in suo soccorso? Il padre da tempo assente aveva perso il diritto di essere d'aiuto, e inoltre non sarebbe stato un aiuto, in questo caso era più decisivo l'aiuto che veniva dalla madre morta.
Ma non si trattava di aiuto, di cosa piuttosto? Di salvataggio. E per un salvataggio lui, il padre, era la persona giusta, anche questa era una certezza. Toccava a lui. Salvare il figlio, certo, ma come? E da che cosa? Di fronte a cosa? Non che in quel momento il giovane stesse andando alla deriva nell'acqua, verso una rapida, una cascata del Niagara, o che dopo un incidente giacesse gravemente ferito, non visto, in un fosso nascosto da cespugli, o che fosse caduto in un serpaio durante un'escursione solitaria sul versante meridionale di una montagna carsica. Vedeva il figlio in un pericolo mortale, impellente, ma che non era un pericolo esterno. Vedeva che senza di lui il ragazzo sarebbe morto, di lì a un'ora. Vedeva come a lui, al sangue del suo sangue – finora dentro di sé non aveva mai avvertito questa sensazione, riguardo al suo discendente! –, una terza mano sarebbe uscita dall'interno del petto, stretta a pugno, e per il figlio sarebbe finita. E vedeva sé stesso mettersi a correre e attraversare fiumi e montagne in una sola ora per arrivare dal suo altro-sé-stesso. E si vedeva, a questo d'altronde si era abituati dai film, mentre riusciva a raggiungerlo all'ultimo momento. E a salvarlo.
Però – ancora una volta – come? Perché qui c'era ben poco da salvare. Contro una minaccia dall'interno, contro una terza mano come quella, che da sé si rivolgeva contro qualcuno, non si poteva ottenere nulla? Lo salvò, fece sparire il pugno chiuso all'interno del suo congiunto, lo rese privo di peso e di sostanza sacrificandosi, avete sentito bene, sacrificandosi. Non sacrificandosi per la pace e magari per la comunità. Certo, lui avrebbe messo in gioco la propria vita, e non semplicemente in gioco, e nel gioco, lo sapeva, sarebbe morto. Ma si sarebbe sacrificato soltanto per il suo congiunto, per niente e per nessun altro, non per la donna e non per un vicino, per un estraneo o addirittura per la pace nel mondo.
© Paolo Melandri (6. 10. 2019)
*
Primo disordine
Una sottile fetta di salame pende dal panino.
Il venditore ambulante smette di guardare. L'oggetto non può essere caduto da solo. Quando l'uomo a cui dedica la frase distoglie lo sguardo, continua ad applicare la frase al più vicino, senza interromperla. Scorge un tubo di crema da barba col tappo svitato. Gli va di traverso la lingua. L'uomo si guarda il pollice. Tiene un bicchiere con la mano nuda. Il venditore ambulante guarda la bottiglia di birra ridendo.
Improvvisamente non sa dove andare. Si sforza ripetutamente di colpire la medesima tacca. Tutto quello che vede gli sembra un corpo estraneo. Quando il nocciolo vien strappato fuori dal frutto, si sente uno scricchiolio. Lui alza la testa, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Il tubo per terra viene tirato di colpo contro l'angolo della casa. Le sue mani pendono contro le cosce. Non desidera restare qui, ma neppure andarsene.
Il burro molle cade con uno schiocco sul pavimento di pietra.
La tosse lo soffoca.
Dietro le ginocchia della donna si disegnano le vene. L'uomo intasca la lettera senza aprirla. Il gatto non ha visto nulla. “Questo è sangue di maiale.” Un bicchiere tintinna, forse è una vetrata.
Il solo punto asciutto della strada ha la forma di un uomo in una posizione simile a quella di una rana.
La palpebra gli trema.
Dimostra la sua innocuità camminando con la giacca aperta. Il venditore ambulante ascolta un respiro che non è il suo. La camicia lascia intravvedere la pelle nuda.
Ora non hanno più niente di cui parlare, devono parlare di sé.
Si muove perché notino che è ancora lì. Le spalle dell'uomo sono gradevolmente ampie. La vivacità si manifesta sbracciandosi. In cima allo steccato è avvolto un voluminoso panno chiaro. Lui schiaccia la sigaretta voluttuosamente. Il sedile dell'automobile è caduto in avanti, sul volante. La scarpa è sotto la scala, nell'ombra, in una posizione in cui non si trovano di solito le scarpe vuote. Si tiene fermo il copricapo mentre parla, benché non spiri un alito di vento. L'uomo non si volta mai, e così non riesce mai a vederlo in faccia. Un grosso giornale cade pesantemente sulla strada.
Quando i due, poco dopo il primo incontro, tornano a incontrarsi nello stesso posto, sorridono imbarazzati.
Fissa il ricevitore che è lì, pronto per lui. Quando il sudore freddo comincia a scorrergli sulla pelle, lo spaventa come un contatto estraneo. La molletta è troppo cedevole per tenere il giornale. È un uomo di età indefinibile. La spugna tuffata con forza torna rapidamente alla superficie. La linea si è interrotta.
Si pulisce l'abito, poi osserva la punta delle dita. La piega è ancora abbastanza fresca. Il bottone allentato penzola dal cappotto. La cassa all'interno è molto ampia. Si china un poco sul microfono, come fa chi riceve la risposta. Tutti continuano a muoversi con velocità costante. Chi si avvicina alla compagnia viene soltanto per unirsi ad essa. Il venditore ambulante osserva una scarpa abbandonata.
Per un istante qualcosa ha brillato, ma lui non è riuscito a riconoscere l'oggetto che deve essersi mosso. Quando solleva la testa gli vengono le vertigini. La tenda è già rossa in partenza.
Non si vedono più bolle nell'acqua. La ruota giace sulla strada in una strana posizione obliqua. Si appoggia al muro e riflette. Parlano di lui come di un oggetto. La merce non si vede perché il suo nome è così ridicolo e sgradevole. Il giornale scivola sulla strada a scatti intermittenti. Sul collo della donna compare una vena che pulsa violentemente. Al telefono chiedono di uno sconosciuto.
La scarpa solitaria ha la punta schiacciata.
Osserva che la pozzanghera si estende sempre più. Si scambiano consigli su come togliere la macchia di unto. La tegola non è caduta, l'hanno gettata! L'uomo indica con la sigaretta. Sono entrate nella casa più persone di quante ne siano riuscite.
Scorge un mucchio di argilla isolato e spiaccicato. La pupilla si dilata. È l'attizzatoio che manca!
La pelle di lei gli sembra incompleta senza contatti estranei. Diventa loquace per mancanza di ricordi. Non guarda negli occhi nessuno. Il fatto di tenere la testa più in alto o più in basso del normale lo rende mal certo, ma gli permette di scoprire cose nuove.
Improvvisamente una tapparella vicinissima a lui si abbassa con fragore. Lo scoppio non era destinato a nessuno. In un secondo la macchia si diffonde sulla camicia inamidata.
Il venditore ambulante si scusa di un contatto involontario. Da qualche parte qualcuno grida, e una porta sbatte rumorosamente. All'uomo cade di mano un frutto.
© Paolo Melandri (6. 10. 2019)
*
Il cavaliere nero
Il cavaliere nero
In un'armatura di acciaio nero sto dinanzi a un castello infernale. Le sue mura sono nere, le torri gigantesche di colore rosso sangue. Dinanzi al portone divampano guizzando bianche fiamme, come colonne di fuoco. Mi apro un varco, attraverso la corte del castello e salgo la scalinata. Una fuga di sale si apre ai miei occhi. Il rumore dei miei passi si rifrange contro le massicce pareti, e l'eco rompe il silenzio di morte. Entro finalmente nella stanza circolare di una torre; sopra la porta è scolpita una rossa chiocciola. La stanza non ha finestre, ma s'indovina l'enorme spessore delle mura; nessuna luce arde, eppure uno splendore senz'ombra illumina lo spazio chiuso.
A tavola siedono due fanciulle, una bruna e una bionda, e una donna. Benché le tre figure non si somiglino, devono essere madre e figlie. Sulla tavola, dinanzi alla fanciulla bruna, c'è un mucchio di lunghi e lucenti chiodi da maniscalco. Ella li prende in mano uno dopo l'altro, con cura, saggia la loro punta aguzza, e li conficca nel viso, nelle membra, nel petto della fanciulla bionda. Costei non si muove e non le sfugge un grido. La bruna le solleva la veste per un attimo, e vedo che le cosce e il corpo straziato sono un'unica sanguinosa ferita. A questi silenziosi movimenti si accompagna un'insolita lentezza, come se congegni segreti ritardassero il corso del tempo.
Anche la donna che siede di fronte alle due fanciulle resta muta e immobile. Come le immagini dei santi che si trovano in campagna, ella porta un grande cuore ritagliato in carta rossa che le nasconde quasi interamente il seno. Con orrore, mi accorgo che ad ogni punta di chiodo confitta nel corpo della fanciulla bionda quel cuore si sbianca come neve, a somiglianza di quel che accade al ferro che da rovente si fa incandescente. Mi precipito fuori, verso l'uscita del castello, poiché mi sento impari a sopportare questa prova. Corro via tra due interminabili fughe di porte, tutte ermeticamente chiuse da chiavistelli di acciaio. Ecco, ora so: dietro ogni porta, dal più profondo sotterraneo fino alla camera che è in cima alla più alta torre, si stanno compiendo innumerevoli supplizi di cui nessun uomo avrà mai conoscenza. Sono penetrato nella segreta rocca del dolore, ma già il primo dei suoi esempi era troppo atroce per me.
© Paolo Melandri (29. 9. 2019)
*
La radura
In seguito uscì dal bosco, all'aperto, anche se non in una delle propaggini della metropoli, bensì in una radura che creava l'impressione di essersi addentrati per davvero nei boschi soltanto adesso, e precisamente al loro centro. Se attorno alla tenuta della donna l'erba arrivava ai fianchi, qui era alta fino al petto. La luce era, appunto, come può essere solo in una radura, e spirava un vento vivificante nel quale la lanugine dei cardi sfiorati, che formava piccole isole nell'erba, veniva sospinta tanto lentamente quanto costantemente attraverso lo spazio aereo della radura. Più nessuna aquila in cielo, nient'altro all'infuori della monodia dei grilli sprofondati nell'erba, che usciva dal basso, dal – come si chiamava? – regno terreno. Il cuore si allargò, al massimo. E gli venne in mente la donna. È vero: non l'amava. Ma insieme a lei si sentiva abbellito. E questo era niente? Aveva tempo. Aveva ancora tempo; nulla di più degno per un uomo. “Ciao, nuvole!”
© Paolo Melandri (26. 9. 2019)
*
Catabasi
Catabasi
Erano le dieci del mattino. Al primo piano, in una grande sala comune che dava su un gruppo di aiuole disposte banalmente, la cui terra era stata rivoltata e lasciata esposta ai primi freddi, sopra qualche faggio che aveva ormai preso l'ultimo colore dell'anno e qualche rosa fiorita tardi, c'erano quaranta o cinquanta persone sedute o intente a gironzolare. Nessuno guardava fuori dalle finestre. Erano di tutte le età, stature e corporature, e c'erano sia uomini che donne. Tuttavia, c'era una maggioranza di persone di mezz'età, soprattutto donne. Alcune guardavano la televisione, o meglio, siccome i programmi non erano ancora iniziati, guardavano l'immagine di prova – una cascatina che scendeva sulle pietre sotto alcuni alberi fioriti, in primavera. Alcune lavoravano a maglia, altre chiacchieravano. Sarebbe stato facile pensare di essere nella sala di un albergo di seconda categoria o di qualche paese di provincia, se non fosse stato per il tipico odore di medicinali.
C'erano tavoli e poltroncine sparpagliati per la stanza; al tavolo centrale, interamente coperto da un solitario particolarmente complicato, sedeva una ragazza tutta sola. Era bruna e aveva un'aria mediterranea. Aveva capelli scuri e lisci, grandi occhi neri e pelle olivastra. Era snella ma formosa, anche se non eccessivamente. Corrispondeva dunque all'idea di bellezza femminile e alla moda del momento. Indossava un abito nero che seguiva elegantemente la linea del seno e delle anche. Le maniche erano lunghe e strette. Il collo era alto e aderente. L'abito aveva semplici polsini bianchi e un colletto arrotondato, anch'esso bianco. Questi ultimi erano un po' sporchi. L'abito sarebbe stato adatto per una governante, per una segretaria perfetta, o per una giovane signora vittoriana che trascorreva la mattinata a controllare i conti, se non fosse stato che terminava dieci centimetri sotto l'attaccatura delle cosce. In altre parole, era un miniabito particolarmente succinto. Sarebbe stato difficile immaginare un miniabito più sorprendente. Il contrasto tra la sua severità e convenzionalità e le lunghe gambe nude era particolarmente stupefacente: a vederlo, stupiva davvero. Le gambe della ragazza non erano completamente nude. Indossava delle sottilissime calze color grigio chiaro, ma non indossava le mutande. Era seduta a gambe spalancate, in un modo che faceva pensare che le avesse dimenticate, o che fosse talmente impegnata a controllare e gestire la sua metà superiore da non potersi prendere la briga di ricordarsi delle gambe e pure del sesso. Le sue parti intime spiccavano, erano una macchia scura, umida, cespugliosa; la loro esposizione le donava un'aria ingenua, affascinante, commovente.
Fra le pazienti sedevano due infermiere. Erano entrambe povere donne proletarie, pagate troppo poco, e si trovavano lì soltanto perché i loro mariti non guadagnavano abbastanza per mantenere una famiglia secondo il livello che la televisione promette alla nazione. Le donne guardavano la giovane più spesso di quanto non facessero con tutte le altre pazienti. Lo facevano con un astio che non si sarebbe placato nemmeno con uno stipendio dieci volte superiore a quello che guadagnavano.
Entrambe avevano figlie adolescenti, ed entrambe conoscevano bene le liti che si fanno per il trucco e i vestiti. A una delle due piaceva che la figlia mettesse abiti corti e si truccasse molto e all'altra no, ma quella differenza tra loro si era dileguata sotto la pressione di un'inquietudine profonda, causata dagli scontri violenti che avevano avuto con quella ragazza, Bianca, i cui miniabiti erano ben più corti di quanto richiedesse la moda, e che entrambe trovavano disgustosi, anche senza considerare il fatto che la giovane si rifiutava di portare le mutande. Le parole che Bianca rivolgeva alle infermiere (figure materne, autoritarie, come entrambe erano state addestrate a interpretare alla perfezione), accusandole di essere all'antica, di odiare le ragazze, di essere sessuofobe, vecchie e via discorrendo, erano esattamente, ma proprio esattamente, parola per parola, le stesse che si sentivano dire dalle figlie durante le liti. Il fatto che Bianca fosse pazza, e che usasse le stesse argomentazioni delle loro figlie per non portare le mutande, così da avere sempre un aspetto provocante e da causare continui problemi con i pazienti maschi già di per sé poco stabili, costituiva un turbamento troppo grande per la morale comune. Ovviamente lo schema di riferimento morale di una delle due infermiere – quella che approvava le minigonne, le ciglia finte e il trucco pesante sugli occhi della figlia – era molto più liberale di quello dell'altra; tuttavia, entrambe finivano per pensare diverse volte al giorno che le loro posizioni, liberali o all'antica che fossero, posizioni di cui entrambe andavano orgogliose, venissero vanificate o addirittura messe in ridicolo dal fatto che la signorina Bianca se ne stava lì seduta con le gambe spalancate, a mostrare tutto ciò che aveva. E per una questione di principio. In nome della libertà, dei diritti dei giovani e del miglioramento della condizione femminile. Entrambe le donne avevano ammesso con sé stesse, e successivamente con la collega e con i dottori, che di tutte le pazienti di cui si occupavano Bianca era quella che metteva più duramente a prova la loro capacità di autocontrollo. Erano pronte a dire che la odiavano, un atteggiamento che alcuni dei dottori a loro superiori avevano condannato come privo di perspicacia e controllo, e che invece altri avevano approvato in quanto dimostrazione di onestà e franchezza nei confronti della paziente e di loro stesse. Le infermiere sapevano benissimo che il modo di Bianca di starsene seduta lì, con indosso la parodia di un vestito da governante e il sesso in bella vista, era una sfida alla loro sanità mentale. Per giunta, oltre ad avere l'odore sgradevole delle medicine, Bianca non si lavava quanto avrebbe dovuto (un segno riconoscibilissimo della sua malattia) e puzzava.
Era anche bellissima, di una bellezza esotica e per nulla convenzionale.
Sedeva da sola. Sapeva di essere sempre stata sola. Faceva solitari con le carte perché sono giochi che si fanno da soli. Tutto intorno a lei, se solo le persone avessero avuto occhi per vederlo, c'era uno spazio in cui guizzavano e saettavano fiammate di odio, un fuoco velenoso. Bianca era isolata da quest'aura di odio che lei sola percepiva. Si era accorta che le due donne di mezza età la tenevano d'occhio più degli altri, ma non le vedeva per come erano, due povere donne che facevano un brutto lavoro perché non erano abbastanza qualificate per averne uno migliore. Le vedeva enormi, tre volte più grandi della loro vera statura, arbitrariamente potenti, pericolose, terrificanti. Le odiava con tutto il cuore perché erano di mezza età, erano sciatte, limitate e povere, e perché quella mattina, come tutte le mattine della settimana passata, le avevano detto che doveva mettersi le mutande oltre alle calze, e che faceva schifo, e che il loro lavoro era già abbastanza difficile anche senza che lei facesse eccitare gli uomini, e poi le avevano dato dell'egoista, dell'antisociale, della disobbediente.
Quando le guardava, si sentiva invadere dal terrore giovanile di trovarsi davanti all'immagine del proprio futuro. Si dava il caso che la vita le avesse insegnato molto presto che era facile, anzi molto comune, essere giovane, bella e allegra e trovarsi poco dopo a essere di mezza età, stanca e trascurata.
In alcuni dei primi quadri di Goya, non quelli che descrivono la guerra o la pazzia, ma quelli che mostrano immagini allegre e cortesi, c'è sempre qualcosa di indefinibile che turba l'osservatore. Non è una sensazione immediata. È perché in tutti i gruppi di persone rappresentate – affascinanti, convenzionali, pastorali, sempre fondamentalmente civili – ce n'è sempre una che rivolge lo sguardo in una direzione diversa, oltre la tela, che guarda negli occhi l'osservatore. Questa persona, che rifiuta di uniformarsi alle convenzioni del quadro in cui l'artista stesso l'ha posta, mette in discussione, e di fatto distrugge, quelle stesse convenzioni. È come se l'artista si fosse detto: immagino di dover dipingere questo genere di quadro, è quello che tutti si aspettano da me… ma gliela faccio vedere io. Quando si osserva quel quadro, il resto dell'immagine si dissolve: le persone affascinanti con i loro sorrisi e le loro gale, i giovani eroi, la civiltà, tutto questo si dissolve a causa del lungo sguardo diretto che arriva dal personaggio che ci guarda dalla tela e che dice in silenzio che lui, o lei, sa che è tutta una commedia. È lì per dirci che la pensa così.
Gli occhi di Bianca Lampi ottenevano lo stesso risultato: quello di negare il resto del suo aspetto… e forse di dire la stessa cosa.
E come se non si trattasse di una sfida sufficiente, il contrasto strabiliante tra l'abito nero convenzionale e la nudità della parte inferiore del corpo, i capelli lisci da ballerina e la macchia triste, bagnata, più in basso, la posizione sociale della 'giocatrice di carte' e l'isolamento che la circondava a causa della paura e dell'odio… come se ciò non bastasse (e oltretutto a questo va aggiunto il corollario sociale, forse meno importante, dato dal prezzo elevato del vestito, delle scarpe, della borsetta, tutti oggetti che da soli si sarebbero portati via una settimana di stipendio delle infermiere povere) c'era anche un altro contrasto. Gli occhi neri di Bianca guardavano direttamente fuori dalla tela, e seguendo quello sguardo, lasciandosi scivolare all'interno di quello sguardo, in modo da intrufolarsi nella sua testa, ciò di cui si diventava parte non era la violenza dell'odio, ma una pozza di lacrime, le lacrime di una bambina che diceva: Oh, amami, abbracciami, perdonami, non lasciarmi mai, non farmi crescere. Ciò che provava dentro a quella facciata di contrasti perturbanti erano i sentimenti di una bambina piccola picchiata o maltrattata da un genitore autoritario, che sa benissimo che, la prossima volta in cui il padre – o la madre – sarà arrabbiato, ubriaco, o a sua volta spaventato, accadrà esattamente la stessa cosa. Era solo una vittima, tradita, tormentata, vulnerabile e bisognosa di amore.
Era seduta lì a fare il suo solitario con un atteggiamento che gridava 'Perché mi lasciate così sola?' quando un bell'uomo di circa cinquant'anni entrò nella sala comune. Aveva morbidi capelli grigio scuro che dovevano essere stati neri, occhi azzurri e un sorriso buono.
A differenza di altri, che erano entrati mentre lei, seduta, diceva in silenzio 'Ti sfido a venire a sederti con me', e che se ne erano andati altrove, l'uomo andò dritto verso di lei. Si mise a sedere, estrasse subito una pipa dalla tasca e prese ad affacendarsi per riempirla e accenderla. Indossava una giacca sportiva con sotto un maglione blu scuro. Aveva l'aria di uno che è stato un atleta, anche se a livello amatoriale.
Era il professor Carlo Veglia. Lui e Bianca erano amici.
Senza chiedergli nulla, Bianca raccolse le carte e cominciò a fare un mazzo da poker, che era uno dei loro giochi preferiti: ciascuno giocava tre mani, con sette carte per mano, quattro jolly e i piatti divisi. Bianca vinceva quasi sempre, non perché fosse più intelligente del professore, ma perché si impegnava di più.
“Facciamo che i jolly sono i tre, i cinque, i sette e i fanti” annunciò con aria socievole.
Giocarono. Vinse lei.
Mescolando le carte, gli disse: “Oggi l'hai visto?”
“Sì, il dottor X non c'è.”
“Che ha detto?”
“Dice che mi devono spostare da qualche parte. Che per come sto adesso, non possono continuare a tenermi qui.”
“Perché, perché non possono? Oh, è veramente troppo!”
“Continua solo a dire che questo è un'ospedale di accettazione generale e che non può forzare le regole.”
“Però non lasciare che ti mandino al Bacino Nord. Qualunque cosa, ma non lì.”
“Non preoccuparti, non lo farò.”
Bianca distribuì le carte.
© Paolo Melandri (19. 9. 2019)
*
Il grande evento
Il grande evento
Quel giorno, quello che finì con il Grande Evento, iniziò con un temporale mattutino. L'uomo di cui qui si dovrà raccontare venne svegliato da un potentissimo tuono. La casa, insieme al letto, avrà tremato e continuato a vibrare per un lungo istante. Istante: che non risultò essere tale per colui che era coricato lì. Bruscamente distolto dal sonno, l'uomo tenne gli occhi chiusi, in attesa di capire come si sarebbe sviluppato l'avvenimento.
Non pioveva ancora, e dalla finestra spalancata non si udiva alcun rumore di vento. In compenso i fulmini si susseguivano. Balenavano attraverso le palpebre chiuse dell'uomo con un fumigare denso, e il tuono secco che seguiva a intervalli sempre più brevi si rifrangeva amplificato nelle orecchie.
Bruscamente distolto dal sonno: anche questo non era del tutto vero per l'uomo coricato. Lo scatenarsi del temporale sembrava non averlo affatto sorpreso. Rimase sdraiato tranquillo e lasciò che i lampi attraversassero le palpebre e i tuoni risuonassero dentro il cranio, come fosse qualcosa che accadeva ogni mattina, qualcosa di quotidiano; come se fosse abituato a ridestarsi in quel modo, e non solo abituato, come se avesse anche diritto a quel particolare genere di risveglio. Fulmini e tuoni avevano l'effetto di una sveglia musicale che dal sonno profondo lo trasportava, tanto repentinamente quanto naturalmente, in una totale presenza di spirito, e anche in qualcos'altro: in una disponibilità. Disponibilità a confrontarsi, a prendere posizione, a intervenire. Intanto giaceva lì disteso nel tumulto e se lo godeva.
Al primo tuono sarebbe quasi balzato fuori dal letto per staccare le spine del televisore-hi-fi-eccetera. Ma nello stesso momento la consapevolezza: non era a casa sua, era in un letto sconosciuto. La località stessa in cui aveva dormito era sconosciuta, l'intero paese.
Questa, da molto tempo, era stata la prima notte lontano dal suo letto, lontano dagli ambienti familiari. Con gli occhi ancora chiusi aveva allungato il braccio verso la parete consueta, che però non c'era. Aveva afferrato il vuoto. Anche questo non lo spaventò, si stupì soltanto, finché gli tornò alla mente: ma certo, sono in viaggio. Sono partito ieri. Sì, non mi sono svegliato nel mio letto, ma nemmeno in uno sconosciuto.
Un tempo, nella prima mattina in qualche altro luogo, la sua casa gli era mancata. Già le sere in cui arrivava in un paese diverso, già all'aeroporto, per esempio, guardava con una specie di dolore da separazione il tabellone che annunciava l'imminente volo di ritorno. Ma la mattina del giorno del suo Grande Evento il luogo estraneo non solo non lo infastidì neanche per un attimo, ma lo fece subito sentire come a casa propria. Non voleva più aprire gli occhi, mai più.
Erano i tuoni e i fulmini, i fulmini e i tuoni che adesso, lontano da casa, lo accoglievano in maniera ospitale. E quando un poco alla volta divennero più deboli e si dileguarono, lo fece la pioggia. Tutto d'un tratto, già nel silenzio seguito al temporale, cominciò a cadere, un battito unico, regolare, continuo. Protetto dal rovescio, l'uomo giacque lì, sempre con gli occhi chiusi. Nulla poteva accadergli. Persino se stesso, là fuori, ci fosse stato il diluvio universale: si trovava in un'arca, si trovava al sicuro.
In quella sicurezza venne cullato anche da un terzo fattore. Aveva dormito e si era svegliato nel letto di una donna che era bendisposta nei suoi confronti. Che lo amava? Durante la notte, sì, lei glielo aveva fatto capire. Ma non sarebbe stato d'accordo nel vederlo scritto, qui, così alla lettera. Bendisposta verso di me: questo era quanto poteva dire.
Quella mattina anche lui era bendisposto verso la donna, più intensamente che nella notte, o più ampiamente, ma in modo diverso. Lei aveva lasciato letto e casa di buon'ora, prima che spuntasse il giorno, per il suo lavoro. Uscendo non aveva fatto il minimo rumore, e lui, nel dormiveglia, era stato colmato da una riconoscenza quasi infantile; era diventato, lo sentiva in tutto il corpo, l'incarnazione della riconoscenza stessa. Non avrebbe mai e poi mai potuto dirglielo, ma rimase disteso lì, come tendendo l'orecchio alla corrente d'aria che si allontanava insieme a lei attraverso i locali della casa, e l'ammirò, ammirò quella donna.
In realtà sarebbe stato più propenso a considerarsi il suo ammiratore piuttosto che il suo amante. Quando una volta lei l'aveva chiamato così – piena d'orgoglio, gli parve –, lui aveva alzato le sopracciglia e guardato da un'altra parte, e non solo perché aveva superato l'età per impersonare il ruolo di un amante.
Avvolto nello scroscio della pioggia forte e uniforme, senza vento, si addormentò di nuovo. Sebbene per lui ci fosse qualcosa di incombente, quel giorno e specie l'indomani, gli sembrava di avere tutto il tempo del mondo e, insieme, era come se quella condizione fosse già parte e inizio del confronto che lo attendeva. Era un sonno così leggero che la persona svaniva al suo interno. Se lui interpretava ancora qualcosa, questo qualcosa era unicamente il sonno. Gli attori, quando nei film interpretano dei dormienti, per quanto realisticamente, appaiono sempre improbabili. Lui invece, anche se poteva restare del tutto cosciente dopo il primo risveglio, dormiva davvero mentre recitava il sonno, dormiva e dormiva, recitava e recitava. E se dormendo sognava e comunicava allo spettatore qualcosa del suo sogno, di nuovo questo qualcosa riguardava soltanto il librarsi e lo svanire. Era un sogno senza azione, nel quale per esempio non poteva volare. Ma presumibilmente anche il librarsi-in-sogno, allo stesso modo del poter-volare, aveva un significato. Solo che lui l'aveva dimenticato, così come nel corso degli anni aveva dimenticato molte cose, con risolutezza.
Questo è il momento di ricordare che in effetti l'uomo di cui qui si narra è un attore. Da giovanissimo, nella piccola azienda del padre, aveva imparato un mestiere e, spesso anche insieme al genitore, aveva posato piastrelle in tutte le casette dei sobborghi a nordovest di B. In lui lo si notava ancora, e non solo per le mani, e forse era ancora più evidente osservando i movimenti – un frequente indietreggiare, camminare all'indietro, poi di nuovo avanzare –, le occhiate intense, soprattutto il suo sollevare lo sguardo, improvviso, dopo averlo tenuto a lungo fisso al suolo, il suo ridurre gli occhi a fessure in alcune scene di un film, senza alcun motivo, senza nessuna posa, senza un significato acquisito macchinalmente come non di rado avveniva per altri eroi dello schermo.
Ma come, la storia di un attore, in un'unica giornata, dal mattino fino a notte fonda? E di un attore non nel suo agire, ma nello starsene in ozio? Un tipo così nel ruolo, in un modo o nell'altro, di eroe di una storia, per giunta di una storia seria? Nessuno più minacciato, nessuno più resistente di un attore, di un attore come lui. Nessuno che nella vita interpreti meno ruoli. Lui, l'attore, come “io!”, l'Eccedenza di un Io minore. Senza il suo lavoro di interprete – quando non recita –, abbandonato a se stesso per giorni interi. Uno così è epico, grava sulla terra con tutto il suo peso. Di lui c'è una storia da raccontare come forse di nessun altro.
© Paolo Melandri (11. 9. 2019)
*
Il venditore ambulante 3
Il venditore ambulante posa il piede sulla carta che svolazza.
Si informa sulla via da percorrere, poi, stupito dai gesti con cui l'interpellato gliela indica, si dimentica di ascoltare la risposta. Le unghie penetrano nel palmo della mano. Non può accadere nulla. Ha il tempo di stupirsi. In un giorno simile nessuno pensa alla morte. Dalla baracca del pietrisco sporge un manico di badile. La strada non è vuota. Il venditore ambulante scorge una pietra grande come il pugno di un bimbo. Il cuoio capelluto si contrae. Nessuno si terge in fretta il viso con il fazzoletto. Il marciapiede è abbastanza alto sopra il livello della strada. Il cappotto dell'ambulante gli arriva alle caviglie. Dalla fessura sotto la porta del nogozio filtra schiuma di sapone. La bottiglia nell'acqua in posizione quasi verticale. Finestre si alternano a porte.
Egli vede la gente con maggior chiarezza del solito. L'unghia gratta la stoffa, trova i bottoni. L'ambulante muove le gambe con naturalezza. I sedili dell'automobile formano una linea perfetta. La strada è stata innaffiata da poco. Egli scopre davanti a sé, con sorpresa, le proprie ginocchia. Le finestre brillano. Scuote incredulo la testa. Solo una scarpa è lucida, l'altra è ancora impolverata. I pensieri lo aggrediscono. Un chiodo, nel conficcarsi, si è piegato!
Il venditore ambulante bussa nel muro con una matita. Senza una ragione, ma incapace di fare altro, osserva la vecchia seduta su uno sgabello davanti alla porta di casa.
Tra le case cammina diversamente che in aperta campagna. La mano che ha portato la valigia trema. La porta della cabina telefonica è chiusa. È una bella mattina. Dopo il primo rintocco, aspetta il secondo con ansia. Le punte delle scarpe guardano all'insù!
Non si volta né a sinistra né a destra. Le mani che poggiano sul volante sono avvolte in guanti di pelle. Non riesce ad immaginarsi che qualcuno possa gridare, ora. Gli oggetti non lo rendono inquieto, ma neppure lo distraggono. Fin dove giunge il suo sguardo, la terra è intatta. Ha con sé solo oggetti personali. I suoi abiti sono più adatti all'oscurità che alla luce del giorno. I suoi capelli sono arruffati, e non c'è vento. Le persone che incontra lo guardano da capo a piedi. Quando scorre verticalmente, il rivoletto diviene più sottile. Il venditore ambulante sta in ascolto. Tutti gli angoli delle case sono arrotondati. Improvvisamente, la strada davanti a sé, prova repulsione per ogni lontananza. Forse la corda è sfuggita di mano a chi mette in azione la campana. Perché proprio adesso la stringa si deve slacciare di nuovo? Stendono un copertone sopra la macchina. Ci sono innumerevoli direzioni. Le unghie prudono. Due vecchie segano un grosso tronco.
Adesso ha bisogno di una diversione. Per terra, improvvisamente, il tubo di gomma si tende. Le tasche del cappotto sono così ampie e profonde che non riesce a sentirci dentro le mani. Barcolla di proposito. I muri delle case non recano segni né disegni. Ogni cosa è al suo posto. Il venditore ambulante ha un sorriso maligno. Un pesante giornale sta appeso all'edicola con una molletta. La ruota è ben appoggiata al muro. Lui sbadiglia camminando. Le immagini si deformano ogni volta che inspira. Il corpo rifiuta qualunque cosa vedano gli occhi. I tronchi, sul camion, rimbombano. Non sa dove mettere le mani. La donna pulisce la maniglia con lo strofinaccio. Il primo scoppio dell'accensione difettosa lo spaventa. A ogni parola che sente, ne segue un'altra.
Ha camminato tanto, che tutte e due le stringhe si sono slacciate. Sul ricevitore del telefono c'è ancora l'impronta di una mano sudata. Deve insistere più volte sullo stesso pensiero, fino ad annientarlo.
Espira ed inspira.
Nota che l'ordine intorno a lui sta diventando un gioco. Il tintinnio dei bicchieri è un rumore pericoloso. Quando gli rivolgono la parola risponde a gesti e a smorfie. Il riso della donna si inserisce in tutti gli altri suoni. Pur ritenendo che non farà mai conoscenza con alcuno dei presenti, l'ambulante cerca di imprimersi i loro volti nella memoria. Qua e là la strada è nera di fuliggine. Le dita che teneva serrate di sono aperte. Davanti alla porta c'è uno stivale spaiato col gambale rimboccato. Il secchio delle immondizie appare vuoto. La moneta è ancora calda.
Quel suo affannoso mescolare nel bicchiere non è che un'ammissione della sua inerzia. Per il disagio le scarpe guardano in direzioni diverse. Tutti si sono già abituati ai loro movimenti. Questo silenzio è solo il silenzio che attende una risposta. Prendono cibi pesanti. La porta si apre senza difficoltà. La mano che regge il vassoio è alta sopra la testa. La schiuma ristagna davanti a un ostacolo. D'un tratto pensare gli piace. È lo scoppio di un turacciolo!
Si toglie le scarpe sotto il tavolo. “Se si sparano palle di cannone sull'acqua, vengono fuori gli annegati.” Si rallegra della quiete. La signora toglie la schiuma dal bicchiere con uno stecco.
Il collo della sua camicia non è più immacolato.
Ci sono delle macchie sul palmo della mano.
Il grido è soltanto quel grido che precede la risata provocata da una barzelletta.
Non fa molto caldo, ma gli abiti lo opprimono. La parete della casa ha solo false finestre. La strada è molto frequentata. L'odore di sudore significa buona salute. Lei allontana i capelli dall'orecchio col pollice. Lui non può immaginarsi che un grido, di giorno, sia un grido di aiuto. Solo un lato della scatola di fiammiferi è segnato dallo sfregamento. Le parole che sente si riferiscono ai soliti argomenti. La fettina di limone ondeggia lentamente verso il fondo del bicchiere. La donna rimette la scopa al suo posto. Lui si schiarisce la gola, ma non dice nulla. Neppure i nomi degli oggetti gli vengono in mente in questo ambiente estraneo. Quando l'uomo che gli siede di fronte scoppia a ridere e getta indietro la testa, gli offre la gola indifesa.
© Paolo Melandri (9. 9. 2019)
*
Le orme
Le tue mani odorano di pane.
Lei prese il coltello del pane che era troppo grande per le sue mani e tagliò scavando profondamente nella vena, guardandosela forse per un po', accovacciata fra le more che in montagna erano proprio mature; invece di tagliarsi i polsi avrebbe potuto restare seduta e mangiare le more; oppure avrebbe potuto prendere un altro coltello più piccolo per non esagerare. Ma non c'erano spettatori. Quell'immagine deve essere rimasta impressa per un po', perché i suoi occhi guardavano la mano, lei non si muoveva affatto: come quando mio padre un mattino arrivò e la buttò giù dal letto così che lei andò a sbattere contro la parete e ruppe la lampada; e come quando mio padre le disse: vieni qui, amoruccio mio, con una voce da far paura: prendi il pane e la carne dalla credenza. No, mio padre non aveva una voce da far paura: amoruccio mio, vieni qui, disse. Portami dell'acqua calda. Voglio svestirmi e lavarmi. Lei andò in cucina e mise l'acqua sul fuoco mentre lui si spogliava. Cosa guardi tu, mi disse. Mettiti piuttosto nell'angolo e canta le preghiera del mattino. Io mi misi nell'angolo mormorando, con la testa girata, la mia imprecazione sul legno e sulle ragnatele e cantai la preghiera del mattino. In quel mentre la sentii entrare con la bacinella e fermarsi sulla porta. Sanguini, disse lei. No, rispose lui. Non sanguino, sono insanguinato. Lei non disse altro; io fissai un ragno: aveva otto zampette prima che gliene strappassi due; cantavo la mia preghiera del mattino. Lavami, disse mio padre. Strappai al ragno la sesta zampetta, poi la quinta, la quarta di colpo. Così sentii lei che lo lavava con l'acqua calda e con uno straccetto di spugna; si piegava e si rialzava lavandogli tutto il corpo mentre io strappavo al ragno le ultime zampette. Ora potrei dire: ricordo ancora la venatura delle travi che osservavo, oppure qualcosa d'altro che si può percepire con gli occhi; ma io non ricordo che l'odore dell'acqua quando lei strizzava lo straccetto di spugna. La sera avrebbe potuto strizzarsi anche la mano mentre sedeva fra le more, ma non ne sarebbe più uscita una goccia. Quando salimmo verso la baracca avevamo già sentito le sue urla; io tornavo dalla scuola nella vallata, mio padre non veniva da nessun posto; ci eravamo trovati per strada. Chi è che grida nel bosco, dissi. Una ghiandaia, rispose mio padre, o un gallo cedrone o una tigre. Ma queste sono grida, dissi meravigliato. Sì, gridano così, disse mio padre. Ascolta come gridano. Tu devi sapere come grida una tigre o un gallo cedrone quando sarai grande. Adesso sono grande e non so ancora come grida una tigre; ma come grida qualcuno fra le more, già troppo debole per uscirne fuori, ora lo so. Più tardi, la sera, quando uscimmo a cercarla verso lo stagno arrivarono i calabroni. Era metà autunno o metà inverno. Mio padre si fermò piegando le canne e scrutando il filo dell'acqua: i calabroni sono arrivati, torniamo indietro. Si girò e io lo seguii col suo odore nel naso: mio padre aveva un odore forte. Io lo seguivo mentre lui andava sempre più svelto verso il bosco, i calabroni arrivavano, i calabroni sono arrivati, i calabroni hanno gridato nel bosco, disse lui. Cominciò a nevicare molto forte, bianco e giallo, l'aria rintronava, c'era un odore aspro di calabroni che ci nevicavano addosso mentre andavamo verso il bosco nel quale lei era distesa fra le more, immobile. Fai presto, disse mio padre, lasciando orme fra i calabroni che coprivano il suolo, con le sue enormi scarpe faceva orme profonde nella neve, nel vento e nell'oscurità mentre l'aria ronzava e gemeva, e lui faceva orme profonde, orme profonde faceva, mentre io lo seguivo a piedi scalzi sui calabroni che si muovevano e si dissolvevano – i calabroni che si muovevano e dissolvevano le orme profonde che lui faceva affondando le scarpe, finché la trovammo nel cespuglio, le orme profonde che lui fa e che noi calpestiamo mentre guardiamo mentre ci lamentiamo mentre calpesto le orme di mio padre.
© Paolo Melandri (4. 9. 2019)
*
Il mare
Vedeva il mare come ciò che solitamente stava dietro le colline e le case, e questo vuoto si popolava, nella contemplazione, delle sue possibilità di vita non sfruttate, che là si profilavano pallide, vaghe, indeterminabili, eppure con grande forza. Poi, al ritorno nell'interno del paese, sentiva il mare sotto le case della metropoli.
© Paolo Melandri (22. 8. 2019)
*
Qualcosa accadrà
Qualcosa accadrà. Racconto denso di avvenimenti
Uno dei più strani periodi della mia vita è stato certamente il tempo che trascorsi come impiegato nella fabbrica del signor Aleardo Valsenti. Confesso di essere per natura più incline alla meditazione e all'ozio che al lavoro; ma di tanto in tanto, visto che la meditazione non rende più dell'ozio, non potevo non cercare – per certe mie difficoltà di cassa – quello che si dice un impiego. Fu così che, quando mi trovai ancora una volta in acque basse, mi affidai all'ufficio di collocamento, che m'indirizzò, insieme ad altri sette compagni di ventura, alla fabbrica Valsenti per sostenere la prova di capacità.
Già l'aspetto dell'edificio, tutto costruito in un bel vetro opaco, mi rese diffidente. Nutro per le costruzioni chiare e gli ambienti luminosi la stessa antipatia che ho per il lavoro. La mia diffidenza crebbe quando vidi che ci offrivano, in una bella mensa tutta dipinta a colori chiari e festevoli, una sontuosa colazione. Graziose inservienti ci servirono caffè, uova e toast. Sui tavoli spiccavano caraffine graziose col succo d'arancio, ai vetri degli acquari di un tenero verde i pesci rossi appoggiavano i loro musi annoiati. Le cameriere avevano un'aria così allegra che mi aspettavo di vederle scoppiare di gaiezza da un momento all'altro. Credo che facessero uno sforzo di volontà per non abbandonarsi a soavi gorgheggi. Erano piene di canzonette come certe galline son piene di uova da deporre. Capii subito quello che mi pare sfuggisse ai miei compagni candidati, che cioè anche quella colazione faceva parte dell'esame. Mi feci dunque un dovere di masticare con l'aria assorta di un uomo perfettamente conscio che sta ingerendo nel suo organismo preziose sostanze. Feci addirittura qualcosa che in circostanze normali nessuna forza al mondo avrebbe potuto impormi: a stomaco vuoto bevvi il succo d'arancio, ma non toccai né uovo né caffè, a malapena un pezzetto di toast. Dopo mi misi a camminare su e giù per la mensa, a gran passi, come chi abbia da partorire cento cose.
Fu così che mi fecero passare per primo nella sala d'esame, dove su tavoli di gusto squisito erano già pronti i formulari. Le pareti erano sul verde, di un verde che avrebbe strappato dalle labbra di certi patiti dell'arredamento la parola “affascinante”. Non si vedeva nessuno ma io ero sicuro di essere osservato e così mi comportai come si comporta uno che ha cento cose da partorire quando sa di essere osservato.
Con uno scatto d'impazienza tolsi di tasca la stilografica, l'avvitai, mi posi al tavolo più vicino e trassi a me il formulario con la mossa di certi tipi collerici quando si applicano a rifare il conto in trattoria.
Domanda prima: “Ritiene giusto il candidato che l'uomo abbia solo due braccia, due gambe, due orecchie e due occhi?”
Raccogliendo per la prima volta i frutti della mia meditazione, scrissi senza indugio: “Alla mia sete d'azione non sarebbero sufficienti nemmeno quattro braccia, quattro gambe, quattro orecchie. L'attrezzatura del corpo umano è semplicemente inadeguata.”
Domanda seconda: “Quanti telefoni è in grado di far funzionare contemporaneamente il candidato?”
Anche questa domanda mi fu facile come un'equazione di primo grado e scrissi: “Quando ho disponibili solo sette telefoni mi sento nervoso. Con nove incomincio a sentirmi a mio agio!”
Domada terza: “Che cosa fa il candidato, a lavoro finito?”
Risposta: “Lavoro finito è un'espressione di cui non ho memoria. La cancellai dal mio vocabolario il giorno del mio quindicesimo compleanno. Giacché in principio era l'azione – non il verbo!”
L'impiego fu assegnato a me. A dire il vero, nemmeno nove telefoni bastavano a dare sfogo al mio gusto per l'azione. Alzavo i ricevitori e gridavo: “Agisca immediatamente!”, oppure: “Faccia qualcosa!”, “Deve accadere qualcosa!”, “Dovrebbe accadere qualcosa!”, “Qualcosa è già accaduto!” Generalmente però mi servivo della forma imperativa, più adatta all'atmosfera.
Quanto mai interessanti erano le soste per il pasto di mezzogiorno. Immersi in silenzioso giubilo, c'impegnavamo a consumare i cibi ricchi di vitamine offerti dalla mensa. La fabbrica Valsenti formicolava di persone che andavano pazze per raccontare come si addice a dei veri e propri apostoli dell'azione – tutto il corso della loro carriera. Ci tengono più che alla vita. È come pigiare un bottone: subito ti stendono davanti, con gran sussiego, tutto il ruotolino di avanzamento.
Il sostituto del signor Valsenti, per esempio, si chiamava Gallimberti. Si era fatto anche lui un nome perché da studente, lavorando di notte, aveva mantenuto una donna paralitica con sette figlioli. Nello stesso tempo aveva saputo tenere con ottimo successo ben quattro rappresentanze di commercio in articoli vari e in due anni era riuscito ad affermarsi agli esami di stato col massimo dei voti. Quando i giornalisti una volta gli chiesero: “Ma allora, signor Gallimberti, Lei quando dorme?”, rispose: “Dormire è peccato.”
La segretaria di Valsenti invece aveva sfamato un paralitico e i suoi quattro bambini, lavorando a maglia e nello stesso tempo si era laureata in etnologia e psicologia, si era dedicata all'allevamento di cani da pastori ed era divenuta famosa come cantante in un locale notturno col nome di “Vamp 7”.
Lo stesso Valsenti del resto era una di quelle persone che la mattina, appena si svegliano, sono già fermamente decise ad agire ad ogni costo: “Devo agire,” dicono stringendo con energia la cintola dell'accappatoio: “Devo agire,” pensano mentre si fanno la barba e gettano sguardi di trionfo sui peli che con la schiuma vanno scivolando nel lavandino. Quei poveri peli sono la prima vittima del loro imperioso e categorico imperativo all'azione. Perfino quando assolve i suoi più elementari bisogni questa gente si sente felice: l'acqua che va giù nello sciacquone, la carta che consuma è pur sempre qualcosa che “è stato fatto”. Poi c'è da masticare il pane, c'è da rompere il guscio dell'uovo. La più insignificante faccenda, eseguita da Valsenti, assumeva le proporzioni di un avvenimento: il modo di mettersi il cappello in testa o di abbandonarsi il cappotto con le dita tremanti di energia, perfino il bacio che dava alla moglie uscendo di casa, erano degli avvenimenti.
Appena entrava in ufficio, lanciava il suo saluto alla segretaria: “Bisogna che accada qualcosa!” “E qualcosa accadrà,” rilanciava essa raggiante. Dopo, Valsenti andava di reparto in reparto facendo echeggiare il suo allegro: “Bisogna che accada qualcosa!” e tutti in coro: “Qualcosa accadrà”. Anch'io lo salutavo entusiasta appena entrava nella mia stanza e gli gridavo: “Qualcosa accadrà.”
Già una settimana dopo la mia assunzione avevo portato a undici il numero dei telefoni serviti contemporaneamente; dopo due settimane erano saliti a tredici. In tram la mattina mi dilettavo a escogitare nuove forme d'imperativo e coniugavo il verbo accadere in tutti i tempi e modi, nelle forme più acrobatiche del congiuntivo e del condizionale. Per due giorni andai martellando una sola frase che mi era andata a genio: “Sarebbe dovuto accadere qualcosa.” Per altri due giorni invece imperò un'altra frase: “Questo non sarebbe dovuto accadere!”
Il mio impetuoso dinamismo già incominciava a distendersi a suo agio quando accadde davvero qualcosa. Un martedì mattina – non ero ancora assestato al tavolo di lavoro – il signor Valsenti si precipitò nella mia stanza col solito appello: “Qualcosa ha da accadere!” Notai qualcosa sulla sua faccia, qualcosa che non riuscivo a spiegarmi e che m'impedì di rispondere col solito brio, la solita frase: “E qualcosa accadrà.” Indugiai tanto che il signor Valsenti, che non gridava quasi mai, quella volta muggì come un leone: “Risponda! Lei deve rispondere secondo le prescrizioni!” Allora risposi ma a voce bassa, esitando come un bambino quando gli viene imposto di dire: “Io sono un bambino cattivo.” Durai gran fatica per finire alla meglio tutta la frase: “Accadrà certo qualcosa.”
L'avevo appena pronunciata che davvero accadde qualcosa. Valsenti si abbatté al suolo, rovesciandosi di fianco nella caduta e rimase immobile, di traverso alla porta spalancata. Io già sapevo quello che avrei constatato mentre giravo lentamente intorno al tavolo per chinarmi su di lui: sapevo che era morto. Scavalcai, scuotendo la testa, il cadavere del signor Valsenti e, sempre lentamente, andai alla porta del signor Gallimberti, entrai senza bussare. Gallimberti stava seduto alla sua scrivania, teneva in ogni mano un ricevitore del telefono e, stretta fra i denti, una biro con cui scriveva appunti su un taccuino; intanto, coi soli piedi sfilati dalle pantofole, azionava una macchina per maglieria sistemata sotto lo scrittoio. È un suo sistema per contribuire all'incremento del guardaroba familiare.
“È accaduto qualcosa,” gli dissi sottovoce. Gallimberti sputò via la penna, abbassò i due ricevitori e ritirò la punta dei piedi dal pedale della macchina, poi mi chiese: “Che cosa è accaduto?”
“Il signor Valsenti è morto,” dissi io, “Ma no!” disse lui. “Invece sì,” replicai. “Venga a vedere.” “No, è impossibile,” diceva ancora Gallimberti mentre s'infilava le pantofole e mi seguiva fino alla porta. “No,” continuò a dire davanti al cadavere disteso del signor Valsenti, “no, no.”
Non volli contraddirlo. Con cautela voltai il corpo del signor Valsenti sulla schiena, gli abbassai le palpebre e lo guardai pensosamente. Provavo quasi tenerezza per lui e in quel preciso momento mi accorsi di non averlo mai odiato. Sul suo volto c'era qualcosa, l'espressione che è sul volto dei bambini quando insistono cocciutamente a credere a Babbo Natale, benché gli argomenti in contrario dei loro compagni di gioco abbiano tutto il sapore della verità. “No,” continuava a dire il signor Gallimberti, “no.”
Allora gli sussurrai: “Bisogna che avvenga qualcosa.”
E qualcosa avvenne. Il signor Valsenti ebbe i suoi funerali ed io fui prescelto nell'incarico di seguire il feretro recando una corona di rose finte. Effettivamente io sono nato non soltanto con una sensibile inclinazione alla vita meditativa e all'ozio, bensì anche con un personale e con una faccia che vanno a pennello con gli abiti scuri. Credo di aver fatto una grande impressione incedendo dietro la bara del signor Valsenti con quella corona di rose finte in mano. Di lì a poco, infatti, un'impresa di pompe funebri, molto distinta e richiesta, mi offrì di passare al suo servizio per fare la parte del “signore a lutto”. “Lei è nato per fare la persona colpita da grave lutto,” mi disse il direttore d'impresa, “al guardaroba provvederemo noi. La sua faccia è semplicemente grandiosa.”
Mi licenziai da Gallimberti col pretesto che in quell'impiego, nonostante i tredici telefoni, non riuscivo a dare il giusto sfogo a tutte le mie energie. La prima volta che partecipai a un funerale in lutto di servizio, dovetti confessare a me stesso che quello faceva per me, era il posto che mi competeva nella vita.
Meditabondo, con un sobrio mazzo di fiori in mano, sto eretto dietro il feretro esposto nella cappella funebre mentre suonano il largo di Händel; è un pezzo cui la gente bada poco. Sono divenuto cliente fisso al caffè presso il cimitero, ci passo il tempo degli intervalli del servizio, fra un funerale e l'altro. Ma qualche volta mi vien fatto di accodarmi a qualche funerale senza averne l'obbligo. Compro di tasca mia un mazzetto di fiori e mi unisco al drappello dei funzionari dell'ufficio comunale di assistenza che seguono la bara di qualche morto apolide.
Ogni tanto vado a fare una visita alla tomba del signor Valsenti. In fondo devo ringraziare lui se ho finalmente scoperto la mia vera vocazione per la quale il requisito fondamentale è la meditazione e il non far nulla è un lavoro.
Molto tempo dopo mi è venuto di pensare che non mi ero preoccupato mai di sapere quali articoli producesse la fabbrica del signor Valsenti. Se non mi sbaglio, doveva trattarsi di sapone.
© Paolo Melandri (3. 8. 2019)
*
Viaggio indietro
Viaggio indietro
Roberto non era stupito di essere stupito. Che oramai si fosse abituato a precipitare da un'esistenza all'altra?
Il mondo aveva smesso di pestare, sbandare, oscillare; invece di mugghii e scricchiolii, alle orecchie gli giungeva il suono di flauti e violini, al cupo chiarore delle lampade a olio era subentrato uno straordinario sfavillio di luci: e tutto era successo da un momento all'altro. Lui ancora barcollava, la testa gli ronzava e lo stomaco afflitto dal mal di mare non gli dava tregua.
Questa volta si ritrovò in un'ampia sala ovale dall'alto soffitto e dalle colonne di marmo rosato. Sul parquet tirato e lucido come uno specchio, dame incipriate e splendidamente vestite, e signori con nivee parrucche, si esibivano in una danza da marionette. Sullo sfondo c'era l'orchestra e lungo le pareti erano schierati i lacchè in divisa grigio-azzurra. Nessuno gli prestava attenzione.
Solo dopo qualche tempo, all'improvviso due servitori – due spilungoni con le casacche gallonate e i pantaloni stretti al ginocchio – si precipitarono verso di lui. Lo afferrarono con una certa energia facendogli male, e stavano già per portarlo via quando una delle dame, la più giovane di tutte, avendo visto la scena, piantò in asso il suo stupefatto cavaliere e si avvicinò a Roberto. I suoi occhi nero-blu e leggermente obliqui sfavillavano.
– Cosa vi salta in mente? Non vedete che quest'uomo è malato? – investì i due servitori. – Lasciatelo andare, accompagnatelo subito nei miei appartamenti e fate venire il mio medico personale. Che si occupi immediatamente di lui!
– Molto bene. Come Vostra Altezza comanda, – sussurrarono i lacchè.
La giovane, che aveva forse diciassette anni, lanciò a Roberto uno sguardo pieno di curiosità, si voltò, diede la mano al cavaliere che l'aveva seguita, e riprese a ballare come se niente fosse.
Con una scrollatina di spalle, i due servitori condussero Roberto in un salottino elegantemente arredato e lo lasciarono solo. Lui si accomodò su uno stretto sofà, rivestito di seta a strisce bianche e gialle. Quando si fu ripreso almeno in parte dal mal di mare, tornarono a ronzargli in testa le vecchie domande: dove sono? e soprattutto quando sono? Essendo troppo esausto per cercare una risposta, le scacciò come mosche. Ma almeno qui non doveva vedersela con una lingua sconosciuta, sebbene l'italiano parlato da quelle parte gli sembrasse piuttosto legnoso.
Arrivò il medico, un brontolone ingrigito, che non indossava un camice bianco e nemmeno un vestito nero, bensì un'uniforme marrone con cordoncini d'argento, e quasi assomigliava a un portiere d'albergo. Visitò Roberto superficialmente, gli toccò la fronte, accostò l'orecchio al petto, scosse la testa e bofonchiò fra sé e sé: – Non è niente, ha solo bisogno di un po' di riposo –. E senza degnare Roberto di uno sguardo a passettini lasciò la stanza.
Potevano essere passate alcune ore – successivamente ricordò di avere fatto sogni confusi – quando, svegliato da una risatina sommessa, Roberto vide entrare la sua protettrice, seguita da un signore compassato, dall'aria arrogante, che a sua volta indossava un'uniforme, molto più sontuosa e ornata d'oro di quella del medico.
– Allora, come sta il fanciullo che ha avuto l'ardire di sorprenderci durante il ballo in maschera?
– Meglio, molto meglio, – rispose Roberto. – Grazie per avermi aiutato. Ci mancava poco che quei due zoticoni mi buttassero fuori.
– Vorrei ricordarvi che siete a corte, giovanotto, e richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che è fatto obbligo rivolgersi a Sua Altezza la Principessa d'Aosta con l'appellativo di Vostra Altezza serenissima, – si intromise l'uomo con i galloni dorati, gettando a Roberto uno sguardo di riprovazione.
“Dio mio, – pensò Roberto, – ci mancava anche una principessa in carne e ossa! E magari devo rivolgermi a lei con espressioni assurde come “Vostra Altezza si compiaccia di consentirmi”, e così via… Complicatissimo, non è mica più facile del francese o del latino. E l'altro chi sarà? Un maggiordomo? O si diceva maresciallo di corte?”
– Vostra Altezza vorrà perdonarmi, – disse sperimentando quella nuova lingua, – ma sono nuovo da queste parti e non conosco le usanze di lorsignori.
– Oh, non fa niente, – rispose la Principessa. – Qui siamo fra di noi, e quanto all'etichetta… avrai modo di impararla. Mi sei simpatico. E poi sono curiosa. Come ti chiami, e di che ceto sei? E non essere così timido, se è lecito dirlo.
– Roberto è il mio nome e… – Ma qui iniziò a balbettare perché proprio non sapeva cosa rispondere. – … e sono di ceto né troppo alto né troppo basso, credo, – disse infine.
La Principessa rise.
– Se vuoi posso darti una mano. Non dovrebbe essere difficile. Che ne pensate, caro Messeri? – disse rivolgendosi al dignitario. – Non sarebbe un buon paggio? Certo non con questa ridicola tenuta. Fate in modo che abbia vestiti decenti e procurategli un alloggio al castello. Il resto, mio piccolo Roberto, si accomoderà.
Il ciambellano non sembrò particolarmente entusiasta di questo incarico, ma non ebbe altra scelta. Fece un inchino e attraverso riecheggianti corridoi e ampie scalinate condusse Roberto in una maleodorante stanzina sottotetto, dove un omino grigio era il padrone assoluto di alcuni giganteschi armadi. Accolse Roberto con ripetuti inchini, mentre il ciambellano o maggiordomo o cos'altro era quel pallone gonfiato, prima di scomparire a mo' di commiato gli lanciò uno sguardo gelido.
Per la prova ci vollero alcune ore. Da armadi e bauli, il vecchio sarto faceva comparire un abito dopo l'altro, ma non era mai soddisfatto di come cadeva. Alla fine Roberto vide nello specchio un signore che stentava a riconoscere: indossava un gilè di broccato color vinaccia con bottoni d'argento, un fazzoletto di pizzo, calze di seta color pesca, una giacca di raso con polsini ricamati, e, da non credersi, una parrucca incipriata biondo chiara. Stava quasi per stropicciarsi gli occhi, ma preferì non farlo: ormai sapeva come poteva andare a finire.
Questi costumi fantastici esistevano solo a Hollywood o nei libri di fiabe. Oppure era finito in un tempo ancora più lontano? Gli vennero in mente i cioccolatini con il ritratto di Mozart o quell'opera che un'estate aveva visto all'aperto, nel parco di un castello. Barocco o rococò? Non che ne avesse un'idea precisa, però aveva l'impressione che questa volta fosse tornato indietro almeno due o trecento anni. A sua madre quell'ambiente sarebbe piaciuto: alla televisione non si perdeva nemmeno un matrimonio reale e sapeva tutto di tutti sulle corti europee. A Roberto invece quelle vicende non interessavano per niente.
Adesso invece, ancora intontito dalle novità, doveva farsi comandare a bacchetta da un nuovo maggiordomo meno importante al quale era stato assegnato. Era un tipo davvero grossolano che si presentava sempre con un atteggiamento tronfio, salvo poi farsi piccolo piccolo ogni volta che incontrava un superiore. Assegnò a Roberto una camera in un'ala laterale del castello e gli indicò dove, con le altre cariche della corte, al capo estremo di una lunga tavolata, poteva mangiare. La stanza era un indubbio progresso rispetto al ripostiglio del sarto, e anche i pasti, se paragonati al magro pane della moglie del pastore, erano abbondanti. Ben presto però Roberto si accorse che Venaria non era un paradiso; sin dal giorno successivo infatti iniziò l'addestramento.
– Cosa? Non sai tirare di scherma? E non sei mai stato a caccia? Un bell'impiastro! Ma almeno sai ballare? No? Probabilmente hai letto troppi libri. Di gente così non sappiamo che farcene. Per non parlare poi dell'educazione! Hai ancora molto da imparare se vuoi fare strada a corte. E non credere che la protezione della Principessa ti possa servire molto. Sappiamo come stanno le cose. Ha cercato di farsi bello, il furbetto! Aspetta che il Principe lo venga a sapere. Con Sua Altezza Serenissima c'è poco da scherzare: l'unica figlia la protegge come la pupilla dei suoi occhi. Sei proprio uno sprovveduto! E a cavallo almeno ci sai andare?
Sì, a cavallo Roberto sapeva andare. Alle lezioni con il maestro di scherma invece non si divertiva e si sentiva in imbarazzo a girare tutto il santo giorno con la spada. Anche le bevute con i suoi nuovi spocchiosi amici gli creavano qualche problema. Si accorse che puzzavano: evidentemente al castello non c'era l'abitudine di lavarsi ogni giorno e Roberto aveva chiesto invano un pezzo di sapone. Sotto i sontuosi gilè di raso, i signori portavano le camicie fino a quando non avevano i bordi neri come le loro unghie.
La cosa peggiore però era che non poteva esibire antenati. La gente parlava di continuo degli alberi genealogici e delle persone con cui era imparentata. Roberto sapeva che non poteva fare sfoggio citando sua nonna. Anche prescindendo dal fatto che non era ancora nata, si chiamava Maria Sarti e non aveva nemmeno uno straccio di titolo nobiliare. E invece non era questo che contava per quella gente. “Il mio signor padre, il barone di Capri”, “il mio illustre cugino”, “mia zia, una Sassonia-Gotha-Altenburg”: tutto il giorno con questa solfa. Solo Roberto era sempre solo Roberto. Il che era abbastanza comodo, ma alla lunga imbarazzante.
Anche il modo come parlavano gli procurava qualche grattacapo. Quando era arrivato aveva creduto che sarebbe finalmente tornato a parlare la sua lingua e questo lo aveva reso felice. Ma non era così semplice e la sua felicità era stata prematura. Ad esempio non si poteva dire “Il Principe vuole” o “Il Principe vorrebbe”. La formula giusta era: “Sua Altezza si degna di comandare”. Altre volte Roberto aveva l'impressione di studiare francese. Doveva imparare parole che non aveva mai sentito prima. Come faceva a sapere cos'era una gavotte, un'assemblée, un tesoriere, o un fidecommisso? Neanche le cose più comuni si chiamavano come era abituato a chiamarle. Un soggiorno qui era un salon, o un boudoir, a seconda dei casi, oppure anche un gabinetto o una salle de compagnie. Col tempo però si rese conto che gli bastava tenere aperte le orecchie e dopo qualche settimana le espressioni della gente del luogo gli uscivano di bocca senza problemi.
© Paolo Melandri (30. 7. 2019)
*
Gli ospiti sconcertanti
Gli ospiti sconcertanti
Non è che io sia nemico degli animali, anzi mi piacciono e la sera – mentre il gatto mi sta accovacciato sulle ginocchia – godo a far il solletico al nostro cane. Mi diverto a guardare i bambini che danno da mangiare alla tartaruga nell'angolo del soggiorno.
Ha un posticino nel mio cuore persino il piccolo ippopotamo che teniamo nella vasca da bagno e i coniglietti che girano liberi per casa da tempo non mi rendono più nervoso. E poi, la sera sono abituato a trovare visite inattese: un pulcino pigolante o un cane senza padrone a cui mia moglie ha concesso asilo. Perché mia moglie è una donna buona e gentile, non manda nessuno fuori di casa, né uomini né bestie e già da molto tempo alla preghiera serale dei nostri bambini è aggiunta la postilla: “Signore, mandaci mendicanti e animali!”
Il peggio è che mia moglie non sa resistere né ai rappresentanti di commercio, né ai venditori ambulanti e così a casa nostra si accumulano cose che io ritengo superflue: sapone, lamette da barba; spazzole e lana da rammendare; in giro nei cassetti ci sono polizze di assicurazione e contratti di compravendita del genere più disparato. I miei figli sono assicurati per la durata del loro studio, le mie figlie per la loro dote, ciononostante di qui al matrimonio o agli esami di abilitazione e laurea non possiamo nutrirci esclusivamente di lana o di sapone, e le lamette da barba vengono sopportate dall'organismo solo in casi eccezionali.
Si capirà quindi come mi vengono qualche volta degli attacchi di leggera impazienza, sebbene sia generalmente conosciuto come un uomo tranquillo.
Mi sorprendo spesso con invidia ad osservare i conigli che stanno comodi sotto il tavolo e rosicchiano beati le loro carote, e lo sguardo stupido dell'ippopotamo che accelera nella nostra vasca da bagno la formazione del fango, qualche volta mi provoca tanto che faccio le boccacce.
Anche la tartaruga che mordicchia stoica le foglie di insalata non ha la più pallida idea delle pene del mio cuore: la nostalgia di un profumato caffè, di tabacco, di pane e di uova e del calore benefico che il cognac sa provocare nelle gole degli uomini afflitti da pensieri. La mia unica consolazione è ancora Bello, il nostro cane, che sbadiglia dalla fame come me.
Se poi arrivano ospiti inattesi, contemporanei dalla barba lunga come la mia, oppure madri con i loro bambini, a cui diamo da bere latte caldo con i biscotti inzuppati dentro, devo tenere duro per mantenere la calma. Ma la conservo perché è rimasta forse l'unica cosa che possiedo.
Ci sono giorni in cui la sola vista delle patate giallognole, appena cotte, mi fa venire l'acquolina in bocca perché già da tempo, e questo lo ammetto solo esitando e arrossendo violentemente, la nostra cucina non merita più la definizione di borghese. Circondati da ospiti e da animali, in piedi, facciamo solo di tanto in tanto spuntini improvvisati. Per fortuna mia moglie – ormai da molto – non può più comprare cose inutili perché non abbiamo più denaro liquido. Il mio stipendio è pignorato sino a tempo indeterminato e io sono costretto – travestito perché nessuno mi riconosca – a vendere sottocosto, in ore serotine, sapone e bottoni e lamette da barba in lontani sobborghi, perché la nostra situazione è diventata preoccupante. Possediamo però ancora alcuni quintali di sapone, migliaia di lamette da barba, bottoni di ogni tipo e assortimento e io, verso la mezzanotte, barcollo verso casa, metto insieme tutti i soldi che tiro fuori dalle tasche. I miei bambini, i miei animali, mia moglie mi stanno intorno con gli occhi lucenti perché di solito per la strada ho fatto la spesa: pane, mele, lardo e margarina, caffè e patate, un genere di cibo d'altronde desiderato ardentemente dai bambini come dagli animali. Così nelle ore notturne ci riuniamo tutti per un allegro pasto: mi circondano animali contenti, bambini soddisfatti, mia moglie mi sorride e noi lasciamo anche aperta la porta del soggiorno perché l'ippopotamo non si debba sentire escluso, e il suo allegro grugnito risuona dal bagno fino a noi. Per lo più mia moglie mi confessa di aver nascosto in dispensa ancora un ospite supplementare, che mi viene presentato solo dopo che i miei nervi sono stati rinforzati da un pasto. Gli ospiti sono uomini timidi dalla barba lunga che prendono posto alla tavola fregandosi le mani, donne che si spingono fra i nostri bambini per sedersi sulle panchettine mentre si riscalda il latte per gli urlanti bebè. In questa maniera imparo a conoscere animali di cui non sapevo molto: gabbiani, volpi e maiali, solo una volta un piccolo dromedario.
“Non è carino?” chiese mia moglie, e io, costretto, per necessità dissi di sì, che era carino, mentre osservavo preoccupato l'instancabile ritmo ruminante di questo animale color pantofola che ci guardava dai suoi occhi di lavagna. Per fortuna il dromedario rimase solo una settimana, e i miei affari andavano bene: si era sparsa la voce della buona qualità della mia merce e dei prezzi sottocosto. Qualche volta riuscivo a vendere anche stringhe da scarpe e spazzole, articoli di solito non richiesti. Vivemmo – per così dire – un certo periodo di apparente prosperità e mia moglie – misconoscendo completamente la situazione economica – tirò fuori una frase che mi preoccupò: “Siamo in ascesa!” Io invece vedevo sparire le nostre provviste di sapone, diminuire le lamette da barba e nemmeno la provvista di spazzole e di lana era più così rilevante.
Proprio a questo punto, quando mi avrebbe fatto bene una specie di conforto spirituale, una sera, mentre sedevamo tutti insieme, tranquilli, si sentì nella nostra casa una scossa, che assomigliava a un terremoto di media intensità. I quadri oscillarono, il tavolo tremò e un rocchio di salsiccia scivolò dal mio piatto. Stavo per saltar su, cercare la ragione di tanto disordine, quando notai sul viso dei bambini un riso soffocato. “Cosa sta succedendo, qui?” gridai e per la prima volta nella mia vita così ricca di imprevisti ero realmente fuori di me; “Piero,” disse piano mia moglie – e posò la forchetta, “ma è soltanto Giollo!” Cominciò a piangere e io di fronte alle sue lacrime mi sento indifeso perché mi ha dato sette figli.
“Chi è Giollo?” domandai stanco, e in quel momento la casa fu scossa da un nuovo tremito. “Giollo,” disse mia figlia, la più piccola, “è l'elefante che abbiamo adesso in cantina.”
Debbo confessare di essere rimasto sconcertato e anche la mia confusione sarà comprensibile. L'animale più grande che avevamo ospitato era stato il dromedario e io trovavo troppo grande l'elefante, troppo grande per la nostra casa dato che non godiamo le provvidenze delle case popolari. Mia moglie e i bambini, nemmeno lontanamente turbati come invece ero io, mi informarono: il direttore di un circo fallito aveva messo da noi al sicuro l'animale. Per mezzo dello scivolo con cui facciamo rotolare il carbone, è arrivato in cantina senza fatica. “Si è arrotolato come una palla,” disse mio figlio maggiore, “davvero una bestia intelligente.”
Non ne dubitai, accettai la presenza di Giollo e venni portato in cantina in trionfo. L'animale non era più grosso del normale, agitava le orecchie e sembrava sentirsi a suo agio da noi, tanto più che aveva a sua disposizione un sacco di fieno. “Non è carino?” domandò mia moglie, ma io mi rifiutai di rispondere affermativamente. Carino non mi sembrava la parola adatta. La famiglia pareva addirittura delusa del minimo grado del mio entusiasmo e mia moglie disse, lasciando la cantina: “Sei cattivo, vuoi che finisca al mattatoio?” “Che mattatoio e mattatoio, cosa vuol dire cattivo, e poi è proibito nascondere parte dei beni fallimentari.” “Non mi interessa, ma all'animale non deve succedere niente.”
Nella notte ci svegliò il proprietario del circo – un uomo timido, scuro di capelli – per chiederci se avessimo ancora posto per un animale. “È tutto quello che ho, l'ultima cosa che mi resta. Solo per una notte. Come sta l'elefante?”; “Bene,” rispose mia moglie, “mi dà pensiero solo la sua digestione.” “Si rimetterà a posto,” disse il proprietario del circo, “è il cambiamento. Gli animali sono così sensibili. E allora? Prendete anche il gatto, per una notte?” Guardava me e mia moglie mi diede quasi una gomitata e disse: “Su, non essere così duro.” “Duro,” dissi io, “no, non voglio essere duro. Per conto mio, metti pure il gatto in cucina.”
“È fuori in macchina,” disse l'uomo.
Lasciai che mia moglie aiutasse a sistemare il gatto e ritornai a letto. Mia moglie era un po' pallida quando si mise a letto e io ebbi la sensazione che tremasse un po'.
“Hai freddo?” domandai. “Sì,” disse lei, “ho degli strani brividi.” “Sarà la stanchezza.” “Forse sì,” disse mia moglie – ma mi guardava in una maniera così insolita. Dormimmo tranquilli, solo che in sogno rivedevo l'insolito sguardo di mia moglie rivolto a me e come costretto da qualcosa di strano mi svegliai prima del solito.
Decisi di radermi. Sotto il nostro tavolo di cucina c'era un leone di media grandezza, dormiva tranquillo, solo la coda la muoveva un po' e faceva un rumore come di chi giocasse con una palla molto leggera. Mi insaponai accuratamente e tentai di non far rumore, ma quando voltai a destra il viso, per radere la guancia sinistra, vidi che il leone teneva gli occhi aperti e mi fissava: “Sembrano davvero gatti,” pensai.
Quello che pensava il leone, lo ignoravo: continuava ad osservarmi ed io a radermi senza tagliarmi, ma debbo aggiungere che è una strana sensazione radersi in presenza di un leone. Le mie esperienze in fatto di bestie feroci erano minime; così mi limitai a guardare acutamente il leone, mi asciugai e tornai in camera da letto. Mia moglie era già sveglia, stava per dire qualcosa, ma io le tolsi la parola e gridai: “Perché parlare?” Mia moglie cominciò a piangere e io misi la mano sulla sua testa e dissi: “In fondo è pur fuori dal comune, lo devi ammettere.”
“Cos'è fuori del comune?” disse mia moglie, e io non seppi rispondere.
Intanto si erano svegliati i conigli, i bambini facevano chiasso nel bagno e l'ippopotamo – si chiamava Amato – strombazzava già; Bello si stirava, solo la tartaruga dormiva ancora, del resto lei dorme quasi sempre. Lasciai i conigli in cucina, dove hanno la loro cassettina per il cibo sotto l'armadio: i conigli annusarono il leone, il leone i conigli e i miei bambini, disinvolti e abituati a trattare gli animali erano già venuti in cucina. Mi sembrava quasi che il leone sorridesse: il mio figliolo, il terzo, gli aveva trovato un nome: Bombilus. E gli restò.
Alcuni giorni più tardi il leone e l'elefante vennero ritirati dal padrone. Devo confessare che vidi sparire l'elefante senza rimpianto: lo trovavo stupido, mentre la tranquilla, gentile allegria del leone aveva conquistato il mio cuore, tanto che la dipartita di Bombilus mi addolorò. Mi ero così abituato a lui: era veramente il primo animale che avesse goduto tutta la mia simpatia.
© Paolo Melandri (27. 7. 2019)
*
L’uomo che ride
L'uomo che ride
Quando mi interrogano sulla mia professione, mi sento imbarazzato: divento rosso, balbetto, io che altrimenti sono noto per essere un uomo disinvolto. Invidio la gente che può dire: faccio il muratore.
Ai parrucchieri, ai ragionieri, agli scrittori invidio la semplicità delle loro confessioni; queste professioni si spiegano da sole, non richiedono ulteriori chiarimenti. Io invece sono costretto a rispondere a queste domande: rido. Un'ammissione simile ne richiede altre, perché anche alla seconda domanda “Vive di questo Lei?” devo rispondere “sì”; il che risponde al vero. Vivo realmente del mio riso e vivo bene perché il mio riso, per esprimersi commercialmente, è richiesto. Rido bene, ho imparato a ridere, nessun altro ride come me, nessuno conosce come me le sfumature di quest'arte. Per molto tempo – per sfuggire a noiose spiegazioni – mi sono definito attore, ma le mie qualità mimiche e recitative sono così povere che questa definizione non mi è sembrata rispondere a verità e la verità è: rido.
Non sono né un clown, né un comico, non rallegro l'umanità, ma rappresento l'allegria; rido come un imperatore romano o come un sensibile giovinetto candidato agli esami di maturità, il riso del XVII secolo mi è così familiare come quello del XIX e – se il caso lo richiedesse – rido tutti i secoli, tutte le classi sociali, tutte le età.
L'ho semplicemente imparato, così come si impara a risuolare le scarpe. Il riso d'America riposa nel mio petto, il riso d'Africa, riso bianco, rosso, giallo – e per un onorario adeguato – lo faccio risuonare così come esige una regia.
Sono diventato indispensabile, rido su dischi, su supporti informatici e i registi dei radiodrammi mi trattano con riguardo. Rido malinconicamente, con misura, istericamente – rido come un controllore del treno o come un apprendista nel negozio di generi alimentari: come si ride la mattina, la sera, di notte e al crepuscolo, in breve: dovunque e quando ci sia da ridere, io rido.
Mi si crederà, se dico che una tale professione è faticosa tanto più – è la mia specialità – che so fare anche il riso contagioso: sono così diventato indispensabile anche ai comici di terzo o quart'ordine che, a ragione, tremano per la loro battuta e quasi ogni sera vado in giro per i variétés, come un raffinato genere di claqueur, per ridere contagiosamente ai punti deboli del programma. Deve essere un lavoro fatto su misura: il mio riso forte, vigoroso e selvaggio non deve arrivare né troppo preso né troppo tardi, ma cominciare proprio al momento giusto e allora – scoppio a ridere secondo il programma, tutto il pubblico urla insieme a me e la battuta è salva. Ma io mi trascino poi esausto al guardaroba, infilo il cappotto, felice di essere finalmente libero dal lavoro. A casa mi aspettano poi messaggi: “Ci occorre urgentemente il Suo riso” – “Registrazione martedì” e poche ore dopo mi trovo in un TAV surriscaldato e mi lamento della mia sorte. Ciascuno capirà che dopo il mio lavoro – o in vacanza – ho poca voglia di ridere. Il contadino che munge è felice quando può dimenticare la mucca, il muratore è soddisfatto quando può lasciar stare la calcina e i falegnami a casa hanno per lo più porte che non funzionano o cassetti che si aprono solo a fatica.
I pasticceri amano i cetrioli sott'aceto, i macellai il marzapane e il fornaio preferisce al pane la salsiccia: i toreri amano le colombe e i pugili diventano pallidi quando ai loro bambini viene il sangue al naso. Capisco tutto perché dopo il lavoro io non rido mai. Sono una persona terribilmente seria e la gente – forse a ragione – mi considera un pessimista. Nei primi anni di matrimonio mia moglie mi diceva spesso: “Su, ma ridi un po'” ma nel frattempo ha capito che non posso esaudire il suo desiderio. Sono felice quando posso distendere gli affaticati muscoli del mio viso o il mio animo malconcio, con una profonda serietà. Sì, anche il riso degli altri mi rende nervoso perché mi ricorda la mia professione. Così il nostro matrimonio è quieto e tranquillo perché anche mia moglie ha disimparato a ridere; di quando in quando la sorprendo a sorridere e allora sorrido anch'io. Insieme, parliamo piano perché io odio il rumore dei variétés, odio il chiasso che può esserci negli studi di registrazione. Persone che non mi conoscono mi considerano di carattere chiuso. Forse lo sono perché troppo spesso devo aprire la bocca al riso.
Con un viso immobile passo attraverso la mia vita; mi permetto di tanto in tanto un pallido sorriso e penso spesso se abbia mai riso. Credo di no. I miei fratelli raccontano che io sono stato sempre un ragazzino serio. Così rido in tante maniere, ma il riso mio, non lo conosco.
© Paolo Melandri (26. 7. 2019)
*
Presentimenti
Quando un'automobile frenò bruscamente davanti al viandante e con suo sollievo gli fu chiesta soltanto la strada lui si augurò di incontrarne altri che non la conoscevano; avrebbe potuto aiutarli tutti. Un gruppo di gente ferma a lato della carreggiata, come un assembramento, era invece in attesa a una fermata d'autobus. Più oltre, seguivano quasi soltanto distributori di benzina, depositi, e tra l'uno e l'altro sempre più spazi vuoti. Guardando indietro verso il centro si avvertiva la presenza del fiume, senza vederlo, dai gabbiani che volavano in cerchio sopra i tetti. Gli alberi lungo la strada digradavano in siepi e cespugli pieni di piccole bacche bianche. Com'era stato vario il verde del fogliame estivo, com'era vario anche adesso il grigio dei rami invernali – il primo distinguibile da lontano, il secondo da vicino.
2.
In uno di questi cespugli con tutte le sfumature di grigio vide una massa colorata, a prima vista un cartellone pubblicitario caduto dall'alto, ma poi, dalle dita che si piegavano, divenne riconoscibile un essere vivo. Era una donna anziana, con gli occhi chiusi, quasi senza capelli, stesa bocconi, non però a terra, bensì in alto tra i rami, che si divaricavano sotto il peso. Soltanto le punte delle sue scarpe toccavano terra; il corpo era sospeso per traverso e ricordava, anche per via delle braccia allargate, un aereo che avesse tentato un atterraggio di fortuna finendo sulla cima di un albero. La donna aveva le calze rovesciate fino ai polpacci e la fronte solcata da una ferita sanguinante, forse causata dalla spina di un cespuglio. Doveva trovarsi lì già da molto e avrebbe potuto restare così ancora a lungo, poiché di lì a piedi non passava nessuno. Ora il solo che vi era passato non riuscì a sollevare dalla macchia il corpo pesante, stranamente caldo. Ma allo spettacolo straordinario già molte macchine si erano fermate e accorrevano i soccorritori, pur senza chiedere. Quindi, radunati sul marciapiede attorno alla donna, cui fecero scivolare un cappotto sotto la nuca, rimasero tutti in attesa dell'autoambulanza. Sebbene nessuno di loro si conoscesse, si misero a chiacchierare, persino gli stranieri, come vicini di vecchia data riuniti in una felice combinazione. Tra loro regnava un anonimato addirittura allegro. E anche l'infortunata, che era in sé, con i grandi occhi molto chiari, costantemente fissi su chi l'aveva trovata, rimase senza nome. Sicuramente lo ignorava, così come ignorava il suo indirizzo e il modo in cui era finita tra le spine sulla strada di scorrimento veloce. Era in camicia da notte, vestaglia e pantofole, e avanzarono l'ipotesi che provenisse da un ospizio e si fosse smarrita. Parlava la lingua nazionale, non il dialetto, ma con un accento che faceva pensare non a una lontana regione, bensì all'infanzia di colei che parlava; come se, per la prima volta da allora, le uscissero di nuovo i suoni dell'infanzia. E in effetti erano semplici sillabe e singoli suoni, diretti come i suoi sguardi esclusivamente al suo scopritore, a cui lei, in modo incoerente, misterioso e al contempo con voce tanto più chiara, voleva comunicare qualcosa di urgente. Soltanto lui poteva capirla – nient'altri che lui, e senza riserve. In poche frasi spezzate, incomprensibili agli altri, gli raccontò tutta la storia della sua vita, dagli anni di gioventù fino al presente e, già presa in custodia dall'ambulanza, gli impose la sua storia fino all'ultimo sporgendosi dalla vettura come se gli affidasse un incarico. E quando lui fu di nuovo solo, dopo essersi congedato dai suoi compagni, non ebbe forse l'impressione di intuire tutto di quella vecchia confusa? Già da sempre l'intuizione non gli aveva forse dato di più che non il sapere letterale? Guardò il cespuglio vuoto e vide in futuro il corpo pesante, con le dita che si piegavano, sempre distesa nello stesso luogo «O voi, sacri presentimenti, restate».
© Paolo Melandri (26. 7. 2019)
*
Prima luce
Sedeva quieto nella notte al tavolo, mosso soltanto dal battito del cuore. Le porte variamente aperte dappertutto nella casa conferivano agli ambienti un che di alato. Il cespuglio del giardino si levò nel vento e venne nella stanza in visita. La tovaglia si muoveva come un lago. Alla prima luce del mattino gli uccelli svolazzarono intorno alle alture del sobborgo, e la metropoli in basso era il loro nido.
© Paolo Melandri (25. 7. 2019)
*
Lichtenberg
Lichtenberg
Londra, autunno 1775. Lichtenberg si reca nell'elegante negozio del miglior costruttore di strumenti scientifici della metropoli. Quando mostra una lettera del re che garantisce per ogni acquisto, il proprietario gli consegna il primo esemplare della sua invenzione. È una macchina elettrostatica di ottone luccicante.
Giorgio III manda a Lichtenberg un invito per il tè nel palazzo d'estate di Kew. È interessato alla nuova scienza, la fisica. L'atmosfera è informale; è presente tutta la famiglia regnante. All'improvviso il monarca viene colto da uno strano attacco. Comincia a parlare in modo sconclusionato. Il principe ereditario si permette una battuta cattiva sul padre. La regina lo redarguisce. Lui se ne va furibondo. Il re si riprende; come se niente fosse accaduto, parla con il visitatore delle ultime scoperte nei mari del Sud.
Più tardi passeggia nel parco insieme a Lichtenberg. Vede in lui un uomo che sa cosa significa convivere con una minorazione.
Il boudoir di un'attrice, arredo decadente. Il principe racconta a Perdita della visita di Lichtenberg a Kew. Lei ha sentito dire che toccare un gobbo è un magico rimedio contro l'impotenza e propone al principe un esperimento. Vuole sedurre Lichtenberg. Nel momento decisivo il suo amante dovrebbe toccarlo. Il figlio del re vede in questo piano anche una possibilità di schernire suo padre, di cui disprezza la gretta vita familiare e di cui odia le ramanzine. Perdita è elettrizzata dall'idea di giacere con uno storpio.
All'ignaro Lichtenberg viene preparata una trappola. Fino a quel momento le sue esperienze erotiche si sono limitate a domestiche e sguattere. Con la bella Perdita ha gioco facile. Quando il principe esce dal suo nascondiglio, Lichtenberg si accorge di essere stato raggirato. In preda al disgusto lascia la casa e fugge da Londra a rotta di collo.
A Gottinga l'arrivo della macchina elettrostatica suscita grande scalpore. Il professor Lichtenberg alloggia in un vecchio edificio pieno di anfratti in cui ha allestito un laboratorio con svariati strumenti e apparecchi. È arrivato alla conclusione che l'energia dell'amore sia dovuta a un fluido sconosciuto che presenta somiglianze con l'elettricità animale. Su questo tema tiene una lezione all'università che ha uno svolgimento decisamente bizzarro. Quando arriva al punto critico, Lichtenberg cade dall'alto sgabello su cui è seduto. Gli studenti reagiscono con un misto di curiosità, scherno e inquietudine.
Lichtenberg si riprende dalla depressione e decide di dedicarsi a nuovi esperimenti. Stavolta si tratta dell'elettricità dell'aria. Per misurarla, costruisce un aquilone. Una gran folla si è radunata sui bastioni per seguire l'esperimento. Durante i preparativi, Lichtenberg nota una giovane fioraia. Le chiede quanti anni ha e da dove viene. Si chiama Dorothea Stechardin. Mentre l'aquilone si alza in volo, lui continua a girarsi verso di lei. Non si accorge delle nuvole temporalesche che si addensano sopra la città. Un fulmine colpisce l'aquilone, che è collegato a terra, e lo fa precipitare. L'esperimento è fallito.
Il giorno dopo il professore fa visita ai genitori di Dorothea. Vorrebbe assumere la ragazza come domestica. I genitori acconsentono, perché Lichtenberg offre un generoso compenso. Dorothea dovrà occuparsi della pulitura dei suoi strumenti scientifici. Ma segretamente lui persegue un piano ben diverso. Vuole produrre la prova delle sue scoperte. La quindicenne appare come ideale cavia umana. I due cominciano a osservarsi e a spiarsi a vicenda. L'intimità crea un'atmosfera di desideri inespressi. Lichtenberg le insegna a leggere e a scrivere. Riesce a documentare, anche senza un diretto contatto fisico, tracce di fluido erotico in base a fenomeni di fluorescenza e di risonanza.
Nel momento in cui l'amore inizia a far scintille, lo studioso è raggiunto da un invito del re inglese che equivale a un ordine. Non gli resta altro che partire immediatamente per Londra. Giorgio III gli mette a disposizione un alloggio in una palazzina nel parco di Kew. Lo colma di onorificenze. Lichtenberg diventa membro della Royal Society. A un ricevimento gli viene presentato Omai, che Forster ha portato con sé da Tahiti. Il polinesiano non comprende perché non possa abbracciare una donna che gli sorride solo perché si tratta della figlia del lord cancelliere. In Lichtenberg, questa naturalezza suscita una grande impressione.
C'è un colloquio con il re nell'ossevatorio astronomico di Richmond. È presente anche il medico personale di Giorgio III, che però si tiene in disparte. Lichtenberg mostra al re Venere e gli parla della spedizione di Cook nel Pacifico. Ma il re ha altro per la testa. A prescindere dalla guerra con le colonie americane, lo tormenta la paura dell'impotenza e di un nuovo attacco psicotico. Anche il pricipe ereditario gli è sospetto. Pensa persino che voglia attentare alla sua vita. Prega Lichtenberg di rimanere a Londra e gli offre una splendida posizione. Ma lui ha in mente solo una cosa: l'esperimento con Dorothea, che lo aspetta a Gottinga. Risponde in modo evasivo. Il re è offeso e gli impone di restare.
Il medico personale, che riguardo alla malattia del monarca non formula una prognosi favorevole e pensa addirittura alla sua interdizione, punta sul principe ereditario, con il quale è in contatto. Vede in Lichtenberg un pericolo per i piani dell'erede al trono e informa quest'ultimo sul colloquio nell'osservatorio.
Il giorno seguente Lichtenberg lascia Kew per recarsi a teatro. Nella carrozza che lo viene a prendere si trova di fronte una giovane donna che gli si offre in maniera inequivocabile. Ma questa volta non ci casca: minaccia di buttarla fuori dalla carrozza in corsa. Il cocchiere si volta verso di lui: è il principe. Invece della donna è Lichtenberg a finire in strada. È preso dal panico, ruba i vestiti a un giardiniere e fugge. Sotto falso nome raggiunge una nave che lo porta ad Amburgo.
Il re si mostra generoso. Lo perdona e ordina che gli spediscano a Gottinga un nuovo telescopio e il suo guardaroba. Lichtenberg cammina per strada in nuovi abiti eleganti e fa vedere a Dorothea le sue magnifiche parrucche. Parla soltanto inglese. Convince la ragazza a stabilirsi stabilmente da lui. Si dedica tutto alla costruzione della macchina che dovrà servire al grande esperimento. Una notte giunge il momento decisivo. L'unione dei due genera la prova lampante dell'esistenza della quarta forza elementare. Sono entrambi felici. Ora Lichtenberg è alle prese con un altro problema: si preoccupa della stabilità dell'amore. Realizza di nascosto un accumulatore che, alla maniera di una bottiglia di Leida, dovrebbe assicurare il potenziale delle forze d'amore anche per il futuro; in fondo ha ventitre anni più della sua amante.
Cede alla tentazione di presentare la grande invenzione agli studenti. D'improvviso interrompe la lezione a metà e scompare nel suo alloggio privato. Adirati, nonostante il severo divieto gli studenti fanno irruzione nell'appartamento. Lo trovano mentre copula con Dorothea dentro una macchina che miscela e accumula il fluido. La luminescenza e lo scintillio sono così forti che i guardoni restano accecati e si danno alla fuga.
Il rapporto tra gli amanti è cambiato. Per nulla passiva e arrendevole, Dorothea ha progressivamente acquistato coscienza del proprio valore. Allo scienziato sfugge il dominio sull'esperimento messo in atto. Si ha quasi l'impressione che, a modo suo, Dorothea esegua un esperimento su di lui. Ottiene il permesso di comparire nelle vesti di padrona di casa quando Lichtenberg invita i propri amici. Nella piccola città il fatto suscita scandalo.
Alla fine del semestre la situazione deflagra. I due partecipano al tradizionale ballo di chiusura, al quale sono invitati tutti i notabili e i più ricchi fra gli studenti inglesi. Uno sconosciuto in maschera invita Dorothea a un giro di danza. Lichtenberg, che non sa ballare, li osserva. Lo sconosciuto si apparta con Dorothea nel cortile interno, dove tenta di violentarla. Alle sue grida di aiuto accorrono tre studenti, che bloccano lo sconosciuto, lo minacciano con gli spadini sguainati e gli strappano la maschera. È il principe ereditario. Dopo avere pugnalato un rivale in un bordello londinese, ha dovuto lasciare l'Inghilterra per qualche tempo. Viaggia in incognito. Gli studenti, che lo hanno riconosciuto, non possono trattenerlo. Quando viene a conoscenza del fatto, Lichtenberg è furioso.
Nella piccola città girano voci sugli inquietanti esperimenti che conduce con la Stechardin. Si dice che con l'aiuto della sua invenzione possa sottomettere qualsiasi donna. Le supposizioni scatenano invidie, paure e ipocrisie. Tra gli studenti nascono due fazioni. Gli avversari di Lichtenberg vogliono metter fine alle sue pratiche, se necessario con la forza. Il loro mandante e finanziatore è lo straniero, che riesce a conservare l'incognito. È anche alla testa della masnada che una sera si presenta davanti alla casa di Lichtenberg.
Lui e Dorothea vedono dalla finestra la gentaglia che si avvicina e il caporione che istiga la folla. Hanno intenzione di distruggere il misterioso apparecchio. Lasciali fare, dice Dorothea al suo compagno spaventato. La macchina non ci serve più. I due si nascondono in un armadio a muro. La macchina viene fracassata. Ma quando il principe cerca di distruggere anche la grande macchina elettrostatica, crolla a terra colpito da una scossa. I suoi seguaci pensano che sia morto e lasciano precipitosamente la casa.
La situazione è pericolosa anche per Lichtenberg e Dorothea. La ragazza tenta di rianimare il principe con una respirazione bocca a bocca. Arriva il medico chiamato d'urgenza; l'erede al trono si salva e viene portato via su una barella. Furioso per l'umiliazione subita, sussurra a Dorothea: Tra noi non è ancora finita. Mi rivedrai!
Il principe è tornato in Inghilterra. Lichtenberg non ha più intenzione di esporsi ulteriormente all'atmosfera ostile di Gottinga. Si trasferisce con Dorothea in un'incantata casetta con giardino appena fuori città. Un nuovo sogno si è impadronito di entrambi: il volo. Dalla Francia arriva la notizia di macchine aerostatiche che si sollevano in aria. Da scienziato Lichtenberg si chiede se non esista una componente dell'atmosfera più leggera dell'aria. Grazie all'aiuto dei pochi strumenti che ha salvato riesce a isolare con metodi elettrostatici una piccola quantità di idrogeno. In un mattatoio si procura vesciche di maiale tasparenti che riempie di gas. Quando queste si librano toccando il soffitto Dorothea è entusiasta. Lichtenberg è riuscito a mettere in salvo anche l'elettroforo, il canocchiale e un paio di accumulatori. Dorothea non immagina che là dentro è conservata una riserva della loro energia amorosa.
Sette mesi dopo Dorothea muore di tubercolosi. Nei suoi vaneggiamenti febbrili le appare il principe ereditario che la minaccia. Al tempo stesso vede davanti a sé la scena in cui Lichtenberg è a letto con una sconosciuta, mentre il principe lo schernisce.
Il suo amato riesce a scacciare questo incubo. Apre la finestra e fa salire in cielo decine di palloni. Anche noi voleremo via come loro, dice. Le descrive i paesi e i continenti sopra i quali passeranno. Quando Dorothea cessa di respirare, lui libera gli ultimi palloni.
Al funerale partecipa da lontano. Il cimitero si trova nelle vicinanze della casetta. Con il canocchiale Lichtenberg segue dal tetto il percorso della bara. Poi scende di sotto e apre le bottiglie verdi nelle quali è immagazzinato il fluido. Ebbro d'amore come non mai entra nella grande stanza al pianterreno. Lì, sul divano, lo attende Dorothea. Ha l'aspetto che aveva al loro primo incontro. Non dice una parola. Lichtenberg le gira attorno e poi si siede con cautela sulla sedia accanto a lei. Dopo qualche istante dice: Sapevo che saresti tornata.
© Paolo Melandri (21. 7. 2019)
*
Sabina
La notte mi avvolgeva, una fotografia staccata dalla cornice. La fodera di un mantello lacerata nel mezzo come le due valve di un'ostrica. Il giorno e la notte, scollati, e io cadevo in mezzo, senza sapere su quale strato riposavo, se fosse l'alta, fredda e grigia foglia dell'alba, o l'oscuro strato della notte.
Il viso di Sabina era sospeso nell'oscurità del giardino. Dagli occhi un vento di simun raggrinziva le foglie e sollevava la terra, tutto ciò che prima aveva avuto un andamento verticale girava ora in tondo, attorno al viso, attorno al suo viso. Lei contemplava con uno sguardo antico i pesanti secoli rigogliosi tremolare in profonde processioni. Dalla sua pelle di madreperla si levavano spirali di profumo, come incenso. Ogni suo gesto accelerava il ritmo del sangue e risvegliava un canto ritmico che era il suono dei suoi piedi che calpestavano, nel sangue, l'impronta del suo volto.
Una voce che aveva attraversato i secoli, così profonda da spezzare ciò che toccava, così profonda da farmi temere che avrebbe risonato eternamente dentro di me, una voce scolorita dal suono delle imprecazioni e dalle grida rauche che scaturiscono dal delta nel parossismo estremo dell'orgasmo.
Il mantello nero pendeva come capelli neri dalle sue spalle, per metà drappeggiato e per metà fluttuante attorno al suo corpo. Il tessuto del suo abito si muoveva sempre un momento prima che lei si muovesse, quasi consapevole dei suoi impulsi, e ondeggiava ancora a lungo dopo che lei si era arrestata, come onde che rifluiscono verso il mare. Le maniche scivolavano giù come un sospiro e la bordura della veste danzava intorno ai suoi piedi.
Come foglie che cadono le sue parole, come vetri dipinti le gradazioni del suo umore, la raucedine nella sua voce, il fumo nella sua bocca, il suo respiro sul mio sguardo come respiro umano che offuschi uno specchio.
Chiacchiere, chiacchiericci, frasi lasciate a mezzo, astrazioni, campanelli cinesi suonati con bastoncini ricoperti di ovatta, falsi fiori di arancio dipinti su porcellana. I soffocati, segreti chiacchiericci di donne dal tenero corpo. Gli uomini che ha abbracciato, e le donne, si confondono nella risonanza della mia memoria. Suono dentro suono, scena dentro scena, donna dentro donna – come un acido che riveli una scrittura invisibile. Una donna dentro l'altra, alla fine, in una processione che si spinge lontano, che frantuma la mia mente in quarti di tono che nessun direttore d'orchestra potrà mai più ricomporre.
La maschera luminosa del suo volto, cereo, immobile, dagli occhi come sentinelle. Fissa il mio incedere sibaritico, e io il sibilare della sua lingua. Affondate l'una nell'altra volgemmo altrove i nostri occhi da puttana. A Bisanzio era un idolo, un idolo che danzava a gambe larghe, e io scrivevo con polline e miele. Con parole di bronzo ho inciso nel cervello degli uomini il tenero segreto abbandono di donna, ho tatuato sui loro occhi quell'immagine. Li consumava la febbre dei loro visceri, l'indissolubile veleno delle leggende. Se il torrente era incapace di inghiottirli, oppure se riuscivano a trarsi in salvo, io ossessionavo la loro memoria con racconti che volevano dimenticare. Tutto ciò che è rapido o maligno in una donna può essere distrutto spietatamente, ma chi può distruggere l'illusione con cui mettevo lei a giacere ogni notte? Vivevamo a Bisanzio. Sabina e io, fino a che i nostri cuori sanguinarono dalle pietre preziose che portavamo sulla fronte, fino a che i nostri corpi furono sopraffatti dal peso dei broccati e le narici arse dal fumigare dei profumi; e quando fummo passate in altri secoli, ci racchiusero in cornici di rame. Gli uomini l'hanno sempre riconosciuta: lo stesso viso splendente, la stessa voce arrochita. E noi due ci riconoscemmo l'un l'altra: io il suo viso e lei la mia leggenda.
Mi mise al polso un braccialetto piatto di acciaio e il polso cominciò a battere come lei voleva, perdendo il suo ritmo umano, pulsando quasi in un selvaggio parossisimo orgiastico. Il lamento dei flauti, il doppio canto del vento attraverso le nostre ossa ci rammentava a distanza quando, sui letti di piuma, il culto che ispiravamo diventava lussuria.
Camminavamo mentre razzi scoppiavano dai lampioni delle strade, inghiottivamo la strada asfaltata con un ruggito da giungla e le case con i loro occhi chiusi e le ciglia di geranio; inghiottivamo i pali telegrafici vibranti di messaggi, inghiottivamo i gatti randagi, alberi, colline, siepi, il sorriso labirintico di Sabina sul buco della serratura. La porta cigolava, si apriva. Il suo sorriso si chiudeva. Un usignolo sfogliava un caprifoglio di miele. Nutrito di miele. Dita di flauto. La casa spalancava il cancello verde, e ci inghiottiva. Il letto galleggiava.
© Paolo Melandri (13. 7. 2019)
*
Atalanta
La prima volta che la vidi, la terra era velata dall'acqua. Appartengo a quella razza di uomini e di donne che vedono le cose solo attraverso il velo del mare, e i miei occhi hanno il colore dell'acqua.
Guardai con occhi di camaleonte la mutevole faccia del mondo, con sguardo anonimo guardai dentro il mio io incompleto.
Ricordo la mia nascita nell'acqua. Intorno a me una trasparenza sulfurea e le mie ossa si flettono come se fossero di gomma. Oscillo e ondeggio, su alluci privi di ossa, protesa a cogliere suoni lontani, suoni che orecchie umane non percepiscono, a vedere cose che occhi umani non scorgono. Nata con la memoria delle campane di Atlantide. Sempre in ascolto di suoni perduti e alla ricerca di perduti colori, sempre protesa sulla soglia come chi è angosciato dai ricordi, cammino nuotando. Fendo l'aria con ampie pinne e nuoto attraverso stanze senza pareti. Espulsa da un paradiso di silenzio, cattedrali ondeggiano al passaggio di un corpo, come musica senza suono.
Questa Atlantide si può trovarla soltanto di notte, lungo la strada del sogno. Non appena il sonno ricopre la rigida città nuova, la rigidità del nuovo mondo, i più massicci portali si schiudono su gong bene oliati e si entra nel mutismo del sogno. Il terrore e il godimento di delitti compiuti in silenzio, nel silenzio di slittamenti e sfioramenti. La distesa dell'acqua ricopre le cose soffocando ogni voce. Soltanto un mostro per caso mi trasportò in alto, in superficie.
Perduta nei colori di Atlantide, i colori si sciolgono l'uno dentro l'altro senza delimitazioni. Pesci di velluto, di organza, con denti di merletto, pesci di taffetà luccicanti, di seta e piume e lanugine, fianchi di lacca e occhi di cristallo di rocca, pesci dalle squame inaridite e occhi di uvaspina, occhi di albume. Fiori che palpitano sullo stelo come cuori marini. Non avvertono il proprio peso, il cavalluccio marino si muove come una piuma…
Una sonnolenza. Amavo la facilità, la cecità e la soavità del viaggiare sull'acqua che mi trasportava oltre gli ostacoli. L'acqua era lì a trasportarti come un enorme ventre; c'era sempre acqua su cui riposare e l'acqua trasmetteva le vite e gli amori, le parole e i pensieri.
Dormii molto al di sotto del livello della tempesta. Mi muovevo nel calore e nella musica come dentro a un diamante marino. Nessuna corrente di pensieri, solo la carezza del flusso e del desiderio che si amalgamano, si toccano, si spostano, si ritraggono, vagano – infiniti fondi di pace.
Non ricordo di aver avuto freddo o caldo laggiù. Di aver sofferto il freddo o il caldo. La temperatura del sonno, senza febbre né gelo. Non ricordo di avere avuto fame. Il cibo filtrava attraverso pori invisibili. Non ricordo di avere pianto.
Sentivo solo la carezza del movimento – movimento nel corpo di un altro – assorbita e perduta nella carne di un altro, cullata dal ritmo dell'acqua, il palpitare lento dei sensi, il muoversi della seta.
Amare senza coscienza, muoversi senza sforzo nello scorrere morbido dell'acqua e del desiderio, respirare in un'estasi di dissolvimento.
Mi svegliai all'alba, riversa su uno scoglio, scheletro di una nave soffocata dalle sue stesse vele.
© Paolo Melandri (12. 7. 2019)
*
Primo amore
Primo amore
A una svolta del sentiero, appena passato il cimitero di Santa Lucia, mi appaiono i cipressi delle Sacca. Sono anni e anni che non torno a salutarli. Mi sento, con orrore, tornare bambino, e a poco a poco, senza accorgermene, affretto il passo, quasi fuggendo incontro a loro. Entro così nella selva di cipressi che dalla villa dei Da Filicaia si stende fino a quella dei Fossombroni, e, a mano a mano che penetro nell'ombra odorosa di resina amara, mi nasce nel cuore una tristezza vile.
Non appena mi volto e mi rivedo bambino, laggiù, in fondo agli anni tristi dell'infanzia, mi prende un senso di sgomento e di umiliazione. Ho paura e ribrezzo di me bambino. Di me uomo ho confidenza. Conosco i miei segreti, la mia forza, le zone oscure e le zone luminose del mio spirito, quel che c'è di già morto in me, di ancora vivo. So come deludermi, come rifiutarmi. Ma di me bambino che cosa conosco? Uno spettro dolente. Nella vita di ogni uomo non c'è nulla di più segreto e di più misterioso dell'innocenza e della castità dell'infanzia. Quel che di impuro affiora ogni tanto nei nostri gesti, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, ci viene da quell'età torbida e infelice. Dentro ogni uomo c'è un bambino morto: un groviglio di paure, di istinti, di sentimenti corrotti, disfatti. Chiudo gli occhi, e mi rivedo ragazzo camminare per questi poggi, sotto questi cipressi e questi olivi, e i grilli scricchiolano all'orlo dei prati, le cicale cantano aggrappate alla scorza nera e rugosa delle viti, le serpi strisciano fra i sassi, e viene dagli Abatoni, dalla fabbrica dei Franchi, l'ansito di un motore, il rantolo di una bestia in agonia. Eccolo lì, davanti a me, il bambino che ero. Mi vedo fermarmi ad ascoltare lo scricchiolio dei grilli, il canto funebre delle cicale, curvarmi a frugare tra l'erba rossa e turchina, cogliere i fiori gialli delle ginestre, scovare i granchi di sotto le pietre immerse nell'acqua limpida e fredda. Mi guardo intorno, nulla è mutato, i pagliai ronzano come alveari, il sole al tramonto si riflette roseo nel lastrico grigio delle aie, nelle foglie argentee degli olivi, già le prime ombre della sera salgono lentamente dalla valle del Bisenzio, su per i fianchi nudi dello Spezzavento, con moto ambiguo di ragni, gli uccelli volano bassi, un morbido sonno cade dal cielo.
Son vissuto per tanti anni prigioniero fra questi monti, questi alberi, dentro questo orizzonte troppo breve per la mia ansia infantile, che l'antico furore mi scuote, l'antico odio. Mi risento all'improvviso umiliato dal ricordo di quella prima schiavitù. Ho vergogna di essere stato un bambino. Vorrei, con un gesto, liberarmi del bambino morto che è in me, con quello stesso gesto col quale mi liberai, allora, dell'essere misterioso che già cominciava a formarsi nel fondo della mia coscienza. Fu proprio lì, sotto quei cipressi, fra quei cespugli di ginestre dove biancheggiano come un cielo stellato i fiori di cicuta. Era la figlia di un carrettiere di Santa Lucia, una ragazza dai capelli rossi, un'enorme testa ricciuta, una fronte bianca sparsa di lentiggini gialle. Distesa sull'erba, dormiva. Sulle prime non mi ero accorto della sua presenza, camminavo respirando l'aria densa di resina, quella polvere verde che si alza dai boschi al tramonto. Erano gli ultimi giorni di primavera, la terra mandava un soffio caldo, un alito di mucca malata. Il cielo appariva tutto incrinato, come un antico specchio sbiadito, gli alberi e i monti vi si riflettevano capovolti, come in un lago. I cipressi nel vento mandavano un suono strano, le foglie degli ulivi urtandosi facevano un tintinnio di conchiglie.
La ragazza mi apparve all'improvviso supina nell'erba, le mani incrociate sotto la nuca. Il viso era chiuso, inespressivo, lontano. Era un sonno vuoto di sogni, una specie di estasi pigra e incosciente. Si era tolta la leggera camicetta di cotone, le braccia nude affondavano morbide nell'erba di un verde lucido. Di sotto le ascelle spuntavano due ciuffi di peli rossi. Un odore acre e violento di sudore mi bruciava le narici. Respiravo con fatica, il sangue mi batteva nelle tempie con un tonfo che pareva un urlo. Quella chioma rossa, quella fronte bianca illuminata di lentiggini gialle, mi avevano sempre dato uno stordimento febbrile. La vedevo passare tutte le sere davanti al cancello della nostra villa, prendere su per la viottola che sale al poggio delle Sacca, camminare con quella sua andatura pigra e amorosa. Una sensualità già matura si sprigionava dal suo seno ancora acerbo, dai fianchi lisci, dalle spalle larghe e ossute. La seguivo con gli occhi per un lungo tratto, una strana inquietudine mi faceva tremare il cuore. Era un dolce terrore, una tenerezza timida e spaurita. I contadini e i barrocciai le rivolgevano sottovoce parole misteriose con un furbesco atteggiare del viso, un sospettoso ammiccare degli occhi. Mi sentivo attirato da lei, spinto verso di lei da un'oscura forza, alla quale tentavo resistere con una sorta di spavento.
Quella stessa forza da cui mi ero sentito attirato la prima volta che avevo visto un morto, nella cappella mortuaria del cimitero di Santa Lucia. Era una contadina ancora giovane, tutti le portavano fiori, la bara scoperchiata era piena di fronde di ginestra. Ero entrato in punta di piedi, non osavo avvicinarmi alla bara, eppure una strana forza mi spingeva verso la morta, camminavo a piccoli passi, tutto curvo in avanti, ansando, in un silenzio gelido e vuoto. Tutti mi fissavano in viso, e io mi accorgevo di ogni mio gesto, di ogni mio passo, mi pareva di vedermi in uno specchio appannato, avevo paura e curiosità di quel che facevo, avrei voluto fermarmi, tornare indietro, ma non potevo, un avido spavento mi spingeva innanzi. Era come se la morta mi chiamasse per nome, a voce bassa, muovendo appena le labbra bianche, guardandomi di sotto le ciglia socchiuse, perfino nel gesto delle mani incrociate sul petto c'era come un richiamo, un invito. A un tratto allungai con violenza la mano verso quel viso di cera, come per colpirlo, e qualcuno in quell'istante mi afferrò il braccio, udii un grido, il mio grido, voci concitate intorno a me, un rumore di passi, mi trovai fuori all'aperto, disteso per terra, tutto tremante e piangente.
La ragazza dormiva, il vento le aveva rialzato la sottana fin sopra il ginocchio, e appariva la carne rosea e ferma della coscia, sparsa di una lucente peluria color rame. Mi rivedo nascosto dietro un cespuglio, curvo, ansante, gli occhi opachi e fissi. Ho paura e ribrezzo di quel ragazzo, sento che la vista della donna addormentata gli accende nelle vene un'ansia crudele, un furore lucido e preciso. Mi accorgo che una forza irresistibile sta per vincerlo, una violenza calda e rossa, un istinto di rivolta e di liberazione. O il primo istinto del delitto. Mi guardo intorno: il luogo è deserto, lo stesso luogo, la stessa ora. Sono solo, solo davanti a quel ragazzo che ero, di cui ho vergogna e paura. Vorrei corrergli incontro, trascinarlo via con me, prima che possa compiere il gesto che già vedo incidersi nell'aria dura e lucente. Quel gesto di cui all'improvviso mi assale l'orrore antico: ma un orrore che ha in sé ancora un'ombra di orgoglio, di pudore ferito.
A un tratto vedo il ragazzo curvarsi, afferrare un sasso, scagliarlo con tutte le sue forze contro la donna addormentata. Il sasso la coglie in mezzo alla fronte, la donna si solleva di colpo sui gomiti, un urlo le rompe la bocca, un rivo di sangue le inonda il viso. Il ragazzo rimane in ginocchio, immobile, per qualche istante, un sorriso stanco e deluso sulle labbra esangui. Poi adagio adagio si allontana, fugge lento e cauto fra le ginestre, si ferma, appoggia la fronte al tronco di un cipresso, un tremito convulso gli scuote le mani.
Il sole intanto è scomparso, l'aria trema intorno alle foglie immote, non soffia alito di vento, ma l'aria trema, i profili dei monti impallidiscono a poco a poco, si sciolgono nella carne viva del cielo. Il ragazzo all'improvviso si volta e mi guarda. Sono io, mi riconosco, sono io quel bambino pallido, dalla fronte ansiosa, dagli occhi opachi e tristi. “Va' via!”, gli grido, curvandomi a roccogliere un sasso. Il ragazzo mi guarda fisso con un'intensa espressione di pietà, e io a poco a poco mi sento umiliato dalla pietà di quel bambino, ho rimorso di avere avuto paura e vergogna di lui, vorrei chiedergli perdono, gli son grato di avermi salvato con quel gesto dall'incubo del delitto, di avermi liberato per sempre da quella misteriosa schiavitù, che fa dell'amore il sentimento più vicino alla speranza e all'umiliazione della morte.
© Paolo Melandri (12. 7. 2019)
*
La grondaia
La grondaia
Rimasero stesi a lungo, svegli, e fumarono, mentre il vento attraversava la casa, staccava dei frammenti e faceva precipitare le pietre; pezzetti di intonaco volavano giù con fragore dai piani superiori, in basso scoppiavano e si sparpagliavano come detriti.
Di lei vedeva soltanto un barlume, un caldo alito rossastro quando le sigarette brillavano: il tenero disegno dei seni sotto la camicia e il suo profumo tranquillo. Alla vista della sottile fessura ben chiusa delle sue labbra, questa piccola valle nel suo viso, la tenerezza lo colmava. Rimboccarono le coperte ai lati, si strinsero l'uno all'altro e seppero che sarebbero stati al caldo per tutta la notte; le imposte sbattevano e attraverso i buchi sfrangiati dei vetri il vento fischiava; in alto ululava nei resti dell'ossatura del tetto e da qualche parte qualcosa batteva forte e continuamente contro una parete, qualcosa di duro, di metallico, e vicino a lui lei disse piano: – È la grondaia, è difettosa da molto tempo –. Tacque un attimo, gli prese la mano e continuò a bassa voce: – Non c'era ancora la guerra, abitavo già qui e quando tornavo a casa vedevo il pezzo di grondaia che pendeva lì e pensavo: devono farlo riparare; ma non lo hanno riparato. Pendeva di sghembo, una delle graffe si era staccata e sembrava che stesse per precipitare, ad ogni istante. La sentivo sempre, quando c'era vento; ogni notte, quando c'era tempesta e stavo qui distesa. Anche quando venne la guerra pendeva ancora lì. Sul muro grigio della casa si vedevano chiaramente le tracce dell'acqua che dopo ogni pioggia era entrata obliquamente nel muro: una strada bianca, orlata di grigio scuro, che passando vicino alla finestra portava verso il basso, alla sua destra e alla sua sinistra grandi macchie rotonde, il cui centro era bianco, circondato da anelli di grigio più scuro. Più tardi sono stata molto lontana, ho dovuto lavorare a Trento e a Trieste, e quando la guerra è finita sono tornata di nuovo qui e la grondaia era sempre lì che pendeva: metà della casa era crollata (ero stata molto lontana, molto, e avevo visto molto dolore, morte e sangue, mi avevano sparato contro le mitragliatrici degli aeroplani e avevo avuto paura, molta paura) e per tutto questo tempo questo pezzo di lamiera è rimasto appeso qui, ha diretto l'acqua nel vuoto, perché il muro sotto era quasi sparito. Le tegole erano precipitate, gli alberi erano stati rovesciati, l'intonaco era caduto giù sgretolato, erano cadute le bombe, ma questo pezzo di lamiera era sempre rimasto appeso a quell'unica graffa, non era mai stato colpito o aveva rinunciato alla sua posizione obliqua per la pressione dell'aria.
La sua voce divenne ancora più lieve, quasi cantante, gli strinse la mano. – È piovuta molta pioggia, – disse, – in questi sei anni, ci sono state molte morti, sono andati distrutti molti duomi, ma la grondaia pendeva ancora lì, quando sono tornata. La sentivo di nuovo battere, la notte, quando c'era vento. Ci credi, che ero felice?
– Sì, – disse lui.
Il vento si era calmato, tutto divenne calmo e il freddo strisciò più vicino. Tirarono più su le coperte e vi nascosero sotto anche le mani. Nell'oscurità non si riusciva a distinguere più niente, non vedeva più il suo profilo, nonostante lei fosse così vicina che ne sentiva il respiro: il suo ritmo calmo e breve lo colpiva tranquillo e regolare e lui pensò che dormisse già. Ma improvvisamente non sentì più il suo respiro e cercò a tastoni le sue mani. Lei tolse la mano da in alto e afferrò la sua e la tenne stretta e lui seppe che era caldo e che per tutta la notte non avrebbe dovuto aver freddo.
Improvvisamente sentì che piangeva. Non c'era nulla da sentire, dedusse soltanto dai movimenti del letto che con la mano sinistra si asciugava il viso, ma anche questo non era chiaro, e tuttavia lui sapeva che piangeva. Si alzò a sedere, si chinò su di lei e sentì di nuovo il suo respiro che sembrava diffondersi sul viso di lui come una corrente e scorrergli dolcemente accanto. Anche quando il suo naso le toccò la guancia fredda non vide ancora nulla.
– Stenditi, – disse lei piano, – prendi freddo.
Rimase sopra di lei, voleva vederla, ma non vide nulla, finché all'improvviso lei spalancò gli occhi: vide lo splendore dei suoi occhi nel buio, le lacrime che brillavano.
Pianse a lungo. Lui le prese la mano, la tenne e rimboccò di nuovo la coperta. Le tenne stretta la mano a lungo, finché la sua presa cedette, si sciolse lentamente da quella di lui – lui le mise il braccio intorno alla spalla, la attirò vicino a sé e anche lui si addormentò e nel sonno si scambiarono i respiri come tenerezze…
© Paolo Melandri (11. 7. 2019)
*
Neolitico
Elsa ha aggiustato di sale. Prima della procreazione abbiamo mangiato spalla di montone con contorno di fagiolini e pere, dato il principio d'ottobre. Ha fatto, ancora a tavola a bocca piena: – Adesso andiamo a letto poi subito o prima vuoi raccontarmi com'è iniziata la nostra storia, quando dove?
Io: sono io in ogni tempo. E anche Elsa c'è stata dall'inizio. Verso la fine del Neolitico rammento il nostro primo litigio: duemila anni in cifra tonda prima che il Signore si facesse carne, allorché il crudo e il cotto si scissero in miti distinti. E se oggi, prima del montone con fagiolini e pere, si è discusso di figli, suoi e miei, con parole sempre più corte, così attaccammo briga tra le paludi, avvalendoci di un lessico neolitico, a cagione delle mie pretese su almeno tre dei suoi nove marmocchi. Ma perdetti io. Malgrado l'ardore con cui la mia lingua faceva ginnastica e allineava suoni primitivi, non fui mica capace di mettere insieme la bella parola padre; soltanto madre era possibile. In quel periodo lì Elsa si chiamava Aua.
Avevo lardellato la spalla di montone con dei mezzi spicchi d'aglio e accomodato le pere stufate nel burro tra i fagiolini verdi bolliti. Anche se, a bocca ancora piena, Elsa ha detto che poteva prender piede o funzionare al primo colpo, dal momento che lei, come le aveva consigliato il medico, aveva sbattuto le pillole nel cesso, io ho capito che il letto doveva aver ragione per il primo e la cuoca neolitica per il dopo.
Così ci siamo stesi, abbracciati aggambati come in ogni tempo. Una volta io di sopra, una volta lei. In parità di diritti, benché Elsa sostenga che il privilegio maschile della penetrazione non è certo compensato dallo scadente diritto femminile di negare l'accesso. Comunque, siccome abbiamo procreato nell'amore, i nostri sentimenti si sono talmente dilatati da riuscire a produrre in uno spazio più ampio, al di fuori del tempo e del suo tic-tac e perciò al netto di ogni terrestre giacenza, un'eterea procreazione parallela; quasi a conguaglio, il suo sentimento è penetrato a stantuffo nel mio sentimento: siamo stati bravi del doppio.
Dopo che aveva forse preso piede abbiamo fumato a letto, sotto una sola coperta, ciascuno la sua idea di sigaretta. (Io me la sono svignata, giù per le scale del tempo). Elsa ha detto: – A proposito, abbiamo finalmente bisogno di una lavastoviglie.
Prima che riuscisse a mettere in moto ulteriori speculazioni sulla distribuzione invertita dei ruoli – Mi gusterebbe una volta conoscerti incinto! – le ho raccontato di Aua e dei suoi tre seni.
Credimi, Elsa: ne aveva tre. La natura ci arriva. Sul serio: tre esemplari. Ma non li aveva lei sola. Tutte ne avevano tanti così. E se ben ricordo, nell'età della pietra si chiamavano tutte così: Aua Aua Aua. E noi ci chiamavamo Edek come un sol uomo. Intercambiabili. E anche le Aue erano uguali tra loro. Uno due tre. Di più all'inizio non sapevamo contare. No, non più in basso, non più in alto: accomodato in mezzo. Inoltre erano grandi lo stesso, tutti e tre, e collineggiavano ameni. Col tre inizia il plurale. La molteplicità, la serie, la catena, inizia il mito. Adesso però non farti mica venire i complessi. Noi ne abbiamo avuti più tardi. Dalle nostre parti, a oriente del fiume, Potrimpos, che diventò dio dei Pruzzi accanto a Pikollos e Perkunos, era famoso per i suoi tre testicoli. Sì, c'hai ragione: tre seni sono di più, o sembrano di più, sempre di più, significano sovrabbondanza, proclamano prodigalità, garantiscono sazietà in eterno, ma a guardar bene sono abnormi – comunque pur sempre pensabili.
Chiaro. Dovevi dirlo: Proiezione del desiderio maschile! Può anche darsi che anatomicamente non sia possibile. Ma a quell'epoca lì, quando i miti facevano ancora ombra, Aua ne aveva tre. Ed è vero, oggi il terzo manca spesso. Voglio dire: manca qualcosa. Beh, la terzità. Non t'incazzare subito. Figurati! Non ne farò sicuramente un culto. Naturalmente due sono abbastanza. Puoi crederlo, Elsa, in linea di principio mi bastano. Mica son tanto matto da correre dietro a una cifra. Adesso che ha funzionato di sicuro, senza pillola e grazie alla tua zuppa, adesso che sei incinta e i tuoi due peseranno presto più dei tre di Aua, io sono appagato e come senza desideri.
Il terzo è sempre stato un di più. In fondo solo un crepaccio della capricciosa natura. Inutile come l'intestino cieco. E poi mi domando, cosa significa in realtà questa senodipendenza? Questa tettomania tipicamente maschile? Quest'invocazione della superficie primordiale? D'accordo, più avanti Aua è diventata una dea e si è fatta confermare i suoi tre ciucci in idoli d'argilla grandi come una mano. Ma altre dee – per esempio la dea Kalì – avevano quattro e più braccia. Qua ci stava ancora un senso pratico. Le dee-madri greche – Demetra, Era – erano invece equipaggiate normalmente, e ciò malgrado hanno tenuto insieme la loro bottega per millenni. A dire il vero ho visto delle effigi di dèi con un terzo occhio, e pure in mezzo alla fronte. Non lo vorrei neanche regalato.
In generale il numero tre promette poi più di quanto mantenga. Coi suoi tre cosi Aua ha calcato la mano, proprio come le Amazzoni l'hanno tenuta leggera col loro unico seno. Ragion per cui le femministe di oggi cascano sempre nell'altro estremo. Adesso non mettermi subito il muso. Io sono a favore delle lib. E credimi, Elsa, due bastano davvero. Te lo conferma qualunque medico. E il nostro pupo, se non è un maschio, ne avrà certo abbastanza di due. Cosa significa qui: Aha! Insomma gli uomini ci hanno questa mania, sbavano dietro a sempre più seno. Del resto tutte le cuoche con cui ho periodato avevano solo qualcosa a destra a sinistra, come te: Mestina due, Agnese due, Amanda due, Sofia c'aveva due commoventi tazzine da caffè. E la badessa cuciniera Margherita ha asfissiato nel letto il ricco patrizio Eberardo con le sue due – peraltro immani – tette. Quindi restiamo sulla terra. Più che altro si tratta di un sogno. Non roseo, no! Non cominciare sempre a litigare. Sarà ben consentito, ancora, sognare un pochino. O no?
Semplicemente ridicola, questa gelosia di tutto e niente. Dove andremmo a finire, in che povertà ci ridurremmo senza progetti né utopia! Allora non potrei più far guizzare tre volte la linea col piombo sulla carta bianca. Allora l'arte si ridurrebbe a dire sempre sì e sissignore. Ti prego, Elsa, sii ragionevole per una volta. Facciamo che tutto questo è un'idea dalla cui contraddizione crescerà al seno femminile la dimensione mancante, qualcosa come una specie di sovrasseno. Devi concepirla dialetticamente questa cosa. Pensa alla lupa romana. A espressioni come: il seno della natura. E per quanto riguarda il numero, al dio trino e uno. Oppure ai tre desideri della fiaba. Perché preso in castagna? Io desidero proprio? Dici? Ah. Dici?
E va bene. Concesso: quando brancolo nel vuoto, intendo sempre il terzo seno. Di sicuro non capita solo a me. Ci saranno pure dei motivi, se noi uomini siamo ossessionati dal seno e come slattati troppo presto. Deve dipendere da voi. Potrebbe dipendere da voi. Perché voi date peso, troppo peso all'eventualità che vi caschino, vi caschino sempre di più. E lasciali cascare, maledizione! No. I tuoi no. Ma anche loro, garantito, col tempo. Quelli di Amanda cascavano. I seni di Lena furono cascanti anzitempo. Eppure io le ho amate, le ho amate così tanto. Mica dev'essere sempre quel po' di seno in più o in meno. Per esempio potrei trovare altrettanto bello il tuo culo, fossette comprese. E, sia chiaro, in nessun caso tripartito. Oppure qualche altra rotondità. Adesso lì, dove la tua pancia presto sfereggerà e sarà la quintessenza di tutto ciò che ha spazio. Forse ci siamo dimenticati che c'è dell'altro. Qualcosa di terzo. Anche in altri campi, anche politicamente, come possibilità.
Aua, comunque, ne aveva tre. La mia Aua trisenuta. E anche tu ne avevi uno in più, là nel Neolitico. Retropensa un pochino, Elsa: a come abbiamo cominciato.
© Paolo Melandri (9. 7. 2019)
*
Pomeriggio 3
Il sentiero era giallo degli aghi di larice caduti. Lo strato, sebbene in certe curve fosse alto come una scarpa, era così soffice che sotto i passi scivolava di lato. In tal modo sull'asfalto si era formata una pista di strie che avevano qualcosa di labirintico. Durante le ultime ore trascorse in casa, quanto più attorno a lui si era fatto silenzio, egli era stato incalzato dall'ossessione che fuori nel frattempo il mondo non esistesse più e che lui nella sua stanza fosse l'ultimo sopravvissuto; e tanto più ora si sentì sollevato nel vedere un uomo sano, in carne ed ossa, uno spazzino, già cambiato e pronto per il riposo serale, che uscì curvo dalla sua baracca e poi con un enorme fazzoletto da naso si pulì con cura gli occhiali dalle lenti molto spesse. Quando si salutarono, lo scrittore si accorse che oggi questo era stato il suo primo scambio di parole; sino allora o aveva ascoltato in silenzio l'annunciatore delle notizie del mattino, o aveva parlato con il gatto, o aveva ripetuto ad alta voce una serie di parole alla scrivania, cosicché ora, alla prima consueta formula di saluto da persona a persona, dovette persino schiarirsi la voce. Anche se l'altro nella sua miopia non riusciva quasi a vederlo, com'era rassicurante, dopo avere immaginato la fine del mondo, incontrare questi due occhi vivi pieni di brio. Gli sembrava di sentirsi capito soltanto dai loro colori, così come anche lui capiva i visi dei passanti sempre più numerosi in vicinanza della città, come se nel loro viso si specchiasse il suo.
Sebbene la sua casa fosse in alto sulla collina, con le finestre rivolte verso tutti i punti cardinali, per tutto il giorno non aveva mai guardato davvero in lontananza. Soltanto scendendo e avvicinandosi alle persone recuperò la capacità di guardare fino all'orizzonte. (A casa non evitava forse anche la terrazza sul tetto – oggetto per così dire di invidia da parte dei suoi visitatori, perché là si sentiva troppo rapito dal panorama, e non utilizzava forse il luogo soltanto per appendervi la biancheria?) Così, nella montagna da cui sgorgava il fiume apparvero un vitreo campo di neve e dall'altro lato, al limite della pianura con gli ultimi sobborghi della città, un arco morenico come tirato con il carboncino. Mentre camminava, sentiva in modo tangibile i muschi e i licheni sotto la neve e il ruscello scavato nella morena, insieme agli spuntoni di ghiaccio delle rive, dove frusciava l'acqua. Oltre gli isolati della periferia si distingueva ancora una serie di agglomerati urbani più piccoli, che però a distanza più ravvicinata risultavano in movimento: là era riconoscibile l'autostrada con gli autocarri che transitavano in silenzio; e per un momento sentì le sue braccia vibrare, come se anche lui fosse stato un guidatore seduto in una cabina. Vicino alle ciminiere della zona industriale, in una striscia di terra di nessuno, una steppa coperta di arbusti, si accese una luce rossa e il container scuro là dietro si rivelò per un treno in sosta, che al cambio di posizione del segnale, quasi impercettibilmente, cominciò ad avvicinarsi ingrandendosi. La maggior parte dei viaggiatori aveva già indossato il cappotto e si preparava a scendere alla stazione centrale. Una mano infantile cercò la mano di un adulto. Quelli che proseguivano il viaggio allungarono le gambe. Il cameriere in servizio già di primo mattino nella carrozza ristorante quasi vuota uscì nel corridoio, abbassò il finestrino e si lasciò investire dal vento della corsa, mentre l'addetto al lavaggio delle stoviglie, un meridionale più anziano, guardava fisso davanti a sé nella sua nicchia senza socchiudere gli occhi e fumava una sigaretta. Insieme a queste immagini in lontananza (“lontananza, la mia materia”), al di sopra dei tetti del centro lo scrittore vide una statua di pietra con in mano un ramoscello di palma scolpito in ferro stagliarsi in cielo sopra le cupole di una chiesa, circondata da altre figure di contorno che sembravano eseguire un girotondo.
L'ultima parte del sentiero della collina scendeva per una scala, fiancheggiata da palazzi vecchi di secoli. Nella parte superiore di tanto in tanto giardini pensili sporgevano verso il parapetto della scala come una serie di ponti levatoi. Nei piani inferiori, accanto al pendio roccioso, le luci erano accese in tutte le stanze probabilmente già dal mattino. Da ogni livello c'era la vista su un piano inferiore. Una lampada da tavolo proiettava un cerchio di luce su alcuni libri aperti che la persona seduta al tavolo, nella sua immobilità, sembrava più contemplare che studiare. Una donna, come se fosse appena entrata dalla porta, aveva ancora addosso cappotto e cappello e in mano una borsa pesante con la spesa. Un uomo dai capelli bianchi con le bretelle e le maniche della camicia rimboccate attraversò lentamente la sua stanza con il bricco del caffè e scese un paio di gradini seguito da una grande faccia piangente in uno schermo quadrato da televisore dietro a una tenda traforata. Sull'ultimo livello, infine, i piani terra, tutti agenzie o uffici, illuminati al neon: i ficus, i raccoglitori, la parete con le cartoline illustrate; i molti che lì erano di casa, e il singolo estraneo maldestro, che davanti agli impiegati si fa sempre da parte, quel che di familiare dato dalla cravatta allentata dell'uno, i capelli sciolti degli altri, i rami di dicembre fioriti nella bottiglia sul davanzale. Era come se qui, vicino alle abitazioni, scendendo di piano in piano il clima diventasse più caldo: in alto, sulla nuda roccia, ghiaccioli grandi come colonne, e sotto, nei giardini, oltre ai consueti arbusti di bosso e alle macchie di abeti si vedevano già singoli tronchi di palma e tondi alberi di alloro di un verde splendente, anche se protetti dai teloni di plastica.
© Paolo Melandri (5. 7. 2019)
*
Stella meravigliosa
L'interesse degli esseri umani per gli oggetti indica una necessità di salvare sé stessi dalla irreversibilità del tempo. Il dominio dell'uomo sulla materia presuppone inconsciamente la vittoria finale della materia stessa. Altrimenti perché rimarrebbero sulla terra tanti volgari monumenti, costruzioni e tombe di pietra, di bronzo e di ferro? Studiando a fondo, in un certo qual modo, l'essenza della materia, l'essere umano è giunto a scoprire l'energia atomica. La bomba all'idrogeno è l'oggetto più paradossale raggiunto dagli esseri umani (potrei darvi molti esempi: al giorno d'oggi non esiste amicizia più bella di quella dell'uomo con il suo cane, perché tra gli esseri umani la vera amicizia non esiste più ed essi si incontrano solo per motivi di interesse). La bomba all'idrogeno è comparsa, appunto, come una specie di ultima espressione umana.
Essa è solitaria, eroica, gigantesca, possiede una forza senza limiti, è modernissima e intellettuale, ha un unico e semplice obiettivo (la distruzione), e inoltre vive soltanto l'attimo presente, non appartiene né al passato né al futuro e, qualità ancor più essenziale, è bella ed effimera come un fuoco d'artificio. Non c'è immagine dell'“uomo” più ideale di questa. Il suo obiettivo è l'annientamento di sé e dell'altro… L'annientamento di sé e dell'altro: ah, non sembra il ritornello di una meravigliosa canzone? Prima o poi gli esseri umani dovranno baciare questa loro immagine. Per ora si accontentano di ballarvi intorno perché sanno che il loro atto susciterebbe un esito irreversibile, ma un giorno o l'altro, necessariamente, ineluttabilmente, l'uomo si chinerà ai piedi di quell'immagine e la bacerà. Le sue labbra premeranno un piccolo bottone, e il cielo all'alba sarà attraversato da un missile a testata nucleare. Solo un piccolo bottone. Quell'immagine non è infatti soltanto un essere umano, è anche un bottone. Che esistenza ideale! Un piccolo bottone, come quelli che a volte cadono ai bambini e che i bambini raccolgono con cura. Alcuni sentimentali umanisti si ostinano a considerare la bomba all'idrogeno una semplice “cosa”. Ma si sa, gli esseri umani hanno una testa confusa, è possibile che reputino una cosa persino l'“ultimo uomo”. È nel loro stile. Sussiste tuttavia un problema, la bomba all'idrogeno è qualcosa di non ancora perfezionato. Per garantire la loro felicità, gli esseri umani devono vivere circondati dalla perfezione delle cose. Soprattutto gli umanisti, che prediligono le pipe e i vestiti da passeggio con toppe di pelle sui gomiti, non amano compromessi su questo argomento. Perciò devono anch'essi conferire un senso alla bomba all'idrogeno… e come riuscire nell'intento? Premendo semplicemente un bottone.
Rodolfo ascoltava in silenzio a testa bassa, nascondendo il suo malumore, ma il parrucchiere applaudì rumorosamente con le sue morbide mani sudaticce.
«Ha proprio ragione, professore. Io amo mia moglie e i miei figli, e nutro un meraviglioso senso di affetto per la famiglia proprio perché sono un extraterrestre. Se fossi un essere umano sarebbe differente. Soprattutto le persone ricche e famose si comportano in realtà con freddezza verso la famiglia, e gli uomini affascinanti si comportano da seduttori, e considerano le donne un oggetto. Si può immaginare la decadenza in cui è sprofondato l'essere umano considerando quanto facilmente le donne cadono nelle loro trappole. Insomma, anche per sedurre le donne bisogna comportarsi con onestà e con sincerità, rispettarle come esseri umani e circondarle di tenero amore. Ovviamente io non ho tempo per far questo perché mi occupo soltanto di mia moglie e dei miei figli».
«La seconda malattia», continuò il professore ignorando la reazione dei suoi compagni, «è l'interesse dell'uomo per gli altri esseri umani. La sua più evidente manifestazione è forse l'istinto sessuale, che tuttavia non è un vero e proprio interesse umano. È soltanto l'atto di spiare il crepuscolo del mondo da una fessura tra la riproduzione e l'annientamento.
A prescindere tuttavia, dall'istinto sessuale è davvero incomprensibile perché l'essere umano continui a interessarsi agli altri dal mattino alla sera! Il giornale del mattino non parla che di fatti accaduti agli esseri umani, e alla televisione non si fa che vedere uomini. Se qualche volta compaiono immagini di animali, sono animali umanizzati, in modo che siano gradevoli. E i discorsi umani? Parlano sempre di problemi umani. Se talvolta si accenna a fenomeni naturali quali i terremoti, i maremoti, la fioritura dei ciliegi, se ne discute sempre dal punto di vista del danno o del giovamento che rappresentano per l'uomo: gli umani amano, del resto, le storie di morti e di omicidi.
Pertanto, il loro interesse universale e popolare verte costantemente sui problemi umani. L'astronomia, la matematica, la fisica e la chimica sono affidate a un nugolo di esperti, non godono assolutamente del favore delle masse. E anche ciò che viene chiamato “politica”, che infervora il popolo per quanto teorizzata e strutturata sia, è dal principio alla fine una questione che riguarda uomini, uomini e ancora uomini.
Consideriamo per esempio un banchetto, durante il quale gli esseri umani godono dell'interesse che nutrono per gli altri esseri umani. Si scambiano parole e sentimenti, tutti sono allegri, si sentono amici gli uni agli altri come se lo fossero dalla creazione della terra, tutto si fonde, tutto sembra in comune. Eppure, cibi presi dallo stesso piatto e vino versato dalla stessa bottiglia attraversano l'oscuro esofago di ciascuno e si dirigono verso il buio stomaco di ciascuno. Là inizia il processo della digestione, completamente staccato dagli stomaci altrui, insomma, se al banchetto partecipano otto persone, esistono, sotto le sfavillanti luci della sala, otto canali nascosti, solitari, tenebrosi, con condotti diversi l'uno dall'altro.
Immaginiamo ora un incidente stradale, con una ragazza riversa sull'asfalto: ha le cosce scoperte, da cui sgorga sangue che si mescola con la pioggia notturna, e sembra indossare una fresca calzamaglia a rete rossa che lascia trasparire le gambe».
«Esatto! Gli esseri umani sono tutti delle fontane di sangue, e una fontana che non zampilla sangue durante la vita è soltanto una fontana secca o rotta. Le colombe si avvicinano agli esseri umani per abbeverarsi a quella fontana, poi volano via deluse. Quelle bianche, gentili colombe non riescono a colorarsi le ali di spruzzi di sangue!» interruppe con tono lirico il giovane impiegato in banca in preda all'eccitazione.
«E i curiosi che le si radunano intorno», continuò freddamente il professore, «osservano attentamente la donna agonizzante rapiti dalla gioia. Tutti sanno che le sofferenze non si trasmettono e che nello stesso tempo ciascuno di loro porta il peso di una “condizione” che lo assoggetterà prima o poi a simili tormenti.
L'interesse dell'uomo per un altro essere umano assume sempre questa forma. La sicurezza che, pur avendo ricevuto in sorte il peso di uguali condizioni di esistenza, non esista una sofferenza comune all'umanità, un unico stomaco per tutti gli esseri umani… Anche voi saprete che le donne dimenticano velocemente le sofferenze del parto e credono che il loro sia stato il più doloroso. Sebbene siamo tutti destinati a invecchiare, ad ammalarci e a morire, la sofferenza individuale non ammette assolutamente una malattia e una morte comune a tutta l'umanità.
© Paolo Melandri (3. 7. 2019)
*
Origini
Vivevano sulle rive di un mare dalle tiepide acque, su un'isola in effetti molto vasta, ma senza allontanarsi mai da quei luoghi. Erano creature marine, si nutrivano di pesce, alghe e frutti che crescevano in prossimità della spiaggia. Dimoravano dentro alte caverne, con il fondo sabbioso, anche se potevano tranquillamente dormire all'aperto, sugli scogli, oltre al riparo delle grotte. Da quanto vi si erano stabilite? È qui che ci imbattiamo subito in un grosso problema, anzi nell'ostacolo principale che abbia dovuto affrontare in quest'opera di ricostruzione storica. Le Clito ignoravano in quale momento la loro specie fosse emersa per la prima volta dalle onde per respirare, appollaiandosi sulle rocce, né la questione le incuriosiva. Non si ponevano interrogativi sull'argomento. Allorché si chiedeva loro – ma questo molto tempo dopo – “Quant'è antico il vostro popolo?” rispondevano senza convinzione e quasi con disinteresse “Cioè?”. Non avevano l'attitudine mentale a porsi interrogativi, nemmeno di scarso rilievo. Credevano – senza tuttavia essere disposte a lottare per difendere tale convinzione – che fosse stato un Pesce a condurle in quel luogo dalla luna. Ma quando? A quella richiesta seguivano lunghi sguardi perplessi e ottusi. Erano uscite dalle uova deposte in mare dall'astro celeste, che aveva perso un frammento: ecco perché a volte appariva grande e splendente e a volte pallido e sottile. Quanto alla capacità di procreare, non si erano mai soffermate sull'argomento. Era sempre stato così, né sarebbe cambiato in un futuro più o meno immediato, anche se la loro era una sensazione piuttosto che un'opinione da sostenere o tanto meno da enunciare. Da quanto tempo? Domanda inutile. Quando venne alla luce il primo “Mostro”, lo si considerò uno dei bambini deformi che talvolta nascevano; a quello ne fece seguito un altro, dalle stesse orribili e inquietanti fattezze. Venivano abbandonati sulla Roccia della morte e non gettati in pasto ai pesci, forse perché si riteneva, per una forma di superstizione, che in mare i Mostri avrebbero potuto proliferare e perfino raggiungere a nuoto la spiaggia. Ma è lecito parlare di superstizione a proposito di esseri che vivevano in una realtà a noi del tutto sconosciuta?
Sono convinto che la comparsa dei Mostri abbia rappresentato il primo evento negativo o addirittura allarmante verificatosi nella loro comunità.
Certo, sulle pareti delle caverne si notano i segni lasciati ad altezza notevole dalle acque che spesso, evidentemente, vi penetravano impetuose, ma non dimentichiamo che si trattava di creature marine. Non è possibile scoprire cosa provassero invece di fronte all'invasione dei Mostri; i loro canti non contengono riferimenti a vicende storiche, sono solo una sorta di lamento funebre, dal suono simile al vento che stormisce.
Non fu la nascita del primo Mostro a scuoterle dal sogno. Un braccio e una gamba storta, una mano difettosa, perfino dei lineamenti imperfetti o una testa malformata, erano circostanze tristi ma non provocavano allarme; ben diverso fu quando iniziarono a venire al mondo sempre più bambini con quell'appendice di carne proprio là davanti, dove loro erano lisce e avevano una semplice fenditura circondata da morbida peluria. Che orrore… ne nascevano in continuazione… non vedevano l'ora di abbandonarli sulla Roccia della morte. Quegli affari sporgenti da cui zampillava liquido, che cambiavano continuamente forma, schifosi, raccapriccianti, con un che di…
Be', ci pensavano le aquile a ghermirli e a divorarli, togliendoli di mezzo.
Poi tutto cambiò. Dev'essere successo come quando si conficca uno stecco nel corpo di uno di quei torpidi animali arenati sulla spiaggia, che si contorcono appena avvertono la trafittura.
Quelle creature sognanti erano sempre più sconvolte, e fu questo senso di panico impotente a scatenarne la crudeltà.
A un certo punto divenne evidente che i Mostri avrebbero continuato a nascere, e si fece strada una nuova preoccupazione, che la comunità si riducesse sempre più di numero.
Subentrò anche la paura che le femmine che avevano partorito un Mostro ne generassero ancora. Come sarebbero state giudicate? Non è dato sapere se esistesse un primitivo sentimento di animosità tra queste creature. Le altre le temevano? O erano loro a provare apprensione verso sé stesse? Una femmina che avesse messo al mondo più di un Mostro abortiva appena scopriva di essere di nuovo incinta? Non vi è risposta a questi interrogativi.
Quanto si protrasse quell'epoca primordiale?
Le Memorie non ci aiutano a ricostruire tale dato.
Abbiamo l'impressione che si sia trattato di un'evoluzione molto lenta, anche se non è possibile misurarla in termini di tempo. L'enorme fossa o cavità dentro cui le ragazze venivano gettate traboccava di ossa, pur essendo assai profonda. Sul fondo, là dove le rocce erano franate, vi si aprivano crepe e spaccature, e dall'esterno si intravedevano gli strati inferiori di quel macabro deposito: gli scheletri non apparivano recenti e integri, come quelli in alto, bensì recavano delle fratture e si presentavano in frantumi; ancora più in basso, il suolo di quell'ampia voragine era ricoperto da una spessa coltre di polvere biancastra, costituita da ossa sbriciolate. Deve essere occorso un lungo periodo perché si formasse, nonostante il vento e l'acqua salata che penetravano dalle fenditure, accelerando il processo.
Non sembra probabile che tale popolazione, apparentemente immersa in un sogno, compisse regolarmente dei sacrifici, o qualunque altro rito; a scandirne la vita erano impulsi e ritmi che a stento si riuscirebbe a comprendere. Tuttavia, benché non vi sia un sistema per contare gli scheletri o impiegare gli strati di ossa polverizzate per stabilire un intervallo cronologico, possiamo affermare senza tema di smentita che siano trascorsi secoli.
Un'esistenza immutabile, simile a quella dei pesci che risalgono la corrente, in armonia con le fasi lunari. Finché non intervenne il vero cambiamento, quello definitivo, con la nascita dei neonati deformi, gli Squirti, i Mostri, da cui si determinò una condizione di disagio emotivo, di inquietudine, di malcontento, e l'inizio della consapevolezza di sé e del proprio modo di vivere. Solo un primo passo, avvertito come l'insulto di cui deve sentirsi vittima la creatura marina arenatasi sulla spiaggia quando le viene affondato lo stecco nella carne.
In questo racconto c'è una parte destinata a rimanere avvolta nel mistero. E già, i precedenti tentativi di risolvere l'enigma sono approdati a soluzioni più fantasiose che verosimili. Come ha avuto origine il primo nucleo di maschi? È difficile credere che le aquile abbiano nutrito i neonati con carne cruda rigurgitata, riscaldandoli tra le loro piume. No, la spiegazione dev'essere un'altra.
I rapaci si cibavano dei bimbi deformi abbandonati sulla Roccia della morte: quanto tempo andò avanti questa storia? Quella sorte probabilmente toccò ai primi Mostri. Ma a un certo punto – anche se ignoriamo quando – alcuni maschietti, allevati come “animali da compagnia” e usati a mo' di trastullo dalle Clito, fuggirono. Sappiamo che bambini di quattro anni, per non parlare di quelli tra i cinque e i sette, possono dimostrare una grande resistenza, e perfino forza fisica. Due, tre, quattro marmocchi scapparono dalle grotte a picco sul mare. Le aquile, per quanto enormi, di dimensioni molto maggiori degli uccelli che oggi conosciamo, non sarebbero state in grado di trasportare ragazzini di quell'età, non per lunghi tratti. I bambini scoprirono in che direzione puntavano i rapaci, verso i loro nidi, oltre la Roccia della morte, al di là della valle, sulla montagna, e li seguirono fino al crinale, su cui le aquile si appollaiavano, ma senza fermarsi. Come dovevano apparire spaventosi ai loro occhi quei giganteschi uccelli. Valicata la cima, si ritrovarono nella vallata dove scorreva il grande fiume. Avevano mangiato sempre e solo pesce, e anche lì ve n'era, benché di specie diverse. Piccoli com'erano, dopo aver dimorato nelle caverne, quella conca dovette apparire loro immensa. Come non rimanere ammirati di fronte a tanta audacia e intelligenza? Il fiume era ampio, dalle acque profonde e impetuose. Eppure furono costretti a immergervisi per pescare. Dove si rifugiarono? Non erano capaci di costruirsi capanne o alloggi di fortuna: non ne avevano mai visti. Conoscevano però i nidi delle aquile; raccolsero dei pezzi di legno sempre più grossi, trascinandoli, e li accatastarono, per poi scivolare dentro quei rifugi improvvisati al calar della sera. Una volta cresciuti, ormai giovani vigorosi, iniziarono a servirsi dei rami caduti per fabbricare delle case. Il clima era mite; non si pativa il freddo. Ma non dimentichiamo le fiere che popolavano le foreste lungo le sponde del grande fiume. Il fatto che siano sfuggiti ai loro assalti ha del prodigioso. È stata forse una divinità a proteggere quelle creature? Eppure nelle testimonianze che ci sono giunte non si accenna minimamente a un intervento soprannaturale. Certo, si proclamavano figli dell'Aquila, ma quello è l'unico riferimento a un nume.
Va ricordato che quei primi bambini di sesso maschile erano atrocemente mutilati, in varie maniere, sulle quali preferirei non soffermarmi. I loro “squirts” erano stati oggetto di mille torture – le femmine li tiravano e vi si trastullavano – e lo scroto talvolta veniva asportato per gioco, in modo da estrarne i testicoli. Poi, soprattutto, non avevano mai conosciuto la tenerezza e le cure di una madre. Le loro genitrici li avevano nutriti, per ordine delle Anziane, ma controvoglia, e sempre in misura insufficiente. Vorremmo addolcire i contorni di questa dolorosa vicenda immaginando che qualche Clito abbia manifestato affetto per la sua deforme creatura, pur dovendo celare i propri sentimenti, riservandole carezze e attenzioni frettolose. Erano ragazzini duri, coraggiosi e abili a passare inosservati. Pelle e ossa, ma forti e temerari, con scarse probabilità di sopravvivenza, però, se non altro, liberi da quelle aguzzine delle Clito.
A quel punto accadde un fatto degno di nota. Le aquile portarono nella valle alcuni maschietti che erano stati abbandonati sulla Roccia della morte. I neonati urlavano dalla fame, ma non erano mutilati; come avrebbero fatto loro, dei bambini, a nutrirli?
Le foreste non erano popolate solo da belve feroci, ma anche da animali mansueti. I ragazzini scorsero delle cerve con i loro cerbiatti, e forse per la prima volta, osservando quelle bestie in compagnia della prole, assistettero a una dimostrazione di amore materno. Si avvicinarono di soppiatto per guardare. Una femmina se ne stava ferma, per nulla spaventata: gli animali non avevano ancora motivo di temere la nostra specie. E inoltre aveva di fronte un bambino, e per di più in difficoltà. Il piccolo si mise ad accarezzare il soffice pelame della cerva, mentre il cerbiatto cozzava con la testa o gli leccava le gambe, e subito dopo prese a succhiare il latte della madre; il bimbo, in ginocchio, lo imitò. La femmina volse il capo e leccò a sua volta il ragazzino. Fu così che ebbe inizio la familiarità tra i bambini e quegli animali.
Ricordo un canto che diceva: “Siamo figli dei cervi”, ma non è attestato con la stessa diffusione di quello sulle aquile.
Appena i neonati cominciavano a vagire e a strepitare, i ragazzini capivano che andavano allattati; il sistema più naturale era quello di portarli dalle cerve, che appresero in breve tempo a stendersi a terra e a offrire le mammelle ai piccini. Che ci guadagnavano? Possiamo fare delle ipotesi. Sono convinto che gli animali siano più intelligenti di quanto crediamo. In fin dei conti, è stata una lupa ad allattare i nostri progenitori, Romolo e Remo. La sua effigie scolpita, insieme ai due gemelli, è oggetto di grande devozione presso il nostro popolo. Probabilmente quel legame si sviluppò a causa del terribile stato di bisogno in cui versavano i neonati, che rischiavano di morire per mancanza di ciò che la cerva – o la lupa – avevano in abbondanza. La necessità aguzza l'ingegno.
E per quale motivo le aquile si diedero a salvare i bimbi e a portarli oltre la montagna, dai loro simili, anziché divorarli? Semplice: i ragazzini pescavano del pesce per i rapaci e lo deponevano sull'erba; i grossi uccelli, dopo aver depositato il carico di creature urlanti, si appollaiavano sul banchetto, costituito da pesci enormi, e lo divoravano; spesso arrivavano anche senza neonati, per consumare il loro pasto, oppure afferravano un pesce, intero o meno – nel fiume ve n'erano di giganteschi – e volavano verso la montagna per sfamare gli aquilotti.
Dunque i Mostri, o Squirti, della seconda ondata non soffrirono per l'abbandono materno, ma furono oggetto di tenerezze e ricevettero nutrimento dalle amorevoli cerve, e spesso giocavano con i cerbiatti con l'atteggiamento dei cuccioli.
© Paolo Melandri (29. 6. 2019)
*
Pomeriggio 2
Il sentiero era giallo degli aghi di larice caduti. Lo strato, sebbene in certe curve fosse alto come una scarpa, era così soffice che sotto i passi scivolava di lato. In tal modo sull'asfalto si era formata una pista di strie che avevano qualcosa di labirintico. Durante le ultime ore trascorse a casa, quanto più attorno a lui si era fatto silenzio, lo scrittore era stato incalzato dall'ossessione che fuori nel frattempo il mondo non esistesse più e che lui nella sua stanza fosse l'ultimo sopravvissuto; e tanto più ora si sentì sollevato nel vedere un uomo sano, in carne ed ossa, uno spazzino, già cambiato e pronto per il riposo serale, che uscì curvo dalla sua baracca e poi con un enorme fazzoletto da naso si pulì con cura gli occhiali dalle lenti molto spesse. Quando si salutarono, lo scrittore si accorse che oggi questo era stato il suo primo scambio di parole; sino allora o aveva ascoltato in silenzio l'annunciatore delle notizie del mattino, o aveva parlato con il gatto, o aveva ripetuto ad alta voce una serie di parole alla scrivania, cosicché ora, alla prima consueta formula di saluto da persona a persona, dovette persino schiarirsi la voce. Anche se l'altro nella sua miopia non riusciva quasi a vederlo, com'era rassicurante, dopo aver immaginato la fine del mondo, incontrare questi due occhi vivi pieni di brio. Gli sembrava di sentirsi capito soltanto dai loro colori, così come anche lui capiva i visi dei passanti sempre più numerosi in vicinanza della città, come se nel loro viso si specchiasse il suo.
© Paolo Melandri (18. 6. 2019)
*
Miracoli provvisori
Non tutti sono presi da un raptus omicida. Non tutti desiderano lo sterminio altrui né il proprio. Al più tardi il giorno in cui ogni energia sarà esaurita e i combattenti avranno raggiunto il loro obiettivo, quando il paese sarà quindi un cumulo di rovine e i suoi morti saranno ormai sepolti, solo allora verranno alla luce i veri eroi della guerra civile. Arrivano tardi. La loro entrata in scena non è mai eroica. Non dànno nell'occhio né compaiono mai in televisione.
In un laboratorio improvvisato si costruiscono protesi per i mutilati. Una donna cerca stracci da usare come fasce. Con i pneumatici di un veicolo sconquassato dai proiettili, si fanno scarpe. La prima conduttura dell'acqua viene riparata alla meglio, comincia a funzionare il primo generatore. Contrabbandieri procurano del carburante. Compare un postino. La madre che ha perso i figli appende alla porta della sua catapecchia una scritta dipinta a mano e apre un caffè, l'unico nel raggio di diverse miglia. Il vescovo raccoglie mercenari allo sbando nella rimessa accanto alla chiesa, e allestisce un'autofficina. La vita civile comincia. È inarrestabile, fino alla prossima volta.
Anche la guerra microscopica, molecolare, non dura in eterno. Una volta finite le battaglie di strada arrivano i vetrai, dopo il saccheggio, nella cabina devastata, due uomini riallacciano con le tenaglie i cavi del telefono. In cliniche sovraffollate medici in servizio d'emergenza lavorano l'intera notte per salvare la vita dei sopravvissuti.
La perseveranza di questi uomini ha del miracoloso. Sanno che non possono rimettere a posto il mondo. Soltanto un angolo, un tetto, una ferita. Sanno persino che gli assassini torneranno, poche settimane o dieci anni dopo. La guerra civile non dura in eterno, ma il pericolo che ricominci incombe continuamente.
Si è voluto fare di Sisifo un eroe esistenzialista, un outsider e ribelle di tragicità sovrannaturale, avvolto da un satanico fulgore. Forse è del tutto errato. Forse Sisifo è qualcosa di molto più importante, ossia un personaggio della vita quotidiana. I Greci interpretarono il suo nome come il comparativo di sophos, intelligente; Omero lo definisce addirittura il più intelligente di tutti gli uomini. Non era un filosofo, ma una mente astuta. Si narra che riuscì a incatenare la morte e che più nessuno morì sulla terra finché Ares, il dio della guerra, liberò la morte e la consegnò a Sisifo stesso. Ma questi raggirò la morte per la seconda volta e riuscì a tornare sulla terra. Dicono che sia diventato molto vecchio.
Più tardi, come punizione per la sua avvedutezza, fu condannato a far rotolare un pesante macigno fino alla sommità di un monte, in eterno. Questo macigno è la pace.
© Paolo Melandri (15. 6. 2019)
*
Storia di mio figlio
Sentirmi fare delle domande su mio figlio, da parte di chiunque, mi ha sempre infastidito, di punto in bianco; mi ha subito strappato dall'armonia con chi mi stava di fronte. Era ancora peggio quando in aggiunta dovevo raccontare di lui, “Racconta!”: già in questa forma di esortazione una parola per me sgradevole, e soprattutto in rapporto al proprio figlio. Una via di scampo era, tutt'al più, renderlo cattivo nella mia risposta, denigrarlo da lontano e in genere inventare storie raccapriccianti sul suo conto (che peraltro suscitavano una partecipazione ben diversa da quando, di malavoglia, riferivo la verità).
Già da piccolo, appena raccontavo qualcosa di lui a una terza persona, in sua presenza, accadeva che mi interrompesse, come se suo padre stesse commettendo un tradimento. Ancora adesso l'effetto è che, in sua assenza, costretto a parlare di lui, immagino la sua disapprovazione. Ma di norma la consegna del silenzio su quanto riguarda la vita di mio figlio, comprese le inezie (appunto queste), nasce soltanto da me. Già a suo tempo, anche senza lo sguardo di rimprovero del bambino, raccontando di lui ero quasi sempre conscio che si trattava di spiattellare qualcosa e che non stava bene.
Evito accuratamente anche di fare domande ad altri genitori sui loro discendenti, e se talvolta me ne sfugge una, per gentilezza o sbadataggine, per sbadata gentilezza?, sento subito una riluttanza verso qualsivoglia risposta, e poi mi stupisco dell'entusiasmo con cui essa sgorga, persino se le notizie sono cattive, come se alcuni padri e madri incappassero nel loro elemento linguistico solo affrontando il tema dei figli – perché altrimenti la metamorfosi del tono colloquiale in uno strombazzare?
Il rifiuto di raccontare a qualcuno di mio figlio non sembra quindi essere una legge generale. Non è forse ridicolo che io già me la prenda con chi chiede se costui chiama familiarmente per nome la persona sulla quale vuole informazioni da me?: “Cosa fa Valentino?”.
Una cosa diversa è raccontare del mio congiunto o a me affidato se nessuno mi chiede di lui. Questo mi riesce talvolta così spontaneamente, con una voce fatta quasi di più voci assieme, che mio figlio, ne sono certo, non soltanto sarebbe d'accordo, ma si sentirebbe anche convalidato. Raccontare così è dentro di me. Solo esce da me indubbiamente troppo di rado, perché o è sbagliato l'ascoltatore, o piuttosto è sbagliato il momento (esiste poi l'“ascoltatore sbagliato”?).
E qualcosa di ancora diverso è il racconto scritto. Qui, non rivolto a nessuno in particolare, senza mai un'intromissione della mia voce, non dipendente dal momento giusto – nello scrivere, che come nessun'altra attività mi dà la coscienza di avere tempo, il momento è in mio potere –, il mio raccontare mi appare come, oralmente, accade solo per un colpo di fortuna, che spesso è già privo di valore il giorno dopo. Soltanto come racconto scritto il mio raccontare è conforme alla mia natura, sulla strada giusta, al suo posto, di chiunque si tratti, anche di mio figlio.
Questa nel frattempo è diventata una convinzione, sostenuta dal fatto che per tutta la vita, ogniqualvolta ho aperto la bocca a un raccontare, tanto ne ero dominato, perché trovasse un minimo ascolto, ho stupito sgradevolmente gli altri e ho guastato loro la festa. Dov'era la battuta di spirito in ciò con cui interloquivo? Solo attraverso la forma scritta e l'essere letto le cose poi cambiarono.
2.
Quest'anno, mentre mio figlio era in viaggio nell'Europa sudorientale, quasi sempre da solo, per la prima volta non ebbi più paura di lui. Non poteva succedergli niente, e in alcuni momenti, a un pensiero del genere, mi sentivo poi di nuovo poco tranquillo.
Ma anche negli anni precedenti, proprio quando lo sapevo in pericolo, la continua paura per lui non era finalmente cessata e al suo posto non era subentrato un gradevole consenso? E poiché i pericoli, ogni volta grandi, negli ultimi tempi si erano accumulati, non ero proprio per questo diventato immune dalla mia vecchia paura per la persona a me più vicina? E: chi ero io senza la mia vecchia paura?
Quando ad esempio Valentino ebbe la gamba quasi troncata dal pedale di avviamento di una moto che passando a tutta velocità lo aveva urtato mentre faceva l'autostop alla periferia della città, e senza un soccorso istantaneo sarebbe morto lì dissanguato, tornai poi a casa dall'ospedale e da lui che giaceva là con le ossa fracassate, a notte fonda, e mi sentii ricettivo come mai ero stato per quella particolare ora notturna, in genere per il momento presente, e grato; così com'era adesso, andava bene; mi ero liberato di una parte di me, e precisamente di una parte non più produttiva. Così leggero e incrollabile, come ero allora, o impassibile?, poteva esserlo solo un adulto. Ad ogni modo quell'ora, e le altre, quasi mortali per mio figlio, che seguirono, mi fornì il parametro.
© Paolo Melandri (13. 6. 2019)
*
Zapparoni 9
Appena avevo conosciuto la scoperta di Zapparoni, subito avevo pensato ai miglioramenti. Il che è proprio del nostro tempo. Quando poi apparvero le figure opache, cominciai a sentirmi inquieto, perplesso, a irritarmene; anche questo è un segno del tempo, dove la categoria di un uomo è determinata dalla sua padronanza della tecnica, e la tecnica è diventata despota. È mortificante non capire e doversi abbandonare allo stupore come un ottentotto davanti al quale si accende un fiammifero o al cui orecchio si accosta un orologio. Veramente simili ottentotti non esistono più. Già, sin da bambino, viene abituato a ragionare.
Che cosa potevano significare i nuovi apparecchi che si mescolavano agli sciami delle api? La questione non mutava: appena si era capita una nuova tecnica già se ne ramificava e staccava l'antitesi. Nelle correnti delle api si erano inseriti individui variopinti come chicchi di porcellana in una colonna di vetro. Erano anche più rapidi, come ad esempio in una colonna di automezzi le vetture dell'ambulanza, dei pompieri, della polizia. Altri si libravano in alto, al di sopra del traffico. Dovevano avere una circonferenza maggiore; per determinarla mi mancava un punto di riferimento. Mi interessavano soprattutto gli apparecchi grigi, che volavano avanti e indietro davanti agli stabilimenti e, adesso, molto più vicino a me. Uno di loro pareva fatto di corno opaco o di quarzo fumoso. Girava in cerchio pesantemente a una moderata altezza intorno al boschetto, in modo da sfiorare quasi i gigli tigrati; ogni tanto restava immobile nell'aria. Forse era una cellula di sorveglianza o di comando. Tenni specialmente d'occhio questo apparecchio grigiofumo e cercai di comprendere se ai suoi movimenti corrispondevano o seguivano mutamenti nella massa degli automi.
Sarebbe stato difficile calcolarne le dimensioni, erano oggetti fuori dell'esperienza solita e per i quali mancava una norma. Senza esperienza non esiste dimensione. Se vedo un cavaliere, un elefante, un autobus, non importa a quale distanza, ne conosco le dimensioni. Qui invece i sensi si confondevano.
In tali casi di solito ricorriamo all'esperienza, ai raffronti. Cercai, dunque, quando il grigiofumo si muoveva nel mio campo di visione, di cogliere nello stesso momento un oggetto conosciuto che me ne desse le dimensioni. Non fu difficile; da alcuni minuti infatti il grigiofumo si librava tra me e il più vicino fosso della palude. Questi minuti, mentre io, con gli occhi fissi su di lui, lentamente spostavo il capo, ebbero un effetto specialmente soporifero. Non sapevo dire se i mutamenti che credevo di riconoscere sulla superficie dell'automa fossero reali o no. Lo vedevo trascolorare come per segnali ottici, sbiadiva e poi bruscamente si illuminava di color sangue. A poco a poco si fecero visibili due escrescenze nere, sporgenti come corna di lumache.
Intanto non dimenticavo di osservarne le dimensioni, quando il grigiofumo invertì il movimento del suo cammino e per la durata di un secondo si fermò sopra una pozza della palude. Gli sciami di automi se n'erano andati o non li vedevo più, perché ero rimasto incantato? Comunque il giardino era perfettamente silenzioso e senza ombre, come accade nei sogni.
“Una scheggia di quarzo, della grandezza di un uovo di anatra.” Arrivai a questa conclusione, confrontando il grigiofumo col fiore del giunco, che egli quasi sfiorò. I fiori del giunco li conoscevo bene fin da bambino; allora li chiamavo “puliscicilindri” e ci eravamo rovinati il vestito nell'acquitrino tentando di coglierli. Bisognava aspettare che l'acqua gelasse, ma anche allora l'avvicinarsi era pericoloso, perché rasente ai giunchi il ghiaccio era fragile e crivellato dai buchi delle anatre.
Un perfetto termine di paragone era la zanzara, che ornava la foglia della drosera come incisa in un rubino. Anche la drosera era una mia antica conoscenza. L'avevamo presa con le radici durante le nostre incursioni nelle torbiere per trapiantarla nel terrario. I botanici la chiamano “pianta carnivora”: era stata questa barbarica esagerazione che ci aveva fatto desiderare la delicata pianticella. Quando il grigiofumo, che ora si librava più in basso, sfiorando quasi l'orlo della pozza nella palude, entrava nel mio raggio visivo, potevo notare che, in verità, paragonato alle api, egli era di considerevole grandezza.
Nell'osservazione tesa e monotona si nasconde il pericolo delle allucinazioni, come sanno tutti quelli che viaggiano nella neve o sulla sabbia o hanno percorso le strade interminabili e diritte come una fettuccia. Cominciamo a sognare; e le immagini prendono il sopravvento.
“La drosera, dunque, è una pianta carnivora, un'erba cannibalesca.”
Perché mi era venuto questo pensiero? Era come se avessi veduto le foglie rosse frangiate con le ventose appiccicaticce immensamente ingrandite. Un inserviente vi gettava da mangiare.
Mi strofinai gli occhi. Una figura di sogno mi aveva ingannato in questo giardino, dove le cose minuscole diventavano grandi. Però nel medesimo tempo sentii nel mio intimo un segnale stridulo, come il campanello di una vettura che si avvicinasse.
Dovevo aver veduto qualcosa di illecito, di vergognoso, che mi aveva spaventato.
Questo era un luogo nefasto. Pieno di una grande costernazione balzai in piedi, per la prima volta da quando ero seduto, e puntai il binocolo sulla pozza della palude. Il grigiofumo si era avvicinato di nuovo; non era più librato nell'aria e mi accerchiava con le antenne sporgenti. Non badai a lui, avvinto dal quadro sul quale egli aveva guidato il mio sguardo come un cane da punta sulle pernici.
La drosera era piccola come prima. Una zanzara era già un buon pasto per lei. Però accanto a lei, nell'acqua galleggiava un osceno oggetto rosso. Lo esaminai attentamente con il binocolo. Oramai ero bene sveglio; non poteva essere un'illusione.
La pozza della palude era circondata da giunchi, in uno spazio aperto vidi lo stagno bruno e ricco di torbe. Foglie di piante acquatiche vi formavano sopra un mosaico. L'osceno oggetto rosso stava sopra una di queste foglie, vi spiccava nettamente. Lo esaminai ancora, non poteva sussistere alcun dubbio: era un orecchio umano.
Qui non era possibile alcun errore: era un orecchio mozzato. E non era nemmeno da porre in forse che io non fossi in possesso delle mie facoltà, del mio pieno giudizio. Non avevo bevuto vino e nemmeno fumato una sigaretta. Da molto tempo, già in conseguenza delle mie tasche vuote, ero vissuto nel modo più sobrio. Del resto non sono di quelli come Caretti che improvvisamente diventano allucinati.
Cominciai a scrutare la pozza nella palude sistematicamente e con raccapriccio crescente: era seminata di orecchie! Distinguevo orecchie grandi e piccole, delicate e grossolane, e tutte recise da un taglio netto. Alcune giacevano sulle foglie delle piante acquatiche come il primo orecchio, che avevo scoperto inseguendo il grigiofumo. Altre erano per metà coperte dalle foglie, e altre ancora luccicavano nell'acquitrino bruno.
A questo spettacolo mi assalì una ondata di nausea come accade a un viandante, il quale camminando lungo una spiaggia si imbatte in un fuoco di cannibali. Riconobbi la provocazione, la svergognata sfida che includeva. Conduceva a una realtà sempre più bassa. Era come se l'attività automatica, che un momento prima mi aveva ancora tenuto nel suo incanto, fosse scomparsa; non la notavo più. Mi parve possibile che fosse stata un miraggio.
Nel medesimo tempo fui sfiorato da un'aura glaciale, la vicinanza del pericolo. Sentii le ginocchia che mi si piegavano e mi lasciai ricadere nella poltrona. Forse vi si era seduto il mio predecessore prima di scomparire? Forse una di quelle orecchie gli era appartenuta? Sentii una punta di fuoco alla radice dei capelli. Ormai non era più questione di accettare o rifiutare un posto. Oramai era in gioco la testa, e se uscivo sano e salvo da quel giardino, avrei potuto parlare di fortuna.
Sul caso bisognava riflettere.
© Paolo Melandri (2. 6. 2019)
*
Indietro nel tempo
Roberto non era stupito di essere stupito. Che oramai si fosse abituato a precipitare da un'esistenza all'altra?
Il mondo aveva smesso di pestare, sbandare, oscillare; invece di mugghii e scricchiolii, alle orecchie gli giungeva il suono di flauti e violini, al cupo chiarore delle lampade a olio era subentrato uno straordinario sfavillio di luci: e tutto era successo da un momento all'altro. Lui ancora barcollava, la testa gli ronzava e lo stomaco afflitto dal mal di mare non gli dava tregua.
Questa volta si ritrovò in un'ampia sala ovale dall'alto soffitto e dalle colonne di marmo rosato. Sul parquet tirato e lucido come uno specchio, dame incipriate e splendidamente vestite, e signori con nivee parrucche, si esibivano in una danza da marionette. Sullo sfondo c'era l'orchestra e lungo le pareti erano schierati i lacchè in divisa grigio-azzurra. Nessuno gli prestava attenzione.
Solo dopo qualche tempo, all'improvviso due servitori – due spilungoni con le casacche gallonate e i pantaloni stretti al ginocchio – si precipitarono verso di lui. Lo afferrarono con una certa energia facendogli male, e stavano già per portarlo via quando una delle dame, la più giovane di tutte, avendo visto la scena, piantò in asso il suo stupefatto cavaliere e si avvicinò a Roberto. I suoi occhi nero-blu e leggermente obliqui sfavillavano.
– Cosa vi salta in mente? Non vedete che quest'uomo è malato? – investì i due servitori. – Lasciatelo andare, accompagnatelo subito nei miei appartamenti e fate venire il mio medico personale. Che si occupi immediatamente di lui!
– Molto bene. Come Vostra Altezza comanda, – sussurrarono i lacchè.
La giovane, che aveva forse diciassette anni, lanciò a Roberto uno sguardo pieno di curiosità, si voltò, diede la mano al cavaliere che l'aveva seguita, e riprese a ballare come se niente fosse.
Con una scrollatina di spalle, i due servitori condussero Roberto in un salottino elegantemente arredato e lo lasciarono solo. Lui si accomodò su uno stretto sofà, rivestito di seta a strisce bianche e gialle. Quando si fu ripreso almeno in parte dal mal di mare, tornarono a ronzargli in testa le vecchie domande: dove sono? e soprattutto quando sono? Essendo troppo esausto per cercare una risposta, le scacciò come mosche. Ma almeno qui non doveva vedersela con una lingua sconosciuta, sebbene l'italiano parlato da quelle parte gli sembrasse piuttosto legnoso.
Arrivò il medico, un brontolone ingrigito, che non indossava un camice bianco e nemmeno un vestito nero, bensì un'uniforme marrone con cordoncini d'argento, e quasi assomigliava a un portiere d'albergo. Visitò Roberto superficialmente, gli toccò la fronte, accostò l'orecchio al petto, scosse la testa e bofonchiò fra sé e sé: – Non è niente, ha solo bisogno di un po' di riposo –. E senza degnare Roberto di uno sguardo a passettini lasciò la stanza.
Potevano essere passate alcune ore – successivamente ricordò di avere fatto sogni confusi – quando, svegliato da una risatina sommessa, Roberto vide entrare la sua protettrice, seguita da un signore compassato, dall'aria arrogante, che a sua volta indossava un'uniforme, molto più sontuosa e ornata d'oro di quella del medico.
– Allora, come sta il fanciullo che ha avuto l'ardire di sorprenderci durante il ballo in maschera?
– Meglio, molto meglio, – rispose Roberto. – Grazie per avermi aiutato. Ci mancava poco che quei due zoticoni mi buttassero fuori.
– Vorrei ricordarvi che siete a corte, giovanotto, e richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che è fatto obbligo rivolgersi a Sua Altezza la Principessa d'Aosta con l'appellativo di Vostra Altezza serenissima, – si intromise l'uomo con i galloni dorati, gettando a Roberto uno sguardo di riprovazione.
“Dio mio, – pensò Roberto, – ci mancava anche una principessa in carne e ossa! E magari devo rivolgermi a lei con espressioni assurde come “Vostra Altezza si compiaccia di consentirmi”, e così via… Complicatissimo, non è mica più facile del francese o del latino. E l'altro chi sarà? Un maggiordomo? O si diceva maresciallo di corte?”
– Vostra Altezza vorrà perdonarmi, – disse sperimentando quella nuova lingua, – ma sono nuovo da queste parti e non conosco le usanze di lorsignori.
– Oh, non fa niente, – rispose la Principessa. – Qui siamo fra di noi, e quanto all'etichetta… avrai modo di impararla. Mi sei simpatico. E poi sono curiosa. Come ti chiami, e di che ceto sei? E non essere così timido, se è lecito dirlo.
– Roberto è il mio nome e… – Ma qui iniziò a balbettare perché proprio non sapeva cosa rispondere. – … e sono di ceto né troppo alto né troppo basso, credo, – disse infine.
La Principessa rise.
– Se vuoi posso darti una mano. Non dovrebbe essere difficile. Che ne pensate, caro Messeri? – disse rivolgendosi al dignitario. – Non sarebbe un buon paggio? Certo non con questa ridicola tenuta. Fate in modo che abbia vestiti decenti e procurategli un alloggio al castello. Il resto, mio piccolo Roberto, si accomoderà.
Il ciambellano non sembrò particolarmente entusiasta di questo incarico, ma non ebbe altra scelta. Fece un inchino e attraverso riecheggianti corridoi e ampie scalinate condusse Roberto in una maleodorante stanzina sottotetto, dove un omino grigio era il padrone assoluto di alcuni giganteschi armadi. Accolse Roberto con ripetuti inchini, mentre il ciambellano o maggiordomo o cos'altro era quel pallone gonfiato, prima di scomparire a mo' di commiato gli lanciò uno sguardo gelido.
Per la prova ci vollero alcune ore. Da armadi e bauli, il vecchio sarto faceva comparire un abito dopo l'altro, ma non era mai soddisfatto di come cadeva. Alla fine Roberto vide nello specchio un signore che stentava a riconoscere: indossava un gilè di broccato color vinaccia con bottoni d'argento, un fazzoletto di pizzo, calze di seta color pesca, una giacca di raso con polsini ricamati, e, da non credersi, una parrucca incipriata biondo chiara. Stava quasi per stropicciarsi gli occhi, ma preferì non farlo: ormai sapeva come poteva andare a finire.
Questi costumi fantastici esistevano solo a Hollywood o nei libri di fiabe. Oppure era finito in un tempo ancora più lontano? Gli vennero in mente i cioccolatini con il ritratto di Mozart o quell'opera che un'estate aveva visto all'aperto, nel parco di un castello. Barocco o rococò? Non che ne avesse un'idea precisa, però aveva l'impressione che questa volta fosse tornato indietro almeno due o trecento anni. A sua madre quell'ambiente sarebbe piaciuto: alla televisione non si perdeva nemmeno un matrimonio reale e sapeva tutto di tutti sulle corti europee. A Roberto invece quelle vicende non interessavano per niente.
Adesso invece, ancora intontito dalle novità, doveva farsi comandare a bacchetta da un nuovo maggiordomo meno importante al quale era stato assegnato. Era un tipo davvero grossolano che si presentava sempre con un atteggiamento tronfio, salvo poi farsi piccolo piccolo ogni volta che incontrava un superiore. Assegnò a Roberto una camera in un'ala laterale del castello e gli indicò dove, con le altre cariche della corte, al capo estremo di una lunga tavolata, poteva mangiare. La stanza era un indubbio progresso rispetto al ripostiglio del sarto, e anche i pasti, se paragonati al magro pane della moglie del pastore, erano abbondanti. Ben presto però Roberto si accorse che Venaria non era un paradiso; sin dal giorno successivo infatti iniziò l'addestramento.
– Cosa? Non sai tirare di scherma? E non sei mai stato a caccia? Un bell'impiastro! Ma almeno sai ballare? No? Probabilmente hai letto troppi libri. Di gente così non sappiamo che farcene. Per non parlare poi dell'educazione! Hai ancora molto da imparare se vuoi fare strada a corte. E non credere che la protezione della Principessa ti possa servire molto. Sappiamo come stanno le cose. Ha cercato di farsi bello, il furbetto! Aspetta che il Principe lo venga a sapere. Con Sua Altezza Serenissima c'è poco da scherzare: l'unica figlia la protegge come la pupilla dei suoi occhi. Sei proprio uno sprovveduto! E a cavallo almeno ci sai andare?
Sì, a cavallo Roberto sapeva andare. Alle lezioni con il maestro di scherma invece non si divertiva e si sentiva in imbarazzo a girare tutto il santo giorno con la spada. Anche le bevute con i suoi nuovi spocchiosi amici gli creavano qualche problema. Si accorse che puzzavano: evidentemente al castello non c'era l'abitudine di lavarsi ogni giorno e Roberto aveva chiesto invano un pezzo di sapone. Sotto i sontuosi gilè di raso, i signori portavano le camicie fino a quando non avevano i bordi neri come le loro unghie.
La cosa peggiore però era che non poteva esibire antenati. La gente parlava di continuo degli alberi genealogici e delle persone con cui era imparentata. Roberto sapeva che non poteva fare sfoggio citando sua nonna. Anche prescindendo dal fatto che non era ancora nata, si chiamava Maria Sarti e non aveva nemmeno uno straccio di titolo nobiliare. E invece non era questo che contava per quella gente. “Il mio signor padre, il barone di Capri”, “il mio illustre cugino”, “mia zia, una Sassonia-Gotha-Altenburg”: tutto il giorno con questa solfa. Solo Roberto era sempre solo Roberto. Il che era abbastanza comodo, ma alla lunga imbarazzante.
Anche il modo come parlavano gli procurava qualche grattacapo. Quando era arrivato aveva creduto che sarebbe finalmente tornato a parlare la sua lingua e questo lo aveva reso felice. Ma non era così semplice e la sua felicità era stata prematura. Ad esempio non si poteva dire “Il Principe vuole” o “Il Principe vorrebbe”. La formula giusta era: “Sua Altezza si degna di comandare”. Altre volte Roberto aveva l'impressione di studiare francese. Doveva imparare parole che non aveva mai sentito prima. Come faceva a sapere cos'era una gavotte, un'assemblée, un tesoriere, o un fidecommisso? Neanche le cose più comuni si chiamavano come era abituato a chiamarle. Un soggiorno qui era un salon, o un boudoir, a seconda dei casi, oppure anche un gabinetto o una salle de compagnie. Col tempo però si rese conto che gli bastava tenere aperte le orecchie e dopo qualche settimana le espressioni della gente del luogo gli uscivano di bocca senza problemi.
© Paolo Melandri (30. 5. 2019)
*
Alta Piana
Attraverso le ombre del fumo mi sembrò di intravedere più volte l'ombra del mostro, ma sempre troppo fuggevolmente per aver agio di colpirlo. Inoltre, nel vortice, false immagini mi trassero in errore, sicché infine mi vidi sperduto nella selva. E udii un fruscio e il pensiero m'intimorì che la fiera mi avesse aggirato per assalirmi alle spalle. Per esser sicuro da tal pericolo mi inginocchiai sul terreno, tenendo presso di me il fucile e avendo alle spalle, per difesa, un roveto.
Avviene che in simili situazioni a volte il nostro occhio si arresti sulle minime cose; ed io osservai, inginocchiandomi, una pianticella in fiore, e riconobbi il rosso “uccellino di bosco”. Mi dovevo dunque trovare là dove mi ero spinto un giorno assieme a fratello Ottone, cioè assai presso la cima del colle di Cranio di Corvo. E veramente, con un breve cammino, riuscii a raggiungere la non vasta cima, che al modo di un'isola sporgeva dall'onda di fumo.
Di qui vidi la radura presso Cranio di Corvo illuminata da pallidi riflessi di luci; ma il mio sguardo ne venne distratto verso un punto lontano nella profondità dei boschi, ove scorsi, minuscolo e costruito quasi di rossa filigrana, un castello, con i suoi pinnacoli e le rotonde torri, in fiamme; e rammentai che sulla carta di Fortunio quel punto era designato come la «Residenza meridionale». Quell'incendio mi rivelò che l'audacia del principe e di Brandimarte li aveva condotti sino alle gradinate stesse del palazzo e a colpire quivi; e come sempre, quando vediamo la prova di un'azione animosa, un sentimento di gioia mi gonfiò il petto. Ma tornandomi nella memoria la risata trionfante del Forestaro, il mio sguardo ansioso perlustrò Cranio di Corvo; e io vidi cose il cui spudorato orrore mi fece impallidire.
I fuochi che illuminavano Cranio di Corvo davano ancora riflessi e bagliori, ma similmente a una coppa argentea che sia coperta da uno strato di bianca cenere. Il riflesso ne cadeva sulla capanna dello scorticatore e per la porta spalancata, colorando di rossa luce il teschio che ghignava, fissato all'architrave. Da varie tracce, evidenti sul terreno attorno alle zone arse e nell'interno della capanna, e di cui non voglio dire, si poteva indovinare che i lemuri avevano colà tenuta una spaventosa festa, e i resti ne giacevano ancora sul luogo. Noi uomini guardiamo simili stregonerie orrende trattenendo il respiro e come a un mondo inconcepibile.
Sia sufficiente il dire che il mio occhio scoprì fra i teschi da lungo tempo scarnificati ancora altre due teste nuove, erette in cima a lunghe pertiche: quelle del principe e di Brandimarte. Dalle punte di ferro, al cui uncino erano infilate, esse fissavano i bracieri, che andavano ingrigendo nello spegnersi. Al giovane principe i capelli erano divenuti bianchi, ma i tratti del suo viso erano più nobili ancora di quella suprema bellezza che solamente il dolore educa e forma.
Le lacrime mi scesero per il viso a quello spettacolo, quelle lacrime nelle quali meravigliosamente con il dolore si confonde un moto di entusiasmo. Su di quella pallida maschera, donde la pelle pendeva a brandelli e che elevata sul palo del martirio di là considerava, a terra, il fuoco, vi era l'ombra di un sorriso di suprema dolcezza e serenità; e indovinai che in quel giorno, a ogni nuovo passo, ogni debolezza era caduta da quel nobile spirito come gli stracci da un re, che vada travestito da mendicante. Allora un brivido mi percorse: intesi come costui fosse degno dei suoi lontani antenati vincitori di mostri; egli aveva vinto, nel proprio petto, il drago che ha nome spavento. Ora finalmente fui libero da ogni dubbio: vi erano ancora tra di noi uomini nobili, e nel loro cuore viveva sempre la conoscenza dell'ordine e dei valori di cui la loro nobiltà ci era conferma. E poiché gli alti esempi ci muovono all'imitazione, io giurai, di fronte a quel capo mozzo, che in futuro, in qualsiasi istante, avrei preferito morire in solitudine tra uomini liberi piuttosto che trionfare in mezzo a un branco di servi.
I tratti del viso di Brandimarte invece erano immutati: dall'alto della sua stanga egli guardava con lieve ribrezzo e con scherno Cranio di Corvo, e l'espressione era di calma voluta, come chi sia preso da crampi dolorosi e non ne lasci apparire traccia in volto; né mi avrebbe sorpreso il vedere fisso nell'occhiaia il monocolo, che egli usava portare quando era vivo. I suoi capelli erano ancora neri e lucenti, e compresi che al momento giusto egli aveva ingoiata la pastiglia, che ogni Mauretano porta con sé. Codesta è una capsula di vetro colorato, che nel momento della minaccia più grave si pone in bocca; un morso è quindi sufficiente a rompere la capsula, nella quale è racchiuso un veleno di grande potenza. Questa è una procedura che nel linguaggio dei Mauretani si usa denominare «appello di terza istanza», in risposta al terzo grado di violenza; e la procedura risponde all'idea che quell'ordine si è formato della dignità umana. Si ritiene cioè che la dignità umana possa essere minacciata dal sopportare la bassa violenza, e ci si attende che ogni Mauretano sia pronto, a ogni ora, a rispondere all'appello mortale. Tale fu dunque l'ultima avventura di Brandimarte.
Non so quanto io sostassi colà, fissando impietrito quello spettacolo e quasi fuori dal tempo; ero caduto in una specie di sogno, pur vegliando, e avevo scordato l'incombere del pericolo. Ma in tale stato sonnambulare si procede fra i pericoli senza prudenza e tuttavia in comunione con l'intima anima delle cose. Io salii sulla radura di Cranio di Corvo, e quasi in una ebbra visione le cose mi apparvero chiare, eppure intime nel mio essere, come se conosciute e amiche già nei favolosi paesi dell'infanzia. I teschi pallidi fissati ai vecchi alberi mi guardavano interrogandomi e udivo i colpi echeggiare per la radura, il pesante ronzare del bolzone della balestra e l'acuto fischio della palla da schioppo. I colpi mi passavano così vicini da agitarmi i capelli sulle tempie, ma io ne avevo la percezione solamente al modo di una melodia che accompagnandomi segnasse il ritmo del mio passo.
Giunsi, alla luce delle fiamme residue, sino alla dimora dell'orrore e abbassai verso di me l'asta che portava la testa del principe. Con ambedue le mani la estrassi dalla punta di ferro e la deposi nella sacca di cuoio. Mentre inginocchiandomi adempivo questa cerimonia, sentii un forte colpo alla spalla. Un proiettile doveva avermi toccato, ma non provavo dolore e neppure vedevo sangue sulla mia giubba; e tuttavia il braccio destro pendeva paralizzato. Come se ridesto dal sonno, ora mi guardai attorno e mi affrettai a rientrare con il mio nobile trofeo nel bosco. Avevo dimenticato il fucile colà ov'era il rosso fiorellino, né ormai poteva più servirmi. Mi affrettai perciò a ritrovare il luogo ove avevo lasciato i combattenti.
Quivi era silenzio e le fiaccole non davano più luce. Un bagliore di rossa bragia vagava ancora fra i cespugli bruciati, e a quel barlume di luce l'occhio vedeva giacere sull'oscura terra i cadaveri dei lottatori e i cani uccisi, gli uni e gli altri mutilati e straziati spaventosamente. Belovar giaceva in mezzo ad essi, presso il tronco di una vecchia quercia, e il capo era spaccato e il sangue fluendo aveva macchiata la bianca barba. Anche la bipenne al suo fianco e il largo pugnale che la sua destra stringeva ancora saldamente erano rossi di sangue. Ai suoi piedi agonizzava il fedele molosso Leontodonte, il corpo segnato da ferite, e nel morire gli leccava la mano. Il vecchio aveva combattuto bene, attorno a lui giaceva una corona di uomini e di cani, ch'egli aveva uccisi, e così aveva trovato una morte degna di lui, nel pieno tumulto della lotta, dove rossi cacciatori perseguono per i boschi rossa selvaggina, e morte e voluttà sono profondamente confuse. Io fissai a lungo gli occhi dell'amico morto e con la mia sinistra gli posi sul petto un pugno di terra. La grande madre, di cui aveva compiute le selvagge feste ricche di sangue, è orgogliosa di simili figli.
© Paolo Melandri (28. 5. 2019)
*
Viaggio
La cosa peggiore non era il freddo, ma il vento davvero pungente. Gli sembrava di essere sotto una doccia ghiacciata. Roberto si sfregò gli occhi ma fu inutile: era proprio sveglio.
Era lì, in pieno inverno, su un'ampia strada tutta dritta e innevata che non aveva mai visto prima. O invece sì? Le donne con i fazzoletti in testa che spalavano la neve accumulandola ai margini della via, le case grigie e tutte uguali, gli uomini in uniforme con i lunghi cappotti: quelle cose le conosceva! Proprio accanto a lui c'era la vecchia con gli occhi acquosi. Di nuovo c'era solo quel tizio con il cappotto di pelle e un berretto piatto color verde oliva che se ne stava lì a gambe divaricate come un ufficiale. Il cappotto gli arrivava fino alle caviglie e in braccio reggeva una pesante scatola nera: la puntava come un'arma verso la donna che non la smetteva di brontolare. Solo quando iniziò a girare una manovella e la macchina si mise a ronzare, Roberto capì che si trattava di una vecchia cinepresa.
Sullo sfondo si vedeva una gran folla, dalle cui prime file si staccarono alcuni uomini con addosso malridotti cappotti militari. Più indietro delle donne recitavano in coro uno slogan incomprensibile: ram-tam-tàm, ram-tam-tàm. Roberto se ne stava lì, intirizzito dal freddo. Non aveva la minima idea di come fosse finito in quel posto; una cosa sola sapeva: stava succedendo qualcosa. Queste scene le aveva già viste in tivù. A prescindere da cosa volesse quella gente agitata – magari aveva fame oppure si trattava di uno sciopero – in ogni caso aveva la rabbia stampata in faccia. Dalla parte opposta nel frattempo erano arrivati due camion verde oliva che sembravano usciti da un vecchio film di guerra. Ma erano troppo sgangherati per essere degli americani. Quando l'ufficiale smise di riprendere e urlò un ordine, i soldati saltarono giù dai mezzi e bloccarono la strada imbracciando i fucili. I piedi erano avvolti in stracci di lana. Per un attimo ci fu grande silenzio. Le donne con i fazzoletti in testa abbassarono le pale. Poi da lontano si udì un rumore di cingoli: dovevano essere i carri armati.
Roberto aveva paura. Si guardò intorno, si abbassò e poi si mise a correre. Riuscì a sgusciare fra due soldati sogghignanti, a superare con un salto un mucchio di neve e si fermò senza fiato davanti all'ingresso di una casa. Scosse la porta di ferro, ma era chiusa. A sinistra, una piccola scala innevata conduceva in cantina. Inciampò, e si accorse che le scarpe gli si erano riempite di neve. Pieno di rabbia guardò intorno nella stanza buia e disadorna. L'odore di sapone e vapore raffreddato gli fece capire che doveva essere finito nella lavanderia. Di macchine lavatrici però nemmeno l'ombra. Inciampò in un mucchio di carbone. Un tubo tutto arrugginito portava a una cucina sulla quale c'erano due pentoloni. Ma la cucina era spenta. A una corda tesa erano appese delle enormi lenzuola. Ne prese tre, assicurandosi che fossero asciutte, vi si avvolse per riscaldarsi perché con la sua giacchetta di lino moriva dal freddo e infine si sdraiò su una panca di legno mezza marcia al centro del locale.
© Paolo Melandri (25. 5. 2019)
*
Giustizia
Ero seduto in mezzo al giardino. Davanti a me il viottolo coperto di ghiaia saliva tra due prati verdepallido fin dove l'erta cessava e lo steccato dipinto di verde scuro si profilava nitido sul chiaro cielo primaverile. Dove terminava il viottolo, nello steccato c'era una porticina. Nell'aria limpida e sottile le api andavano e venivano tra gli alberi rosei dei peschi in fiore. Ed ecco che in alto cigolò la porticina e per primo balzò nel giardino un cane, un levriero grande e aggraziato dalle lunghe zampe. Dietro al cane entrò, chiudendo dietro di sé la porticina, un giovane angelo biondo e snello, uno degli snelli paggi di Dio. Portava calzari a punta rialzata, al fianco gli pendeva una lunga spada e nella cintura aveva uno stiletto. Gli copriva il petto e le spalle una fine corazza d'un azzurro metallico, che brillava al sole, e petali bianchi cadevano sopra i suoi lunghi e folti capelli d'oro. Così scendeva per il viottolo, la figura esile e delicata serrata in un giustacuore color di smeraldo, le maniche rigonfie dalla spalla al gomito, di lì strette sino alle nocche delle belle mani. Camminava lentamente, con grazia, la mano sinistra giocava con l'impugnatura dello stiletto, il cane saltava nell'erba lungo la via del padrone, alzando di quando in quando lo sguardo verso di lui con amore. Ora non era più lontano di quanto getta la palla un bimbo di cinque anni.
“Mi rivolgerà la parola quando sarà qui?”.
Nel prato il bambino del giardiniere giocava coi fiori caduti. Si avvicinò traballando all'angelo e gli guardò i piedi. “Che belle scarpe hai, molto belle!” disse. “Sì,” disse l'angelo “lo credo bene, vengono dal mantello della Madonna”.
Vidi ora che le scarpe erano di drappo d'oro, intessuto di non so quali fiori o frutti rossi. “Un giorno il santo apostolo Pietro rincorreva la Madonna,” disse l'angelo al bambino “perché aveva qualcosa da dirle, e lei non lo sentì e non si fermò. E allora egli le corse dietro e nella fretta mise un piede sullo strascico del mantello e ne strappò un lembo. Così il mantello fu messo da parte e ne furono ritagliate delle scarpe per noi”. “Molto belle sono le tue scarpe!” ripetè il bambino. Quindi l'angelo riprese il suo cammino lungo il viottolo che l'avrebbe condotto davanti alla mia panchina. Un'indicibile esaltazione mi invase al pensiero che avrebbe parlato anche con me. Ché sulle parole semplici che balzavano dalle sue labbra era diffuso uno splendore, come se intanto pensasse a tutt'altro, pensasse in segreto e con giubilo represso a beatitudini del paradiso. Ed ecco che stava davanti a me. Lo salutai togliendomi il cappello e mi alzai. Quando sollevai lo sguardo l'espressione del suo viso mi spaventò. I lineamenti erano di meravigliosa finezza e bellezza, ma gli occhi azzurri avevano uno sguardo cupo, quasi minaccioso, e i capelli d'oro non avevano nulla di vivo, ma mandavano un sinistro luccichio metallico. Accanto gli stava il cane, una zampa davanti graziosamente sollevata, e mi guardava anche lui con occhi attenti.
“Sei un giusto?” chiese l'angelo severamente. Il tono era altero, quasi sprezzante. Tentai di sorridere: “Non sono cattivo. Voglio bene a molta gente. Ci sono tante belle cose”. “Sei giusto?” ripeté l'angelo. Pareva che non avesse neppure udito quel che dicevo; nelle sue parole c'era un'ombra dell'impazienza di un signore che ripete a un servo un ordine che non ha capito subito. Con la destra trasse un poco lo stiletto dal fodero. Mi feci inquieto; cercai di comprenderlo, ma non mi riuscì; il mio pensiero si spense, incapace di afferrare il senso vivo di quella parola; davanti al mio occhio interno stava una parete nuda; tentavo invano, penosamente, di raccogliere i miei pensieri. “Ho afferrato così poco della vita,” dissi finalmente “ma talvolta m'invade un grande amore e allora nulla mi è estraneo. E sicuramente allora sono giusto: ché mi sembra di comprendere tutto, come la terra esprima alberi fruscianti e come le stelle ruotino sospese nello spazio, e di tutto l'essenza più fonda, e tutti i moti degli uomini…”.
Mi arrestai sotto il suo sguardo sprezzante, schiacciato da una tale consapevolezza della mia insufficienza che mi sentii arrossire di vergogna. Lo sguardo diceva chiaramente: “Che vano, odioso chiacchierone!” Né c'era traccia di comprensione o di pietà.
Un sorriso altero increspava le labbra sottili. “Giustizia è tutto,” disse “giustizia è la prima cosa, giustizia è l'ultima. Chi non lo comprende morrà”. Così dicendo mi voltò le spalle e a passi elastici prese la via in discesa, scomparve dietro la pergola del caprifoglio, riemerse poi e infine scese per la scala di pietra; scomparendo a tratti, prima le gambe snelle fino al ginocchio, poi i fianchi, infine le spalle con la scura corazza, i capelli d'oro e il berretto color di smeraldo. Dietro di lui correva il cane, si disegnò in contorni nitidi e delicati sul primo ripiano della scala e balzò poi d'un tratto nell'invisibile.
© Paolo Melandri (23. 5. 2019) [Questo racconto è così conchiuso e terminato.]
*
Piove
L'indomani mattina, mentre mi dirigevo verso la sala dei professori, udii al secondo piano un baccano d'inferno. Accorsi e vidi che quattro ragazzi, E, G, H e T che ne picchiavano un altro, il govane F.
“Che vi salta in mente?” gridai. “Se credete di potervi picchiare come dei ragazzini delle elementari, che almeno sia uno contro uno. Ma così, quattro contro uno, è una vigliaccheria!”
Mi guardarono senza capirmi, anche F, che gli altri quattro avevano assalito. Il suo colletto era stracciato.
“Che cosa vi ha fatto?” chiesi.
Ma i quattro tacevano e la loro vittima anche. Tuttavia, a pezzettini, riuscii a sapere che F non aveva fatto loro niente; al contrario, erano gli altri che gli avevano rubato il panino, non per mangiarlo, ma solo per lasciarne senza lui. E l'avevano buttato dalla finestra nel cortile.
Mi affaccio, lo vedo sulla pietra grigia. Piove sempre e il panino luccica. Penso: forse i quattro non avevano pane ed erano furibondi che F ne avesse. Ma no, tutti avevano il loro: anzi, G ne aveva due. Chiedo:
“Perché avete fatto questo, allora?”
Non lo sanno, stanno imbarazzati davanti a me e sogghignano. Certo, l'uomo è cattivo, sta scritto pure nella Bibbia. Quando smise di piovere e le acque del diluvio si ritirarono, Dio disse: “Non punirò mai più la terra per colpa dell'uomo, poiché la natura del cuore umano è malvagia dall'infanzia.”
Dio ha mantenuto la promessa? Non lo so. E non voglio neanche sapere perché i ragazzi hanno buttato il panino nel cortile. Domando loro soltanto se non hanno mai sentito dire che dalle epoche più remote, da migliaia e migliaia di anni, dall'origine della civiltà, una legge non scritta si è imposta con un rigore sempre più imperioso, una bella legge umana: “Se vi battete, che almeno sia uno contro uno.”
Mi volgo di nuovo ai quattro e chiedo:
“Non vi vergognate?”
Non si vergognano, parlo loro una lingua sconosciuta. Mi guardano con occhi stupefatti. Soltanto la vittima sorride. Sorride di me.
“Chiudete la finestra,” dico, “altrimenti pioverà dentro.”
I ragazzi chiudono la finestra.
Che cosa diventerà, questo diavolo di generazione? Dura o solamente brutale? Non aggiungo parola, e mi dirigo verso la sala dei professori. Sul pianerottolo mi fermo e tendo l'orecchio. Che si picchino ancora? No, tutto calmo.
Sono stupefatti.
© Paolo Melandri (21. 5. 2019)
*
Afrodite 9
Sul mare si levò l'alba oscura; tutte le cose furono tinte di lilla. Il focolare fiammeggiante acceso sul faro si spense con la luna. Fuggevoli barlumi gialli apparvero nelle onde viola, come visi di sirene sotto capigliature di alghe paonazze. Di colpo si fece giorno.
La gettata era deserta, la città morta. Era la triste luce che precede i primi chiarori dell'alba, che rischiara la vetta del mondo e apporta gli snervati sogni del mattino. Non esisteva che il silenzio.
Simili a uccelli addormentati, le lunghe navi lungo le banchine lasciavano pendere i loro remi nell'acqua. La prospettiva delle strade si disegnava con linee architettoniche, che non un carro, non un cavallo, non uno schiavo turbava. Alessandria non era che una vasta solitudine, un'apparenza di antica città, abbandonata da secoli.
Un leggero rumore di passi fremette sul suolo e due fanciulle apparvero, l'una vestita di giallo, l'altra di azzurro.
Portavano entrambe la cintura delle vergini, che girava attorno ai fianchi e si congiungeva bassissimo, sotto i loro giovani ventri. Erano le cantatrici della notte e una delle suonatrici di flauto. La suonatrice era più giovane e più bella della sua amica. Pallida come il celeste del suo vestito, i suoi occhi semiperduti sotto le palpebre debolmente sorridevano. I due flauti esili pendevano dietro all'elegante nodo sulla spalla. Una duplice ghirlanda d'iris attorno alle sue gambe ondulava sotto la stoffa leggera e sulle caviglie si attaccava a due braccialetti d'argento. Ella disse:
– Mirtocleia, non rattristarti per avere perduto le nostre tavolette. Avresti dimenticato tu che l'amore di Rodide ti appartiene, o puoi pensare, cattiva che sei, che saresti stata la sola a leggere quella riga scritta dalla mia mano? Sono forse una di quelle cattive amiche che incidono sull'unghia il nome della loro sorella di letto e vanno a unirsi a un'altra quando l'unghia è spuntata del tutto? Hai bisogno di un mio ricordo quando mi hai tutta viva ed intera? Giungo ora all'età in cui le giovani si maritano e non avevo la metà dei miei anni quando ti vidi per la prima volta. Ti ricordi? fu al bagno. Le nostre madri ci tenevano sotto le braccia e ci dondolavano l'una verso l'altra. Noi abbiamo a lungo giocato sul marmo prima di rivestirci, da quel giorno non ci siamo più lasciate e cinque anni dopo ci siamo amate.
Mirtocleia rispose:
– C'è un altro primo giorno, Rodide, lo sai: il giorno in cui tu hai scritto queste tre parole sulle mie tavolette unendo i nostri nomi. Fu il primo: non lo ritroveremo più. Ma non importa: ogni giorno è nuovo per me, e quando tu verso sera ti svegli, mi sembra di non averti mai vista. Io sono persuasa che tu non sei una ragazza: sei una piccola ninfa d'Arcadia, che ha abbandonato le sue foreste perché Febo ha inaridito la sua fontana. Il tuo corpo è snello come un ramo di olivo, dolce è la tua pelle come l'acqua dell'estate, l'iris gira attorno alle tue gambe e tu porti il fiore del loto come Astarte il fiore aperto. In quale bosco popolato di immortali si è addormentata tua madre, prima della tua nascita felice? e quale Egipan indiscreto o qual dio del fiume divino si è a lei unito sull'erba? Quando noi lasceremo questo crudele sole africano, tu mi condurrai alla tua sorgente, lontano, oltre Psofide e Feneo, nelle vaste foreste piene di ombre, ove sulla terra molle si vede la duplice orma dei satiri alternata ai passi leggeri delle ninfe. Là tu cercherai una roccia liscia e inciderai sulla pietra ciò che avevi scritto sulla cera: le tue parole che sono la nostra gioia. Ascolta, ascolta Rodide! Per la cintura di Afrodite dove tutti i desideri sono ricamati, tutti i desideri mi sono estranei, perché tu sei più del mio sogno! Per le corna di Amalteia, donde scaturiscono tutti i beni del mondo, il mondo mi è indifferente, perché tu sei il solo bene che io abbia trovato! Quando ti guardo e quando tu mi vedi, non so più perché tu mi ricambi d'amore. I tuoi capelli sono biondi come le spighe di grano, i miei neri come i peli del capro; la tua pelle è bianca come il formaggio dei pastori, la mia abbronzata come la sabbia sulle spiagge; il tuo seno tenero è fiorito come l'arancio dell'autunno, il mio è magro e sterile come il pino delle rocce. Se il mio viso è abbellito, è perché ti ho amato. O Rodide, tu lo sai, la mia singolare verginità è simile alle labbra di Pan che mangino un po' di mirto; la tua è rosea e graziosa come la bocca di un bambino. Non so perché tu mi ami, ma se un giorno cessassi di amarmi, se, come tua sorella Teano, che vicino a te suona il flauto, tu restassi mai a dormire nelle case dove suoniamo, allora io non avrei neppure il desiderio di dormir sola nel nostro letto e ritornando mi troveresti strangolata con la cintura.
I lunghi occhi di Rodide si riempirono di lacrime e di sorriso, tanto l'idea era folle e crudele. Posò il piede su un paracarro.
– Mi danno fastidio i fiori tra le gambe; scioglili, Mirto adorata. Per questa notte non danzo più.
La cantatrice ebbe un sussulto.
– Oh! è vero. Li avevo già dimenticati, quegli uomini e quelle ragazze. Vi hanno fatto danzare entrambe, tu in questa veste di Coos che è trasparente come l'acqua, e tua sorella nuda, con te. Se non ti avessi difeso ti avrebbero preso come una prostituta, come hanno preso tua sorella davanti a noi, nella stessa camera… Oh! che abominio! tu sentivi le sue grida e i suoi lamenti! Come è doloroso l'amore dell'uomo!
Ella si inginocchiò vicino a Rodide e staccò le due ghirlande, poi i tre fiori posti più in alto, mettendo un bacio al posto di ognuno di essi. Quando si rialzò, la fanciulla le cinse il collo e vacillò sotto la sua bocca.
– Mirto, tu non sei gelosa, vero, di questi viziosi? Che ti importa che mi abbiano veduta? Teano basta per loro e gliela ho lasciata. Non mi avranno, Mirto mia. Non essere gelosa di loro.
– Gelosa!… ma io sono gelosa di tutto ciò che ti si avvicina. Perché i tuoi vestiti non ti abbiano essi soli, io li indosso quando tu li hai portati. Perché i fiori dei tuoi capelli non restino innamorati di te, li abbandono alle cortigiane povere che li sporchino nelle orge. Non ti ho mai dato nulla, perché nulla ti possieda; ho paura di tutto ciò che tocchi e detesto ciò che guardi. Vorrei, per tutta la vita, essere fra le mura di una prigione dove non fossimo che tu ed io, e unirmi a te così profondamente, nasconderti così nelle mie braccia che nessun occhio ti potesse scoprire. Vorrei essere i frutti che tu mangi, il profumo che ti piace, il sonno che entra sotto le tue palpebre, l'amore che contrae le tue membra. Sono gelosa della felicità che ti do; e malgrado ciò vorrei darti anche quella che mi viene da te. Ecco di che sono gelosa; ma non temo le tue amanti di una notte quando esse mi aiutano a soddisfare i tuoi desideri di bambina; quanto agli amanti so benissimo che tu non apparterrai mai a loro, e so che non puoi amare l'uomo, l'uomo intermittente e brutale.
Rodide esclamò sinceramente:
– Piuttosto andrei come Nausitoe a sacrificare la mia verginità al dio Priapo adorato a Tasos. Ma questa mattina no, mia cara. Ho danzato a lungo e sono troppo stanca; vorrei già essere a casa e dormire nelle tue braccia.
Sorrise e continuò:
– Bisognerà dire a Teano che il nostro letto non è più per lei. Gliene facciamo un altro alla destra della porta: dopo ciò che ho visto questa notte non potrei più baciarla. Mirto, è davvero una cosa orribile. È possibile amarsi così? È questo che essi chiamano amore?
– È questo.
– Si ingannano, Mirto: non sanno.
Mirtocleia la prese tra le braccia e tacquero tutte e due.
Il vento confondeva i loro capelli.
© Paolo Melandri (21. 5. 2019)
*
Eleusi
Tacquero. Erio provò un senso di vertigine, come quando incomincia il mal di mare. Desiderava che Conero parlasse ancora: troppo gravoso andava facendosi per lui il silenzio. Si sentiva nel fuoco di una lente; aveva l'impressione che i raggi convergessero sul suo diaframma. Lì qualcosa si muoveva – la pressione insistente di un animale dai molti tentacoli che si contorce nella rete.
Anche Irzio e Lunia erano pallidi. Tutto quell'agitarsi – come di folletti – in cortile, quel grattare e raschiare, quello spazzare e battere si fecero ancora più insistenti. In alto, al di sopra della nebbia, doveva esserci in volo uno stormo di uccelli, i cui gridi arrivavano fin sotto – al ritmo di lamentosi presagi, come profetiche sibille che remassero in un mare d'aria.
Poi udirono una musica. Era l'orchestra di bordo su un bastimento che passava in mezzo ai banchi di nebbia? Era una radio accesa in cucina, oppure un juke-box? Era un'allucinazione acustica? Erio non sapeva dirlo con certezza. “Sono disorientato” pensò. Il suo udito era divenuto sensibile come un intreccio di corde che rispondesse prima ancora di essere sollecitato. Si sentiva potentemente chiamato in causa, come se i suoni, per una sorta di predeterminazione, raggiungessero il punto in cui loro sedevano lì tutti insieme, attorniati dall'acqua e dalla nebbia. Era un canto da Re degli Elfi. Un moto vorticoso lo trascinò negli abissi, dove gli venne a mancare il terreno sotto i piedi. Una donna dal volto velato lo attendeva. Con un braccio teso indicava una meta oscura. Ne seguì una danza: l'elemento tenuto a freno. Ma quel bussare si era fatto più sordo, più spaventoso; l'allentarsi della presa non bastava. Non era che un tessere la tela al di sopra degli abissi.
Gemette. Sempre la stessa figura. Non ne sarebbe mai venuto a capo. Le cose cominciavano a caricarsi di energia e ad acquistare vita; sorgevano dagli oggetti, così come sempre gli erano apparsi, assumendo adesso un potere inquisitorio, anzi giudiziario. Era ancora in grado di respingerlo, ma non doveva lasciarsi coinvolgere di più: questo sentiva. Soprattutto non doveva guardare Conero. In modo analogo il bevitore, benché ormai sfiorato dal tirso, conosce il limite entro il quale le cose ancora gli appaiono con il consueto aspetto, e oltre il quale ha paura di spingersi. Ancora un bicchiere, e già varca la soglia di nuovi dominii, si sottomette a un'altra legge.
La melodia in quanto tale non era più percettibile, essendosi dilatata in vibrazioni. Dovevano esistere monadi sonore: quando il tempo si allungava, anzi si arrestava, allora era possibile coglierle. Il cane nel cortile ricominciò a guaire, in tono sommesso e funesto. Durante quell'intervallo di tempo doveva essersi prodotto un mutamento nell'atmosfera. L'ululato era lontanissimo. In esso risuonavano chiaramente la fame, le minacce, la scomparsa del mondo. Non era più una fame materiale. Irzio udì il lungo, eterno lamento, l'alito del nulla. Tese l'orecchio e pensò: «A quale distanza sarà mai? È un lupo mannaro che rovista in mezzo a un cumulo di macerie, lontanissimo». Lo colse un brivido ancora più violento. Era il lupo Ferni che levava il suo grido; la voce veniva da remote lontananze, al di là della Luna, al di là di Sirio. La Via Lattea era la schiuma lasciata dalla sua bava. La Terra vomitava le sue stesse viscere. Si rivelò una spaventosa misura, quella che anche il tempo più limitato, anche la distanza più breve celavano dentro di sé. Le cose gli arrivavano vicinissime. Sentì che si stava aprendo il sipario su una scena dove tutto era possibile. Cercò la mano di Lunia, che era posata accanto a lui sul bracciolo.
8.
Conero continuava a tenere lo sguardo fisso su Erio – l'immagine stessa della desolazione. La fisionomia era caduta come una maschera, era cancellata. Si rimaneva costernati vedendo quale brutalità potesse manifestarsi su un viso così fine, così intelligente. Lo strato roccioso irrompeva in mezzo all'humus, il magma tra i vigneti. Nel frattempo un sorriso si delineava sempre più netto sul volto di Conero. Era come una lampada, la cui luce, via via più intensa, si stesse facendo insostenibile.
Sembrava fosse passato un tempo infinito. Ma i rumori contraddicevano quest'impressione, perché fuori qualcuno ancora spazzava l'aia. Potevano essere trascorsi solo pochissimi minuti, durante i quali avevano udito alcuni accordi di musica, i richiami di uno stormo di oche selvatiche, i latrati di un cane. Non c'era stato altro, se non una pausa nella conversazione, e Conero si ricollegò – questa volta in tono interrogativo – al suo primo rilievo.
“Lei ne sa di più, non è vero?”.
Tutti si sentirono interpellati, benché la domanda fosse rivolta ad Erio. Questi ne fu colpito come da un'arma di cui avesse sempre ignorato l'esistenza. Una sensazione paragonabile soltanto allo choc, che segue a un attacco al tempo stesso violento e osceno, ma andava ancora più in profondità perché era come gli venissero strappati non solo gli abiti, ma anche lembi di pelle, di quella superficie che egli riteneva indissolubilmente, inseparabilmente unita a sé. Era esausto, dilacerato, e adesso si trovava in mezzo al guado e in balia del vuoto, dopo un incontro che aveva voluto, senza però mostrarsene all'altezza. Sedeva sprofondato nello stallo con le braccia penzoloni, come lo avessero preso all'amo.
Fuori, nel raspare e nel battere, si avvertiva adesso una nota di infinita mestizia. Anche Lunia ed Irzio coglievano questa tonalità. Lunia aveva l'impressione di essere in una grotta, molto al di sotto del terreno coltivato, in ampie sale, dove si udivano lamentosi mormorii. Gocce cadevano a larghi intervalli in vasche invisibili e destavano un suono perfettamente limpido, che riecheggiava nel cristallo di rocca. Quello era il regno delle lacrime; mai lei sarebbe risalita da un mondo così pervaso di tristezza.
Il freddo nella stanza aumentò e, con esso, la percezione delle vuote lontananze, della scomparsa dell'universo, nella quale era inclusa la propria morte, il proprio essere defunti. Avevano paura di guardarsi, perché ormai i segni della decomposizione sui loro volti non si potevano più dissimulare. Come avrebbero voluto nascondere, soffocare di parole, mascherare di smorfie ciò che in quel momento si annunciava!
E adesso era assolutamente chiaro anche quanto stava accadendo fuori. Sentivano qualcuno scavare una fossa, sentivano i becchini calare la cassa. Non potevano più né occultarlo né metterlo in dubbio. Sopraggiungeva, facendosi sempre più vicino, sempre più intimo, ciò da cui immancabilmente si fugge, anche nel caso delle persone più amate. Era il grande, l'ignominioso mistero di questo mondo, l'onta suprema. Essi vedevano arrivare quello che in moltissimi speravano e tenevano nascosto nei loro penetrali, dove la tenebra cresceva a ogni istante. Era il pungolo della carne, e a questa sola risalivano tutti gli altri generi di vergogna.
9.
A poco a poco i rumori si fecero più lievi, più ovattati. Il picchiare cessò, la scopa diede ancora gli ultimi colpi, il raschiare divenne più sommesso, più smorzato. L'aia era in ordine, la fossa scavata, il lavoro concluso. Gli operai posarono gli attrezzi.
Che sensazione di benessere! Tutto era silenzio nella torre. Ma il silenzio ormai non era vuoto, non lasciava più spazio alla grande, spaventosa lontananza. Il silenzio era delimitato, era saturo. Le candele avevano un bagliore più soffuso, più dorato. Era lo scintillio che annuncia il concludersi del giorno? O era una nuova luce? Oppure la consapevolezza che ogni fine è anche un inizio? Che senza la fine non è possibile alcun inizio? Regnava un silenzio come fuori dal mondo, in una cella scavata nella valle rocciosa di un pianeta sconosciuto. Lì ci si poteva sentire al sicuro.
Conero non aveva distolto gli occhi da Erio. Ripeté la domanda piegandosi verso di lui:
“Lei sa di più, vero?”.
E di nuovo tutti ebbero la sensazione che la domanda riguardasse anche loro. Questa volta la voce aveva un tono suadente, incoraggiante. Alla fine Erio osò guardarlo. Il sorriso continuava a essere terribile – o forse “terribile” non era la parola giusta? Si sentiva come di fronte a un grande capotribù o al capitano di una nave che abbia lasciato l'ultimo porto conosciuto. Lì vigeva ancora l'antica autorità. Era più facile dubitare di una montagna che di quello sguardo.
Tutto poteva accadere ormai. Eppure c'era qualcosa di familiare in quel sorriso ostinato, che quasi bruciava, ma senza perdita di sostanza. Erio provava sempre l'antico timore di chi si sta addentrando in una selva soggetta a divieto di caccia. A quel punto si fece strada in lui qualcosa di nuovo e, al tempo stesso, di ignoto. In questo senso si sentì come messo a parte di un segreto, di una congiura. Doveva esserci un Terzo nella stanza. Senza che lo sapesse, anche sul suo volto si delineò un sorriso, un sorriso che era un'astuta risposta.
In tutti brillava adesso la medesima gaiezza, il cui scintillio era come un riflesso di specchi. Si trasmetteva anche agli oggetti. Il viso di Irzio ricordava una maschera, infiammata dal fulgore degli scudi e delle armi sguainate. Anche Lunia sorrideva. Era arrossita e teneva la testa bassa.
Il lume cominciò a crepitare; un filo azzurro si levava dal bordo del candeliere. Erio lo osservò dapprima sorpreso, poi rapito, come se i suoi occhi possedessero una nuova forza. Forza, grazie alla quale si rivelavano i giochi di quel fumo dall'aroma di miele, che si levava su uno stelo esile per poi ramificarsi in delicate fronde. Era come se, a crearlo, fosse stata la sua immaginazione – un pallido fantasma di giglio di mare negli abissi che palpitavano appena al frangersi delle onde. Il tempo operava in quella figura – vi aveva impresso delle scanalature, l'aveva fatta girare vorticosamente e l'aveva attorcigliata, quasi fossero state messe in fretta, l'una sopra l'altra, monete immaginarie. La molteplicità dello spazio si rivelava nell'ordito delle fibre, nelle innervature che a dismisura intessevano il filo e si dispiegavano verso l'alto.
© Paolo Melandri (19. 5. 2019)
*
Nessun luogo
La traccia insidiosa con cui il tempo si allontana da noi.
Voi, predecessori, sangue nella scarpa. Sguardi senza occhi, parole senza bocca. Forme, prive di corpo. Discesi dal cielo, dispersi in seplocri lontani, resuscitati dai morti, ancora, sempre rimettendo ai nostri debitori, triste pazienza angelica.
E noi, ancora, sempre avidi del sapore di cenere delle parole. Non ancora, come dovremmo, muti.
Di' per favore, grazie.
Per favore. Grazie.
Risa antiche, di secoli. L'eco, immane, più volte spezzata. E il sospetto che nulla più verrà all'infuori di questa risonanza. Ma solo la Grandezza giustifica la mancanza contro la legge e riconcilia il colpevole con se stesso.
Uno, Kleist, colpito da questo udito troppo sensibile fugge con pretesti che non gli è concesso penetrare fino in fondo. Senza meta, in apparenza, segna la lacerata carta d'Europa con la sua traccia bizzarra. Dove io non sono, là è la felicità.
La donna, Gunderrode, confinata in quel cerchio ristretto, meditativa, perspicace, non segnata dalla caducità, risoluta a vivere per l'immortalità, a sacrificare il visibile all'invisibile.
Che si siano incontrati: vagheggiata leggenda. Winkel sul Reno, noi l'abbiamo visto. Un luogo adatto.
Giugno 1804.
Chi parla?
Nocche bianche, mani che dolgono, allora sono le mie. Allora vi riconosco e vi ordino di lasciare quello a cui vi siete aggrappate. Che cos'è. Legno, finemente arcuato, bracciolo di una poltrona. La fodera rilucente, di tinta incerta, azzurro argento. Splendente parquet a mosaico sul quale mi trovo io. Persone disseminate con naturalezza per la sala, come i sedili, in bell'ordine. Se ne intendono, bisogna ammetterlo. Non come noi in Prussia. Più sontuoso, più raffinato. Gusto, gusto. Loro lo chiamano cultura, io lusso. Mantenersi cortese e tacere, per quel po' di tempo.
Questo mese, è deciso, pensa Kleist, voglio tornare. Silenzio però. Come mi sento io non riguarda nessuno, e me meno di tutti. Una battuta di cui sarei fiero se fosse mia. Eventualmente la userò per spaventare quel povero consigliere aulico.
Lo seguo come un agnello, contraddire è un segno di malattia. In grado di viaggiare? Ma certamente, diamogliela vinta, al dottor Wedekind. Per dio e per il diavolo, io sono sano. Sano come quel matto incatenato alla rupe, Prometeo. Quello vive mille anni e anche più a lungo. Brucio dalla voglia di chiedere al dottore dov'è quell'organo che ricresce, e se non me lo tira via per far arrabbiare gli avvoltoi. Niente pesanti confidenze con il mondo degli dèi. Essere mortale, pio desiderio.
Buffonate. Delle quali questi qui, nella loro regione serena, non sanno niente. Che io non mi possa mescolare a loro. Tè con intrattenimento, diceva l'invito. La parete dietro a me, bene. Questa luminosità. Sulla sinistra la fila di finestre, ampio panorama. Un paio di case del paese in primo piano, lungo una strada in pendio. Terreno a prato con qualche albero. Poi il Reno, questo fiume indolente. E lontano, stagliata nitidamente, la catena delle colline uniformemente fluttuante. Al di sopra, ignaro azzurro, il cielo.
La signorina accanto alla finestra mi toglie la vista del paesaggio.
Sì: la giustezza assoluta della natura. La Gunderrode, ipersensibile alla luce, si protegge gli occhi con la mano, si sposta dietro la tenda. Degno è il dolore di stare a cuore agli uomini, e di esser tuo confidente, o natura! Son giorni e giorni che questo verso non mi esce dalla testa. Quel pazzo poeta. Cercare conforto in un folle – come se non sapessi cosa significa. Già penso che avrei fatto bene a restare al convitto, nella verde penombra della stanza, sopra quel lettuccio, prevenire il mal di testa, invece che venire qui da Francoforte in quella carrozza orribilmente traballante, restare silenziosa, scostante, e sciupare agli altri l'atmosfera. Mi lasciano stare ora, tollerano il mio distacco come un'estrosità, non chiedono altro se non che io estrosa mi mostri, di tanto in tanto. Invece, per finzioni e compiacenze mi manca la voglia, ora e sempre. Non provo inclinazione per nessuna delle cose che il mondo propugna. Le sue esigenze, le sue leggi e i suoi disegni, mi pare tutto quanto così insensato.
Quel peso sul petto, già dal mattino, da quel sogno che ora riaffiora. Insieme a un gruppo di persone lei camminava in una zona arida e dolce, estranea e al tempo stesso familiare, nel suo fluente abito bianco, fra Savigny e Bettina. Savigny d'improvviso portò all'altezza della guancia un arco, lo tese, prese la mira con un dardo smussato. Allora lei vide: al margine del bosco il capriolo. Il grido di spavento che si sentì sfuggire arrivò come sempre troppo tardi, il dardo lo raggiunse. Il capriolo, colpito alla gola, si abbatté al suolo. Accanto a lei Bettina, che non la perdeva d'occhio, fu la prima a rendersi conto della sciagura. Lina! esclamò con un lamento. La Gunederrode capì: lei stessa era stata ferita, al collo, non c'era bisogno di toccarselo. Lo scialle bianco di Bettina si tinse di rosso tanto che la Gunderrode non poté non stupirsi dell'intensità che hanno i colori nel sogno. Trovava così naturale morire dissanguata. Ed ecco sorgere dinanzi a loro dal terreno il tetto basso di una tenda, e sotto, chinata, una creatura pelosa, una specie di gnomo, che rimescolava una disgustosa brodaglia fumante dentro una pentola. E una mano – la sola che sapesse cosa era necessario fare – si immergeva senza timore nella brodaglia, che non scottava, ma leniva, e la cospargeva sulla ferita che lei aveva nel collo. L'incantesimo agì all'istante. Sentì la ferita rimarginarsi, scomparire. Svegliandosi si toccò quel punto: una pelle delicata, illesa. È questo che io posso avere da lui: l'ombra di un sogno. Si proibì di piangere e dimenticò il sogno e il motivo della sua tristezza.
Ora comprende: la mano era quella di Savigny.
Ma perché al collo? Non così è stabilito. Lei conosce il punto sotto il seno su cui deve appoggiare il pugnale, un chirurgo, che lei ha scherzosamente interrogato in proposito, gliel'ha indicato premendovi sopra il dito. Da allora, se si concentra, avverte quella pressione e di colpo è tranquilla. Sarà facile e sicuro, deve solo fare attenzione ad avere l'arma sempre con sé. Quel che pensiamo abbastanza a lungo e sovente non fa più nessuna paura. I pensieri si logorano come monete che passano da una mano all'altra o come immagini evocate di continuo dinanzi agli occhi della mente. In qualunque luogo lei può vedere disteso il suo cadavere, senza trasalire, anche laggiù in riva al fiume, su quella lingua di terra sotto i salici su cui sosta il suo sguardo. C'è solo da augurarsi, pensa, che a ritrovarla sia un estraneo, uno coi nervi saldi e che dimentica in fretta. Lei si conosce, conosce la gente, si aspetta di venir dimenticata. I gesti clamorosi li evita finché è possibile. Ha la sfortuna di essere appassionata e orgogliosa, quindi di essere mal giudicata. Così si tiene a freno con briglie che tagliano la carne. Può anche andare, si vive. Pericoloso diverrebbe se cedesse all'impulso di allentare le briglie, di partire, e se poi, nella corsa più sfrenata, andasse a cozzare contro quell'ostacolo che gli altri chiamano realtà e di cui lei, glielo rimprovereranno, non si fa il giusto concetto.
Che disposizione provvidenziale che i pensieri non ci passino sulla fronte quali scritte visibili. Come niente qualunque occasione di stare insieme, anche una innocua come questa, si trasformerebbe in un incontro tra assassini. Oppure impareremmo a elevarci al di sopra di noi stessi, a guardare senza odio in quegli specchi deformanti che gli altri sono per noi. E senza l'impulso a frantumare gli specchi. Ma per questo, lei lo sa bene, non siamo fatti.
© Paolo Melandri (19. 5. 2019)
*
Crepuscolo e temporale notturno
Inchiodato dai ragazzi al portone del granaio, lo sparviero si torceva orribilmente incontro alla notte che sopravveniva. Eusebio, il maggiore di quei ragazzi, fermo nell'ombra fissava l'uccello, mentre si dibatteva a morte ai chiodi di ferro che gli trafiggevano le ali. Dall'aria che si faceva buia piombò allora la femmina; con stridi laceranti tracciava come impazzita piccoli cerchi vertiginosi, si librò poi immobile con le ali distese e gli occhi di brace e all'improvviso si gettò in alto, indietro, incontro alla parete del monte, scomparendo, riapparendo, in folli voli selvaggi. I suoi stridi dovettero attirare il temporale nerissimo che, sospeso nel cielo, col bagliore soffocato dei lampi illuminava a tratti il proprio corpo, e trarlo con cerchi magici sopra il villaggio. A fatica il ragazzo riusciva a tenersi in piedi, l'orrore lo afferrò alla nuca, e non ardiva girare la pupilla. Ma quando, al guizzo silenzioso di un lampo, tutto il granaio balzò livido, e, cacciato da un colpo di vento, alla sua destra sbucò fuori da una fenditura del muro il caprimulgo barbuto, per infilzare uno scarafaggio, e alla sua sinistra passò barcollando il pipistrello, egli dovette voltarsi e fuggire giù verso il paese coi denti che gli battevano. Qui un nuovo lampo gli scoperse proprio di fronte il muro del cimitero con tutte le sue commessure abitate dalle scolopendre; sotto la luce improvvisa le croci parvero allungare le braccia e sulla tomba di un bambino morto l'anno prima si squassò il cespuglio che per fiori aveva cuori rossi, appesi a fili. Ma quando il lampo si spense e l'oscurità calò pesante come un lenzuolo, dalla finestra di dietro di una piccola casa una striscia di luce scivolò obliqua sul muro del cimitero. In quella cameretta dormiva la figlia del macellaio, la più bella ragazza del paese; e una volta uno dei ragazzi più grandi, lo sapevano tutti, in quel punto, mentre ella si spogliava, aveva potuto vedere continuamente l'ombra delle sue mammelle sulle tendine, fino a che la ragazza non aveva spento il lume.
Così Eusebio si rannicchiò sotto una tettoia tra cataste di assicelle; e il cuore gli batteva in modo differente da prima. Di fronte a lui pendeva con la testa riversa il vitellino che aveva visto condurre al macello quel pomeriggio; dal muso morbido pareva emanare ancora l'alito caldo. Qui il ragazzo in agguato non avvertiva il passare del tempo; non udiva i quarti d'ora battere quasi sopra il suo capo e rimbombare nell'aria soffocante. Non si curava dei lampi che scoprivano crudamente le campane nella loro cella; sentiva soltanto il vitello, lo riempiva la certezza che la ragazza era là dentro e poi nella sua camera si sarebbe messa a letto. Ora lei girava per l'osteria, c'erano ai tavoli due o tre che bevevano, il macellaio mesceva il vino dell'annata.
Ora si avvicinarono alla casa due figure scure; erano servitori della gente in città, che aveva le sue case di campagna intorno al paese e sulle falde dei monti; uno era in livrea con i calzoni al ginocchio, l'altro era vestito da guardaboschi. Uno di loro rimase indietro e l'altro lo precedette ed entrò nella mescita. Allora, dall'angolo buio presso una fontanella fragorosa una donna s'avanzò verso colui che era rimasto e cercò di afferrargli il braccio. La parte inferiore della sua figura era di una ampiezza informe ed Eusebio seppe subito che era la serva dell'oste della Corona, una giovane di fuori via, che lui e gli altri ragazzi guardavano di nascosto quando con il suo corpo pesante si inginocchiava a sciacquare i panni presso la gora del mulino: perché tutti loro sapevano che era incinta. Ora il servitore si scosse di torno la donna implorante, che si dovette appoggiare con una mano sull'orlo della fontana. In quel momento l'altro servitore si fece sulla soglia con la bella figlia del macellaio, e quello in livrea, voltandosi a mezzo verso la serva ferma nel buio, alzò subito la voce, dando alle sue parole un particolare tono ricercato.
“Quello era l'anno scorso” replicava forte “e ora ne corre un altro. E con ciò amen!”.
E poiché quella con un “Giuseppe, Giuseppe” che le prorompeva dalla bocca angosciosamente spalancata, cercava nuovamente di farsi vicina, quegli le gettò in faccia con parole taglienti, tali da fermarla impietrita, che una donna nel suo stato doveva vergognarsi di girare per la strada e davanti alle osterie, e che rimpiangeva il tempo perso l'anno scorso con lei, e anche ora avrebbe rimpianto ogni minuto di più, ché aveva di meglio da fare che starsene lì con lei.
Al ragazzo nel suo nascondiglio quelle parole taglienti passarono l'anima con una specie di voluttà crudele. Il modo disinvolto con cui il servitore pronunciò le sue parole e poi, fischiando tre battute, scomparve senza voltarsi nell'osteria, lo turbò non diversamente di quando lo sfioravano le vesti delle donne e delle ragazze di città; si sprigionava da esse un profumo sottile e inebriante, che lo riempiva di un sentimento contraddittorio: aspirandolo si sentiva mancare mollemente, sottomesso, e allo stesso tempo qualcosa si inalberava in lui con violenza. Questo doppio sentimento si impadronì nuovamente di lui, quasi gli si schiudesse davanti, come una porta nel buio, la segreta magnificenza della vita della gente in città e dei suoi servitori, e lo spingesse a seguire la serva che, gemendo fra sé, una mano sulla bocca, si allontanava vacillando con il viso disfatto, e a continuare a tenerle dietro furtivamente, giocando con la donna inconsapevole a un gioco crudele. Ella camminava in mezzo alla strada, immersa in una sorda disperazione; egli scivolò di fianco tra le siepi che si piegavano nella tempesta, sotto gli alberi che la tempesta squassava, lungo i granai che gemevano nelle loro impalcature. La tempesta notturna gli cacciava polvere e pula negli occhi spalancati; non vi badava: aveva perduto la coscienza della propria forma, per un minuto era piccolo come una donnola, come i rospi, come tutto quello che striscia e si acquatta sulla terra tremante, l'attimo dopo era gigantesco, si allungava fino agli alberi, ed era lui che afferrava le loro cime e le faceva piegare cigolando; era il Tremendo che sta in agguato nel buio e balza fuori ai crocicchi, ed era in lui la timidezza di un capriolo impaurito, e si sentiva correre giù per la schiena tutti i brividi da lui stesso suscitati. La donna che avanzava barcollando davanti a lui era interamente caduta in sua balia; egli era un signore di città e di quelle ne aveva parecchie; due donne le aveva rinchiuse in casa sua e ora cacciava questa a raggiungere le altre; era il macellaio che appostava una bestia fuggita per menarla a morte, ma la bestia era una bestia stregata; era quella donna là davanti a lui. Egli si rannicchiava quando il vento taceva, e balzava in avanti a ogni nuova raffica; vi era una stretta concordanza tra il respiro del vento e la sua caccia selvaggia e segreta; il vento era in lega con lui e i grandi lampi illuminavano la strada con i solchi dei carri, gettavano la loro luce sui muri bianchi delle case e tra le macchie, rischiaravano il bosco e scoprivano le radici degli alberi, e tutto per mostrargli continuamente la sua preda, se quella volesse sfuggirgli nel buio.
© Paolo Melandri (16. 5. 2019)
*
Avventura del maresciallo
In una certa epoca della mia vita il mio servizio mi obbligò a passare abbastanza regolarmente più volte la settimana a una data ora sul ponte piccolo (a quel tempo il Pont Neuf non era ancora costruito); avveniva allora che io fossi riconosciuto e salutato per lo più da artigiani ed altra gente minuta, ma in modo più regolare e appariscente da una merciaia molto graziosa, la cui bottega era distinta da un'insegna con due angeli, e che ogni qual volta in quei cinque o sei mesi ebbi a passare di lì, s'inchinava profondamente e mi seguiva con lo sguardo fin dove poteva. Il suo contegno mi colpì e cominciai anch'io a guardarla e a rispondere premurosamente al suo saluto. Un giorno, era inverno inoltrato, tornavo a cavallo da Fontainebleau a Parigi, e quando risalii di nuovo il ponte piccolo ella si fece sull'uscio della sua bottega e, mentre passavo, mi disse:
“Serva sua, signore”. Io ricambiai il saluto e, voltandomi di tanto in tanto, vidi che ella si sporgeva per seguirmi il più a lungo possibile. Avevo dietro di me un servitore e un postiglione che intendevo rimandare la sera stessa a Fontainebleau con lettere per certe dame. Per mio ordine il servitore smontò da cavallo e andò dalla giovane a dirle in mio nome che avevo notato come le fosse caro vedermi e salutarmi; se desiderava conoscermi più da vicino, io sarei andato a trovarla dove avesse voluto.
Rispose al servitore che non avrebbe potuto portarle messaggio più gradito, e che sarebbe venuta lei dove io avessi disposto.
Proseguendo a cavallo chiesi al servitore se non conoscesse qualche luogo in cui potessi incontrare la donna. Rispose che l'avrebbe condotta da una mezzana che lui sapeva; ma da quell'uomo sollecito e coscienzioso che era, questo servitore Guglielmo di Courtrai, aggiunse subito che essendosi qua e là manifestata la peste, e n'erano morti non solo gente del popolino sudicio ma anche un medico e un canonico, mi consigliava di far portare materassi, coperte e lenzuola da casa mia. Io accettai il suggerimento ed egli promise di prepararmi un buon letto. Prima di smontare, gli dissi inoltre di portare laggiù anche un buon lavamano, un flacone di essenza odorosa e un po' di dolci e di mele; provvedesse anche a che la stanza fosse ben riscaldata, ché dal freddo i piedi mi si erano gelati nelle staffe, e il cielo era carico di nuvole da neve.
La sera ci andai e trovai una bellissima donna di circa vent'anni che sedeva sul letto, mentre la mezzana, con la testa e la schiena rotonda imbacuccate in uno scialle nero, le andava parlando fitto fitto. La porta era accostata, nel caminetto grossi ceppi freschi ardevano crepitando, nessuno udì i miei passi e io rimasi un istante fermo sulla soglia. La giovane fissava tranquilla con i suoi grandi occhi la fiamma; con un gesto del capo si era come allontanata di miglia e miglia dalla vecchia ripugnante; a quel moto una parte dei suoi pesanti capelli scuri era traboccata dalla piccola cuffia da notte che portava e scendeva sopra la camicia tra la spalla e il petto, formando due o tre boccoli naturali. Portava inoltre una corta gonnella di lana verde e pantofole ai piedi. In quel momento qualche rumore dovette tradire la mia presenza; lei voltò il capo e protese verso di me un viso cui l'estrema tensione dei lineamenti avrebbe dato un'aria quasi selvaggia, senza la raggiante dedizione che prorompeva dai grandi occhi spalancati e balzava dalle labbra silenziose come una fiamma invisibile. Mi piacque in modo straordinario; in men che non si dica la vecchia era scomparsa e io accanto alla mia amica. Quando, nella prima ebbrezza del meraviglioso possesso, volli prendermi qualche licenza, ella si sottrasse a me con un'indescrivibile veemenza così dello sguardo come della voce dal timbro profondo. Ma un attimo dopo mi sentii cingere da lei stessa e avvincere, più appassionatamente ancora che dalle braccia e le labbra, dallo sguardo che prorompeva inesauribile da quegli occhi senza fondo; parve quindi volesse parlare, ma le labbra palpitanti di baci non riuscivano a comporre parole, dalla gola tremante non riusciva suono più distinto che un singhiozzo rotto e sommesso.
Ora, io avevo trascorso gran parte di quella giornata a cavallo su strade gelate, poi nell'anticamera del re avevo avuto un incidente molto spiacevole e violento, quindi, per stordire il malumore, avevo bevuto e tirato gagliardamente con lo spadone a due mani; e così nel bel mezzo di questa avventura incantevole e misteriosa, mentre giacevo allacciato da morbide braccia e sparso di chiome odorose, mi colse una stanchezza e quasi uno stordimento così improvviso e violento che non riuscivo nemmeno a ricordare come fossi capitato appunto in quella stanza, anzi per un attimo confusi con tutt'altra di tempi passati la donna il cui cuore batteva così vicino al mio, e subito dopo mi addormentai profondamente.
Quando mi ridestai, era ancora notte buia, ma sentii subito che la mia amica non era più accanto a me. Levai la testa e al chiarore fievole del fuoco che andava spegnendosi la vidi ritta presso la finestra: aveva socchiuso una delle imposte e guardava fuori dallo spiraglio. Poi si voltò, s'accorse che ero desto e gridò (la vedo ancora portare la palma sinistra alla gota e gettare dietro alle spalle i capelli che le erano caduti davanti):
“Non è ancora giorno, non è!”.
Soltanto allora vidi veramente quanto fosse grande e bella, e attendevo con impazienza il momento che con pochi passi lunghi e tranquilli dei bei piedi, che la luce rossastra lambiva, fosse di nuovo accanto a me. Ma ella si avvicinò prima al caminetto, si chinò, prese tra le braccia nude e splendenti l'ultimo grosso ceppo che ancora rimaneva e lo gettò rapidamente nel fuoco. Poi si voltò, la sua faccia sfavillava di fiamme e di gioia, passando di corsa accanto al tavolo afferrò a volo una mela e mi era già vicina, le membra ancora calde della recente carezza del fuoco, e subito dopo illanguidite e scosse di dentro da fiamme ben fiù forti, che mi abbracciava con la destra, e con la sinistra offriva alla mia bocca il fresco frutto già morso e insieme occhi guance e labbra. L'ultimo ciocco del camino ardeva più forte di tutti. Seminando faville suggeva in sé la fiamma e la faceva poi di nuovo divampare violenta, così che il riflesso del fuoco ci investiva come un'ondata che si rompeva alla parete e sollevava d'un balzo e lasciava poi ricadere le nostre ombre allacciate. Il legno robusto crepitava senza tregua e nutriva in sé fiamme sempre nuove che levavano guizzando le loro lingue e fugavano le gravi tenebre con fasci e fontane di luce rossastra. Ma a un tratto la fiamma ricadde e un soffio d'aria fredda aperse, leggero come una mano, l'imposta, rivelando un'alba livida e odiosa.
Ci levammo a sedere, sapevamo che ormai era giorno. Ma ciò che appariva là fuori non somigliava a un giorno. Non somigliava al ridestarsi del mondo. Ciò che si stendeva là fuori non pareva una strada. Non si distingueva una singola cosa: era un caos senza forma e senza colore in cui si muovevano forse larve senza tempo. Di lontano, chissà dove, come nella memoria, l'orologio di una torre batté le ore, e un'aria umida e fredda, che non era l'aria di nessun'ora del giorno, penetrò sempre più nella stanza, così che ci stringemmo l'uno all'altra rabbrividendo. Lei si piegò indietro e mi fissò in viso con tutta la forza dei suoi occhi; la sua gola tremava, qualcosa cercava di farsi strada dentro di lei e salì fino all'orlo delle labbra: ma non si fece né parola né sospiro né bacio, ma qualcosa che senza sbocciare somigliava a tutte e tre. D'attimo in attimo si faceva più chiaro e l'espressione mutevole del suo viso palpitante diventava più intensa; a un tratto voci e piedi strascicati passarono così rasente alla finestra, che lei si piegò tutta e voltò il viso verso la parete. Passavano due uomini: per un attimo il riflesso della piccola lanterna, che uno di loro portava, cadde nella stanza; l'altro spingeva una carriola, la cui ruota cigolava e gemeva. Quando furono passati, mi alzai, chiusi l'imposta e accesi un lume. C'era ancora mezza mela: la mangiammo insieme e poi le chiesi se non la potessi vedere un'altra volta, ché partivo soltanto domenica. Quella era stata però la notte tra il giovedì e il venerdì.
Lei mi rispose che lo desiderava ancor più ardentemente di me; ma se non mi trattenevo tutta la domenica le era impossibile; soltanto la notte dalla domenica al lunedì poteva rivedermi.
Mi tornarono dapprima in mente diversi impegni, così feci qualche difficoltà, che ella ascoltò senza dir nulla, ma con un'interrogazione infinitamente dolorosa negli occhi, mentre il viso le si oscurava e induriva quasi paurosamente. Naturalmente io promisi subito di rimanere la domenica e aggiunsi che mi sarei dunque ritrovato domenica sera allo stesso luogo. A queste parole mi guardò dritta in faccia e mi disse con un tono della voce ruvido e rotto:
“So benissimo che per amor tuo sono venuta in una casa infame; ma non l'ho fatto liberamente, perché volevo stare con te, perché avrei accettato a qualsiasi condizione. Ma mi parrebbe di essere l'ultima delle sgualdrine se dovessi ritornare qui una seconda volta. L'ho fatto per amor tuo, perché sei per me quello che sei, perché sei Bassompierre, perché sei l'unico al mondo che con la sua presenza mi renda rispettabile anche questa casa!”.
Disse: “casa”; e per un attimo parve che avesse sulla lingua una parola più sprezzante; e, mentre pronunciava quella parola, gettò su quelle quattro pareti, su quel letto, sulla coperta che era scivolata per terra, uno sguardo tale che sotto il fascio di luce che prorompeva dai suoi occhi, tutte quelle cose brutte e volgari parvero farsi piccine e ritirarsi tremando davanti a lei, come se per un attimo quel miserevole spazio fosse veramente divenuto più grande.
Poi con un tono indicibilmente dolce e solenne soggiunse:
“Che io possa morire di morte miserabile se all'infuori di mio marito e di te sono mai appartenuta ad altri o desideri altri nel mondo!” e, leggermente protesa in avanti, le labbra socchiuse, gonfie di vita, pareva attendere una risposta, una protesta appassionata della mia fiducia; ma non dovette leggere sul mio viso ciò che desiderava, poiché il mio sguardo teso ed ansioso si turbò, le palpebre batterono rapidamente e d'un tratto fu presso la finestra, volgendomi le spalle, la fronte schiacciata contro l'imposta, e il corpo scosso tutto da un pianto silenzioso ma così violento che le parole mi morirono in bocca e non osai toccarla. Afferrai infine una delle sue mani che pendevano come morte, e con le parole più calde che il momento mi suggerì, mi riuscì a poco a poco di calmarla, tanto che rivolgesse di nuovo verso di me la faccia inondata di lacrime, fino a che un sorriso, rompendo improvvisamente come un raggio a un tempo dagli occhi e intorno alle labbra, asciugò in un attimo tutte le tracce di pianto e allagò il viso di luce. Ed ora, riprendendo a parlare con me, incominciò il gioco più delizioso:
“Vuoi vedermi un'altra volta? ebbene, ti farò venire da mia zia!” e con questa frase si trastullò senza fine, ripetendone forse dieci volte la prima parte, ora con dolce insistenza, ora fingendo una diffidenza infantile, poi sussurrandomi la seconda all'orecchio come fosse il più grande segreto, quindi indifferente, alzando le spalle e facendo boccuccia, come se si trattasse dell'intesa più naturale del mondo, e infine ripetendola allacciata al mio collo e guardandomi in viso carezzosa e ridente. Mi descrisse minuziosamente la casa, come si descrive la via a un bambino la prima volta che deve attraversare da solo la strada per andare dal fornaio. Poi si drizzò, si fece seria e – fissando su di me tutta la forza degli occhi raggianti, con tale intensità, che avrebbero potuto, pareva, trarre a sé anche una creatura inanimata – proseguì:
“Ti aspetterò dalle dieci a mezzanotte e anche più tardi e sempre, e la porta in basso sarà aperta. Prima troverai un piccolo andito, ma non ti fermare, ci dà l'uscio della zia. Poi incontrerai una scala che ti condurrà al primo piano, e là sarò io!”. E chiudendo gli occhi, come presa da vertigine, gettò indietro la testa, spalancò le braccia e mi avvinse, e subito dopo s'era già sciolta dal mio abbraccio, e tutta chiusa nelle sue vesti, lontana e severa, e già fuori dalla stanza: era ormai giorno fatto.
© Paolo Melandri (16. 5. 2019)
*
A passi di gambero
Elsa ha aggiustato di sale. Prima della procreazione abbiamo mangiato spalla di montone con contorno di fagiolini e pere, dato il principio d'ottobre. Ha fatto, ancora a tavola a bocca piena: – Adesso andiamo a letto poi subito o prima vuoi raccontarmi com'è iniziata la nostra storia, quando dove?
Io: sono io in ogni tempo. E anche Elsa c'è stata dall'inizio. Verso la fine del Neolitico rammento il nostro primo litigio: duemila anni in cifra tonda prima che il Signore si facesse carne, allorché il crudo e il cotto si scissero in miti distinti. E se oggi, prima del montone con fagiolini e pere, si è discusso di figli, suoi e miei, con parole sempre più corte, così attaccammo briga tra le paludi, avvalendoci di un lessico neolitico, a cagione delle mie pretese su almeno tre dei suoi nove marmocchi. Ma perdetti io. Malgrado l'ardore con cui la mia lingua faceva ginnastica e allineava suoni primitivi, non fui mica capace di mettere insieme la bella parola padre; soltanto madre era possibile. In quel periodo lì Elsa si chiamava Aua.
Avevo lardellato la spalla di montone con dei mezzi spicchi d'aglio e accomodato le pere stufate nel burro tra i fagiolini verdi bolliti. Anche se, a bocca ancora piena, Elsa ha detto che poteva prender piede o funzionare al primo colpo, dal momento che lei, come le aveva consigliato il medico, aveva sbattuto le pillole nel cesso, io ho capito che il letto doveva aver ragione per il primo e la cuoca neolitica per il dopo.
Così ci siamo stesi, abbracciati aggambati come in ogni tempo. Una volta io di sopra, una volta lei. In parità di diritti, benché Elsa sostenga che il privilegio maschile della penetrazione non è certo compensato dallo scadente diritto femminile di negare l'accesso. Comunque, siccome abbiamo procreato nell'amore, i nostri sentimenti si sono talmente dilatati da riuscire a produrre in uno spazio più ampio, al di fuori del tempo e del suo tic-tac e perciò al netto di ogni terrestre giacenza, un'eterea procreazione parallela; quasi a conguaglio, il suo sentimento è penetrato a stantuffo nel mio sentimento: siamo stati bravi del doppio.
Dopo che aveva forse preso piede abbiamo fumato a letto, sotto una sola coperta, ciascuno la sua idea di sigaretta. (Io me la sono svignata, giù per le scale del tempo). Elsa ha detto: – A proposito, abbiamo finalmente bisogno di una lavastoviglie.
Prima che riuscisse a mettere in moto ulteriori speculazioni sulla distribuzione invertita dei ruoli – Mi gusterebbe una volta conoscerti incinto! – le ho raccontato di Aua e dei suoi tre seni.
Credimi, Elsa: ne aveva tre. La natura ci arriva. Sul serio: tre esemplari. Ma non li aveva lei sola. Tutte ne avevano tanti così. E se ben ricordo, nell'età della pietra si chiamavano tutte così: Aua Aua Aua. E noi ci chiamavamo Edek come un sol uomo. Intercambiabili. E anche le Aue erano uguali tra loro. Uno due tre. Di più all'inizio non sapevamo contare. No, non più in basso, non più in alto: accomodato in mezzo. Inoltre erano grandi lo stesso, tutti e tre, e collineggiavano ameni. Col tre inizia il plurale. La molteplicità, la serie, la catena, inizia il mito. Adesso però non farti mica venire i complessi. Noi ne abbiamo avuti più tardi. Dalle nostre parti, a oriente del fiume, Potrimpos, che diventò dio dei Pruzzi accanto a Pikollos e Perkunos, era famoso per i suoi tre testicoli. Sì, c'hai ragione: tre seni sono di più, o sembrano di più, sempre di più, significano sovrabbondanza, proclamano prodigalità, garantiscono sazietà in eterno, ma a guardar bene sono abnormi – comunque pur sempre pensabili.
Chiaro. Dovevi dirlo: Proiezione del desiderio maschile! Può anche darsi che anatomicamente non sia possibile. Ma a quell'epoca lì, quando i miti facevano ancora ombra, Aua ne aveva tre. Ed è vero, oggi il terzo manca spesso. Voglio dire: manca qualcosa. Beh, la terzità. Non t'incazzare subito. Figurati! Non ne farò sicuramente un culto. Naturalmente due sono abbastanza. Puoi crederlo, Elsa, in linea di principio mi bastano. Mica son tanto matto da correre dietro a una cifra. Adesso che ha funzionato di sicuro, senza pillola e grazie alla tua zuppa, adesso che sei incinta e i tuoi due peseranno presto più dei tre di Aua, io sono appagato e come senza desideri.
Il terzo è sempre stato un di più. In fondo solo un crepaccio della capricciosa natura. Inutile come l'intestino cieco. E poi mi domando, cosa significa in realtà questa senodipendenza? Questa tettomania tipicamente maschile? Quest'invocazione della superficie primordiale? D'accordo, più avanti Aua è diventata una dea e si è fatta confermare i suoi tre ciucci in idoli d'argilla grandi come una mano. Ma altre dee – per esempio la dea Kalì – avevano quattro e più braccia. Qua ci stava ancora un senso pratico. Le dee-madri greche – Demetra, Era – erano invece equipaggiate normalmente, e ciò malgrado hanno tenuto insieme la loro bottega per millenni. A dire il vero ho visto delle effigi di dèi con un terzo occhio, e pure in mezzo alla fronte. Non lo vorrei neanche regalato.
In generale il numero tre promette poi più di quanto mantenga. Coi suoi tre cosi Aua ha calcato la mano, proprio come le Amazzoni l'hanno tenuta leggera col loro unico seno. Ragion per cui le femministe di oggi cascano sempre nell'altro estremo. Adesso non mettermi subito il muso. Io sono a favore delle lib. E credimi, Elsa, due bastano davvero. Te lo conferma qualunque medico. E il nostro pupo, se non è un maschio, ne avrà certo abbastanza di due. Cosa significa qui: Aha! Insomma gli uomini ci hanno questa mania, sbavano dietro a sempre più seno. Del resto tutte le cuoche con cui ho periodato avevano solo qualcosa a destra a sinistra, come te: Mestina due, Agnese due, Amanda due, Sofia c'aveva due commoventi tazzine da caffè. E la badessa cuciniera Margherita ha asfissiato nel letto il ricco patrizio Eberardo con le sue due – peraltro immani – tette. Quindi restiamo sulla terra. Più che altro si tratta di un sogno. Non roseo, no! Non cominciare sempre a litigare. Sarà ben consentito, ancora, sognare un pochino. O no?
Semplicemente ridicola, questa gelosia di tutto e niente. Dove andremmo a finire, in che povertà ci ridurremmo senza progetti né utopia! Allora non potrei più far guizzare tre volte la linea col piombo sulla carta bianca. Allora l'arte si ridurrebbe a dire sempre sì e sissignore. Ti prego, Elsa, sii ragionevole per una volta. Facciamo che tutto questo è un'idea dalla cui contraddizione crescerà al seno femminile la dimensione mancante, qualcosa come una specie di sovrasseno. Devi concepirla dialetticamente questa cosa. Pensa alla lupa romana. A espressioni come: il seno della natura. E per quanto riguarda il numero, al dio trino e uno. Oppure ai tre desideri della fiaba. Perché preso in castagna? Io desidero proprio? Dici? Ah. Dici?
E va bene. Concesso: quando brancolo nel vuoto, intendo sempre il terzo seno. Di sicuro non capita solo a me. Ci saranno pure dei motivi, se noi uomini siamo ossessionati dal seno e come slattati troppo presto. Deve dipendere da voi. Potrebbe dipendere da voi. Perché voi date peso, troppo peso all'eventualità che vi caschino, vi caschino sempre di più. E lasciali cascare, maledizione! No. I tuoi no. Ma anche loro, garantito, col tempo. Quelli di Amanda cascavano. I seni di Lena furono cascanti anzitempo. Eppure io le ho amate, le ho amate così tanto. Mica dev'essere sempre quel po' di seno in più o in meno. Per esempio potrei trovare altrettanto bello il tuo culo, fossette comprese. E, sia chiaro, in nessun caso tripartito. Oppure qualche altra rotondità. Adesso lì, dove la tua pancia presto sfereggerà e sarà la quintessenza di tutto ciò che ha spazio. Forse ci siamo dimenticati che c'è dell'altro. Qualcosa di terzo. Anche in altri campi, anche politicamente, come possibilità.
Aua, comunque, ne aveva tre. La mia Aua trisenuta. E anche tu ne avevi uno in più, là nel Neolitico. Retropensa un pochino, Elsa: a come abbiamo cominciato.
© Paolo Melandri (12. 5. 2019)
*
Racconti da lontano
Il giovane non si accorse che toccava a lui. Fissava le piastrelle del corridoio che divideva la navata laterale da quella centrale: erano rosse ed erano bianche, con la superficie modellata ad alveoli, le rosse chiazzate di bianco, le bianche di rosso; ormai non le distingueva più, si confondevano le une nelle altre, e la traccia scura delle fughe in cemento era scomparsa, il pavimento gli galleggiava davanti come un viottolo di ghiaia ricoperto di pietruzze bianche e rosse; la pupilla percepiva il rosso, percepiva il bianco, e le linee delle fughe erano una rete sporca e indistinta poggiatavi sopra.
“Tocca a te” sussurrò una giovane donna accanto a lui, il ragazzo scosse la testa, fece appena un cenno con il pollice indicando il confessionale e la donna gli passò avanti; per un istante il profumo di lavanda si fece più intenso; poi sentì uno scalpiccio, il rumore delle scarpe che strusciavano contro il gradino di legno sul quale la donna andò a inginocchiarsi.
I peccati, pensò il ragazzo, la morte e i peccati; e il desiderio intenso, che all'improvviso provò per quella donna, gli provocò una fitta dolorosa; non l'aveva neppure vista in viso; un dolce profumo di lavanda, una voce giovane, il leggero eppure insistente crepitio dei tacchi alti mentre la donna percorreva i cinque passi che la dividevano dal confessionale: il ritmo dei tacchi insistenti ma leggeri fu soltanto un brandello dell'infinita melodia che gli risuonava notte e giorno negli orecchi. Di sera giaceva sveglio, con la finestra aperta, udiva i passi sul lastricato, i rumori sull'asfalto del viottolo: scarpe, tacchi, insistenti, leggeri, inconsapevoli: udiva voci, sussurrii, risate sotto gli alberi di castagno. Ce n'erano tante, ed erano tutte troppo belle: alcune aprivano le borsette, nel tram, alla cassa del cinema, sul bancone dei negozi, lasciavano le borsette aperte sul sedile della macchina, e lui riusciva a sbirciarne il contenuto: rossetti, fazzolettini da naso, denaro sparso, patenti stropicciate, pacchetti di sigarette, portacipria.
Gli occhi del ragazzo continuarono a tormentarsi ripercorrendo avanti e indietro il corridoio di piastrelle; era il percorso costellato di spine, infinito.
“Ora tocca a lei” gli fece una voce accanto, e lui alzò lo sguardo: non accadeva spesso che gli dessero del “lei”. Una ragazzina, le guance rosse e i capelli neri. Le sorrise e fece un cenno con il pollice. Le scarpe basse da bambina erano prive di ritmo. Mormorio alla sua destra. Che peccati confessava quando aveva la sua età? Ho rubato. Ho detto le bugie. Disubbidiente. Non ho fatto i compiti per scuola. Ho rubato: lo zucchero dalla zuccheriera, resti di dolciumi, bicchieri di vino con i fondi delle baldorie degli adulti. Mozziconi di sigaretta. Ho rubato.
“Tocca a te”. Ormai fece cenno meccanicamente. Scarpe da uomo. Mormorio d'indiscrezione di una mansueta assenza di odori.
Gli occhi gli si abbassarono nuovamente sulle screziature rosse e bianche del pavimento. Gli occhi nudi gli dolevano con la stessa intensità dei piedi che camminavano scalzi su un viottolo di ghiaia. I piedi dei miei occhi, pensò, vagano sulle loro labbra come su laghi rosati. Le mani dei miei occhi vagano sulla loro pelle.
Il peccato, la morte e l'arrogante discrezione di quel non odorare di nulla. Non c'è neppure uno che puzzi di cipolla, di arrosto o di motori, che odori di sapone, di tabacco da pipa, di fiori di tiglio o di polvere, di sudore acre delle fatiche estive, hanno tutti un odore discreto, non sanno di nulla.
Distolse lo sguardo dal corridoio, lasciò che si posasse dall'altra parte, dove si andavano a inginocchiare coloro che erano stati assolti per recitare le preghiere della penitenza. Laggiù c'era un odore di sabato, di pace, di acqua profumata del bagno, di saponetta, di pane fresco ai semi di papavero, di palle da tennis nuove, come quelle che le sue sorelle compravano di sabato con i soldi della paghetta settimanale, si sentiva anche l'odore dell'olio fine e chiaro con cui suo padre ogni domenica puliva la pistola: era nera, lucida, giaceva inutilizzata da decenni, inviolata reliquia del nonno, poco appariscente, supeflua; serviva soltanto al ricordo e ad evocare una luce sul volto di suo padre quando, con grande attenzione, la smontava e la puliva.
“Tocca a te”. Fece di nuovo il cenno. Mormorio. Mormorio in risposta. L'odore penetrante del nulla.
Da quella parte del corridoio c'era ancora odore di perdizione, di peccato, dell'appiccicosa malvagità di tutto il resto della settimana, e la domenica era il giorno peggiore: era il giorno della noia mentre in terrazza borbottava la macchina del caffè. Della noia in chiesa, nel giardino del ristorante, al club di canotaggio, al cinema o al bar, della noia nei vigneti dove si andava a controllare che l'uva crescesse a dovere – dita affusolate tastavano gli acini con lasciva competenza; della noia che non sembrava lasciare altra via d'uscita se non il peccato. Le vedeva dappertutto: la pelle verde, rossa, marrone delle borsette. Dall'altra parte della navata vide il cappotto color ruggine della donna che aveva fatto passare avanti. Ne vide il profilo, il naso delicato, la pelle bruna, la bocca scura, vide la fede al dito, i tacchi alti, strumenti fragili di una melodia mortale: li sentì andar via, un lungo, lungo incedere sull'asfalto compatto, sul lastricato irregolare: le dolci ma gravi note del peccato. La morte, pensò, il peccato mortale.
Adesso andava via davvero: richiuse la borsetta, si alzò in piedi, fece una genuflessione, si segnò, e le gambe condivisero il ritmo con le scarpe, le scarpe con i tacchi, i tacchi con le piastrelle.
Il corridoio gli sembrò un fiume che non avrebbe mai guadato: sarebbe rimasto per sempre sulla sponda del vizio. Quattro passi lo dividevano dalla voce che avrebbe potuto redimerlo o dannarlo, sei ne mancavano alla navata centrale, dove regnava il sabato, la pace, l'assoluzione – ma lui percorse solo i due passi che lo dividevano dall'uscita, dapprima lentamente, poi correndo via come da una casa in fiamme.
Richiuse le porte rivestite di cuoio, la luce e la calura gli piovvero addosso all'improvviso, accecandolo per alcuni istanti: la mano sinistra andò a sbattere contro uno stipite, il libro delle preghiere cadde a terra, il dorso della mano gli doleva forte, lui si chinò, raccolse il libro, lasciò che la porta oscillasse avanti e indietro, rimase dietro l'antiporta a stirare la pagina spiegazzata del libro di preghiere. “Il pentimento più profondo” lesse prima di richiuderlo; se lo infilò nella tasca dei pantaloni, sfregò con la mano destra il dorso dolorante della sinistra e scostò appena il battente dell'antiporta, spingendola con il ginocchio: la donna non si vedeva più, la piazza era vuota, polvere giaceva sulle foglie verdi scure dei castagni; vicino al lampione c'era il carretto bianco dei gelati, al lampione era agganciato un sacco grigio con i giornali della sera. Il gelataio era seduto sul ciglio del marciapiede a leggere il giornale, il rivenditore di giornali era appoggiato a una stanga di carro a leccare un gelato. Passò un tram vuoto: c'era soltanto un ragazzo in piedi sulla piattaforma posteriore che agitava in aria un costume verde.
Lentamente Paolo aprì l'antiporta con una spinta, discese i gradini; sudava già dopo pochi passi, l'aria era troppo afosa e la luce troppo intensa, desiderò di nuovo il buio.
C'erano giornate in cui odiava tutto tranne se stesso, ma quel giorno odiava solo se stesso e amava ogni cosa intorno a lui: le finestre aperte dei palazzi intorno alla piazza; le tendine bianche, il tintinnio delle tazzine da caffè, le risate degli uomini, il fumo bluastro del sigaro espirato da qualcuno che non riusciva a vedere; nubi dense, azzurrognole uscivano dalla finestra sopra la Cassa di Risparmio; più candida della neve fresca era la panna sulla pasta che una ragazza, affacciata alla finestra accanto alla farmacia, teneva in mano: candido era anche il resto della panna intorno alle sue labbra.
L'orologio della Cassa di Risparmio segnava le cinque e mezzo.
© Paolo Melandri (11. 5. 2019)
*
Primo viaggio
La cosa peggiore non era il freddo, ma il vento davvero pungente. Gli sembrava di essere sotto una doccia ghiacciata. Roberto si sfregò gli occhi ma fu inutile: era proprio sveglio.
Era lì, in pieno inverno, su un'ampia strada tutta dritta e innevata che non aveva mai visto prima. O invece sì? Le donne con i fazzoletti in testa che spalavano la neve accumulandola ai margini della via, le case grigie e tutte uguali, gli uomini in uniforme con i lunghi cappotti: quelle cose le conosceva! Proprio accanto a lui c'era la vecchia con gli occhi acquosi. Di nuovo c'era solo quel tizio con il cappotto di pelle e un berretto piatto color verde oliva che se ne stava lì a gambe divaricate come un ufficiale. Il cappotto gli arrivava fino alle caviglie e in braccio reggeva una pesante scatola nera: la puntava come un'arma verso la donna che non la smetteva di brontolare. Solo quando iniziò a girare una manovella e la macchina si mise a ronzare, Roberto capì che si trattava di una vecchia cinepresa.
Sullo sfondo si vedeva una gran folla, dalle cui prime file si staccarono alcuni uomini con addosso malridotti cappotti militari. Più indietro delle donne recitavano in coro uno slogan incomprensibile: ram-tam-tàm, ram-tam-tàm. Roberto se ne stava lì, intirizzito dal freddo. Non aveva la minima idea di come fosse finito in quel posto; una cosa sola sapeva: stava succedendo qualcosa. Queste scene le aveva già viste in tivù. A prescindere da cosa volesse quella gente agitata – magari aveva fame oppure si trattava di uno sciopero – in ogni caso aveva la rabbia stampata in faccia. Dalla parte opposta nel frattempo erano arrivati due camion verde oliva che sembravano usciti da un vecchio film di guerra. Ma erano troppo sgangherati per essere degli americani. Quando l'ufficiale smise di riprendere e urlò un ordine, i soldati saltarono giù dai mezzi e bloccarono la strada imbracciando i fucili. I piedi erano avvolti in stracci di lana. Per un attimo ci fu grande silenzio. Le donne con i fazzoletti in testa abbassarono le pale. Poi da lontano si udì un rumore di cingoli: dovevano essere i carri armati.
Roberto aveva paura. Si guardò intorno, si abbassò e poi si mise a correre. Riuscì a sgusciare fra due soldati sogghignanti, a superare con un salto un mucchio di neve e si fermò senza fiato davanti all'ingresso di una casa. Scosse la porta di ferro, ma era chiusa. A sinistra, una piccola scala innevata conduceva in cantina. Inciampò, e si accorse che le scarpe gli si erano riempite di neve. Pieno di rabbia guardò intorno nella stanza buia e disadorna. L'odore di sapone e vapore raffreddato gli fece capire che doveva essere finito nella lavanderia. Di macchine lavatrici però nemmeno l'ombra. Inciampò in un mucchio di carbone. Un tubo tutto arrugginito portava a una cucina sulla quale c'erano due pentoloni. Ma la cucina era spenta. A una corda tesa erano appese delle enormi lenzuola. Ne prese tre, assicurandosi che fossero asciutte, vi si avvolse per riscaldarsi perché con la sua giacchetta di lino moriva dal freddo e infine si sdraiò su una panca di legno mezza marcia al centro del locale.
© Paolo Melandri (6. 5. 2019)
*
Liscezza
Cura, sulla jeep prestata da Luzi, diretto sul far della notte dall'“Indiana” che non lo aspettava mai ma quando capitava lo serviva con aria sfottente e bonaria e a volte magari con un tono di dignità soddisfatta, aveva davanti a sé, nelle buche della strada inghiaiata lungo la riva, la serie di pozzanghere che, pur non brillando più, mandavano un profondo chiarore e sembravano in correlazione con la superficie del fiume anch'essa di un pallido chiarore. Ma anche quella distesa d'acqua, coi suoi banchi di sabbia in mezzo, non riposava più in sé, si convertiva anzi, senza linee di confine distinguibili, nelle strisce del cielo chiaro che occupavano l'orizzonte intero come un simbolo del Circolo Polare: i nastri di nuvole sottili e neri, lì dentro, potevano benissimo essere le isole agli estremi del bacino fluviale, e l'ultima luce del cielo che lassù si biforcava contro le nuvole era forse ancora il fiume che scorreva verso occidente.
Cura si era fermato e voleva fissare quell'evento dello spazio. E già non c'era più spazio, ma soltanto, là dove senza sfondo né primo piano la prospettiva infine si perdeva, un aprimento che si elevava davanti a lui possente e soave, non vuoto ma incandescentemente materico, e Cura, eccitato al sentire sulla testa e per la schiena tanto più violento il buio pesto del cielo della notte, e ai fianchi e ai piedi il nero carico della terra, tentò di impedire che quel fenomeno naturale e l'oblio di sé che generava svanissero, mentre cercava selvaggiamente di espellere col pensiero da quella immagine i particolari che la contastavano – fino a quando prospettive e punti di fuga si ristabilirono e una pietosa solitudine si fece sentire. Per un momento aveva però avvertito in sé la forza di catapultarsi come un Tutto nell'orizzonte luminoso e di fondersi per sempre nell'indistinguibilità di cielo e terra.
Era seduto sulla macchina che continuava a andare, il corpo rigido, come discosto dai comandi, e teneva il volante un tantino in alto, quasi ne fosse svincolato.
Strade senza nome scorrevano davanti a capanne senza numero. Da più di una finestra pendevano pelli di pecora come già in vista dell'inverno. I palchi d'alce sopra le porte d'entrata si ergevano candidi e smisurati nella luce dei fari. Nelle zone buie sotto le capanne, che a rialzo poggiavano su ceppi, si muovevano le ombre delle cianfrusaglie. La pista di volo lungo il margine del bosco, una striscia inghiaiata che si appuntiva nella fascia dei fari, stava lì vasta e vuota, bordata ai lati da luci rosse di segnalazione a stelo corto – e un cane dal suo buco nella terra. In quella colonia sperduta e senza strade che la collegassero alla rete continentale – non era raggiungibile neppure in barca ma solo con piccoli aerei – c'era comunque una quantità di stradine che in breve portavano alla foresta vergine fino alle paludi, dove di colpo s'interrompevano; ogni abitazione possedeva almeno un veicolo, che gli abitanti usavano anche per i più piccoli tratti, svoltando a tutta velocità tra i cespugli e schizzando dalle strade mai asciutte sleppe di fango contro gli alberi e le pareti delle capanne. In quella contrada del mondo, piatta sì, ma ogni giorno irruvidita da tutti gli oggetti, piante, animali e uomini, come ossuta e taglientemente aguzza, “l'Indiana” (così la chiamava Cura nei suoi pensieri anche quand'era con lei) gli apparve in una liscezza invitante e di una luce fredda pure, come se “la liscezza” fosse da sempre il nome che la ingioiellava.
© Paolo Melandri (5. 5. 2019)
*
Sulla morte di un forestiero
Un ragazzo, mentre cercava il pallone, trovò un uomo nei resti di un bunker; riuscì a vederlo, tra le ortiche folte, prima ancora di essere sceso completamente fino al bordo dell'acqua sul fondo del bunker. Forse si era appena fermato tra le ortiche sul pendio ripido, piegandosi un po' all'indietro per non cadere; appoggiò anche un braccio sul fianco guardando con cura la superficie scintillante dell'acqua. La sua ombra, già lunga, era immersa in quelle arcate abbandonate e molto distanti dalle ultime case; benché cercasse un pallone, il suo comportamento faceva pensare a qualcuno che ascolti attentamente, come se potesse sentire qualcosa oltre al vento. Tutto ciò mi sembra ancora così strano.
No, non sono mai stato da quelle parti, e quindi non posso descrivere com'è quel posto. Quella sera mi sono cambiato e sono andato al cinema. Mi vedo ancora seduto nell'oscurità tra la gente. A un tratto, però, comparve la luna in quel film, su un ampio paesaggio, e la sala fu inondata dal suo chiarore azzurro. In quel momento devo aver detto qualcosa tra me, perché il giovane che mi era seduto vicino si staccò dalla sua ragazza e mi guardò. La ragazza appoggiò la testa alla parete facendomi l'occhiolino e mi guardò con ciglia indolenti nella luce azzurra della luna. Poi si strofinò le labbra col dorso della mano e riavvicinò a sé, come prima, la testa del giovane. Quella sera sono stato al cinema. Ma ho dimenticato il titolo del film.
Abito qui in città presso la sorella di mio padre. Ho il vantaggio che posso, come si suole dire, andare e venire quando voglio. La vedo ogni tanto di mattina, prima di andare al lavoro o a scuola. Apro il lucchetto della bicicletta in cortile e quando mi rialzo scorgo il suo viso sonnolento dietro i vetri che l'inferriata divide in quattro parti. Poi lei apre la finestra e domanda con voce profonda: perché non dici niente? E che cosa devo dire? rispondo mentre sto già salendo sulla bicicletta e guardo in strada attraverso l'uscita. Bisognerebbe prenderti e suonartele un po', dice lei. Bisognerebbe suonartele un po' come a un bambino. È come se tu fossi morto. Io tolgo le mani dal manubrio e applaudo con le mani al di sopra della testa, come ho visto fare dagli egiziani sul campo di calcio. Lei si mette un po' a ridere, gli occhi le si allungano, poi alza lentamente il braccio. No. Non sono mai stato da quelle parti.
Il cinema in cui mi trovavo quella sera non è poi così lontano da quel posto, lo ammetto; ma bisogna pur sempre fare un pezzo di strada piuttosto lungo passando davanti ai giardini dove le case, tutte sprangate, hanno i muri illuminati dalla luce tremolante dei lampioni. Poi la strada fa una curva a destra e si dirama tra le ultime case in sentieri che portano in campagna, coperti a poco a poco da ciuffi di erba alta, fino a perdersi, al tramonto o di notte, nelle ombre dei cespugli sempre più folti; ma quando è giorno li si può vedere fino al fienile nero, che adesso è in parte nascosto dagli aceri selvatici che crescono un po' dappertutto: là dietro deve esserci il bunker. Ma io non sono mai stato in quel posto di notte o di sera, è questo che volevo dire. Perché dovrei andare in quel posto abbandonato anche quando è scuro?
Di giorno, certo, se il tempo era buono, andavo spesso da quelle parti, non ho mai detto il contrario. Mi sdraiavo sull'erba vicino alla bicicletta e guardavo il cielo, oppure avevo portato un libro o una storia western: ognuno pensi come vuole. Anche quel giorno ero là, di pomeriggio, prima di andare al cinema; alcune persone avevano aperto una giostra e un tiro a segno vicino al finile nero. Così andai da loro dopo avere nascosto la bicicletta in un cratere di bomba e restai a guardarli. Forse la donna anziana appendeva il bucato tra la roulotte e un tronco d'albero, e l'uomo se ne stava appoggiato alla giostra, con la sigaretta che gli pendeva dalle labbra: è l'immagine che mi è rimasta di quelle persone. Forse lui portava anche un panama chiaro, una camicia a scacchi un po' strappata e dei guanti di pelle; e la ragazza al banco del tiro a segno aveva i capelli sciolti sulle spalle; non dovevano però essere neri. Ehi, disse lei più o meno allargando le gambe, vuoi? Che cosa? domandai. Mi avvicinai e alzai gli occhi su di lei. Sparare, disse lei meravigliata. Rimase al banco senza muoversi; teneva le braccia conserte, lo sguardo era assente, muoveva soltanto un sandalo, su e giù, continuamente. Voi siete già stati qui l'anno scorso, dissi. È probabile, avrebbe potuto rispondere; ma tacque. Allora eravate in quattro, aggiunsi. Lo siamo ancora, mi disse, e guardò verso la roulotte: quel fagottino chiaro, laggiù nell'erba, in effetti poteva essere un bambino. Allora siete in cinque, dissi. E dopo un momento di silenzio: ma lui dov'è finito?
No, è falso. Come avrei potuto parlare con la ragazza, che non ho mai visto, e in più di cose che non potevo sapere? Come potevo immaginare che c'era un secondo uomo con loro, se non si vedeva nessun altro quando arrivai lì, quando parlai con loro e nessuno mi riconobbe? No, tutto falso, mi dispiace di avere detto cose false. Ma infine questo non è un interrogatorio, non siamo in tribunale.
Certo però che mi sembra strano, se racconto che sono rimasto da loro e che mi sono messo a sparare sui fiori del tiro a segno, o che mi sono seduto di fianco su un cavallo girando così intorno all'uomo che era addetto alla giostra, con lo sguardo sempre fisso su tutto l'impianto. Non so nemmeno perché restai tanto tempo là, forse ero annoiato e non sapevo cos'altro fare quel sabato pomeriggio prima che iniziasse il film. Ma per tutto il tempo non arrivò nessuno, tranne un paio di ragazzi e ragazze, che restarono a guardare un po' la giostra, stretti timidamente l'uno all'altro, e poi se ne andarono verso il fienile. Giornata magra, capo, dissi a quell'uomo scendendo dal cavallo. Aspetta di vedere stasera, fece lui, e battè il guanto sulla coscia. Poi sollevò il mento e mi guardò fisso.
Tranne quella volta, era sempre lo stesso: andavo in quel luogo e mi sdraiavo sull'erba guardando i confini del cielo, dove se c'era vento le cime degli alberi ondeggiavano. Nessuno mi disturbava; d'altronde nessuno avrebbe potuto disturbarmi. Quella volta però c'erano degli estranei, non avevo mai visto nessuno di loro.
© Paolo Melandri (1. 5. 2019)
*
Prima del calcio di rigore
Una mattina, presentandosi al lavoro, l'elettroinstallatore Beppe Bolchi, che era stato portiere di qualche fama, venne informato del suo licenziamento. Bolchi, almeno, interpretò come un'informazione di questo tenore il fatto che, al suo apparire sulla porta della baracca in cui sostavano gli operai, soltanto il capomastro sollevasse gli occhi dalla colazione, e abbandonò il cantiere. Per la strada alzò un braccio, ma – a parte il fatto che Bolchi non aveva alzato il braccio per chiamare un taxi – la macchina che gli passò vicino era un taxi. Alla fine sentì davanti a sé il rumore di una frenata; Bolchi si voltò; dietro a lui c'era un taxi, il taxista imprecava; Bolchi tornò a voltarsi, montò e si fece portare al mercato gastronomico.
Era una bella gornata d'ottobre. Bolchi mangiò una salsiccia calda a un chiosco, poi camminò tra i chioschi verso un cinema. Tutto ciò che vedeva gli dava fastidio; cercava di percepire il meno possibile. All'interno del cinema respirò di sollievo.
Più tardi si meravigliò che la cassiera avesse risposto con un altro gesto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, al gesto con cui, senza aprir bocca, lui aveva deposto il denaro sul piatto girevole. Accanto allo schermo notò un orologio elettrico dal quadrante illuminato. Durante il film sentì suonare una campana; per molto tempo non seppe stabilire se suonasse nel film oppure fuori, nel campanile accanto al mercato gastronomico.
Quando uscì dal cinema si comprò dell'uva, che in quella stagione era particolarmente a buon mercato. Continuò a camminare, mangiando l'uva e sputando le bucce. Il primo albergo in cui chiese una camera lo mandò via, perché aveva con sé soltanto una valigetta diplomatica; il portiere del secondo albergo, che era in un vicolo laterale, lo accompagnò personalmente in camera. Mentre ancora il portiere stava uscendo, Bolchi si stese sul letto e presto si addormentò.
Alla sera lasciò l'albergo e si ubriacò. Più tardi ritornò sobrio e cercò di chiamare al telefono degli amici; poiché spesso questi amici non abitavano nel territorio della città e il telefono non restituiva le monete, Bolchi rimase presto senza spiccioli. Un poliziotto, che salutò credendo di poterlo indurre a fermarsi, non gli restituì il saluto. Bolchi si domandò se il poliziotto non avesse erroneamente interpretato le parole che gli aveva gridato al di là della strada, e pensò alla naturalezza con cui invece la cassiera del cinema aveva girato verso di lui il piatto col biglietto d'ingresso. Era stato così stupito dalla velocità del movimento che aveva quasi dimenticato di togliere il biglietto dal piatto. Decise di andare a trovare la cassiera.
Quando arrivò al cinema le bacheche stavano oscurandosi. Bolchi scorse un uomo che, in piedi su una scala, sostituiva le lettere del film con le lettere del film dell'indomani. Attese finché poté leggere il titolo dell'altro film; poi tornò all'albergo.
Il giorno seguente era un sabato. Bolchi decise di restare all'albergo ancora un giorno. Salvo una coppia americana, era solo nella sala della colazione; per qualche tempo ascoltò la conversazione, che, siccome in passato si era recato qualche volta a New York con la squadra per un torneo, riusciva a capire, discretamente; poi uscì in fretta, per comprare un paio di giornali. I giornali, trattandosi di edizioni di fine settimana, erano quel giorno particolarmente pesanti; Bolchi non li piegò, ma li portò in albergo tenendoli sotto il braccio. Tornò a sedersi al tavolo della colazione, che era già stato sparecchiato, e tolse dai giornali i supplementi con le inserzioni; ciò lo depresse. Fuori vide due persone camminare con grossi giornali. Trattenne il respiro finché furono passate. Soltanto allora si accorse che si era trattato dei due americani; siccome prima li aveva visti soltanto nella sala della colazione, seduti a un tavolo, all'aperto non li aveva conosciuti.
© Paolo Melandri (1. 5. 2019)
*
La donna mancina
Aveva trent'anni e viveva in un quartiere residenziale di bungalow che terrazzava il pendio meridionale di un monte non alto, giusto al di sopra dei fumi di una grande città. Aveva i capelli castani e degli occhi grigi che anche quando non guardava nessuno talvolta si riempivano di luce, senza che per questo il suo viso avesse a mutare. In un tardo pomeriggio d'inverno era seduta nella luce gialla che veniva da fuori, davanti alla finestra del vasto soggiorno, alla macchina da cucire elettrica, con accanto il figlio di otto anni, che faceva un tema per la scuola. Una delle due pareti lunghe dell'ambiente era costituita da un'unica vetrata di là della quale c'era una terrazza tenuta a prato, un albero di Natale gettato via e il muro senza finestre della casa attigua. Il bambino, seduto a un tavolo di legno scuro, era curvo sul quaderno e faceva scricchiolare il pennino e sporgeva la lingua lambendosi le labbra. Di tanto in tanto si fermava, guardava fuori della vetrata per riprendere con maggior zelo; oppure lanciava un'occhiata alla madre che, sebbene guardasse altrove, se ne accorgeva e la ricambiava. La donna era sposata col direttore vendite della filiale locale di una ditta di pocellane nota in tutta Europa, e quella sera egli sarebbe tornato da un viaggio d'affari in Scandinavia, durato varie settimane. La famiglia non era ricca, ma viveva agiatamente, senza dover pensare al denaro; il bungalow l'avevano in affitto, poiché l'uomo poteva essere trasferito da un momento all'altro.
Il bambino aveva finito di scrivere e si mise a leggere forte. «“Qual è la mia idea di una vita più bella”. Vorrei che non fosse né freddo né caldo. Deve soffiare sempre un vento tiepido, ogni tanto un temporale, che ci si debba rintanare. Le automobili scompaiono. Le case sarebbero rosse. I cespugli sarebbero d'oro. Si saprebbe già tutto e non ci serebbe più bisogno di studiare. Si vivrebbe su isole. Per la strada le automobili sono tutte aperte e ci si può andar dentro quando si è stanchi. Ma non si è mai stanchi. Le automobili non sono di nessuno. La sera si rimane sempre alzati. Ci si addormenta dove ci si trova. Non piove mai. Degli amici ce n'è sempre quattro alla volta e la gente che non si conosce scompare. Tutto quello che non si conosce, scompare».
La donna si alzò e andò a guardare fuori della stretta finestra obliqua davanti alla quale sorgevano lontani e immobili alcuni abeti. Ai piedi degli alberi c'erano diverse file di box per auto tutti uguali, rettangolari, a tetto piatto come i bungalow, con davanti la loro strada d'accesso dove, sul marciapiede sgombro di neve, un bambino stava trascinando una slitta. Giù in fondo, dietro gli alberi, sul bassopiano, si vedevano le propaggini residenziali della grande città, e un aereo si levava in quel momento dalla pianura. Il bambino si accostò e chiese alla donna che era lì assorta, ma non irrigidita, anzi con un che di arrendevole, che cosa stesse guardando. La donna non udì, non batté ciglio. Il bambino la scosse e gridò: “Svegliati!”. La donna tornò in sé e mise una mano sulla spalla al bambino. Allora anche lui guardò fuori, sprofondò anche lui in contemplazione, con la bocca che gli si apriva. Dopo un po' si riscosse e disse: “Adesso mi sono perso io pure a guardare, come te!”. Entrambi scoppiarono a ridere e non riuscivano a smettere; quando si quietarono, uno dei due ricominciò e l'altro fece coro. Alla fine a forza di ridere si abbracciarono e rotolarono a terra.
Il bambino chiese se adesso poteva accendere la televisione. La donna rispose: “Ma dobbiamo andare a prendere Bruno all'aeroporto”. Lui però aveva già acceso l'apparecchio e ci si era seduto davanti. La donna si curvò su di lui e disse: “Come faccio a spiegare a tuo padre che è all'estero da settimane, che tu…”. Il bambino davanti alla televisione non udiva già più. La donna alzò la voce; fece imbuto con le mani come se fossero state un altoparlante; ma lui fisso all'apparecchio. Lei gli agitò una mano davanti agli occhi, al che il bambino inclinò la testa da un lato e continuò a guardare con la bocca spalancata.
La donna era fuori, sullo spiazzo di un box, la pelliccia aperta, con l'oscurità che calava, e le pozze di neve che cominciavano a gelare. Il marciapiede era cosparso di aghi di pino degli alberi di Natale gettati via. Aprendo la porta del box, levò gli occhi verso il quartiere residenziale; in alcuni bungalow che stavano ammonticchiati come scatole avevano già acceso le luci. Dietro il quartiere cominciava un bosco, misto per lo più di querce, faggi e abeti, che saliva dolcemente verso la cima di una delle colline, senza un villaggio, senza nemmeno una casa. Il bambino apparve alla finestra della loro “unità di abitazione” (come il marito chiamava il bungalow) e agitò un braccio.
All'aeroporto non era ancora buio del tutto; prima di entrare nella hall dei voli internazionali, in cielo, sopra i pennoni delle bandiere e le bandiere trasparenti, la donna vide delle chiazze chiare. Era in mezzo agli altri e aspettava; il suo volto era colmo di attesa, ma non tirato; aperto eppure come tutto per sé. Comunicarono che l'aereo da Helsinki era atterrato e dagli sbarramenti della dogana presero ad affluire i passeggeri, e fra loro Bruno, con in mano la valigia e il sacchetto di un duty-free-shop, il volto irrigidito dalla stanchezza. Egli era poco più anziano di lei e portava sempre un abito grigio gessato a doppio petto e la camicia aperta. I suoi occhi erano così scuri che era difficile distinguere le pupille; poteva fissare a lungo le persone senza che queste si sentissero esaminate. Da bambino era stato sonnambulo; ma anche da adulto accadeva spesso che parlasse in sogno.
In piena hall, davanti a tutti, abbandonò la testa sulla spalla della moglie, come se dovesse riposare proprio lì, in quel pelo. Lei gli tolse di mano valigia e sacchetto e così lui poté abbracciarla. Rimasero a lungo in quel modo; Bruno sapeva leggermente di alcool.
Nell'ascensore che conduceva al garage sotterraneo egli si mise a fissarla, e anche lei lo guardava.
Salì per prima in automobile e gli aprì l'altra portiera. Ma lui rimase ancora un poco là in piedi con lo sguardo nel vuoto. Finché non si diede una manata alla fronte; poi si tappò il naso con le dita e si fece uscire l'aria dalle orecchie, come se fossero ancora tappate per il lungo volo.
Mentre la macchina correva in direzione della cittadina sul pendio delle colline, dove si trovava il quartiere dei bungalow, la donna chiese, con la mano sulla autoradio: “Vuoi un po' di musica?”. Egli scosse il capo. Intanto si era fatta notte e negli uffici dei grattacieli, lungo la strada, le luci erano quasi tutte spente, mentre i quartieri residenziali sui pendii circostanti facevano un gran scintillio.
© Paolo Melandri (28. 4. 2019)
*
Afrodite 8
Bocconi con i gomiti in avanti, le gambe aperte e la guancia sulla mano, ella trapungeva con piccoli fori simmetrici un guanciale di lino verde, con una lunga spilla d'oro.
Da che si era svegliata, due ore dopo il mezzogiorno e tutta stanca per aver troppo dormito, era rimasta sola sul letto in disordine, coperta soltanto da una parte da una vasta ondata di capelli.
Questa capigliatura era rifluente e profonda, soave come una pelliccia, più lunga di un'ala, morbida, folta, animata, piena di calore; copriva metà del dorso, dilagava sotto il ventre nudo, brillava ancora vicino al ginocchio in anelli spessi e rotondi. La giovane donna era avvolta in questo velo prezioso, i cui riflessi erano quasi metallici e l'avevano fatta chiamare Criside dalle cortigiane di Alessandria. Non erano i capelli lisci delle Siriache della corte, né i capelli tinti delle Asiatiche, né i capelli bruni e neri delle figlie d'Egitto. Erano quelli delle figlie di Efeso e di Cesarea, delle Galilee, al di là delle sabbie.
Criside: questo nome le piaceva. I giovani che venivano a vederla la chiamavano aurea come Afrodite, nei versi che scrivevano sulla sua porta, con ghirlande di rose, il mattino. Ella non credeva ad Afrodite, ma le piaceva che la si comparasse alla dea; e qualche volta andava al tempio per portarle, come ad un'amica, scatole di profumi e veli azzurri.
Era nata sulle sponde del lago di Genezareth, in un paese di ombra e di sole, invaso dagli oleandri. Sua madre, alla sera, andava sulla strada di Gerusalemme ad attendere i mercanti, e si dava loro fra le erbe, in mezzo al silenzio campestre. Era una donna molto amata nella Galilea; i preti non abbandonavano la sua porta perché ella era caritatevole e pietosa; gli agnelli e le pecorelle del sacrificio erano sempre pagati da lei; la benedizione dell'Eterno si stendeva sulla sua casa. Orbene, quando divenne incinta, poiché la sua gravidanza era uno scandalo (giacché non aveva marito), un uomo, celebre per avere il dono della profezia, disse che ella avrebbe messo alla luce una figlia che avrebbe portato attorno al suo collo “la ricchezza e la fede di un popolo”. Non comprese bene come ciò sarebbe avvenuto ma chiamò la bambina Sarah, cioè principessa in ebraico; ciò fece tacere le maldicenze.
Criside aveva sempre ignorato ciò perché l'indovino aveva detto a sua madre quanto fosse pericoloso rivelare alle persone le profezie di cui si è l'oggetto. Ella nulla sapeva del suo avvenire, per questo vi pensava di frequente.
Della sua infanzia ricordava poco e non le piaceva parlarne. Il solo sentimento preciso che gliene fosse restato, era lo spavento e la noia che le causavano ogni giorno la sorveglianza ansiosa di sua madre che, venuta l'ora di uscire in strada, la chiudeva sola nella camera per ore interminabili. Ricordava anche la finestra rotonda per dove scorgeva le acque del lago, i campi azzurrognoli, il cielo trasparente, l'aria leggera del paese di Gâlil. La casa era circondata di lini rosei e di tamarindi. Capperi spinosi innalzavano a caso le loro teste verdi sulla nebbia fine delle gramigne.
Le giovinette si bagnavano in un ruscello limpido dove si trovavano conchiglie rosse sotto i ciuffi di oleandri in fiore: c'erano fiori sull'acqua e fiori in tutta la pianura e grandi gigli sulle montagne.
Aveva dodici anni quando scappò per seguire una compagnia di giovani cavalieri che andavano a Tiro come venditori di avorio e che lei fermò davanti a una cisterna: stavano adornando cavalli dalla lunga coda con pennacchi variopinti. Si ricordava bene come essi l'avevano sollevata, pallida di gioia, sulle loro selle, e come si fermarono una seconda volta, durante la notte, una notte così chiara che non si vedeva neppure una stella.
E neppure aveva dimenticato l'entrata a Tiro: in testa, sopra i cesti di un cavallo da soma si teneva col pugno alla criniera, lasciando orgogliosamente spenzolare i suoi polpacci nudi, per mostrare alle donne della città che lungo le gambe ella aveva del sangue. La stessa sera partì per l'Egitto: seguì i venditori d'avorio fino ad Alessandria.
E là, in una piccola casa bianca con terrazzo e colonnine, essi la lasciarono due mesi dopo, con il suo specchio di bronzo, con tappeti, cuscini nuovi, e una bella schiava indiana che sapeva pettinare le cortigiane.
Altri erano venuti alla sera della loro partenza e altri il domani.
Poiché ella abitava il quartiere dell'estremo levante che i giovani greci di Bruchion sdegnavano frequentare, per lungo tempo, come sua madre, non conobbe che viaggiatori e mercanti. Non rivedeva più i suoi amanti passeggeri, sapeva trarre da loro il piacere, ma lasciarli presto prima di amarli. Si erano visti padroni di carovane vendere a vil prezzo le loro mercanzie per rimanere dove era lei, e rovinarsi in qualche notte. Con la fortuna di questi uomini si era comprata gioielli, guanciali, profumi rari, vestiti a fiori, e quattro schiave.
Era arrivata a comprendere molte lingue straniere, e conosceva i racconti di molti paesi.
Gli Assiri le avevano detto gli amori di Douzi e di Ischtar; i Fenici quelli di Aschthoreth e di Adôni; le ragazze greche delle isole le avevano raccontato la leggenda di Iftide insegnandole strane carezze che a tutta prima l'avevano sorpresa, ma in seguito deliziata a tal segno che ella non poteva starne senza un solo giorno. Sapeva anche gli amori di Atalanta e come, sul loro esempio, suonatrici di flauto ancora vergini sfiniscano i più robusti uomini.
Infine la sua schiava indiana pazientemente, in sette anni, le aveva insegnato fino agli ultimi particolari l'arte complessa e voluttuosa delle cortigiane di Palibotra.
Poiché l'amore è un'arte, come la musica, dà emozioni dello stesso ordine, altrettanto delicate, altrettanto vibranti, qualche volta persino più intense, Criside, che ne conosceva i ritmi e tutte le sottigliezze, si stimava, con ragione, artista più grande di Plango stessa, che pure era musicista del tempio.
Sette anni ella visse così, senza sognare una vita più felice, né più intensa della sua. Ma poco prima del suo ventesimo anno, quando da fanciulla divenne donna, e vide sotto i seni la prima piega deliziosa della maturità che sta per nascere, le vennero d'improvviso delle ambizioni.
E una mattina, poiché si risvegliò due ore dopo il mezzogiorno, tutta stanca per aver troppo dormito, si voltò bocconi attraverso il letto, divaricò le gambe, mise la guancia sulla mano e con una lunga spilla d'oro trafisse con piccoli fori simmetrici il suo guanciale di lino verde.
E rifletteva profondamente.
Furono a tutta prima quattro piccoli punti che formavano un quadrato e un punto nel mezzo, poi quattro altri punti per fare un quadrato più grande, poi tentò di fare un cerchio… ma era un po' difficile. Allora ella gettò le punture a caso e cominciò a gridare:
– Djala! Djala!
Djala era la sua schiava indiana che si chiamava Djalantachtchandratchapalâ, ciò che significa: “Mobile come l'immagine della luna sopra l'acqua”. Criside era troppo pigra per dire il nome tutto intero.
La schiava entrò e rimase vicino alla porta, senza chiuderla del tutto.
– Djala, chi è venuto ieri?
– Non lo sai?
– No, non l'ho guardato. Era bello? Credo di aver dormito tutto il tempo, ero stanca, non mi ricordo più nulla. A che ora è partito? Questa mattina per tempo?
– Al levar del sole, ha detto…
– Che cosa ha lasciato? Molto? No, non dirmelo, mi è indifferente. Che cosa ha detto? Nessuno è venuto da me da che se ne è andato? Ritornerà? Dammi i braccialetti.
La schiava portò un cofano, ma Criside non lo guardò punto e innalzando il braccio quanto più poté:
– Ah! Djala! – disse – ah! Djala! vorrei avventure straordinarie.
– Tutto è straordinario – disse Djala – oppure nulla. I giorni si rassomigliano.
– Ma no, in altri tempi non era così. In tutti i paesi del mondo, gli dèi sono discesi sulla terra e hanno amato le donne mortali. Ah! su quali letti bisogna dunque attenderli, in quali foreste bisogna mai cercarli, coloro che sono un po' più degli uomini? Quali preghiere bisogna dire perché vengano coloro che mi insegneranno qualche cosa o che mi faranno dimenticare tutto? E se gli dèi non vogliono più discendere, se sono morti o se sono troppo vecchi, Djala, morirò io così, senza aver veduto un uomo che metta nella mia vita tragici eventi?
Ella si rivoltò sul dorso e torse le dita le une sulle altre.
– Se qualcuno mi adorasse mi pare che avrei tanta gioia a farlo soffrire fino a che morisse. Coloro che vengono da me non sono degni di piangere. E poi, è anche mia colpa: sono io che li chiamo, come mi potrebbero amare?
– Che braccialetto oggi?
– Li metterò tutti. Ma lasciami, non ho bisogno di nessuno. Va' sugli scalini della porta e se viene qualcuno digli che sono col mio amante, uno schiavo nero, che io pago… Va'.
– Non esci?
– Sì, uscirò sola, mi vestirò da sola, non rincaserò. Vattene, vattene.
Lasciò cadere una gamba sul tappeto e si stirò fino ad alzarsi. Djala era uscita dolcemente.
Ella camminò lentissimamente per la camera, con le mani incrociate attorno alla nuca, intenta alla voluttà di applicare sulle lastre i piedi nudi dove il sudore ghiacciava. Poi entrò nel bagno. Guardarsi attraverso l'acqua era per lei una delizia: si vedeva come una grande conchiglia di madreperla aperta sopra una roccia; la sua pelle diventava omogenea e perfetta, le linee delle sue gambe si allungavano in una luce azzurra, tutta la sua figura era più elastica non riconosceva più le sue mani. L'elasticità del suo corpo era tale che ella si sollevava su due dita, si lasciava galleggiare un po' e ricadeva mollemente sul marmo, sotto un risucchio leggero che le urtava il mento. L'acqua le entrava nelle orecchie col solletico di un bacio.
L'ora del bagno era quella in cui Criside cominciava ad adorarsi: tutte le parti del suo corpo diventavano una dopo l'altra oggetto di un'ammirazione tenera e motivo di una carezza. Con i capelli ed i seni, faceva mille giochi deliziosi. Qualche volta anzi, accordava ai suoi perpetui desideri una compiacenza più efficace, e nessun luogo di riposo si offriva così bene alla minuziosa lentezza di questo delicato sollievo.
Il tempio di Afrodite-Astarte si innalzava fuori dalle porte della città, in un parco immenso pieno di fiori e di ombre, dove l'acqua del Nilo, trasportata da sette acquedotti, manteneva in qualsiasi stagione prodigiose verzure.
Questa foresta, fiorita sulle rive del mare, questi ruscelli, questi laghi, questi prati cupi, erano stati creati in mezzo al deserto, due secoli prima, dal primo dei Tolomei. Da allora, i sicomori piantati per ordine suo erano diventati giganteschi: beneficati dalle acque feconde le aiuole erano diventate praterie, i bacini s'erano allargati in laghi, la natura, di un parco, aveva fatto una contrada.
I giardini erano più che una valle, più che un paese, più che una patria: erano un mondo compiuto, chiuso da limiti di pietra, retto da una dea, che era anima e centro di questo universo. Tutto intorno si elevava una terrazza in forma anulare, lunga ottanta stadi e altra trentadue piedi. Non era un muro, era una colossale cinta, fatta di millequattrocento case. Un ugual numero di prostitute abitava questa città santa e riassumeva in questo unico luogo settanta popoli diversi.
Il piano delle case sacre era uniforme: la porta di rame rosso (metallo sacro alla dea) portava un fallo in guisa di martello, che picchiava su un controbattente fatto a immagine del sesso femminile; e al di sopra era inciso il nome della cortigiana con le iniziali della formula liturgica usuale.
Da ogni lato della porta si aprivano due camere in forma di bottega, cioè senza muro dalla parte del giardino. Quella di destra, detta “camera esposta” era il luogo dove la cortigiana abbigliata sedeva sopra un'alta cattedra, nell'ora in cui arrivavano gli uomini. Quella di sinistra era a disposizione degli amanti che desideravano passar la notte all'aria aperta, senza però coricarsi sull'erba.
Oltrepassata la porta un corridoio dava accesso ad una vasta corte lastricata di marmo, occupata nel centro da una vasca di forma ovale. Un peristilio circondava d'ombra questa grande zona di luce e proteggeva, con un'oasi di freschezza, l'entrata delle sette camere della casa. Nel fondo si innalzava l'altare che era di granito rosa.
Tutte le donne avevano apportato dal loro paese un idolo della dea e lo tenevano sull'altare domestico, adorandolo nella loro lingua, senza mai comprendersi tra di loro.
Lachmi, Aschtoreth, Venere, Ischtar, Freia, Militta, Cipride, tali erano i nomi religiosi della loro Voluttà divinizzata. Qualcuna la venerava sotto una forma simbolica, un ciottolo rosso, una pietra conica, una grande conchiglia spinosa. La maggior parte elevava, sopra uno zoccolo di legno tenero, una statuetta grossolana dalle braccia magre, dai seni pesanti, dai fianchi eccessivi e che accennava con la mano il suo ventre increspato a forma di delta. Deponevano ai suoi piedi un ramo di mirto, seminavano l'altare di foglie di rose e bruciavano un piccolo grano d'incenso per ogni voto esaudito.
L'idolo era il confidente delle loro pene, il testimone dei loro lavori, causa immaginaria di ogni loro piacere. E quando morivano, le seguiva nella fragile bara, come un guardiano nella loro sepoltura.
Le più belle fra queste ragazze venivano dall'Asia. Tutti gli anni, le più belle navi che portavano ad Alessandria i doni dei tributari o degli alleati sbarcavano con le balle e gli otri cento vergini scelte dai preti per il servizio del giardino sacro: erano Misane e Ebree, Frigie e Cretesi, figlie di Ecbàtana e di Babilonia e delle rive del golfo delle Perle, e delle sponde sacre del Gange. Le une erano bianche di pelle, con visi da medaglie e seni inflessibili, le altre, brune come la terra sotto la pioggia, portavano anelli attraverso le narici e scuotevano sulle spalle capigliature corte e fosche.
Ne venivano da più lontano ancora: piccoli esseri fragili e lenti di cui nessuno sapeva la lingua e che rassomigliavano a giovani scimmie divine. I loro occhi si allungavano verso le tempie, i loro capelli neri e diritti erano bizzarramente pettinati. Queste ragazze restavano timide per tutta la vita, come animali sperduti. Conoscevano i movimenti dell'amore, ma rifiutavano il bacio sulla bocca. Le si scorgevano, tra due unioni passeggere, sedute sui loro piccoli piedi a divertirsi puerilmente.
In un prato solitario, le figlie bionde e rosee dei popoli del Nord, vivevano in greggi, coricate sull'erba: erano Sarmate dalla triplice treccia, dalle gambe robuste, dalle spalle quadrate, che con fronde di albero si facevano corone e lottavano a corpo a corpo per divertirsi; Scite camuse, poppute, vellose, che non si accoppiavano se non nella posa delle bestie; Teutoni gigantesche che terrificavano gli Egiziani con i loro capelli pallidi come quelli dei vecchi e le loro carni più molli che quelle dei bambini; Galle rosse come vacche e che ridevano senza motivo; giovani Celte dagli occhi color verde-marino e che non uscivano mai ignude.
Altrove le Iberiche dai bruni seni si riunivano durante il giorno: avevano capigliature pesanti che pettinavano con ricercatezza e ventri nervosi che non depilavano mai. La loro pelle soda e il loro dorso vigoroso piaceva agli Alessandrini.
Le prendevano per danzatrici e per amanti con la stessa frequenza.
Sotto l'ombra larga delle palme abitavano le figlie dell'Africa: le Nubiane velate di bianco, le Cartaginesi vestite di garze nere, le Nere avvolte in costumi multicolori.
Erano millequattrocento.
Quando una donna entrava là, non ne usciva più, se non al primo giorno della sua vecchiaia. Davano al tempio la metà del loro guadagno e il resto doveva bastar loro per i pasti e i profumi. Non erano schiave, ed ognuna di loro possedeva veramente una delle case della Terrazza, ma non erano tutte ugualmente amate e le più fortunate, sovente, compravano delle case vicine, che le rispettive abitanti vendevano per non dimagrire di fame. Costoro trasportavano allora la loro statuina oscena nel parco e cercavano un altare costruito con una pietra levigata, in un angolo che non abbandonavano più. I mercanti poveri lo sapevano e di preferenza si rivolgevano alle fanciulle che dormivano così sul muschio, all'aria libera, vicino al loro santuario; ma qualche volta non si presentavano neppure questi, e allora le povere ragazze riunivano a due a due le loro miserie in appassionate amicizie, che diventavano amori quasi coniugali, famiglie ove ogni cosa veniva divisa, persino il lembo di lana, e nelle quali gli alternativi favori consolavano le lunghe castità.
Coloro che non contavano amiche si offrivano come schiave volontarie alle loro compagne più ricercate. Era proibito a costoro di avere più di dodici di queste disgraziate al loro servizio; ben venticinque cortigiane avevano raggiunto questo massimo e fra tutte le razze avevano scelto una servitù variopinta.
Se per caso concepivano un figlio, era allevato nella cinta del tempio per la contemplazione della forma perfetta, e al servizio della sua divinità: se partorivano una figlia, la bambina nasceva per la dea.
Il giorno stesso della sua nascita si celebravano le nozze con il figlio di Dioniso, e lo Ierofante la deflorava lui stesso con un coltellino d'oro, poiché la verginità spiace ad Afrodite.
Dopo ella entrava al Didascalion, grande e splendido monumento che serviva da scuola, situato dentro il tempio e dove le bambine in sette classi imparavano la teoria e il metodo di tutte le arti erotiche: lo sguardo, la stretta, i movimenti del corpo, le complicazioni della carezza, i segreti della morsicatura, del glottismo e del bacio. L'allieva liberamente sceglieva il giorno della sua prima esperienza, essendo il desiderio un ordine della dea, che non bisognava contrariare; le si dava in quel giorno una delle case della Terrazza; e alcune di queste fanciulle, che qualche volta non erano neppure puberi, erano tra le più infaticabili e spesso tra le più richieste.
La parte interna del Didascalion, le sette classi, il piccolo teatro e il peristilio della corte erano ornati da novantadue affreschi, che riepilogavano gli insegnamenti dell'amore. Era l'opera di tutta quanta una vita umana: Cleocarete d'Alessandria, figlio naturale e discepolo di Apelle, li aveva finiti poco prima di morire.
Recentemente, la regina Berenice, che prendeva vivo interesse alla celebre scuola, e che vi mandava le sue giovani sorelle, aveva ordinato a Demetrio una serie di gruppi marmorei per completare la decorazione; ma uno solo fino allora era stato collocato nella classe infantile.
Alla fine di ogni anno, in presenza di tutte le cortigiane riunite, aveva luogo un gran concorso, che faceva nascere in questa folla femminile una eccitazione straordinaria, poiché i dodici premi assegnati conferivano il diritto alla suprema gloria che potessero sognare: l'entrata al Coditteion.
Questo ultimo monumento era circondato da tanto mistero, che non se ne può dare una descrizione particolareggiata. Sappiamo soltanto che era compreso nel peribolo, che aveva forma triangolare la cui base era un tempio alla dea Coditto, in nome della quale si compivano spaventose orge sconosciute. I due altri lati del monumento si componevano di diciotto case; vi abitavano trentasei cortigiane, così ricercate dai ricchi amatori, che non si concedevano per meno di due mine; erano le Bapti di Alessandria. Una volta al mese, durante il plenilunio, si riunivano nella cinta chiusa del tempio, rese folli da bevande afrodisiache e cinte di falli rituali. La più vecchia delle trentasei doveva prendere una dose mortale del terribile filtro erotogeno. La certezza di una subita morte le faceva tentare senza timore tutte le voluttà pericolose che spaventavano i vivi.
Il suo corpo, spumante in ogni parte, diventava il modello e il centro della vorticosa orgia; fra le lunghe urla, grida, lacrime e danze le altre donne nude la stingevano, bagnavano i loro capelli al suo sudore, si fregavano alla sua pelle ardente e attingevano nuovi ardori nello spasimo ininterrotto di questa furiosa agonia.
Vivevano così tre anni, alla fine del trentaseiesimo mese era questa l'ebbrezza della loro morte.
Altri santuari meno venerati erano innalzati alle donne, in onore degli altri nomi della multiforme Afrodite. C'era persino un altare consacrato a Urania che riceveva i casti voti delle cortigiane sentimentali; un altro ad Apostrofia che faceva dimenticare gli infelici amori; un altro a Crisea che attirava gli amanti ricchi, un altro a Coliade che approvava le più basse passioni, poiché tutto ciò che aveva attinenza con l'amore, per la dea era pietà. Ma gli altari particolari non avevano efficacia e virtù che per i piccoli desideri. Erano serviti di giorno in giorno, i loro favori erano quotidiani e familiare il loro commercio. Le supplici esaudite deponevano al di sopra di essi semplici fiori; coloro che non erano contente li lordavano con i loro escrementi. Non erano né consacrati né mantenuti dagli altri preti e di conseguenza la loro profanazione non era peccaminosa.
La disciplina del tempio era ben differente. Il Tempio, il Gran Tempio e la Grande Dea, il luogo più sacro di tutto quanto l'Egitto, l'inviolabile Astarteion, era un colossale edificio lungo trecentotrentasei piedi, innalzato di diciassette scalini al di sopra dei giardini. Le sue porte d'oro erano vigilate da dodici ieroduli ermafroditi, simboli dei due oggetti dell'amore e delle dodici ore notturne.
L'entrata non era rivolta verso oriente, ma nella direzione del Faro, cioè verso nord-ovest; mai i raggi del sole penetravano direttamente nel santuario della grande Immortale notturna. Ottantasei colonne sostenevano l'architrave, fino a metà erano tinte di porpora, e tutta la parte superiore si librava da queste rosse vestimenta con una ineffabile bianchezza, come dei tronchi di femmina eretti.
Tra l'epistilio e la coronide, il lungo zooforo snodava in cerchio la sua bestiale ornamentazione, erotica e favolosa; vi si scorgevano centauresse coperte da stalloni, capre assoggettate da magri satiri; vergini macchiate da tori mostruosi, naiadi possedute da cervi, baccanti amate da tigri, leonesse afferrate da grifoni. La grande moltitudine degli esseri si svolgeva così, sollevata dall'irresistibile passione divina. Il maschio si tendeva, la femmina si apriva, e nella fusione delle sorgenti creatrici si risvegliava il primo fremito di vita. La folla delle coppie oscure si apriva a caso, qualche volta, attorno a una scena immortale: Europa inclinata sopportante il bell'animale olimpico; Leda che guidava il robusto cigno fra le sue giovani gambe incurvate. Più lungi l'insaziabile Sirena sfiniva Glauco spirante; il dio Pan in piedi possedeva un'amadriade scapigliata; la Sfinge levava la sua groppa al livello del cavallo Pegaso e all'estremità del gran fregio lo scultore si era effigiato lui stesso in cospetto della dea Afrodite, modellando vicino a lei nella molle creta una vulva perfetta, come se ogni suo ideale di bellezza e di gioia e di virtù si fosse raccolto da gran tempo in quel fiore fragile e prezioso.
Le cortigiane erano in mostra nelle loro “camere esposte” come i fiori in vetrina. I loro atteggiamenti e i loro costumi non erano meno differenti di quello che non fossero la loro età, i loro tipi, le loro razze. Le più belle, secondo la tradizione di Frine, non lasciavano scoperto che l'ovale della loro faccia, si tenevano coperte nei capelli fino ai talloni, nei loro grandi abiti di lana leggera. Altre avevano adottato la moda dei vestiti trasparenti, attraverso i quali misteriosamente si distinguevano le loro bellezze, come attraverso un'acqua limpida si vedono i muschi verdi in macchie nere sul fondo. Coloro che per unico fascino non avevano che la loro giovinezza, restavano nude fino alla cintola, e incurvavano il dorso in avanti per far apprezzare la solidità dei loro seni. Ma le più mature, che sapevano come i tratti del viso femminile invecchino prima della pelle del corpo, stavano sedute interamente nude, sostenendo le mammelle nelle mani e divaricando le loro gambe pesanti come se volessero dimostrare che erano ancora femmine.
Demetrio passò loro davanti lentamente senza stancarsi di ammirare.
Non gli era mai successo di vedere la nudità della donna senza un'intensa commozione; non comprendeva né il disgusto davanti alle giovinezze tramontate, né l'insensibilità davanti a bambine troppo giovani. Purché restasse silenziosa e non dimostrasse più ardore del minimum che esigeva la cortesia del letto, egli le perdonava di non esser bella. Meglio ancora, egli preferiva che ella avesse un corpo grossolano, perché con più il suo pensiero si soffermava su forme perfette, con più il suo desiderio se ne allontanava. Il turbamento che gli cagionava la bellezza vivente era di una sensualità esclusivamente cerebrale, che riduceva a nulla l'attività genetica. Si ricordava con angoscia di esser rimasto un'intera ora, impotente come un vecchio, vicino alla più meravigliosa donna che egli avesse mai tenuta nelle braccia. E da quella notte egli aveva imparato a scegliere amanti di una bellezza meno pura.
– Amico – disse una voce – non mi riconosci più?
Si volse, fece segno di no e continuò la sua strada, poiché egli non spogliava mai due volte la stessa donna. Era l'unico principio che seguisse durante le sue visite ai giardini. Una donna che non si è ancora posseduta, ha qualche cosa di una vergine; ma qual buon risultato, quale sorpresa aspettarsi da un secondo incontro? È quasi un matrimonio.
Demetrio non si esponeva alle delusioni della seconda notte. La regina Berenice bastava alle rare sue velleità coniugali, e al di fuori di lei, egli aveva cura di rinnovare ogni sera la complice dell'indispensabile adulterio.
– Clonarietta!
– Gnatena!
– Plango!
– Mnaide!
– Crobila!
– Ioessa!
Gridavano i loro nomi al suo passare e qualcuna vi aggiungeva l'affermazione della propria natura ardente o l'offerta di una pratica anormale. Demetrio continuava la strada: si disponeva, secondo la sua abitudine, a prendere a caso nel gregge, quando una bambina vestita di azzurro inclinò la testa sulla spalla e gli disse dolcemente senza alzarsi:
– Non c'è proprio verso?
Questa formula imprevista lo fece sorridere. Si fermò.
– Aprimi la porta – disse. – Voglio te.
La piccola, con un movimento allegro, balzò in piedi e batté due colpi col martello fallico. Venne ad aprire una piccola schiava.
– Gorgo – disse la piccina – ho qualcuno; presto, del vino di Creta, dei dolci e fa il letto.
Ella si volse verso Demetrio.
– Hai bisogno del satiron?
No – disse il giovane ridendo. – Ne hai?
– Bisogna pur che ne abbia – fece la bambina; – me lo domandano molto più spesso che tu non creda. Vieni da questa parte, sta attento agli scalini, ce n'è uno rotto. Entra in camera mia; ritorno subito.
La camera era molto semplice come quelle delle cortigiane novizie. Un grande letto, un secondo letto di riposo, qualche seggiola e qualche tappeto la ammobiliavano scarsamente, ma da una apertura si vedeva il mare, la duplice rada di Alessandria.
Demetrio rimase in piedi a guardare la città lontana.
Soli cadenti dietro ai porti! incomparabili glorie di città marinare, calma del cielo, porpora delle acque, su quale anima ardente di dolore o di gioia, non sapeste gettare il silenzio? Quali passi non si sono arrestati, quale voluttà non si è sospesa, quale voce non si è spenta a voi davanti?… Demetrio guardava: un'ondata di fiamma torrenziale sembrava uscire dal cielo a metà tuffato nel mare, e direttamente incurvarsi fino all'altra riva del bosco di Afrodite. Dall'uno all'altro dei due orizzonti, la sontuosa gamma della porpora invadeva il Mediterraneo. Tra questo splendore semovente e lo specchio torboso del lago Mareotide, la massa bianca della città era tutta rivestita di riflessi paonazzi. Le diverse orientazioni delle sue ventimila case basse si macchiettavano di mille zone di colore, in perpetua metamorfosi, a seconda delle fasi decrescenti dell'irraggiamento occidentale.
Tutto ciò fu rapido come l'incendio: poi il sole affondò quasi improvvisamente e il primo riflusso della notte fece ondeggiare su tutta la terra un brivido, una brezza vellutata uniforme e trasparente.
– Ecco fichi, dolci, un favo di miele, del vino, una donna. Bisogna godere i fichi mentre c'è luce, la donna quando non ci si vede più!
La piccina rientrava ridendo: ella fece sedere il giovane, si mise a cavalcioni sulle sue ginocchia e con le sue mani dietro la testa, assicurò nei capelli castani una rosa che stava per cadere.
Demetrio ebbe, suo malgrado, una esclamazione di sorpresa. Lei era interamente nuda, e così spogliato dalla sua veste a sbuffi, il suo corpicino appariva così giovane, con un seno così infantile, con anche così strette, così visibilmente impubere, che Demetrio si sentì come invaso di pietà, come un cavaliere sul punto di far sopportare tutto il suo peso a una puledra così gracile.
– Ma tu non sei una donna! – esclamò.
– Non sono una donna? Per le due dee, che cosa sono dunque io? Un Trace, un facchino, un vecchio filosofo?
– Che età hai?
– Dieci anni e mezzo. Undici anni: si può dire undici anni. Sono nata nei giardini; ma mia madre è di Mileto; è Pizia, detta la Capra. Vuoi che te la mandi a chiamare, se mi trovi troppo piccina? Ha la pelle morbida, la mamma, è bella.
– Sei stata al Didascalion?
– Ci sono ancora, al sesto corso. Fra un anno avrò finito: prima no, purtroppo.
– Ti ci annoi?
– Se sapessi quanto sono esigenti le maestre! La stessa lezione la fanno ricominciare venticinque volte: cose inutili, che gli uomini non domandano mai. Ci fanno stancare per nulla: a me tutto ciò non piace. To', prendi un fico; no questo, non è maturo. Ti insegnerò una nuova maniera di mangiarli: guarda.
– La conosco: è la più lunga e non è la migliore. Mi pare che tu sia una brava allieva.
– Oh! ciò che so, l'ho imparato da sola. Le maestre vorrebbero far credere che sono più abili di noi: hanno più pratica, questo è vero, ma non hanno inventato nulla.
– Hai molti amanti?
– Tutti troppo vecchi: è inevitabile! I giovani sono così stupidi: non vanno che dalle donne di quarant'anni. Certe volte ne vedo passar di quelli che sono belli come amori, e se tu vedessi chi scelgono! C'è da impallidire. Spero di non vivere fino all'età di quelle donne: avrei troppa vergogna a spogliarmi. Se tu sapessi come sono contenta di essere ancora così giovane! I seni spuntano anche troppo presto: mi pare che il primo mese in cui vedrò colare il mio sangue mi crederò vicina alla morte. Lasciati dare un bacio: mi piaci.
La conversazione prese qui un andamento meno grave e più silenzioso: Demetrio si accorse ben presto che non era il caso di far lo scrupoloso con una donnina così esperta. Pareva che lei si rendesse conto di essere un pascolo un po' magro per un giovanotto e sconcertava il suo amante con una prodigiosa attività di contatti furtivi, che egli non poteva né prevedere, né permettere, né dirigere, e che mai gli lasciavano il riposo di una stretta amorosa. Il piccolo corpo agile e sodo si moltiplicava attorno a lui, si offriva e si ricusava, scivolava, girava, lottava. Finalmente si presero. Ma quella mezz'ora non fu che un lungo gioco.
Lei scese dal letto per prima, intinse il dito nella coppa di miele, se ne imbrattò le labbra; poi con mille sforzi per non ridere, si chinò su Demetrio fregando la bocca sulla sua. I suoi riccioli rotondi danzavano da ogni parte sulle sue guance.
Sorrise il giovane, alzandosi sui gomiti.
– Come ti chiami? – disse.
– Melitta. Non hai visto il mio nome sulla porta?
– Non avevo guardato.
– Potevi vederlo nella camera. Me l'han tutti scritto sui muri e fra poco sarò obbligata a farli ridipingere.
Demetrio sollevò il capo; le quattro pareti della camera erano coperte di iscrizioni.
– Toh, è curiosa! – disse. – Si può leggere?
– Certo, se vuoi. Non ho segreti.
Lesse: trovò parecchie volte ripetuto il nome di Melitta, accompagnato con nomi di uomini e barbari disegni. Frasi tenere, oscene e comiche si incrociavano bizzarramente. Erano amanti che vantavano il loro vigore o enumeravano i fascini della piccola cortigiana o burlavano le sue buone colleghe. Tutto ciò non aveva interesse, se non come testimonianza scritta della generale abiezione.
Ma verso la fine della parete destra Demetrio sussultò:
– Che è questo? che è? Dimmi!
– Ma chi? che cosa? dove?… – disse la bambina – che hai?
– Qui. Questo nome, chi l'ha scritto?
Il suo dito si fermò su questa duplice linea: Melitta a Criside – Criside a Melitta.
– Ah! – rispose lei. – Sono io. L'ho scritto io.
– Ma chi è questa Criside?
– È una mia grande amica.
– Comprendo, ma non ti domando questo. Quale Criside? Ce ne sono molte.
– Ma la mia è la più bella: Criside di Galilea.
– La conosci? Tu la conosci? Ma parlamene dunque! Da dove viene? Dove abita? Chi è il suo amante? Dimmi tutto!
Si sedette sul letto da riposo e si prese la piccina sulle ginocchia.
– Sei innamorato, allora! – disse lei.
– Non ti riguarda. Raccontami ciò che sai; ho fretta di saper tutto.
– Oh! ma io non so nulla affatto. È subito detto: è venuta due volte da me, e capirai bene che non le ho chiesto informazioni sulla sua famiglia. Ero troppo felice di averla e non ho perduto tempo in conversazioni.
– Come è fatta?
– È fatta come una bella ragazza, che vuoi che ti dica? Devo enumerarti tutte le parti del suo corpo, aggiungendo che è tutto bello? E poi, lei è una donna, una vera donna… quando penso a lei mi viene subito desiderio di qualcuno.
Si gettò al collo di Demetrio.
– Tu non sai nulla – riprese lui – nulla sul suo conto?
– So… so che viene dalla Galilea, che ha quasi vent'anni, che abita nel quartiere degli Ebrei, a oriente della città, vicino ai giardini: ecco tutto.
– E della sua vita? dei suoi gusti? non puoi dirmi nulla? Se viene da te, vuol dire che le piacciono le donne, ma è soltanto lesbica?
– No, certamente. La prima notte che passò qui portò un amante e ti giuro che non simulava nulla. Quando una donna è sincera lo vedo dai suoi occhi. Ciò non impedisce che una volta sia venuta affatto sola… E mi ha promesso una terza notte.
– Non ha altre amiche, che tu sappia, nei giardini? Nessuna?
– Sì, una donna del suo paese, Chimairide, una povera.
– Dove abita? Bisogna che io la veda.
– Dorme nel bosco da un anno, ha venduto la sua casa. Ma conosco il suo buco. Se lo desideri posso condurti. Vuoi mettermi i sandali?
Demetrio con mano rapida allacciò i sandali sulle gracili caviglie di Melitta i cordoni di cuoio intrecciato; le porse la corta veste che ella prese semplicemente sul braccio, e uscirono in fretta.
Camminarono a lungo. Il parco era immenso. Di tratto in tratto, di sotto un albero, una ragazza diceva il suo nome aprendo la veste, poi si ricoricava con il viso tra le mani. Melitta ne conosceva qualcuna, che senza fermarla la baciava. Passando davanti a un logoro altare, ella colse tre grandi fiori e li depose sulla pietra.
La notte non era ancora nera. La luce intensa dei giorni estivi ha qualche cosa di durevole che vagamente si attarda nei lenti crepuscoli. Le stelle deboli e umide, appena più chiare del fondo del cielo, occhieggiavano con palpito dolce e le ombre dei rami restavano indecise.
© Paolo Melandri (25. 4. 2019)
*
Progetto per un romanzo educativo
Egli chiuse gli occhi.
Il suo primo pensiero inseguiva già il secondo, che non voleva manifestarsi. E così ebbe grande difficoltà ad aprire i pugni. Cercò un oggetto da tormentare con le mani. Anche le tende immobili, leggermente aperte, non lo calmarono neppure fugacemente; fin da piccolo aveva sempre creduto di sognare quando dormiva. Dentro di sé però fiutava qualcosa di marcio in quella storia. E nondimeno se la svignò al primo canto del gallo.
La cosa prometteva bene. Col passar del tempo, in città si fece una fama come lanciatore di coltelli. La cosa che più gli piaceva erano i fili del tram. Dato che oltre a ciò aveva la faccia di uno che non sa contare fino a tre, nessuno arrivava a prendersela per le sue occhiate terribili. Ogni volta che attraversava le rotaie, succedeva che persone assolutamente sconosciute si gettassero le braccia al collo. La sua fede nell'umanità cresceva. Tuttavia le sue azioni non diventarono fini a se stesse. Si era proposto ripetutamente di raccontare la verità su se stesso.
Così non gli sembrò inaspettato che un pazzo, appoggiato per ore e ore all'angolo di casa, potesse fischiare aguzzando le labbra.
Questo fatto rafforzò la sua coscienza di sé. Non poteva poi mancare che ciò degenerasse in una specie di smania di se stesso, e come conseguenza nessuno volle accettare la sua storia. Finalmente arrivò ad essere disposto a condividere il pane con un postino; anzi, davanti a un invalido, dopo che entrambi si erano evitati con lo sguardo, abbassò gli occhi per terra. Gli divenne chiaro che tra loro due c'era di mezzo un mondo.
E non soltanto, dopo una riflessione del genere, le cose gli andarono di male in peggio. Dall'agitazione faceva le scale di volata. Gli piaceva ancora saltare i gradini come un tempo, ma a poco a poco la paura aumentava.
Questi pensieri ossessivi svanivano però rapidamente. Le cattive lingue sostenevano, non a torto, che il suo coltello non era più quello di un tempo. Ed era un errore non credere a quelle insinuazioni. In ogni caso viveva senza farsi troppi problemi. Invece di mettere in azione i suoi pensieri, aveva intenzione di fare l'esatto contrario. Dai libri che leggeva uno dietro l'altro imparò che l'inutilità puzza di pesce marcio; perciò si cercava un buon cinema e giocava con le macchinette automatiche all'entrata. Per lo meno arrivò a sapere cos'è la vita.
Dai visi delle persone che passavano, intuiva che erano guardinghe di fronte a lui. In ogni caso amore era per lui una parola sconosciuta. E non poteva poi mancare che gli stessero prudentemente alla larga.
A parte ciò, le cose erano andate meglio in passato. Quando era necessario, riusciva ad ammazzare il tempo col palmo della mano. Certo che però non riusciva a combinare nulla col tempo morto lì davanti a lui.
Viveva in una zona battuta dai venti dell'ovest. Una volta, alzando lo sguardo, vide nel firmamento un'entità simile a un corpo celeste. Si appoggiò a un muro e si riposò. Il vento si alzò. Abbassò la testa, il suo cuore volava. Il vento si calmò.
I parenti lo ritenevano un fannullone perché non voleva mai andare a letto. Anche per la polizia non era più uno sconosciuto. Come poi si dimostrò, i timori dei suoi maestri non erano proprio campati in aria: non gli sarebbe sempre andata liscia. Lo sguardo di una vecchia, che un tempo aveva avuto una bettola e che lui vedeva spesso da lontano, non lo turbò affatto, ma una pozzanghera nera in strada gli fece venire i sudori freddi.
© Paolo Melandri (25. 4. 2019)
*
Le unghie la mattina
Una fanciulla povera viveva in un povero appartamento in affitto al primo piano. E attendeva di sposarsi col fidanzato. Però ogni sera a casa sua c'era un andirivieni di uomini sempre diversi. Era una casa dove non batteva il sole del mattino. Sovente la fanciulla, coi suoi logori jeans da uomo, faceva il bucato presso l'entrata di servizio.
La notte gli uomini, tutti senza eccezione, dicevano:
“Che roba! Non c'è nemmeno la zanzariera?”
“Mi spiace, mi scusi tanto. Sto sveglia io tutta la notte, mi alzo io a mandarle via, le zanzare.”
La fanciulla tutta zelante accendeva lo zampirone verde. Poi spegneva la luce e fissava la fiammella dello zampirone, e non c'era volta che non le sovvenisse di quand'era bambina. Poi, per ore infinite faceva vento al corpo dell'uomo. E anche in sogno continuava a sventagliare.
È ormai autunno.
Cosa insolita, a questo povero primo piano salì un vecchio.
“Non metti la zanzariera?”
“Mi spiace, mi scusi tanto. Sto sveglia io tutta la notte, mi alzo io a mandarle via, le zanzare.”
“Sì? Aspetta un attimo” disse il vecchio alzandosi in piedi, ma la fanciulla tentò di trattenerlo:
“Ma le mando via io fino alla mattina! Non dormo neanche un secondo!”
“Sì, sì. Torno subito.”
Il vecchio prese le scale e sparì. La fanciulla accese lo zampirone ma non spense la luce. Da sola al chiaro i ricordi di infanzia non le venivano.
Nel giro di un'ora il vecchio fu di ritorno. La fanciulla si alzò, di scatto.
“Oh, meno male che ci sono almeno i ganci!”
Nella povera stanza il vecchio appese una zanzariera bianca nuova fiammante. La fanciulla vi entrò, e mentre camminava stendendone l'orlo, il fresco contatto la faceva palpitare.
“Ero sicura che sarebbe tornato, perciò l'ho aspettata con la lampada accesa. Voglio guardarmela ancora un po' alla luce, questa zanzariera bianca.”
Invece cadde in un sonno profondo, come non le accadeva da molti mesi. La mattina neppure si accorse quando il vecchio se ne andò.
“Ehi, ehi, ehi, ehi!”
A svegliarla fu la voce del fidanzato.
“Finalmente domani possiamo sposarci! Però, che bella zanzariera! Solo a vederla, ci si sente già meglio”, e detto ciò tolse via tutti i ganci. Poi trascinò fuori la fanciulla e ve la gettò sopra.
“Mettiti sulla zanzariera. Sembra un grande fiore di loto bianco. Ora anche la stanza è immacolata come te.”
La fanciulla al tocco di quel lino nuovo si sentì una bianca sposa.
“Mi taglio le unghie dei piedi.”
Seduta sulla bianca zanzariera grande quanto la stanza, si mise, tutta assorta, a tagliarsi le unghie lunghe che aveva trascurato.
© Paolo Melandri (24. 4. 2019)
*
Storia con ombrello
L'ombrello
Una pioggerella primaverile che pareva più una nebbia, che non bagnava davvero ma lasciava sulla pelle una vaga umidità. La ragazzina, che si era precipitata in strada, solo quando vide l'ombrello del ragazzo se ne accorse:
“Ehi, ma piove!”.
L'ombrello, più che per la pioggia, il ragazzo l'aveva aperto per nascondere l'imbarazzo di passare davanti al negozio dove sedeva la ragazzina.
Però senza dire una parola la prese sotto l'ombrello. Lei vi entrò solo con una spalla. Il ragazzo si bagnava ma non osava avvicinarsi e dirle «vieni vicino». La ragazzina avrebbe voluto mettercela anche lei una mano sul manico dell'ombrello, invece pareva sempre sul punto di sgusciar fuori.
Insieme entrarono da un fotografo. Il padre del ragazzo, che era un magistrato di sorveglianza, veniva trasferito lontano. Era una foto d'addio.
«Mettetevi qui, uno di fianco all'altro» e il fotografo fece cenno al divano, ma il ragazzo non osava sedersi accanto alla ragazzina. Rimase in piedi dietro di lei, e per poter pensare che i loro corpi fossero in qualche punto allacciati, allungò le dita che teneva attorno al divano fino a sfiorare appena appena la giacca di lei. Era la prima volta che la toccava. Alle sue dita si trasmetteva un impercettibile tepore, ma lui sentì lo stesso calore che se l'avesse stretta nuda fra le braccia.
Per tutta la vita, ogni volta che avesse guardato quella foto, gli sarebbe tornato in mente quel calore.
«Ne facciamo ancora una? Se vi mettete fianco a fianco facciamo un primo piano.»
Il ragazzo si limitò ad annuire. Si volse alla ragazzina e sottovoce le disse: «I capelli!». Lei levò la testa di scatto, lo guardò e avvampò, e con gli occhi che le brillavano di gioia, come una bimba trotterellò ubbidiente allo stanzino del trucco.
Quando aveva visto il ragazzo passare davanti al negozio si era lanciata fuori senza nemmeno il tempo di aggiustarsi i capelli. Quei capelli, sempre per aria come si fosse appena sfilata una cuffia da bagno, erano il suo eterno cruccio. Ma lei davanti a un uomo si sarebbe vergognata anche solo di accennare a ravviarsi una ciocca. Il ragazzo, a sua volta, pensava di metterla in imbarazzo a dirle di pettinarsi.
L'allegria con cui andò allo stanzino del trucco mise allegria anche al ragazzo. E dopo riuscirono a sedere con naturalezza sul divano, vicini.
Quando furono pronti per uscire dal fotografo, il ragazzo cercò l'ombrello. Gli scappò l'occhio e vide la ragazzina che era già uscita e lo aspettava in strada con l'ombrello in mano. Quando la guardò, solo allora, lei si rese conto di essere uscita con l'ombrello del ragazzo. E sbalordì. Con quel gesto involontario non aveva forse dimostrato di sentirsi sua?
Il ragazzo non riuscì a dirle di tenere l'ombrello. Né la ragazzina ebbe il coraggio di porgerglielo. Ma di colpo erano diventati adulti e, ben diversamente dall'andata, il ritorno lo fecero da coppia. Solo per via di un ombrello…
© Paolo Melandri (24. 4. 2019)
*
Il vero sentire 2
Per quanto sentisse il desiderio di uscire, come sempre tardò ad avviarsi. Al piano terra aprì le porte di tutte le stanze in modo che dentro si crearono giochi di luce provenienti dai vari punti cardinali. La casa sembrava disabitata. Era come se ora chiedesse di essere non soltanto un luogo di lavoro e di riposo, ma anche di abitazione. Già da sempre era stato incapace di creare questa condizione, così come era stato incapace di creare una vita familiare. Angoli per sedersi, tavoli da pranzo e pianoforti gli davano subito una sensazione di estraneità; cassette stereo, scacchiere, vasi di fiori, persino biblioteche ordinate gli facevano soltanto specie; da lui i libri erano accatastati sul pavimento o sui ripiani delle finestre. Solo di notte, seduto da qualche parte al buio con dinanzi a sé le fughe di stanze che, gli sembrava, erano illuminate giusto a sufficienza dalle luci della città e dal loro riflesso in cielo, provava qualcosa di simile a una sensazione familiare. Queste ore, in cui finalmente non doveva più lambiccarsi il cervello o pensare al dopo, ma si limitava a starsene tranquillo e tutt'al più, nel silenzio, a ricordare, per lui erano le ore più amate in casa, e ogni volta le prolungava finché, impercettibilmente, il suo meditare trascorreva in sogni ugualmente tranquilli. Ma durante il giorno, in particolare poco dopo il lavoro, sentiva subito l'oppressione del silenzio. Allora il rumore della lavastoviglie in cucina e il ronzio della centrifuga in bagno erano una vera benedizione. Persino alla scrivania col passare del tempo gli divennero necessari i rumori del mondo esterno: una volta, dopo aver scritto per mesi in cima a un grattacielo quasi a isolamento acustico, per così dire molto vicino al cielo, per poter continuare a lavorare si era trasferito in una stanza al pianterreno affacciata su una strada principale molto rumorosa e in seguito, già nella casa attuale, quando era iniziato il chiasso del cantiere nel terreno confinante, dopo una prima sensazione di disturbo ogni mattina aveva usato i martelli pneumatici e i cingoli scorrevoli per sintonizzarsi con la sua attività, così come una volta, agli inizi, aveva usato un pezzo musicale. Poi, di continuo, aveva anche distolto gli occhi dal foglio per guardare gli operai fuori, cercando l'armonia tra il suo lavoro e la regolarità dei loro gesti. Alla lunga la pura natura con gli alberi, l'erba, la vite canadese abbarbicata alla finestra non gli offriva una simile visione, che gli era sempre necessaria. Comunque una mosca nella stanza lo disturbava più che non un battipalo a vapore all'esterno.
Già vicino alla porta del giardino, d'un tratto tornò indietro. Corse in casa, salì a precipizio nel suo studio e sostituì una parola con un'altra. Soltanto allora sentì l'odore del sudore nella stanza e vide che le finestre erano appannate.
© Paolo Melandri (18. 4. 2019)
*
I calabroni
Le tue mani odorano di pane.
Lei prese il coltello del pane che era troppo grande per le sue mani e tagliò scavando profondamente nella vena, guardandosela forse per un po', accovacciata fra le more che in montagna erano proprio mature; invece di tagliarsi i polsi avrebbe potuto restare seduta e mangiare le more; oppure avrebbe potuto prendere un altro coltello più piccolo per non esagerare. Ma non c'erano spettatori. Quell'immagine deve essere rimasta impressa per un po', perché i suoi occhi guardavano la mano, lei non si muoveva affatto: come quando mio padre un mattino arrivò e la buttò giù dal letto così che lei andò a sbattere contro la parete e ruppe la lampada; e come quando mio padre le disse: vieni qui, amoruccio mio, con una voce da far paura: prendi il pane e la carne dalla credenza. No, mio padre non aveva una voce da far paura: amoruccio mio, vieni qui, disse. Portami dell'acqua calda. Voglio svestirmi e lavarmi. Lei andò in cucina e mise l'acqua sul fuoco mentre lui si spogliava. Cosa guardi tu, mi disse. Mettiti piuttosto nell'angolo e canta le preghiera del mattino. Io mi misi nell'angolo mormorando, con la testa girata, la mia imprecazione sul legno e sulle ragnatele e cantai la preghiera del mattino. In quel mentre la sentii entrare con la bacinella e fermarsi sulla porta. Sanguini, disse lei. No, rispose lui. Non sanguino, sono insanguinato. Lei non disse altro; io fissai un ragno: aveva otto zampette prima che gliene strappassi due; cantavo la mia preghiera del mattino. Lavami, disse mio padre. Strappai al ragno la sesta zampetta, poi la quinta, la quarta di colpo. Così sentii lei che lo lavava con l'acqua calda e con uno straccetto di spugna; si piegava e si rialzava lavandogli tutto il corpo mentre io strappavo al ragno le ultime zampette. Ora potrei dire: ricordo ancora la venatura delle travi che osservavo, oppure qualcosa d'altro che si può percepire con gli occhi; ma io non ricordo che l'odore dell'acqua quando lei strizzava lo straccetto di spugna. La sera avrebbe potuto strizzarsi anche la mano mentre sedeva fra le more, ma non ne sarebbe più uscita una goccia. Quando salimmo verso la baracca avevamo già sentito le sue urla; io tornavo dalla scuola nella vallata, mio padre non veniva da nessun posto; ci eravamo trovati per strada. Chi è che grida nel bosco, dissi. Una ghiandaia, rispose mio padre, o un gallo cedrone o una tigre. Ma queste sono grida, dissi meravigliato. Sì, gridano così, disse mio padre. Ascolta come gridano. Tu devi sapere come grida una tigre o un gallo cedrone quando sarai grande. Adesso sono grande e non so ancora come grida una tigre; ma come grida qualcuno fra le more, già troppo debole per uscirne fuori, ora lo so. Più tardi, la sera, quando uscimmo a cercarla verso lo stagno arrivarono i calabroni. Era metà autunno o metà inverno. Mio padre si fermò piegando le canne e scrutando il filo dell'acqua: i calabroni sono arrivati, torniamo indietro. Si girò e io lo seguii col suo odore nel naso: mio padre aveva un odore forte. Io lo seguivo mentre lui andava sempre più svelto verso il bosco, i calabroni arrivavano, i calabroni sono arrivati, i calabroni hanno gridato nel bosco, disse lui. Cominciò a nevicare molto forte, bianco e giallo, l'aria rintronava, c'era un odore aspro di calabroni che ci nevicavano addosso mentre andavamo verso il bosco nel quale lei era distesa fra le more, immobile. Fai presto, disse mio padre, lasciando orme fra i calabroni che coprivano il suolo, con le sue enormi scarpe faceva orme profonde nella neve, nel vento e nell'oscurità mentre l'aria ronzava e gemeva, e lui faceva orme profonde, orme profonde faceva, mentre io lo seguivo a piedi scalzi sui calabroni che si muovevano e si dissolvevano – i calabroni che si muovevano e dissolvevano le orme profonde che lui faceva affondando le scarpe, finché la trovammo nel cespuglio, le orme profonde che lui fa e che noi calpestiamo mentre guardiamo mentre ci lamentiamo mentre calpesto le orme di mio padre.
© Paolo Melandri (17. 4. 2019)
*
Sera
Spense tutte le luci. La neve ed il riverbero della città sulle nubi illuminavano i locali; una chiarità notturna in cui gli oggetti spiccavano tanto più bui. In cucina, fissando il quadrante luminoso della radio, ascoltò le ultime notizie. Sebbene fosse mezzanotte, l'annunciatore sembrava sveglio come in pieno giorno. Tuttavia nel corso dell'annuncio, senza che quello che stava leggendo potesse costituire un motivo, fu sopraffatto da una violenta commozione per qualcosa che l'aveva tormentato tutto il tempo e che ora stava per esplodere: con un filo di voce, palesemente prossimo alle lacrime – una volta si interruppe persino e rimase a lungo in silenzio, come uno che cerca ancora di aggrapparsi e che sta per precipitare con un urlo –, riuscì ad arrivare fino alle previsioni del tempo e a dire ancora “Buona notte”, dopodiché lo allontanarono senza indugio dal microfono. Era stato licenziato in quel momento? Era stato abbandonato dalla sua innamorata? Un attimo prima del colpo di gong gli avevano comunicato che gli era morto qualcuno?
Si sedette in una delle stanze con la vista sulla stanza seguente, nel suo posto notturno, una sorta di sedia da regista da cui aveva gli oggetti all'altezza degli occhi. La giacca chiara sulla spalliera di una sedia, dove si trovava dall'estate scorsa, per un momento gli fece risentire le ciglia umide del nuotatore nel vento del mare. Perché sentiva una partecipazione così pura soltanto quando era solo? Perché poteva capire quelli che gli stavano vicino soltanto quando se n'erano andati, e quanto più erano lontani, tanto meglio? E perché si faceva l'immagine più luminosa di quegli assenti che nella sua mente vedeva come coppia? E perché viveva il suo rapporto più intenso con i morti? Perché soltanto i morti ai suoi occhi potevano trasformarsi in eroi? – Si appoggiò una mano sulla fronte, l'altra sul cuore e rimase seduto come in un treno notturno, che poi in realtà sentì anche passare più giù sul ponte d'acciaio attraverso il fiume, con un rumore nella neve come di pattini sul ghiaccio. Poi, quando suonò il telefono all'ingresso, non alzò il ricevitore: non aspettava nessuno e non voleva neanche più aprir bocca.
Non per stanchezza, ma per impedirsi di continuare a pensare si riscosse e si avviò verso la camera da letto. Mentre si lavava al buio – provava una sorta d'avversione già soltanto ad immaginare di vedere il suo viso – gli sembrava che qualcun altro vicino a lui stesse facendo la stessa cosa. Si fermò e sentì che nell'angolo più lontano della casa qualcuno sfogliava di nuovo una pagina di libro. Una sedia fu spostata di nuovo, un armadio riaperto, e le grucce tintinnarono di nuovo una contro l'altra. Strano, come nel ricordo di tutti i rumori, persino il cigolio delle porte e il trambusto, si disponessero in accordi. Qualsiasi cosa ora si muovesse a tentoni nella tromba delle scale, aveva il passo troppo leggero per essere una persona.
Prese un bicchiere con la maggior cautela possibile e aprì un rubinetto dell'acqua facendo attenzione per evitare il solito fischio. Tenendo davanti a sé entrambe le mani il bicchiere colmo fino all'orlo, salì per la scala e rallentò il passo contando i gradini. Anziché rimuginare, voleva soltanto continuare a contare tranquillamente. Con questo pensiero i suoi passi si fecero così leggeri, che nemmeno il solito gradino scricchiolò. Perché non avevano mai inventato un Dio della lentezza? Entusiasta della sua idea, mancò un gradino e sotto i suoi piedi scricchiolò tutta la casa.
© Paolo Melandri (14. 4. 2019)
*
Zapparoni 8
Gli uccelli tacevano. Sentii di nuovo il mormorio del ruscello nel calore del fondo. Poi mi svegliai di colpo. Già di prima mattina ero stato in piedi, tormentato dall'inquietudine di chi corre dietro al suo pane. In tale stato d'animo il sonno ci sorprende come un ladro.
Dovevo soltanto avere chiuso gli occhi, infatti il sole si era appena mosso. Il sonno nella luce violenta mi aveva stordito. Mi orientai con difficoltà; il luogo era ostile.
Anche le api avevano terminato il loro sonno meridiano; l'aria era piena del loro ronzio. Pascolavano sul prato, sfioravano a sciami la spuma bianca che lo copriva o si tuffavano nella sua variopinta profondità. A grappoli si appendevano al chiaro gelsomino che orlava la strada, e quando sciamavano dall'acero in fiore accanto al boschetto l'aria risuonava come una grande campana, che continua a lungo a vibrare dopo che mezzogiorno è suonato. Di fiori non c'era scarsità; era uno di quegli anni di cui gli apicoltori dicono che vestono di miele i pali delle arnie.
Eppure c'era qualcosa di strano in quel pacifico commercio. Tolti i cavalli e la selvaggina, conosco poco gli animali, infatti non ho mai trovato un maestro che mi facesse appassionare per loro. Per le piante, la cosa è diversa, infatti avevamo un professore di botanica entusiasta, col quale spesso facevamo gite. Quanto può dipendere nella nostra storia da tali incontri. Se dovessi compilare un elenco degli animali che conosco, mi basterebbe un foglietto di carta. Lo dico soprattutto per gli insetti che riempiono il mondo a legioni.
Comunque so press'a poco come sono fatti un'ape, una vespa e anche un calabrone. Mentre lì seduto le contemplavo sciamare, mi pareva che a volte ne passassero alcune che spiccavano stranamente. Dei miei occhi posso fidarmi; li ho messi alla prova non soltanto per la caccia alle galline. Non mi costava nessuna fatica seguire una di quelle api con lo sguardo, finché si posò sopra un fiore.
Allora ricorsi al binocolo e vidi di non essermi ingannato.
Sebbene io, come ho già detto, conosca poco gli insetti, ebbi subito l'impressione di una cosa imprevista e supremamente bizzarra, quasi l'impressione di un insetto piovuto dalla luna. Poteva aver lavorato a fabbricarlo un demiurgo, in regni remoti, il quale una volta avesse sentito parlare di api.
L'ape mi lasciò tutto il tempo di contemplarla, inoltre adesso da tutte le parti arrivavano insetti simili come operai all'ingresso dell'officina quando la sirena ha chiamato al lavoro. In queste api colpiva subito la grandezza. Certo non erano come quelle incontrate da Gulliver a Brobdingnag e contro le quali si difese col pugnale, però erano di molto più grosse di un'ape e persino di un calabrone. Avevano press'a poco la circonferenza di una noce ancora nel mallo. Le ali non erano mobili come negli uccelli o negli insetti, ma giravano intorno al corpo in un orlo rigido, piuttosto come un piano destinato a stabilire l'equilibrio o a sollevare l'automa.
La grandezza dava meno nell'occhio di quel che si potrebbe pensare, infatti l'animale era assolutamente trasparente. L'impressione che ne ebbi mi venne soprattutto dai riflessi provocati dai suoi movimenti alla luce del sole. Quando stava come in quel momento, davanti a un fiore di convolvolo, di cui penetrò il calice con la proboscide formata da uno scandaglio di vetro, era quasi invisibile.
Lo spettacolo mi avvinse in un modo che mi fece dimenticare il luogo e l'ora. Un simile stupore ci prende quando ci viene mostrata una macchina nella cui forma e nel cui modo di funzionare si rivela una nuova trovata. Se un uomo della prima metà dell'ottocento venisse portato per magia a uno dei nostri grandi incroci, il movimento gli darebbe la sensazione di una confusione monotona. Dopo un periodo di sbalordimento comincerebbe a capire, o a sospettarne le regole. Saprebbe distinguere le motociclette dalle vetture per il trasporto delle persone e delle merci.
Così accadde a me quando compresi che quella non era una nuova specie zoologica, ma un meccanismo. Zapparoni, quell'uomo diabolico, aveva ancora una volta invaso il campo della natura, o piuttosto ne aveva corretto le imperfezioni, abbreviando e accelerando il viaggio dell'ape al lavoro.
Mossi attentamente il binocolo per seguire le sue creature che guizzavano nello spazio come diamanti lanciati da robuste fionde. Ne udivo il sibilo, che si interrompeva bruscamente quando frenavano di colpo davanti ai fiori. E dietro di me, presso le arnie ora in piena luce, si moltiplicava in un sibilo chiaro e ininterrotto. Doveva essere costato sottili studi evitare gli urti nei punti dove gli sciami si ammassavano negli intervalli di volo.
Il procedimento, devo riconoscerlo, mi colmava di quel piacere suscitato in noi dalle soluzioni tecniche, che è anche un riconoscimento tra iniziati: qui trionfava lo spirito del nostro spirito. Mi accorsi di diverse specie di automi che pascolavano nei campi e nei cespugli. Animali forniti di particolare vigore portavano un intero gruppo di pungiglioni che tuffavano negli umbrelli e nei grappoli di fiori. Altri erano armati di braccia prensili, che posavano come delicate pinze intorno ai fasci di fiori per spremerne il nettare. Altri apparecchi mi rimanevano incomprensibili. Comunque Zapparoni aveva in quell'angolo un campo di esperimento per brillanti trovate.
Il tempo passò a volo mentre mi dilettavo di quello spettacolo. Gradualmente penetrai nella costruzione, nel sistema dell'invenzione. Gli alveari erano disposti in lunga fila davanti al muro. In parte erano di forma tradizionale, in parte trasparenti, fatti, sembrava, della medesima sostanza delle api. I vecchi alveari erano abitati da api naturali. Probabilmente questi sciami erano lì soltanto per dimostrare la grandezza del trionfo sulla natura. Zapparoni aveva certamente fatto calcolare quanto nettare uno sciame può produrre al giorno, all'ora, al secondo. Ora lo collocava sul campo sperimentale accanto agli automi.
Ebbi l'impressione che egli avesse posto in imbarazzo gli animaletti dalla economia antidiluviana, infatti ne vidi spesso qualcuno volarsene via da un fiore che prima era stato toccato da un concorrente di vetro. Se invece il calice era stato visitato prima da un'ape vera, vi rimaneva sempre un piccolo dessert.
Da questo conclusi, senza alcuna difficoltà, che le creature di Zapparoni procedevano in modo più economico, cioè succhiavano in modo più esauriente. O forse, la forza vitale dei fiori si esauriva dopo che erano stati toccati da un pungiglione di vetro?
Comunque sia, l'evidenza insegnava che questa era un'altra delle fantastiche invenzioni di Zapparoni. Osservai poi il movimento davanti alle costruzioni di vetro che rivelava un metodo complesso. Credo che sia stato necessario l'intero corso dei secoli sino ai tempi nostri per indovinare il segreto delle api. Dell'invenzione di Zapparoni acquistai, dopo averla contemplata dalla mia poltrona soltanto forse un'ora, una concezione già precisa.
Gli alveari di vetro si distinguevano a prima vista dagli antichi per il grande numero di aperture. Non somigliavano tanto ad apiari quanto a centrali automatiche di telefoni. Non avevano poi autentiche aperture, infatti le api non vi entravano. Non vedevo dove si riposavano o venivano fermate o dove avevano la rimessa, infatti non saranno sempre state al lavoro. In ogni caso nell'arnia non avevano nulla da cercare.
Le aperture avevano piuttosto qui la funzione che hanno nei distributori automatici o quella dei fori di contatto in una presa elettrica. Le api vi si avvicinavano, attirate magneticamente, vi introducevano il pungiglione vuotandovi il nettare di cui avevano piena la piccola pancia. Poi ne venivano allontanate con forza quasi come proiettili. Era un prodigio che in questi viavai, nonostante la grande velocità del volo, non avvenissero urti. Sebbene la manovra fosse compiuta con un grande numero di unità, avveniva con perfetta precisione; doveva esservi un principio centrale che la dirigeva.
Evidentemente il procedimento naturale era stato semplificato. Così ad esempio era risparmiato tutto quanto riguardava la produzione della cera. Non c'erano né grandi né piccole celle e nulla che stabilisse la differenza tra i sessi, ogni cosa raggiava di uno splendore perfetto ma completamente privo di erotismo. Non c'erano né uova né larve, né fuchi né regine. Se ci si voleva attenere a una stretta analogia, Zapparoni aveva approvato e sviluppato soltanto un alveare di operaie neutre. Anche su questo punto aveva semplificato la natura, la quale già con l'uccisione dei pecchioni aveva osato una iniziativa economica. Sin dall'inizio egli aveva escluso maschi e femmine, madri e nutrici.
Se mi rammento bene, il nettare che le api succhiano dai fiori subisce diverse trasformazioni nel loro stomaco. Zapparoni aveva tolto anche questa fatica alle sue creature sostituendola con una chimica centrale. Vedevo come il nettare incolore iniettato attraverso i fori veniva raccolto in un sistema di tubi di vetro, nei quali gradualmente cambiava colore. Intorbidato sulle prime da una sfumatura di giallo, diveniva color paglia e arrivava al fondo con una stupenda tinta di miele.
La metà inferiore dell'apparecchio serviva da serbatoio o luogo di raccolta, che si riempiva a vista d'occhio della deliziosa sostanza. Potevo seguire l'aumento sulla misura incisa nel vetro. Se col binocolo osservavo i cespugli intorno e il fondo del prato, e poi riportavo lo sguardo sugli apparecchi, vedevo che il deposito del miele era salito di diverse linee.
Presumibilmente l'aumento e in genere il lavoro non venivano osservati soltanto da me. Distinsi un'altra specie di automi che oziavano davanti agli apparecchi o anche aspettavano come fanno i sorveglianti o gli ingegneri in una officina o in un cantiere di costruzione. Si distinguevano facilmente dagli altri perché erano color fumo.
Capitolo XIII.
Tutto preso da quello spettacolo, avevo completamente dimenticato che aspettavo Zapparoni. Però egli era presente come capo invisibile. Sentivo la potenza sulla quale lo spettacolo era fondato. Nel regno della tecnica, la tecnica diventava magia e non avvinceva tanto per il suo valore economico, e nemmeno per il suo significato politico, quanto per la parte di divertimento che vi si scopriva. In questi casi ci si accorge che siamo presi in un gioco, anzi in una danza dello spirito, che nessun'arte del calcolo può afferrare. Possiamo ricorrere soltanto all'intuizione, a un appello del destino.
I lineamenti del gioco sono più palesi nelle piccole che nelle forme gigantesche del nostro mondo. Agli occhi grossolani ha valore soltanto l'immenso, soprattutto quando è accompagnato dal moto. Eppure una zanzara ha tanti organi quanto il leviatano.
Era questo che mi avvinceva tanto al campo sperimentale di Zapparoni, così come dimenticai il luogo e il tempo come un bambino a scuola. Non pensai nemmeno che forse vi poteva essere pericolo: infatti spesso gli automi mi sibilavano accanto come proiettili. Si irradiavano fuori dagli alveari a fasci, per gettarsi sulla variopinta flora come un tessuto lampeggiante, e poi tornavano in rapido volo, frenavano, attendevano in fitto sciame che una raccoglitrice dopo l'altra venisse chiamata da impercettibili richiami, da invisibili segnali in rapido ritmo perché consegnasse il suo raccolto. Era uno spettacolo che affascinava e ipnotizzava insieme, e cullava la mente. Non sapevo che cosa mi stupisse di più, se la ingegnosa invenzione dei singoli corpi o il loro gioco combinato. Forse più di tutto mi deliziava la forza danzante dello spettacolo, potenza concentrata in ordine superiore.
Non vorrei trascurare una circostanza caratteristica di simili scoperte. Dopo avere osservato per un'ora intera con grande tensione tutte quelle evoluzioni, credetti di comprendere, non il segreto tecnico, ma il sistema dell'invenzione. Subito dopo, ne iniziai anche le critiche e meditai sui miglioramenti. Questa inquietudine, questa scontentezza è strana, sebbene conti fra le nostre caratteristiche. Supponiamo che in Australia ci capitasse di incontrare un genere di animali mai veduto, certo ci colpirebbe lo stupore, però non ci metteremmo subito a riflettere sul modo di perfezionarli. Questo indica la differenza dell'autorità creativa.
La critica è uno dei tratti fondamentali del nostro mondo; è in armonia col movimento. Entrambi sono indipendenti l'una dall'altro. Se la critica diminuisse, aumenterebbe la quiete dello spirito, e l'intelligenza diminuirebbe a beneficio dello sviluppo materiale. Intanto il processo non si lascia dirigere né in un senso né nell'altro: questo significa che sono in gioco potenze superiori.
Oggi ogni ragazzo al quale si regali una motocicletta fa della critica tecnica. Per l'invenzione di Zapparoni, dopo il primo stupore si presentava la questione del costo. Le creature di vetro davano l'impressione di automi di lusso: ciascuna doveva costare quanto una buona automobile, magari addirittura quanto un aeroplano. Certo dopo che fossero state perfezionate, Zapparoni le avrebbe prodotte in serie, come accadeva per tutte le sue invenzioni. Evidentemente con quello sciame, anzi forse con una sola ape di vetro, poteva in una giornata di primavera guadagnare più che con uno sciame naturale in un anno intero. Probabilmente potevano lavorare anche con la pioggia e di notte. Ma come gareggiare con la regina delle api, la Grande Madre, che ne partorisce a migliaia?
E inoltre le api non sono soltanto operaie in una fabbrica di miele. Senza pensare alla loro completa autonomia, il loro lavoro oltre all'utile manifesto ha una parte nei piani cosmici: comprende la loro funzione di messaggeri d'amore, che trasportano il polline, fecondano i fiori. Le vitree collettive di Zapparoni mi avevano dato l'impressione di succhiare i fiori senza riguardo e di usare loro violenza. Dove avessero scacciato i vecchi sciami, la conseguenza doveva per forza essere prima un cattivo raccolto, poi una misera fioritura e infine il deserto. Dopo alcune grandi incursioni non ci sarebbero più stati né fiori né miele, e anche le api si sarebbero spente, come si spengono balene e cavalli. E allora sarebbe stata ammazzata la gallina che aveva fatto le uova d'oro, abbattuto l'albero che dava le mele.
Bene, il miele era un cibo squisito, ma se si voleva accrescerne la produzione, non era faccenda che riguardava l'industria degli automi. Era piuttosto compito della chimica. Pensai ai laboratori, che avevo veduto nella Provenza, magari a Grasse, dove si estrae la sostanza profumata da milioni di fiori. Là c'erano foreste di aranci amari, campi pieni di violette e tuberose e azzurre piante di spigo che pendevano nella macchia. Con simili sistemi si poteva ottenere probabilmente anche il miele. Si potevano sfruttare i prati come i giacimenti di carbone, dai quali si trae non soltanto una sostanza combustibile, ma anche innumerevoli prodotti chimici, essenze, colori, medicine d'ogni specie, anche fibre tessili, conduttori elettrici ed elettronici. Mi sorprende che non vi avessero già pensato.
Naturalmente Zapparoni aveva meditato la questione delle spese già da molto tempo, altrimenti sarebbe stato il primo miliardario che non sapesse calcolare con la massima precisione. Già molti hanno imparato a proprio danno, quanto conosca bene il valore dei centesimi la gente ricchissima. Non sarebbero mai diventati così ricchi se fosse mancato loro quel dono.
C'era dunque da supporre che lo stabilimento avesse un significato, al di fuori della solita economia. Poteva essere il giocattolo di un nababbo, col quale si dilettava quando tornava dal campo da golf o dalla pesca. In un'èra della tecnica ci sono molti giocattoli tecnici. Addirittura dei milionari si sono già rovinati con simili giocattoli. Nel gioco non si stringono i cordoni della borsa.
Però la supposizione era troppo inverosimile, infatti se Zapparoni voleva sprecare tempo e danaro per i suoi menus plaisirs, il cinema gli offriva abbondanti occasioni. La Zapparoni Film era la sua grande passione personale. Là egli osava esperimenti che avrebbero portato ogni altro uomo all'asilo dei poveri. Così l'idea di far recitare degli automi, era naturalmente vecchia e nella storia del cinema era stata sperimentata molte volte. Però che fossero automi quelli così presentati, non era mai stato nascosto, quindi i tentativi si erano limitati al fiabesco o al grottesco, ad effetti consueti nel teatro delle marionette o della vecchia lanterna magica. Zapparoni invece voleva realizzare l'automa nel senso antico, l'automa di Alberto Magno o del Regiomontano. Voleva uomini artificiali in grandezza naturale, figure simili agli esseri umani. Tutti si erano divertiti a quell'idea, se n'erano sdegnati e l'avevano dichiarata la trovata di cattivo gusto di un uomo immensamente ricco.
Eppure tutti avevano sbagliato, infatti già la prima di quelle opere aveva fatto furore. Era una commedia di lusso per marionette senza marionettista e senza fili, la «prima» non soltanto di un nuovo lavoro ma di un nuovo genere d'arte. Certo le figure erano ancora un po' diverse dagli esseri umani, ma a loro vantaggio. Le facce erano più luminose, più immacolate, gli occhi avevano il taglio più grande, erano più simili a pietre preziose, i movimenti più lenti, più nobili e nel turbamento più rapidi, più violenti. E anche il brutto, l'anormale era interpretato in modo nuovo, piacevole o terrificante, ma sempre affascinante. Un Caliban, uno Shylock, un Quasimodo come Zapparoni lo presentava, non poteva esser stato generato in nessun letto, partorito da nessuna donna, per quanto strane fossero le strade in cui si fosse smarrita. E tra questi potevano esservi puri esseri magici, Golia, il nano Naso, l'archivista Lindhorst, l'Angelo dell'Annunciazione, trasparente, così che attraverso il suo corpo e le sue ali si vedevano gli oggetti.
Si poteva dunque dire che queste figure non imitavano semplicemente l'essere umano, ma lo conducevano oltre le sue possibilità, fuori delle sue dimensioni. Le voci giungevano a un'altezza che svergognava ogni usignolo, a una profondità che svergognava qualsiasi basso; movimenti ed espressioni rivelavano che la natura era stata studiata e superata.
L'impressione fu straordinaria. Si ammirava oramai con infatuazione ciò che alla vigilia si era deriso. Non voglio ripetere quel che affermavano i panegiristi. Vedevano nel nuovo teatro delle marionette una nuova opera d'arte che presentava tipi ideali. Certo bisognava tener conto dell'ingenuità dello spirito di allora, che afferrava le più audaci invenzioni come la bambina la sua bambola. I giornali compiangevano il destino di un giovane che si era gettato nel Tamigi. Aveva preso un'eroina di Zapparoni per una donna di carne e ossa e non aveva saputo sopravvivere al dolore. La direzione espresse il suo rammarico e lasciò trasparire che non sarebbe stato inconcepibile che la giovane robot avesse ascoltato il giovane. Egli aveva agito con troppa fretta, non aveva afferrato tutte le possibilità della tecnica. In ogni caso il successo fu tremendo e certamente coprì le spese. Zapparoni aveva la mano d'oro.
No, chi sapeva giocare con uomini artificiali, aveva un passatempo sufficiente. Non aveva bisogno di divertirsi con api di vetro. Quello in cui mi trovavo non era un cortile di ricreazione. Infatti vi sono altre regioni dove il danaro perde la sua importanza. Dovetti pensare alla conversazione col brasiliano che mi aveva detto una volta: «Non è ancora deciso chi sulla terra avrà il sopravvento, se l'uomo o la formica».
Certo, che quelle api di vetro raccogliessero miele, era un gioco. Era un compito assurdo per opere d'arte. Intanto con esseri capaci di questo, si poteva tentare quasi ogni cosa. Per quegli automi era più facile riportare granelli d'oro e diamanti che il nettare attinto dai fiori. Però anche per i migliori affari sarebbero costati troppo. Le assurdità economiche si compiono soltanto dove è in gioco la potenza.
E veramente il padrone di quegli sciami era un uomo potente. Era forse più potente di un altro che comandasse a un uguale numero di aeroplani. Davide era più forte, più intelligente di Golia.
© Paolo Melandri (7. 4. 2019)
*
Giochi africani
È un avvenimento bizzarro come la fantasia, simile a una febbre i cui germi sono apportati da lontano, prende possesso della nostra vita e si insedia in essa sempre più profondamente e ardentemente. Alla fine soltanto l'immaginazione ci pare l'unica realtà e la vita di tutti i giorni un sogno, nel quale ci muoviamo svogliati, come un attore turbato dal suo ruolo. È allora venuto il momento in cui il crescente disgusto fa appello alla ragione e le pone il compito di cercare una via d'uscita.
Questo era il motivo per cui la parola «fuggire» aveva per me una melodia particolare, giacché non si poteva dire che vi fosse un particolare pericolo che giustificasse la sua applicazione; a parte forse gli insegnanti, i quali mi trattavano come un sonnambulo e le cui lamentele si accumulavano, diventando piuttosto minacciose nelle ultime settimane.
«Berti, tu dormi, Berti, tu sogni, tu sei nelle nuvole», era un eterno ritornello. Anche i miei genitori, che vivevano in campagna, avevano già ricevuto qualcuna delle ben note lettere, il cui sgradito contenuto iniziava con le parole «Il Vostro figlio Alberto Berti...»
Queste lamentele erano però non tanto la causa quanto la conseguenza della mia decisione; o meglio, le due cose si trovavano in quel rapporto di interazione, che suole accelerare i movimenti scoscesi. Da mesi vivevo in una eccitazione segreta, che in quegli ambienti difficilmente può passare inosservata. Così ero già arrivato al punto di non partecipare affatto alle lezioni, sprofondandomi invece in descrizioni di viaggi in Africa che sfogliavo sotto il banco. Quando mi veniva rivolta una domanda, dovevo superare tutti quei mari e quei deserti prima di dare alcun segno di vita. In fondo ero presente solo come rappresentante di un lontano viaggiatore. Mi piaceva anche, simulando un improvviso malore, uscire dalla classe e passeggiare sotto gli alberi del cortile scolastico, lì riflettevo sui particolari del mio piano.
L'insegnante di classe aveva già adottato nei miei confronti il penultimo dei provvedimenti educativi, che vuole indicare la definitiva separazione; mi trattava come fossi aria, mi «puniva ignorandomi». Che anche questo castigo non avesse effetto era un brutto segno, un segno di quanto io fossi già assente. Questo isolamento attraverso il disprezzo mi era anzi gradito, perché mi circondava di un vuoto, nel quale mi dedicavo indisturbato ai miei preparativi.
Vi è un tempo in cui il mistero appare raggiungibile al cuore solo nello spazio, solo nelle bianche macchie della carta geografica, e in cui tutto ciò che è oscuro e sconosciuto ha una potente attrattiva. Lunghi, ebbri sogni ad occhi aperti durante le mie passeggiate notturne sui bastioni mi avevano tanto avvicinato a quei lontani Paesi, che pareva ormai sufficiente la sola decisione per penetrare in essi e godere dei loro piaceri. La parola giungla racchiudeva in sé tutta una vita, la cui prospettiva è irresistibile a sedici anni; una vita da dedicare alla caccia, alle ruberie e a straordinarie scoperte.
Un giorno ebbi la certezza che il giardino perduto era celato nel delta superiore del Nilo o del Congo. E poiché la nostalgia per quei luoghi è fra le più difficili cui resistere, cominciai a nutrire innumerevoli, pazzi progetti su come ci si potesse meglio avvicinare alle regioni delle grandi paludi, della malattia del sonno e del cannibalismo. Covavo pensieri quali tutti conoscono certo dai loro più lontani ricordi: volevo farmi strada come clandestino, mozzo o travestito da apprendista artigiano girovago. Ma infine decisi di arruolarmi nella Legione Straniera, per raggiungere così almeno i margini della Terra promessa e penetrare poi da solo all'interno; naturalmente non senza aver prima partecipato ad alcune battaglie, ché il fischiare delle pallottole mi sembrava una musica di più alte sfere, della quale si legge solo nei libri, e per partecipare alla quale bisognava andare in pellegrinaggio, come gli americani a Bayreuth.
Ero dunque pronto a prestare giuramento su qualsiasi pelle di vitello del mondo, se essa mi avesse portato fino all'equatore come il mantello magico di Faust. Ma in fondo neanche la Legione Straniera apparteneva alle forze oscure che basta evocare al primo crocevia quando si voglia patteggiare con esse. Da qualche parte doveva esserci, questo era certo, perché abbastanza spesso leggevo sui giornali i resoconti di pericoli eletti, rinunzie e crudeltà che un abile pubblicista non avrebbe saputo descrivere meglio per attirare fannulloni del mio tipo. Avrei dato molto perché uno di questi ingaggiatori, che ubriacano e rapiscono i giovani, e contro i quali mettevano spesso in guardia, mi si fosse avvicinato; ma mi pareva alquanto improbabile che ciò accadesse nella nostra cittadina nella valle, tanto pacifica e addormentata.
Così mi sembrò più giusto passare prima di tutto la frontiera, per compiere in tal modo il primo passo dall'ordine al disordine. Mi immaginavo che il meraviglioso, il regno delle coincidenze e degli avvenimenti favolosi dovesse rivelarmisi sempre più chiaramente ad ogni passo, se avessi avuto il coraggio di allontanarmi dalla solita vita; che l'attrazione dovesse risultare sempre più forte man mano che le si andava incontro.
Ma non mi nascondevo il fatto che ogni situazione esercita una forza di gravità non superabile con il semplice pensiero. Certo quando, per esempio prima di addormentarmi, pensavo di prendere e andarmene, nulla mi sembrava più facile che vestirmi subito, andare in stazione e salire sul primo treno. Ma appena cercavo anche solo di muovermi, mi sentivo appesantito da pesi di piombo. Questa discrepanza fra le esagerate possibilità offerte dai sogni e i limitati provvedimenti presi per la loro realizzazione mi procurava molto dispiacere. Per quanto sapessi con lo spirito vagare senza fatica per i luoghi più impervi, a mio piacimento, mi accorgevo però nello stesso tempo che nella vita reale anche il comprare un biglietto ferroviario presupponeva uno sforzo ben maggiore di quanto avessi pensato.
Quando, non abituati a tuffarsi, ci si trova su un alto trampolino, si sente fortemente la differenza fra uno che vorrebbe tuffarsi e un altro che si rifiuta di farlo. Quando il tentativo di prendere se stessi per la collottola e buttarsi giù fallisce, si presenta un'altra soluzione. Consiste nel vincersi con l'astuzia, facendo oscillare il corpo sempre più forte sull'estremo bordo del trampolino, finché ci si vede improvvisamente obbligati a tuffarsi.
Sentivo chiaramente che questi sforzi per dare a me stesso la prima spinta verso il mondo dell'avventura erano ostacolati soprattutto dalla mia stessa paura. Il mio più forte avversario ero in questo caso io stesso, cioè un tipo pigro, che amava passare il tempo fantasticando sui libri, e veder muoversi i suoi eroi in contrade pericolose, invece di mettersi in cammino nella notte e nella nebbia per fare altrettanto.
Ma vi era un altro spirito, più selvaggio, il quale mi sussurrava che il pericolo non è uno spettacolo del quale si può godere seduti in poltrona, ma che deve esservi tutt'un'altra soddisfazione nell'osare di spingersi nella sua realtà, e quest'altro spirito cercava di trascinarmi sul palcoscenico.
Spesso durante questi discorsi segreti, di fronte a queste esigenze esasperate, avevo una paura matta. Mi mancava anche il talento pratico; la prospettiva di tutti i sotterfugi e degli intrighi che avrei dovuto osare per andare avanti, mi deprimeva. Come tutti i sognatori avrei desiderato avere la lampada fatata di Aladino o l'anello di Giaunder, il pescatore, con i quali si possono evocare spiriti servizievoli.
D'altra parte la noia penetrava in me come un veleno mortale, ogni giorno di più. Mi sembrava assolutamente impossibile “diventare” qualcosa; già la parola mi ripugnava, e dei mille impieghi che la civiltà può offrire, nemmeno uno mi sembrava adatto a me. Piuttosto mi attiravano le attività molto semplici, come quella del pescatore, del cacciatore o del boscaiolo; però da quando avevo sentito dire che i guardiaboschi oggi sono diventati degli impiegati contabili, che lavorano più con la penna che con il fucile, e che i pesci si pescano con la barca a motore, anche questo mi era venuto a noia. Mi mancava in queste cose la minima ambizione, e a quei discorsi, che i genitori sogliono fare ai figli sulle prospettive delle diverse professioni, assistevo come uno che deve essere condannato al carcere.
Di giorno in giorno si rafforzava la ripugnanza verso ogni cosa utile. La lettura e i sogni costituivano l'antidoto; ma le regioni in cui era possibile agire sembravano irraggiungibili. Là mi immaginavo un'audace società di uomini, il cui simbolo era il fuoco, il cui elemento era la fiamma. Per essere accolto in essa, o anche solo per conoscere un uomo di fronte al quale provare rispetto, avrei volentieri rinunciato a tutti gli onori che si possono conseguire dentro e fuori le quattro facoltà.
Supponevo con ragione che fosse possibile incontrare i figli naturali della vita soltanto voltando le spalle all'ordine costituito. Certo i miei ideali erano forgiati sulla misura di un sedicenne, che non conosce ancora la differenza tra eroi e avventure e che legge cattivi libri. Ma avevo in fondo ragione, in quanto ponevo l'insolito al di là della sfera sociale e morale che mi circondava. Perciò non volevo diventare inventore, rivoluzionario, soldato o comunque un benefattore dell'umanità, come succede spesso a quell'età; ero invece attirato da una zona, nella quale si esprimeva, pura e senza scopo, la lotta delle potenze naturali.
Ritenevo questa zona reale; la identificavo con il mondo tropicale, che circonda come una cintola multicolore l'azzurra cappa di ghiaccio dei poli.
© Paolo Melandri (6. 4. 2019)
*
Un incontro pericoloso 3
Adesso erano seduti uno di fronte all'altra davanti al caminetto a gas. Dai ciocchi di rame perforato guizzavano fiammelle azzurre. Per la prima volta avevano agio di contemplarsi – così come si guardano bei quadri o delle fotografie. Irene era stata una bambina solitaria. Ogni volta che riceveva una nuova bambola, si rintanava in un angolo per poterci giocare come più le piaceva, senza testimoni né spettatori. E ora si beava della stessa sensazione di possesso che allora la coglieva con tanta intensità.
La sventura di questa bella creatura era dovuta al suo indugiare, dal punto di vista spirituale, nell'età infantile – e in questo senso Eraldo le era affine. Il loro era un incontro tra fanciulli, non tra persone adulte. Quando Irene aveva visto per la prima volta il capitano in casa di suo padre, aveva saputo che tutt'a un tratto si faceva sul serio. Fino a quel momento non aveva mai immaginato che uno sguardo potesse essere tanto potente. L'aveva appreso dal colloquio con Kargané – con un senso di costernazione, come se una nave pirata si smascherasse e lasciasse rifulgere i suoi cannoni. Com'era possibile che quegli occhi si tramutassero in due luci che crudelmente, con spudorata consapevolezza, penetravano in lei? E, cosa ancor più incomprensibile, lei aveva risposto all'istante, aveva detto sì a quella domanda con la medesima consapevolezza, la medesima mancanza di pudore. Era stata la fiamma che segue la folgore. Con questo tutto era stato deciso; non c'era più modo di ribellarsi. In fondo il capitano l'aveva presa come un pascià; la costrizione che lui esercitava era più forte di tutte le catene dell'Oriente.
Fin dall'inizio Irene si era dibattuta contro quel dominio. Poteva essere conquistata, ma non vinta. Ogni nuova presa di possesso rafforzava anzi la sua resistenza, che si addensò fino all'odio. Ma con esso crebbe anche la sua gelosia.
Com'era diverso l'idolo che custodiva nel suo intimo e a cui sacrificava nei suoi sogni. Gli si era soprattutto avvicinata nel periodo in cui mandava ogni giorno fiori e frutta al giovane Coquelin, come una pastorella che depone i suoi doni davanti a un'immagine sacra. Non appena entrava in scena l'attore, lei era colta da un lieto sgomento che la trasportava fuori della realtà. Nel teatro si sarebbe sentita volare una mosca quando Coquelin veniva alla ribalta con le sue movenze libere e leggere. Irene doveva chiudere gli occhi – quella era l'apparizione; il suo sacrificio era stato premiato.
Cercava di dimenticare quanto era successo dopo. La sua rovina consisteva nel fatto che dall'ideale si aspettava cose reali, e dal reale la trascendenza. È un male universale, squisitamente umano – solo che in lei attingeva livelli maniacali. Così Irene oscillava costantemente tra l'aspettativa e la delusione.
Mentre contemplava Eraldo, questi si fondeva nella sua mente col giovane attore così com'era quando ancora non l'aveva delusa. Stavolta avrebbe condotto la cosa a buon fine; non avrebbe più sentito la mancanza di Kargané – al contrario, sarebbe andata in viaggio anche lei, appunto con Eraldo. Per cominciare avrebbe fatto in modo che egli assumesse l'aspetto esteriore che piaceva a lei; come allievo sarebbe stato docile. Già lo vedeva comparire nella terrazza mentre i cavalli aspettavano in strada. Ad un tratto sentì il desiderio di carezzargli i capelli, di occuparsi di lui con tenera premura. Gli prese la mano.
“Eraldo – posso chiamarla così, non è vero? – sapesse come sono contenta che lei sia venuto”.
Per Eraldo, che conduceva una vita di puro sogno, fu come destarsi a una più alta realtà; com'era lieve e insieme delizioso il peso di quella mano. Una fata l'aveva cercato. Ora avrebbe udito cose meravigliose, eppure desiderava che il tempo si fermasse e tutto rimanesse com'era.
© Paolo Melandri (3. 4. 2019)
*
Un incontro pericoloso 2
Così dicendo Ducacci aveva fatto un cenno del capo in direzione di una signora che pranzava a uno dei tavolini in compagnia di un vecchio. Ettore l'aveva notata al primo sguardo: dovunque andasse, non poteva non attirare l'attenzione, e anche l'ammirazione – quella donna era bella.
La figura alta e sottile, indossava un tailleur nero che la stagliava nettamente contro il divano rosso. Teneva la testa pigramente appoggiata a una mano e sembrava prestare ascolto al suo accompagnatore anche se di tanto in tanto dava uno sguardo in giro agli altri clienti. Il volto colpiva per la sua regolarità: da lontano sembrava una maschera o una di quelle attrici che stilizzano sapientemente i propri tratti. I capelli castano scuri erano folti e aderenti al capo come la pelliccia di quegli animali che si accarezzano volentieri. Le coprivano le orecchie e metà della fronte. La linea del naso, leggermente troppo corta, dava al suo viso, specialmente quando guardava in su, un tocco di impertinenza. Di contro gli occhi erano grandi e lucenti come agate grigie incastonate nel marmo; e parevano ancora più grandi a causa delle ombre azzurre che li orlavano. La semplicissima eleganza dell'abito conferiva a quella creatura una sorta di conchiuso rigore formale che la faceva assomigliare a una gemma paga della propria luce. Contrastava nettamente con questo il suo fare distratto e trasognato.
Bellezza e inquietudine stridevano in quel volto. È sempre una disgrazia ereditare un potere senza la sicurezza che serve ad amministrarlo. Come un grande patrimonio, che è solo fonte di sventure se colui che lo possiede è un prodigo, così la bellezza può diventare pericolosa non solo per chi l'ha avuta in dono, ma anche per gli altri.
Ducacci, che conosceva bene coloro che vivono ai margini della società, coglieva al volo ogni elemento preoccupante. Sapeva che la contessa veniva preferibilmente evitata. Preoccupanti non erano quei lineamenti da grande gatta. Anche le tigri hanno le loro leggi. A mettere in guardia era un che di disordinato, una mancanza di equilibrio. Causa ed effetto malamente collegati. I processi che si svolgevano in quella testa erano imprevedibili. Le cose vi dovevano funzionare come in una stazione dove il puro capriccio decida se alzare o abbassare le sbarre, e come regolare gli scambi. Chiunque vi indugi si espone al pericolo di collisioni insensate. La bellezza era un'esca stupenda in cui si nascondeva un uncino.
Nel Medioevo un essere simile sarebbe stato sospettato di stregoneria, nel Settecento avrebbe avuto la reputazione di gran dama che agisce solamente in base al proprio arbitrio. Oggi si poteva intuire in tutto ciò una forzata debolezza. Le forme erano ormai quasi del tutto svuotate di contenuto, benché il loro aspetto esteriore sembrasse intatto. I nomi valevano ancora, i patrimoni si trasmettevano ancora per via ereditaria come ai vecchi tempi. Ma i singoli casi diventavano casi-limite in quanto da un lato erano ancora determinati dalla tradizione, e dall'altro già segnati dal declino – da quest'ultimo con maggiore ineluttabilità. Gli antichi tronchi davano ancora fiori, ma i frutti erano già sterili e ibridi.
© Paolo Melandri (3. 4. 2019)
*
La luce che filtra
Quando il mondo invecchiò e lo stupore abbandonò le menti degli uomini; quando grigie città alzarono al cielo torri cupe e spaventose all'ombra delle quali nessuno poteva sognare il sole o i prati di primavera; quando la sapienza rubò alla terra il mantello della sua bellezza e i poeti non cantarono più, se non di fantasmi contorti e dagli occhi ciechi che guardavano solo dentro se stessi, quando avvennero queste cose e le speranze della fanciullezza si furono dissipate per sempre, un uomo fece un viaggio oltre la vita e compì una ricerca negli spazi da cui i sogni del mondo erano fuggiti.
Poco si sa del nome e della famiglia di quest'uomo, perché appartenevano solo al mondo della veglia, ma si dice che fossero entrambi oscuri. Sia sufficiente sapere che viveva in una città dalle alte mura dove regnava uno sterile e perenne crepuscolo, e che lavorava tutto il giorno fra le ombre e il frastuono, per tornare a casa la sera e chiudersi in una stanza le cui finestre non davano su prati e campi, ma su un tetro cortile dove altre finestre dividevano la sua disperazione. Dall'appartamento non si vedevano che mura e finestre di altri palazzoni, a meno di non sporgersi pericolosamente per cogliere qualche stella di passaggio. E siccome un panorama di infinite mura e finestre rende pazzo chi sogna o legge molto, l'inquilino della stanza si sporgeva ogni sera a guardare il cielo, per afferrare un frammento delle cose che stanno oltre il mondo e il folle grigiore dei grattacieli. Dopo alcuni anni imparò a chiamare per nome le stelle che passavano su di lui e a seguirle con la fantasia quando scomparivano dalla vista; finché, alla fine, la visione si estese e fu in grado di percepire cose che l'occhio comune non sospetta. E una notte il grande abisso fu superato, i cieli stregati dai sogni premettero alla finestra dell'osservatore solitario e si mescolarono con l'aria della stanza, facendo di lui una parte del meraviglioso.
Scesero nella stanza rivoli di luce purpurea a mezzanotte, misti a polvere d'oro: vortici di fuoco e luce che filtravano dagli ultimi spazi e portavano profumi al di là dei mondi. Mari oppiacei si riversarono dalle finistre, illuminati da soli che l'occhio umano non vedrà mai e che portavano nell'abbraccio delle onde strani delfini e ninfe di immemorabili profondità. L'infinito si stese silenzioso intorno al sognatore e lo portò via senza nemmeno sfiorare il corpo che penzolava, tutto irrigidito, dalla finestra solitaria; e in un tempo che il calendario degli uomini non sa contare le maree dell'infinito spinsero il visionario verso i sogni che desiderava, quelli che gli uomini hanno perduto. E per molti cicli lo lasciarono a dormire teneramente su una spiaggia verde illuminata dal sole; una spiaggia verde che profumava di fiori di loto ed era punteggiata di fiori rossi.
© Paolo Melandri (31. 3. 2019)
*
Un incontro pericoloso
Era la prima domenica di settembre, una giornata azzurra. Spesso in quest'epoca lo splendore dell'estate concentra le sue forze in un'ultima festa prima che avvampino i colori autunnali. Le notti sono più fresche; così l'alba si bagna di rugiada e la mattina è tiepida e gradevole. Il fogliame degli alberi si è scurito; si staglia contro il cielo come un metallo a sbalzo. Anche nelle città si attenua la calura; e vi penetra un'aura di lusso e di gaiezza.
Eraldo contemplava il piccolo giardino della Trinité. I giardinieri avevano già piantato nelle aiole i primi fiori dell'autunno. Su una bordura sottile fioriva ancora, drizzandosi da un tenero verde, la canna d'India. La sua fascia era interrotta da aiole circolari su cui sorgeva un astro azzurro dalle molte stelle. Le infiorescenze rifulgevano al sole. Sciami d'api e di moscerini le avvolgevano ronzando. Una vanessa a bande rosso brune riposava sul cuscino di un fiore. Ruotava senza fretta sul suo velluto e apriva le ali a pigri intervalli. Era certo venuta da lontano, superando in volo tetti altissimi. Un'altra vanessa si unì a lei. Le due farfalle cominciarono a descrivere dei cerchi e si levarono in alto fino a svanire del tutto nell'azzurro.
Da Saint-Lazare si udivano voci acute, infantili; erano gli strilloni dei giornali della domenica. Le campane si misero a suonare, e una folla vestita a festa uscì dal portale della chiesa dirigendosi verso le vetture che attendevano sulla piazza. Era un corteo nuziale. Chicchi di riso furono sparsi sul tappeto davanti alla giovane coppia. A quella vista Eraldo si riscosse dall'oziosa contemplazione in cui era irretito. Si mescolò ai passanti che confluirono insieme per poi tornare a disperdersi non appena le vetture si misero in moto. Poi, come uno cui non importi affatto imboccare una strada piuttosto che un'altra, svoltò nella Rue Blanche e si avviò pigramente su per la collina.
All'ombra delle case faceva più fresco; le strade erano state innaffiate da poco. L'acqua scorreva a valle dai bordi dei marciapiedi. Il quartiere, solitamente animato da una chiassosa alacrità, quel mattino era più tranquillo; mancavano i venditori ambulanti che offrivano per le strade pesce, frutta e verdura. Oggi si vedevano solo i chioschi dei fiorai. La città sembrava più vuota e perciò più solenne; gran parte della popolazione si trovava in riva al fiume oppure nei sobborghi. Si vedevano ancora le ultime carrozze uscire dalla città; erano cariche fin sul tetto di giovanotti accompagnati da ragazze in abiti variopinti. A mezzogiorno sarebbero stati in mezzo al verde e non sarebbero rientrati che a tarda sera. Qui i cavalli andavano al passo; gli zoccoli sdrucciolavano sul ripido selciato.
Per quanto abitasse nella città da oltre un anno, ciascuna di queste passeggiate era per Eraldo un'esperienza arcana. Quasi non gli sembrava di aggirarsi per piazze e strade, pensava semmai di percorrere le fughe di stanze e i corridoi di una grande casa sconosciuta, o anche di errare in cunicoli scavati in una roccia stratificata. In certe viuzze e a certi incroci l'incantesimo era più forte che mai. Eraldo non riusciva veramente a farsene una ragione. Più che i monumenti e i palazzi, testimoni di un antico passato, lo commuoveva l'anonima vita che aveva fatto sì che questa capitale somigliasse a un banco di corallo – la materia prima del suo destino. Perciò si sentiva a suo agio specialmente nei quartieri che erano cresciuti contro tutte le regole dell'architettura e si erano conglomerati nel corso dei secoli. Un'infinità di sconosciuti avevano vissuto, sofferto e gioito in quei quartieri. Un'infinità di persone abitavano ancora su quel suolo. La loro vita si era trasmessa alla malta. Era una forza incredibilmente concentrata, addirittura prodigiosa. E lui era sempre animato dalla sensazione che quel prodigio potesse prender forma da un istante all'altro: attraverso una lettera, un messaggio, un'avventura o un incontro di quelli che si vivono nelle grotte e nei giardini delle fate.
Durante queste passeggiate egli si sentiva invaso da una grande tenerezza. Era accordato come una corda lenta, che quasi non ha bisogno di una mano che la suoni. Un alito di vento, un raggio di sole bastavano a farla vibrare. L'inviolato lo avvolgeva come un bagliore che si fa visibile anche agli occhi più ottusi.
© Paolo Melandri (31. 3. 2019)
*
Il venditore ambulante
Il venditore ambulante posa il piede sulla carta che svolazza.
Si informa sulla via da percorrere, poi, stupito dai gesti con cui l'interpellato gliela indica, si dimentica di ascoltare la risposta. Le unghie penetrano nel palmo della mano. Non può accadere nulla. Ha il tempo di stupirsi. In un giorno simile nessuno pensa alla morte. Dalla baracca del pietrisco sporge un manico di badile. La strada non è vuota. Il venditore ambulante scorge una pietra grande come il pugno di un bimbo. Il cuoio capelluto si contrae. Nessuno si terge in fretta il viso con il fazzoletto. Il marciapiede è abbastanza alto sopra il livello della strada. Il cappotto dell'ambulante gli arriva alle caviglie. Dalla fessura sotto la porta del nogozio filtra schiuma di sapone. La bottiglia nell'acqua in posizione quasi verticale. Finestre si alternano a porte.
Egli vede la gente con maggior chiarezza del solito. L'unghia gratta la stoffa, trova i bottoni. L'ambulante muove le gambe con naturalezza. I sedili dell'automobile formano una linea perfetta. La strada è stata innaffiata da poco. Egli scopre davanti a sé, con sorpresa, le proprie ginocchia. Le finestre brillano. Scuote incredulo la testa. Solo una scarpa è lucida, l'altra è ancora impolverata. I pensieri lo aggrediscono. Un chiodo, nel conficcarsi, si è piegato!
Il venditore ambulante bussa nel muro con una matita. Senza una ragione, ma incapace di fare altro, osserva la vecchia seduta su uno sgabello davanti alla porta di casa.
Tra le case cammina diversamente che in aperta campagna. La mano che ha portato la valigia trema. La porta della cabina telefonica è chiusa. È una bella mattina. Dopo il primo rintocco, aspetta il secondo con ansia. Le punte delle scarpe guardano all'insù!
Non si volta né a sinistra né a destra. Le mani che poggiano sul volante sono avvolte in guanti di pelle. Non riesce ad immaginarsi che qualcuno possa gridare, ora. Gli oggetti non lo rendono inquieto, ma neppure lo distraggono. Fin dove giunge il suo sguardo, la terra è intatta. Ha con sé solo oggetti personali. I suoi abiti sono più adatti all'oscurità che alla luce del giorno. I suoi capelli sono arruffati, e non c'è vento. Le persone che incontra lo guardano da capo a piedi. Quando scorre verticalmente, il rivoletto diviene più sottile. Il venditore ambulante sta in ascolto. Tutti gli angoli delle case sono arrotondati. Improvvisamente, la strada davanti a sé, prova repulsione per ogni lontananza. Forse la corda è sfuggita di mano a chi mette in azione la campana. Perché proprio adesso la stringa si deve slacciare di nuovo? Stendono un copertone sopra la macchina. Ci sono innumerevoli direzioni. Le unghie prudono. Due vecchie segano un grosso tronco.
Adesso ha bisogno di una diversione. Per terra, improvvisamente, il tubo di gomma si tende. Le tasche del cappotto sono così ampie e profonde che non riesce a sentirci dentro le mani. Barcolla di proposito. I muri delle case non recano segni né disegni. Ogni cosa è al suo posto. Il venditore ambulante ha un sorriso maligno. Un pesante giornale sta appeso all'edicola con una molletta. La ruota è ben appoggiata al muro. Lui sbadiglia camminando. Le immagini si deformano ogni volta che inspira. Il corpo rifiuta qualunque cosa vedano gli occhi. I tronchi, sul camion, rimbombano. Non sa dove mettere le mani. La donna pulisce la maniglia con lo strofinaccio. Il primo scoppio dell'accensione difettosa lo spaventa. A ogni parola che sente, ne segue un'altra.
Ha camminato tanto, che tutte e due le stringhe si sono slacciate. Sul ricevitore del telefono c'è ancora l'impronta di una mano sudata. Deve insistere più volte sullo stesso pensiero, fino ad annientarlo.
Espira ed inspira.
Nota che l'ordine intorno a lui sta diventando un gioco. Il tintinnio dei bicchieri è un rumore pericoloso. Quando gli rivolgono la parola risponde a gesti e a smorfie. Il riso della donna si inserisce in tutti gli altri suoni. Pur ritenendo che non farà mai conoscenza con alcuno dei presenti, l'ambulante cerca di imprimersi i loro volti nella memoria. Qua e là la strada è nera di fuliggine. Le dita che teneva serrate di sono aperte. Davanti alla porta c'è uno stivale spaiato col gambale rimboccato. Il secchio delle immondizie appare vuoto. La moneta è ancora calda.
Quel suo affannoso mescolare nel bicchiere non è che un'ammissione della sua inerzia. Per il disagio le scarpe guardano in direzioni diverse. Tutti si sono già abituati ai loro movimenti. Questo silenzio è solo il silenzio che attende una risposta. Prendono cibi pesanti. La porta si apre senza difficoltà. La mano che regge il vassoio è alta sopra la testa. La schiuma ristagna davanti a un ostacolo. D'un tratto pensare gli piace. È lo scoppio di un turacciolo!
Si toglie le scarpe sotto il tavolo. “Se si sparano palle di cannone sull'acqua, vengono fuori gli annegati.” Si rallegra della quiete. La signora toglie la schiuma dal bicchiere con uno stecco.
Il collo della sua camicia non è più immacolato.
Ci sono delle macchie sul palmo della mano.
Il grido è soltanto quel grido che precede la risata provocata da una barzelletta.
Non fa molto caldo, ma gli abiti lo opprimono. La parete della casa ha solo false finestre. La strada è molto frequentata. L'odore di sudore significa buona salute. Lei allontana i capelli dall'orecchio col pollice. Lui non può immaginarsi che un grido, di giorno, sia un grido di aiuto. Solo un lato della scatola di fiammiferi è segnato dallo sfregamento. Le parole che sente si riferiscono ai soliti argomenti. La fettina di limone ondeggia lentamente verso il fondo del bicchiere. La donna rimette la scopa al suo posto. Lui si schiarisce la gola, ma non dice nulla. Neppure i nomi degli oggetti gli vengono in mente in questo ambiente estraneo. Quando l'uomo che gli siede di fronte scoppia a ridere e getta indietro la testa, gli offre la gola indifesa.
© Paolo Melandri (30. 3. 2019)
*
Un pomeriggio
Nonostante fosse inverno, lì attorno c'era ancora qualche fioritura. Proprio perché piccoli e isolati i garofani selvatici, le margheritine, i ranuncoli e le ortiche morte ravvivavano il terreno percorso da aspri solchi. I calici dei ranuncoli, splendenti come smalto, talvolta sembravano persino raggi di sole. Dalla cima di un melo pendeva ancora qualche frutto, rosicchiato dagli uccelli, dalla polpa vitrea e ghiacciata. Le ultime foglie, appesantite dalla brina, precipitavano a terra una dopo l'altra, quasi in verticale, con uno scricchiolio. Gli amenti del nocciolo erano incolori, come contorti dal freddo. Una campanula sullo steccato e una accanto alla porta di casa erano illividite dal gelo.
All'esterno il giardino confinava con un parco alberato, ma che allo scrittore, come già altre volte nell'ora successiva al lavoro, appariva vasto e primigenio, con il sottobosco e le liane. Si girò ancora una volta verso casa. Con questo gesto gli sembrò di uscire da un'ombra. Il cielo era grigio chiaro solcato da lunghissime striscie più scure, l'insieme dava un'impressione di vastità e di altezza. Non c'era vento, ma l'aria era così fredda che gli sferzava il collo e la fronte. A una biforcazione del sentiero si fermò e rifletté sulla direzione da scegliere: in città ci serebbe stata molta gente per la vigilia di Natale, in periferia sarebbe stato solo. Nei periodi di ozio di regola andava a passeggiare in centro. Quando invece era assorbito dal lavoro, si avviava ai margini della città – dove non c'era anima viva. Almeno finora, questa regola aveva dato buoni risultati. Ma poteva dire di avere delle regole? Le poche che finora aveva cercato di darsi non erano state sempre trascurate a favore di qualcos'altro, gli umori, i casi, le ispirazioni, che a lui sembravano più utili? In realtà, già da decenni, viveva concentrato di volta in volta sulla sua mèta scrittoria; ma fino ad oggi non conosceva nessun modo affidabile di raggiungerla; in lui tutto era rimasto provvisorio com'era stato un tempo nel bambino, in seguito nello scolaro e più tardi ancora nell'esordiente: provvisoriamente abitava, lo stesso esordiente di un tempo, in questa città europea del mondo, sebbene nel frattempo avesse cominciato ad invecchiarvi, gli sembrava; soltanto provvisoriamente era tornato in patria da paesi stranieri, sempre in procinto di ripartire per luoghi lontani e vedeva come qualcosa di provvisorio anche la sua esistenza di scrittore, per quanto corrispondesse ai suoi sogni – tutto ciò che era definitivo lo inquietava da sempre. “Tutto passa?” Oppure “Nessuno si bagna nello stesso fiume?” Oppure, come suonava in origine la sua massima preferita “Sempre diverse sono le acque dei fiumi in cui ci bagnamo?” Sì, per anni si era detto e ripetuto questa frase di Eraclito, come i credenti forse recitavano il loro “Padrenostro”.
Restò fermo dinanzi all'incrocio per un tempo insolitamente lungo. Era come se lui, la cui attività non prescriveva alcuna determinata regola di vita, anche per molti movimenti del quotidiano, sia pur minimi, avesse bisogno di un'idea – e questa si formulò nel pensiero di collegare il cuore della città con il suo limite, di attraversare il centro per andare a passeggiare in periferia. Non si era forse sentito attratto dalla gente, proprio quando sedeva alla scrivania? E non si era forse anche ripromesso, pur non avendo mai mantenuto il proposito, di attraversare almeno una volta al giorno il fiume oltre il quale cominciavano i nuovi quartieri? Ora che aveva stabilito un percorso, subentrò il piacere di passeggiare.
Già nel parco alberato per lungo tempo non incontrò nessuno. Solo con la natura, dopo ore trascorse nella sua stanza, lo scrittore fu quasi sorpreso da un sentimento liberatorio di innocenza. Infine smise di rimuginare sulle frasi della mattina e abbracciò con lo sguardo la tavola illustrata a colori vivaci degli uccelli come pure i cartellini con la scritta “Faggio” e “Acero” sui rispettivi tronchi; aveva occhi solo per la corteccia liscia e chiara di un albero o per quella scura e scalfita di un altro. Guardando una dozzina di passeri, che totalmente immobili, con le penne rizzate per il freddo erano appollaiati su un ramo di quercia ancora coperto di foglie avvizzite, poteva credere alla leggenda del santo che un tempo aveva predicato a queste creature; e in realtà ora gli animali, senza muoversi dal loro posto, avvicinarono le teste, quasi aspettassero di nuovo la prima parola. Disse qualcosa, e il gruppo tra le fronde rimase in ascolto.
© Paolo Melandri (28. 3. 2019)
*
Il decennio
Fu in un chiaro crepuscolo d'inverno che capitai nel retroterra e, seguendo un avvallamento ferroviario che poi si inarcava in terrapieno, passato sotto un ponte di binari, arrivai in un luogo ampio da stropicciarsi gli occhi, per un sobborgo, e insieme particolare.
Su un lato era fiancheggiato dalla stazione, posta su una scarpata alta quanto il piano di una casa, su tutti gli altri da edifici in fila compatta, diversi da quelli di prima anche perché ciascuno era un negozio. Niente ricordava un sobborgo nel vasto quadrilatero, che spiccava dal circondario per le luci della piazza, delle vetrine, delle scritte al neon, dell'atrio della stazione, animato dai treni che arrivavano e partivano in rapida sequenza su al primo piano dell'edificio ferroviario (al secondo un appartamento con la biancheria stesa), e i passeri, alla ricerca di un posto per dormire, per il nuovo arrivato divennero percepibili dai platani esattamente come le macchine, il fischio dei treni e i giochi elettronici dei tre, quattro caffè.
Non solo per via dei tre panettieri, dei tre macellai, dei tre negozi di fiori, del cuoco vietnamita, del ristorante nordafricano, della rivendita con la stampa internazionale, questo era un centro. Qui a me accade lo stesso che al mio amico pittore diciamo a Vigo, il luogo nel quale era entrato attraverso uno specchio, la terra inesplorata, che però già da tempo immemorabile, un pianeta a parte, aveva pulsato e vibrato così, proprio come adesso al momento della scoperta; o a Filip Kobal con il suo Carso, dove lui, per metà esistenza a tu per tu con ogni mucchio di sassi, su quel piccolo altipiano che si abbracciava con lo sguardo, in una sera d'estate con un solo passo di lato capitò in un “secondo Carso”, subito accanto o dietro a quello abituale, con analoghi villaggi da deserto e il loro riflesso di notte qua e là nelle nuvole, già da sempre, ma per lui una fresca, giovane luce.
© Paolo Melandri (25. 3. 2019)
*
Il rifugio
Scomparire è ancora meglio che tuffarsi sott'acqua: al costume dei ranocchi, preferisco quello dei topi. Non penso, però, a quelli neri e grigi delle case e dei giardini, ma al topo giallo-rosso della foresta tropicale, che somiglia ad un minuscolo scoiattolo. Si nutre di noci, di cui nel primo autunno reca una provvista nel suo nido invernale. Là, dorme ben nascosto per sei mesi o più, mentre le folglie cadono sul terreno boschivo e le ricopre poi la neve.
Io ho preso le mie precauzioni secondo il suo modello. Il moscardino, o topo di nocciole, è parente della marmotta: fin da bambino mi raffiguravo la vita di questo sognatore altamente comoda. Non è un caso che, dopo la morte del padre, io mi sia smarrito in questo mondo protettore. Nella mia solitudine, nel solaio di casa, io mi tramutavo in moscardino. Per anni, esso fu il mio animale totemico.
Mi sono cercato, ai margini della foresta, un posticino per la mia tana. Il foro d'ingresso non dovrebbe trovarsi al livello del suolo, è meglio una fessura nella roccia o dentro un tronco cavo. Di là iniziai a scavare il cunicolo, giorno per giorno, sempre più in fondo, raschiando fuori il terriccio, che poi sparpagliavo perché non ne rimanesse traccia.
Una volta giunto abbastanza in fondo, scavai un secondo cunicolo verso l'alto, come uscita di sicurezza. Per ogni ingresso bisogna provvedere alla sortita, per ogni via pensare al ritorno: questo mi risultava chiaro fin da allora. Il lavoro doveva avvenire in assoluto silenzio e con cautela; dall'alto vi era di giorno la minaccia dello sparviero, e di notte del gufo, al suolo animali ostili, in primo luogo la vipera – il moscardino è sempre minacciato. È il tributo che paga alla sua libertà.
Dopo aver scavato i cunicoli, si passava all'abitazione, una comoda cameretta, non troppo piccina, né troppo grande. Che vi potesse stare anche una femmina, non mi veniva ancora in mente. Nemmeno per la mamma c'era da provvedere: era presente ovunque, era la tana stessa.
Una volta apprestata la cameretta e levigato bene il suo ovale, scavai il cunicolo di approccio alla dispensa. Questo era più grande, con una curvatura a forma di focaccia: con un granaio simile non vi sarebbe stata penuria. Non bisognava dimenticare nemmeno quel certo posticino: il moscardino è celebrato per la sua pulizia. Non ha il sentore degli altri topi, soltanto in primavera emana un profumo di muschio. Il posticino nell'inverno si sarebbe riempito di grani neri: anche in questo, non pensavo solo alla bocca, ma anche allo scarico.
Dopo la costruzione, passai all'arredamento. Per un giaciglio in cui occorreva trascorrere, sognando, l'inverno, le piume più fini erano giusto quel che ci voleva. Conoscevo luoghi ove la scelta era già fatta: i nidi degli scriccioli e dei regoli. Ne andai in cerca, non appena udivo il «si-si-si» dei regoli: è il richiamo quando la covata ha preso il volo. Il moscardino si arrampica cauto fra i rami. Trovai lassù le piume ch'essi si erano strappati, le fibrille che vi avevano trasportato, e me ne presi la mia parte.
Ai margini della foresta, s'inerpica tra le ortiche e le scabiose la cùscuta trifoglina. Essa merita il suo appellativo perché forma cuscini di fili morbidi come seta, che nel primo autunno inaridiscono. Anche di questi feci raccolta: li intrecciai al mio giaciglio e vi aggiunsi rose canine e foglie di biancospino.
Lavoro volentieri: coi piedi trattenevo le fibre, con mani e bocca le intessevo. Vi riuscivo senza fatica, sebbene avvenisse al buio. Quando le materie sono gradevoli al tocco e al movimento, il lavoro può diventare un gioco: il godimento materiale si trasforma in piacere spirituale.
Tale era il mio umore nella tana, e si intensificò al cadere delle prime noci – con un suono che disinguevo fra tutti. Era come un battito, un annuncio. Così è la profezia che prediligo. Non vuote promesse, ma fenomeni, una piccola moneta spicciola, materiale. Io sono come Tommaso: mostra le tue piaghe! Allora mi convinco. Presto le noci caddero in gran copia; se il vento passava nel fogliame, era come se grandinasse.
© Paolo Melandri (24. 3. 2019)
*
Una giornata nella casbah 2
La consultazione dello specchio è preziosa, quantunque presenti dei rischi. È oltretutto una ricarica, un passaggio dall'esistenza all'essere. Tra l'altro, potrebbe rafforzare l'elemento femminile, l'influsso della luna e del mare, del sogno e della notte, l'altra faccia delle cose in genere. Qui acquista senso la parola di un saggio: “Di giorno tutti vedono allo stesso modo, in sogno ciascuno in modo particolare”.
Questo fatto potrebbe estraniarci al mondo del calcolo, al linguaggio, da cui dipendiamo. Perderemmo il potere di selettività. Per me, ad esempio, ciò rappresenterebbe il congedo dalla storia come scienza, qual è stata coltivata da generazioni nella mia famiglia.
I sanatori e i manicomi di Eumene sono affollati di malati, che si son lasciati trascinare troppo a fondo. Non hanno nemmeno avuto bisogno di particolari esperienze. Ciò avviene di quando in quando a uno dei miei studenti; il popolo dice allora: “ha studiato troppo”. In tale osservazione c'è del vero: troppa luce acceca; provoca la reazione delle tenebre. Io li vado a trovare volentieri; vi si odono parole simili a quelle degli antichi oracoli, o di Scardanelli – un murmure di energia terrigena.
A dispetto di ogni rischio, è prezioso – vorrei persino dire apprezzabile – non solo credere, ma anche esperire la possibilità di essere al contempo qui e altrove. Io mi ci sono opposto con tanto maggiore caparbietà quanto più mi approssimavo a passare al materialismo. Soprattutto Bruno mi ha aiutato a superare tale fase – in specie col suo corso sui fenomeni ottici ed elettromagnetici. Scendere a particolari mi porterebbe troppo lontano. Mi limito alla sua massima: “L'immagine originaria è nel contempo immagine e riflesso”. Il vero e proprio punto focale della sua concezione sta nell'aver ricondotto l'idea platonica dentro il fenomeno, raggiungendo così la reviviscenza della materia castrata dal pensiero astratto. Il miracolo, egli dice, non deve sperarsi dall'alto e non dal futuro, ad esempio da uno Spirito universale che si edifichi a piani sovrapposti – – – ma rimane in veste mutevole sempre uguale a se stesso, in ogni filo d'erba, in ogni ciottolo.
La madre ode il figlio che la chiama, mentre annega agli antipodi nell'Oceano Pacifico. Non si tratta soltanto di una invocazione. Quanti hanno fatto esperienze simili! Malgrado tutti gli incresciosi pasticci combinati dai culti religiosi, bisogna riconoscere che hanno non solo coltivato una tale sapienza, ma l'hanno anche praticata: in certi passaggi è possibile esercitarsi. È vero che in tali fatti non esiste un monopolio, giacché riescono a tutti trattandosi di doni di natura – – – ma esistono però differenze nel savoir faire. Come è possibile osservare nei moribondi.
Il bagno. Le condutture portano acqua fredda e calda, acqua dolce e acqua marina. L'acqua dolce deriva in parte dal Serchio, in parte è acqua piovana, raccolta nella grande cisterna che è scavata dentro la roccia. Si trova proprio sopra il Tesoro, che può inondare in pochi secondi.
In caso di necessità esiste un'apparecchiatura per desalinare l'acqua marina. A tal riguardo, sarebbe possibile tenere la casbah così a lungo come Eumene la sua acropoli di Nora, “che solo la fame poté costringere alla resa”, come dice uno storico.
Mentre mi rado, la vasca si è riempita. Io preferisco l'acqua di mare. Viene attinta ad una certa profondità ed è assai più fresca che alla spiaggia. Il Domo l'ha fatta analizzare nelle sue qualità chimiche e biologiche: è integra. Poiché tutti i fiumi sfociano nel mare, deve essere più curativa di ogni altra sorgente. Vi si aggiungono i minuscoli esseri viventi, di cui altri esseri fin su alle balene si nutrono, e che nella risacca diventano fosforescenti. Nessun medico sa che cosa significhino anche per noi – comunque, io spezzo il digiuno con un vigoroso sorso di acqua marina, con cui poi gargarizzo. Non vi è nulla di meglio anche per i denti: l'ho appreso dai pescatori e dalla gente semplice, che abitano alla spiaggia. Vivono parsimoniosamente, alla maniera antica che piace all'anarca. Anche il sale lo traggono dal mare, grattandolo dai crepacci e dalle cavità della roccia, dove si cristallizza. Sotto i tribuni, era proibito; avevano regolamentato tutto appuntino, fino alle minuzie. Il sale, il cui prezzo si era centuplicato, doveva essere acquistato nelle loro tabaccherie. Vi facevano aggiungere anche altre materie che i loro chimici vantavano come benefiche, sebbene risultassero poi nocive. Che cervelli siffatti ritengano di essere dei pensatori, è perdonabile; ma pretendono di essere anche benefattori.
La spiaggia, in quel tempo, era pattugliata da doganieri, che appostavano i poveri. Era una misura particolarmente gretta, perché oro e sale dovrebbero spettare ad ognuno, senza interessi, come puro corrispettivo del suo lavoro, così come lo estrae dalla sabbia dei fiumi o lo gratta dalla scogliera. Che il Condor abbia consentito entrambe le cose, è stata una delle prime misure che crearono la sua popolarità.
Un po' di generosità compensa tanti lati dell'amministrazione. I tribuni erano dei redistributori; rincararono ai poveri il pane per renderli felici con le loro idee – ad esempio, costruendo dispendiose università, i cui diplomati disoccupati risultarono di peso all'assistenza pubblica, cioè a lor volta ai poveri, e si rifiutarono di prender più in mano un martello. Il povero, fintanto che non abbia una mentalità da parassita, vuole vedere il meno possibile lo Stato, qualunque siano i pretesti sotto cui gli si mostra. Non vuol essere scolarizzato, vaccinato e costretto al servizio militare: tutto ciò ha contribuito ad accrescere insensatamente il numero dei poveri e con essi la povertà.
Segue l'acqua bollente e poi quella gelata, entrambi con acqua dolce; subito dopo, la ginnastica. Quando ho servizio, ho l'abitudine di radermi una seconda volta la sera, curando particolarmente la mia apparenza esteriore. Prima di scendere, mi metto davanti allo specchio ed esamino Eumelo: tenuta, fisico, sorriso e movimenti devono essere disinvolti e gradevoli. È importante – l'insegnamento ci viene dalle donne – apparire come gli altri ci immaginano nei loro desideri.
© Paolo Melandri (24. 3. 2019)
*
Cima delle donne
“In questo momento…”
Dall'anfiteatro sopra la sala operatoria Mattia avvertì come un'esitazione nella voce di Belardo, una voce che sino a quel momento era stata di una freschezza di timbro sorprendente, una voce che si sarebbe detta ancora quella che era all'inizio, come non fosse cioè la voce di uno che ormai da due ore portava avanti un intervento a dir poco impegnativo come quello.
Belardo stava per dichiarare che quella appena fatta era la mossa record, tanto da esaltare quel momento come avesse qualcosa di storico per lui. E l'aveva, considerato che quello della neovagina è tutt'altro che un intervento abituale e si affida a chirurghi di consolidato prestigio.
Era per questo che l'operatore, Belardo appunto, anche si trattava di un “Pi heic Di”, cioè di un libero docente straniero, tesaurizzava l'intervento sviluppandolo, viavia che ne dettava le mosse al pubblico di studenti che lo seguivano dall'anfiteatro, come una vera e propria lezione in sala operatoria, diffondendosi talmente tanto, specie su certe mosse e fra mossa e mossa, da far sospettare delle volte a Mattia che quella lezione lui l'avesse precedentemente incisa, e non necessariamente in sala operatoria, incisa su di un nastro, ed era da questo ora, per play-back, che la sua voce (quella sua voce, perlappunto, che si sarebbe detta uguale a quella che era all'inizio) parlava al pubblico dell'anfiteatro.
Un momento storico, dunque. Difatti:
“In questo momento” ripeté con una certa antipatica enfasi “passo alle mie strumentiste alle mie spalle prima una poi l'altra pinza di Four che fra le punte stringono quelle che nel verbale di questo primo tempo dell'intervento descriverò come gonadi, parti terminali di colorito biancastro di due formazioni peduncolate, due corpiccoli di consistenza duro elastica, simili a due mandorle sgusciate. In parole più semplici, questi due corpiccioli sono i testicoletti rudimentali della giovane paziente che noi, come primo atto, concludendo la parte addominale dell'intervento, abbiamo asportato perché essi potrebbero andare incontro a degenerazione e che noi molto rapidamente ci apprestiamo a sottoporre a esame istologico preliminare estemporaneo studiandone la struttura, se cioè ci sia già un indizio di degenerazione, e la funzionalità, e cioè la loro capacità di produrre ormoni.” (“Nella sindrome di Rokitanski” aveva detto Belardo due ore prima, nella presentazione agli studenti dell'intervento che stava per iniziare “la paziente ha due ovaie normali per quanto riguarda la loro funzionalità ormonale, il soggetto-donna cioè riceve il beneficio della produzione degli ormoni da parte delle ovaie. Nella sindrome di Morris, quella che interessa a noi, dello pseudo ermafroditismo maschile, si tratterà di vedere se il soggetto, mancante di utero tube ovaie e vagina, è un soggetto-donna o un soggetto-uomo, oppure se è portatore di un mosaico cromosomico aberrante, quello dei due cromosomi sessuali della donna, XX, più la X o la Y dei due cromosomi sessuali dell'uomo.”)
Alle spalle di Belardo, a tempo con la sua voce, le due strumentiste, ognuna con la sua pinza che stringeva uno dei due testicoletti, dopo averle tenute per qualche tempo alte sopra una bacinella posata su un tavolino in mezzo a loro, piena di rifiuti, tamponi di ovatta, frammenti di filo di catgut, batuffoli, bustine per stellette di filo e zaffi di garza, si mossero cautamente fuori dall'alone della scialitica, verso l'antisala della sala operatoria dove si trovava l'anatomo patologo con il refrigeratore, e quando tornarono alle spalle di Belardo le punte delle due pinze non stringevano più niente.
Lo stupore di quell'evento, l'evento dell'uomo che mette mano dove solo il Creatore, anche se distrattamente, l'ha messa, trascorreva con improvvisi brividi nel silenzio d'acquario dell'anfiteatro.
Tutt'intorno alla vetrata, assieme a quella decina di studenti stranottati dall'ora d'inizio di quell'intervento monstre anche quanto alla durata (perché, fra i due tempi chirurgo-ginecologico e chirurgo-plastico, cominciando alle sette, finisce ben oltre mezzogiorno), Mattia dalla sua posizione d'angolo vedeva muoversi in quell'istante l'esotico gruppetto di spettatori formato dalle tre signore in cachemire, dall'aria di tre mannequins, e dal giovane emiro Saad Ibn as-Salah dell'emirato di Kuneor sul Golfo del Petrolio, col suo kefieh di un candore luccicante nelle mezze luci dell'anfiteatro e che era tutto quello che del disdah, dell'abbigliamento tradizionale, resisteva nel suo finissimo completo occidentale.
Erano stati prima come presi in contropiede dall'annuncio che per bocca di Belardo era venuto dalla sala operatoria, e dopo avevano aguzzato gli occhi per vedere, ma a quella distanza forse solo intravvedere, i due pezzi anatomici simili a mandorle sgusciate che le due strumentiste stringevano fra le punte delle pinze sinché non andarono e tornarono dall'antisala.
Mattia poteva vedere ora, ora che erano uscite dall'allineamento alla vetrata, dove prima il profilo col kefieh del Principe gliele copriva, le tre cosiddette Mogli Anziane dell'Emiro, molto probabilmente principesse di rango anch'esse come la Moglie Giovane che stava sul lettino operatorio, tre ragazze che dimostravano un'età fra i venti e i venticinque anni. Mattia, che la mattina alla presentazione col loro Principe le aveva appena guardate, le vedeva ora come per la prima volta. Tutte e tre assai simili fisicamente, molto alte, pelle olivastra, i capelli neri corvini, l'identica mise le rendeva più somiglianti ancora, e in un certo senso qualcosa di familiare c'era effettivamente fra di loro. Erano infatti tre del numero imprecisato di Mogli Anziane del Principe che esse accompagnavano in quel viaggio per svolgervi un compito che a Mattia appariva semplicemente decorativo, di contorno, sinché la loro presenza, la loro presenza di giovani, seducenti donne non rivelò di avere uno scopo più che calcolato in quel viaggio.
Il Principe si era ritratto di qualche passo dalla vetrata e con lo sguardo sembrava cercare l'attenzione di Mattia.
Dopo due ore era la prima volta che levava gli occhi da giù, dalla sala operatoria, dal lettino dove giaceva senza coscienza quell'adolescente principessa che si chiamava Amina, che era, secondo l'esatta espressione di Belardo, “una splendida parvenza di donna come sono quasi tutte queste pseudo ermafrodite maschili”.
In quel momento, che con l'estrazione delle gonadi Belardo concludeva la parte preliminare, destruens, dell'intervento (dopo sarebbe iniziata la vera e propria costruzione della vagina), al giovane Principe insorgeva forse qualche dubbio, qualche scrupolo: aveva fatto bene ad accettare il sacrificio della sua Amina?
© Paolo Melandri (21. 3. 2019)
*
Zapparoni 7
Se scienza deve essere potenza, bisogna sapere, per cominciare, che cosa sia la scienza. Che Zapparoni vi avesse riflettuto, lo rivelava il suo sguardo; era un iniziato, uno che sa. Si era preoccupato di problemi che andavano oltre la parte tecnica. Lo vedevo dai suoi occhi. Guardava come una chimera sui grigi tetti, aveva vivificato la foresta primitiva con le sue piume celesti. Un bagliore di tinta immateriale si era frantumato nel nostro tempo. Nel suo piano, nella sua ambizione egli doveva mirare più su della fame crescente di potenza e di lusso delle masse.
C'erano nel suo occhio sottintesi preistorici. Riconosceva esso ciò che era eternamente sottinteso in un nuovo momento della storia, nell'inganno della Maja con la sua sterminata pienezza di immagini, che ricadono come le gocce d'acqua di una fontana nella vasca? Sentiva la nostalgia delle grandi foreste del Congo, nelle quali sorridono specie nuove? Forse dopo un audace volo nei mondi superni sarebbe tornato laggiù. Storici fauneschi avrebbero allora formulato le loro teorie su di lui come noi sul palazzo di Montezuma.
Di simili questioni avrei parlato volentieri con lui. Ci occupa tutti il cocente pensiero che forse c'è ancora una speranza, dopo tutto. Un grande fisico è sempre nel medesimo tempo un metafisico. Ha un concetto più alto del nostro sapere, del suo compito. Avrei volentieri gettato uno sguardo sui suoi diagrammi di produzione. Mi sarebbe stato anche più prezioso che sistemare la faccenda per la quale ero venuto. Invece di invitarmi nel suo gabinetto, il grande uomo mi accoglieva come un bramino capo, il quale nel tempio della dea Kali è avvicinato da un mendicante. Mi accoglieva con un luogo comune.
Capitolo ix
Per un istante avevo dimenticato che mi trovavo lì per chiedere lavoro; ma soltanto per un istante. Se qualche cosa poteva sollevarmi dalla miseria, sarebbe stata una parola sul nostro mondo e il suo significato dalla bocca di uno dei suoi àuguri, il breve cenno di un capo.
Zapparoni possedeva molti volti, come la sua opera molti significati. Dov'era il minotauro in questo labirinto? Era il buon nonno che faceva la fortuna di bambini, di massaie e di ortolani, era il fornitore militare, che nel medesimo tempo predicava la morale dell'esercito e lo attrezzava con inaudita raffinatezza, era l'audace costruttore, al quale importava unicamente il gioco intellettuale e che voleva descrivere una curva che riconducesse alle forme primitive? O si doveva semplicemente produrre una nuova armatura, come se ne trovano in tutte le classi del regno animale e la natura per quest'opera ingaggiava l'intelletto, ricorrendovi come a un mezzo? Ciò avrebbe spiegato molti tratti ingenui, che sorprendono gli attori del dramma.
Anzitutto, quale era la sua posizione di fronte all'uomo, senza il quale tutto quanto era pazzia? Procedeva dall'uomo e doveva tornare all'uomo. Si potrebbe benissimo immaginare una rosa, una vite senza spalliera, però non mai l'opposto. Voleva rendere l'uomo più felice o più potente o lo voleva più felice e più potente a un tempo? Voleva dominarlo, atrofizzarlo, o introdurlo in regni incantati? Vedeva nell'automa un grande esperimento, una prova da subire, una domanda alla quale rispondere? Lo ritenevo capace di considerazioni teoriche, anzi, teologiche; avevo veduto la sua biblioteca e lo guardavo negli occhi.
È una grande cosa venire a sapere dalla bocca di un saggio in quali faccende siamo irretiti e quale significato hanno i sacrifici che ci vengono richiesti davanti a immagini velate. Anche se si dovessero udire cose spaventose, sarebbe sempre una fortuna vedere lo scopo al di là dell'ottuso vortice.
Intanto non toccava a me porre domande, al contrario. Il saluto mi aveva fatto l'effetto di una doccia fredda. Per un istante fui tentato di difendermi. Ma sarebbe stato un errore, e mi contentai dunque di dire:
“È stato molto gentile a volermi ricevere personalmente, eccellenza”.
Il titolo gli spettava, come molti altri; mi ero informato da Twinnings.
“Mi chiami semplicemente per nome, come fanno tutti i lavoratori nelle nostre officine.”
Non diceva le mie officine e i miei lavoratori. Ci eravamo seduti sopra due sedie da giardino e guardavamo il prato. Zapparoni aveva incrociato le gambe e mi guardava sorridendo. Portava pianelle di marocchino, e in genere dava l'impressione di un uomo che passa piacevolmente la mattina fra le sue quattro mura. Aveva piuttosto l'aria di un artista, di un romanziere alla moda o di un grande compositore, il quale da molto tempo ha lasciato le preoccupazioni materiali dietro di sé ed è sicuro dei suoi mezzi e dell'effetto che produce.
Arrivava da lontano il ronzio delle officine. Presentivo che avrebbe cominciato subito a interrogarmi. Vi ero preparato, ma non avevo nessun discorso pronto, come nei tempi passati in simili incontri. Ogni aspirante vuol fare una determinata impressione, rappresentare il tipo ideale che nella propria mente ha formato di sé. Presenta il suo parere. Qui era impossibile, perché non sapevo precisamente che cosa mi si chiedeva. Inoltre la tecnica della interrogazione ha fatto grandi progressi. Anche se difficilmente potrà accertare che cosa sia un uomo, pure coglie con grande precisione che cosa non è, che cosa si sforza di sembrare.
Perciò la cosa migliore è rispondere sempre chiaro e tondo.
© Paolo Melandri (20. 3. 2019)
*
Zapparoni 6
Noi sentiamo forse: «Ecco, è lui» oppure: «A lui riuscirà» o sentiamo semplicemente il respiro dell'ignoto.
Similmente mi accadde con Zapparoni; sentii: «Lui ha la formula», oppure: «Costui è un iniziato, uno degli alti gradi». Una frase, diventata luogo comune: «Scienza è potenza» acquistò un senso nuovo, immediato, pericoloso.
Anzitutto gli occhi avevano una grande forza; e lo sguardo regale, il taglio largo che lascia vedere il bianco, sopra e sotto l'iride. Si riceveva un'impressione artificiale, come risultante da una delicata operazione, e in più la fissità meridionale. Era l'occhio di un grande pappagallo azzurro, che avesse cento anni. La membrana nittante appariva e scompariva. Non era l'azzurro del cielo, non era l'azzurro del mare, non era l'azzurro delle pietre: era un azzurro sintetico, escogitato in luoghi molto lontani da un maestro che voleva superare la natura. Lampeggiava sull'orlo dei fiumi più antichi del mondo, nel volo sopra le radure. A volte fra le piume si intravedeva un rosso stridulo, un giallo inaudito.
L'occhio di questo pappagallo azzurro era color d'ambra; mostrava, quando guardava verso la luce, le sfumature dell'ambra gialla, e nell'ombra quelle dell'ambra rosso marrone, con altre più antiche nel tempo. L'occhio aveva contemplato grandi accoppiamenti in regni dove la potenza generatrice non è ancora individuale, dove terra e mare si abbracciano e gli scogli si ergono come falli sul delta. Era rimasto freddo e duro come calcedonio giallo, non toccato dall'amore. Soltanto quando guardava nell'ombra, si oscurava come velluto. Anche il becco era rimasto duro e aguzzo, sebbene per più di cento anni avesse schiacciato noci dure come diamanti. Qui non c'era un problema che non venisse risolto. L'occhio e i problemi erano come la serratura e la chiave corrispondente. Lo sguardo tagliava come una lama di acciaio molleggiante. Mi penetrò sino nell'intimo. Poi le cose tornarono al loro posto.
Avevo creduto che i monopoli di Zapparoni riposassero sullo scaltro sfruttamento degli inventori, invece mi bastò uno sguardo per capire che vi era all'opera più di una geniale intelligenza da grande affarista occupata a trarre rendite da regni plutonici. Giove, Urano e Nettuno erano in potente congiunzione. Bisognava dire piuttosto che quel piccolo vecchio sapeva inventare anche gli inventori: li trovava sempre infatti dove il suo mosaico li richiedeva.
Soltanto più tardi mi accorsi e ne fui colpito, di avere subito saputo di fronte a chi mi trovavo. Il che era strano, perché il grande Zapparoni, come lo conosceva ogni bambino, non aveva la minima somiglianza con l'uomo che incontrai nella biblioteca. La figura diffusa specialmente dalla Zapparoni Film era piuttosto quella di un mite nonno, di un Babbo Natale, che ha la sua officina nei boschi coperti di neve, dove i nani lavorano per lui ed egli medita instancabilmente con che cosa potrà fare piacere ai bambini grandi e piccoli. «Ogni anno torna…» ecco il tono del catalogo delle officine Zapparoni, atteso ogni ottobre con un'impazienza di cui non aveva goduto nessun libro di favole, nessun romanzo di fantascienza.
Zapparoni doveva dunque avere un impiegato che faceva per lui questa parte, forse un attore che rappresentava il padre nobile o anche un robot. Era persino possibile che si servisse di varie figure e ombre della sua persona. È un vecchio sogno dell'uomo, che ha prodotto diversi modi di dire, ad esempio: «Non posso mica farmi in quattro». Per Zapparoni a quanto pareva non soltanto era possibile, ma doveva riconoscervi un'utile estensione e un accrescimento della personalità. Da quando possiamo con qualche parte del nostro essere, come con la voce, e con l'apparenza, entrare in una macchina e uscirne godiamo alcuni vantaggi dell'antico proprietario di schiavi senza conoscerne gli svantaggi. Se qualcuno aveva capito questo, era Zapparoni, conoscitore e perfezionatore di automi per il gioco, il godimento e il lusso. Uno dei suoi sosia elevato a immagine ideale lo presentava con voce più convincente e apparenza più mite di quel che la natura gli avesse conferito, nei documentari settimanali e alla televisione; un altro teneva una conferenza a Sidney, mentre il maestro si tratteneva in comoda meditazione nel suo gabinetto.
Mi sentivo vacillare di fronte a questa capacità di moltiplicarsi. Operava come una illusione ottica, suscitava dubbi sull'identità. Chi mi diceva se qui mi trovavo davanti a quello vero? Ma doveva essere lui, e il buon Nonno era un suo sottocapo. La voce, del resto, era gradevole.
Capitolo viii
«Maggiore», disse, «il signor Twinnings me l'ha raccomandato, e il suo giudizio per me è importante. Egli pensa che lei voglia dedicarsi a un'occupazione migliore, più pacifica, e in questo egli l'ha preceduto già da molto tempo. Be', per questo non è mai troppo tardi.»
Con queste parole era uscito sul terrazzo e mi invitava a sedermi. Lo seguii, stordito come dal dentista, il quale con il primo movimento ha toccato sino in fondo il nervo dolorante e il focolaio dell'infiammazione. La cosa cominciava nel modo più favorevole possibile.
Naturalmente ero ai suoi occhi una figura equivoca, e lo ero anche ai miei. Che egli mi avesse voluto assicurare in forma benevola della sua disistima, non poteva offendermi, tenendo poi conto che quello non era certo per me il momento opportuno per essere ipersensibile.
Però con lo sprezzante accenno alla mia professione egli aveva toccato una ferita antica e mai sanata. Sapevo che le mie passate occupazioni, per quel genere di inventori e costruttori che si immedesimava in questo spirito, venivano subito dopo il furto di cavalli, e che era bene staccarsene, ma su questo punto non sapevo imitare Twinnings.
Un uomo come Zapparoni poteva dire quel che voleva, suonava sempre bene, era giusto, non soltanto perché poteva assoldare la stampa, che gli rendeva omaggio in articoli di fondo, nella terza pagina e nelle pubblicità, ma anche più perché incarnava lo spirito del tempo. Gli omaggi erano dunque gradevoli poiché non erano soltanto pagati, ma anche profondamente sentiti: non chiedevano all'intelligenza o alla morale dei pubblicisti più di una gioiosa adesione.
Certo devo ammettere che Zapparoni poteva esser ritenuto il cavallo da parata dell'elevato ottimismo tecnico, che domina i nostri più eminenti intelletti. Inoltre la tecnica in lui tendeva semplicemente verso le cose piacevoli: il vecchio desiderio dei maghi di mutare il mondo in un attimo per mezzo del pensiero sembrava quasi avverarsi. A questo bisognava aggiungere ancora il grande effetto della sua figura, che ogni capo di Stato gli poteva invidiare e che si vedeva sempre circondata da frotte di bambini.
Quanto nelle sue officine veniva fabbricato, costruito e allestito in serie, facilitava parecchio la vita. Ma faceva parte della normale correttezza tacere che era anche pericoloso. Però difficilmente lo si poteva negare. Durante gli ultimi venti o trent'anni, grazie a Dio, non vi era stato nessun grosso incendio, ma soltanto una successione di crisi locali. In quelle occasioni le potenze mondiali avevano con previdente bilancio calcolato i danni che confidavano di poter recare. Allora si era veduto che in quei calcoli le officine Zapparoni rappresentavano una parte principale, e che tutti quei robot lillipuziani e quegli automi di lusso potevano non soltanto contribuire ad abbellire, ma anche abbreviare la vita, senza mutare molto nella loro costruzione. In comune avevano soltanto il ripugnante sistema dell'insidia, il vile trionfo dei cervelli calcolatori sul coraggio vitale.
In grande, le officine Zapparoni somigliavano a un tempio di Giano con una porta colorata e una porta nera, e quando il cielo si annuvolava, da questa porta oscura scaturiva un fiume di raffinati strumenti micidiali. Quella porta oscura era anche tabù; in verità non doveva nemmeno essere presente. Però ogni tanto tornavano a trapelare dagli uffici di costruzione voci sommamente inquietanti e non per niente l'officina dei modelli si trovava nel cerchio più interno. Era presumibile che anche il posto vacante fosse in rapporto a simili cose.
Non ho nessuna intenzione di ricamare su uno dei nostri temi più popolari: «Perché accade ciò che non dovrebbe accadere?» Tanto accade lo stesso. Mi preme piuttosto una questione specifica, che su questo punto mi aveva spesso preoccupato e che in conseguenza del saluto umiliante mi si presentò di nuovo bruscamente alla coscienza. Voglio dire: perché questi spiriti, che hanno minacciato e mutato la nostra vita in modo così allarmante e imprevedibile, non sono contenti dello scatenamento e del dominio di immense forze e della fama, della potenza, della ricchezza che affluiscono verso di loro? Perché vogliono a ogni costo essere anche santi?
La questione mi preoccupava specialmente quando lavoravo al collaudo dei carri corazzati. Tra i pochi libri che portavo allora con me, oltre al Flavio Giuseppe, avevo la Conquista del Messico di Prescott. Il fascino di quest'opera sta nell'evocazione del denso incantesimo, della magia in cui vive l'uomo entro una tarda civiltà neolitica, con la sua casta sacerdotale e i suoi templi solari, nei quali si sacrificano ininterrottamente vittime umane. Come attraverso una fessura lo sguardo si posa sopra volti rigidi, tagliati nella pietra, sopra fiumi di sangue, scorrenti dagli scoli del theokallis. Non c'è da meravigliarsi se gli spagnoli pensavano che una delle grandi residenze di Satana si era spalancata davanti a loro.
Però, se anche una volta calerà il sipario del grande teatro mondiale, chi può dire che su di noi e sui nostri sacrari non si poserà uno sguardo ugualmente sgomento? Non sappiamo come si parlerà di noi nella storia dei lontani secoli o nel grande giudizio dei morti delle varie culture. Forse preferiranno un simile prete sanguinario ai nostri santi.
© Paolo Melandri (17. 3. 2019)
*
La forbice 9
I segnali non si irradiano solo linearmente, ma anche in forma di circolo o di sfera. Se un teleschermo facesse parte dell'attrezzatura di un satellite, i tratti percorsi sarebbero rappresentati sugli altri satelliti come più lunghi o più corti.
La ricezione è possibile in ogni luogo dell'universo – non sappiamo che cosa accada quando inviamo un segnale. È possibile solo costatare il luogo e la data dell'invio, magari l'esplosione di un sole distante milioni di anni luce. La notizia raggiunge le stelle in tempi diversi – alcune ne sono distrutte, altre rimangono intatte. Anche per noi l'effetto è diverso, a seconda che l'evento sia registrato a Babilonia, nell'antica Cina o dai nostri osservatori.
2.
È possibile determinare l'inizio del cammino; la lunghezza e la durata rimangono incerte. Si può accorciare il cammino, posporre la meta; come quella della vita attraverso l'arte medica.
A chi consideri il cammino più importante della meta e ritenga la meta uno dei possibili intervalli del cammino si presenteranno ulteriori domande, soprattutto questa: se il cammino conduca al di là della meta oppure no.
L'onda si esaurisce nel frangente, oppure questo non è che una summa, certo altamente significativa? Per restare sull'immagine del teleschermo che trasforma le onde in suoni, colori e addirittura in romanzi, esso non è forse per il raggio soltanto un filtro, che separa ciò che è divenuto superfluo dall'essenziale? Il viaggio è concluso; la nave viene abbandonata, il bagaglio resta a bordo.
© Paolo Melandri (15. 3. 2019)
*
Nella biblioteca
Dalla terrazza si passava nella biblioteca per una porta a vetri. Nelle serene ore mattutine questa porta era interamente aperta, sicché fratello Ottone sedeva al suo ampio tavolo come se fosse in giardino. Entravo sempre volentieri in questa camera, alla cui parete le verdi ombre del fogliame parevano giocare, e il cui silenzio era appena interrotto dal pigolio degli uccelli usciti da poco dal nido e dal vicino ronzio delle api.
Presso le finestre su di un cavalletto era disposta la grande tavola da disegno, e alle pareti si susseguivano file di libri sino al soffitto. La fila inferiore era disposta in un compartimento alto, opportuno per gli in-folio, per il grande Hortus Plantarum Mundi e per opere con alluminature a mano, quali ormai più non si stampano. Sopra quel compartimento sporgevano i ripostigli, che si potevano ancora ampliare mediante tavole, coperte di carte occasionali o dai fogli ingialliti degli erbari. Quei cassetti contenevano anche una raccolta di piante pietrificate, che noi avevamo estratte da miniere di calce e di carbone, e fra di esse parecchi cristalli, che si usano esporre come soprammobili, e che a volte si soppesano in mano, per trastullo, nel meditato conversare. Sopra le cassettiere si innalzavano le file di volumi di formato minore, una raccolta di opere botaniche non molto vasta ma completa di tutto quanto prima di allora era apparso sulla coltivazione dei gigli. Questa parte della biblioteca si distingueva in tre diversi rami, formati cioè dalle opere circa la struttura, il colore e il profumo del giglio.
© Paolo Melandri (14. 3. 2019)
*
Visita a Eleusi
Si guardarono di nuovo. Ebbe l'impressione che un altro corpo spiccasse il volo da lui. Lì attorno si sentiva un crepitio, lievissimo, come sprizzassero scintille d'ambra. Era vero: già da un pezzo avevano seppellito suo padre – non riusciva a capacitarsi che lui fosse stato così vicino, così presente. Adesso sentiva il crepitio dell'ambra in tutto il suo corpo. Ne era avvolto come da una seconda pelle.
Doveva aver messo paura a sua madre. Volle stringerla fra le braccia, ma una forza lo trattenne. In quella cucina aleggiava qualcosa di sinistro. C'era ancora dell'altro che aveva dimenticato, un fatto della massima importanza. Cercò di ricordare – e d'improvviso gli venne in mente: aveva dimenticato che anche la madre era morta, che da tempo riposava nella tomba accanto al padre.
Ma se quello era un sogno – che cos'era allora la realtà? Un incontro nella notte del sortilegio, una visione del fato. Non provò paura. Faceva molto freddo, ma si avvertiva nel contempo un bollore come di aria liquida. E non solo i genitori, anche gli antenati erano vicini, lì nel rifosso. Quella era una delle loro grandi notti, una festa dei morti. Si accalcavano per uscire dalla cavità della montagna.
L'orizzonte si era rischiarato. Tutt'intorno uno sfarfallio di luci. E regnava una grande agitazione. Erano carretti, bestiame e cavalli ciò che egli intuiva tra un lampo e l'altro, erano macchine di ferro oppure oggetti di genere affatto sconosciuto? Il vento soffiava sulle ampie distese. I fuochi ardevano. Da lontano si udiva l'ululato dei lupi. Un vento gelido arrivava dalle loro terre. Si udiva un cigolio sull'orlo del fosso.
Regnava la disperazione, che ritorna di continuo sulla Terra. E la Terra era polvere, teatro della fine e dei suoi orrori; aveva sete di sacrifici cruenti. I branchi si avvicinavano e giravano attorno alle mura; qua e là avevano già fatto irruzione nel fossato. Le fiamme salivano fino al cielo; castelli e città, frutteti e campi di grano scomparivano tra un guizzo e l'altro. I tigli attorno alle fontane ardevano, i boschi di querce, nei quali il vischio attendeva impaziente la falce dorata, rosseggiavano come fiaccole di notte.
E di nuovo si udirono i lupi: ma erano solo battitori; con il loro ululato annunciavano il vecchio capobranco, che spuntò dietro le sue mute come il destino dal mare di fuoco. Le catene saltarono, i lupi furono liberi.
Irzio udì in lontananza Conero dire a Erio:
“Ma lei ne sa di più”.
Li vide seduti là in fondo, più lontani di quanto non sarebbe se distese di terra e mare li separassero da lui, e nel contempo ravvicinati per una frazione di secondo come attraverso un canocchiale. Poi di nuovo fu catturato dal sogno premonitore.
Adesso le fiamme lambivano il firmamento. Rivelarono il vicolo cieco in cui era finito il destino dell'uomo, il suo inevitabile tramonto. Ma, caso strano, ecco che lo spettacolo pareva subire una metamorfosi nell'attimo stesso in cui lo spirito lo accettava rinunciando a battere in ritirata, a prendere la via di fuga. Non era forse come se dal fuoco si levasse non soltanto il rosseggiare dei grandi incendi, ma anche il bagliore, il presagio di una nuova luce? E nel sibilo e nell'ululato del tempo dei lupi e di venti non erano frammisti anche altri suoni?
Intorno a lui si avvertiva sempre quel crepitio che lo aveva assalito e strappato – dal suo stesso corpo. Ma il terrore intanto non stava forse tessendo una veste di invulnerabilità? Tornò a vivere in lui un presentimento: che le fiamme nulla potessero contro la sua persona. Sollevò il capo e, ancora titubante, tese l'orecchio al tumulto. Certo, là riecheggiavano adesso motivi diversi, familiari. Non era forse il suono della vittoria ciò che gli veniva incontro, come se si aprissero poco alla volta gli scuri battenti di un portale, dai quali usciva il suo doppio, la sua sempiterna figura? Era stata messa alla prova nei gorghi del tempo, nello straccio dei cercatori d'oro.
La luminosità si faceva più quieta, più dorata. Da tutte le colline echeggiavano richiami, come si stessero provando degli inni. Quando torna il silenzio – dopo il sommuoversi degli elementi nel quale si erano dischiusi gli abissi –, le orecchie quasi non credono alla trasmutazione e odono ancora le procelle risuonarvi con accordi d'arpa.
Passate simili tempeste, gli uomini si interrogano con lo sguardo, come per leggere sul volto l'uno dell'altro se possono confidare nei sensi ed essere certi di aver attinto la riva. Fu così che Irzio guardò Lunia. Erano sempre nel rifosso – e ancora restava in sospeso di quali incontri e di quali misure si trattasse. La ragazza, rapita, lo guardava senza vederlo. Si teneva piegata in avanti, simile a una polena o a chi inceda nella tormenta.
Anche dai capelli di Lunia egli comprese come attorno a lei vi fosse grande agitazione. Una circostanza, poi, aveva del sorprendente, pur essendogli balzata agli occhi solo in seguito: i capelli erano d'oro, mentre lui li aveva sempre visti bruni. E la loro lucentezza continuava ad aumentare.
Sentiva che il brusio, il crepitio stavano crescendo: erano gonfiati sino a divenire un fragore. Gli parve di dover distogliere gli occhi dalla luce, che pure non abbagliava. A filtrarla era un elemento dirompente, come se la terra si trasformasse in metallo fuso e questo in puro splendore. Si liquefaceva forse, fino a scomparire, ciò che altrimenti era motivo di affanno nella vita – oppure quello che era diviso si sublimava nel mistero? Su tutti i monti fiammeggiavano adesso gli scudi, si compivano le armonie, si affermava la pace perpetua.
Sì, lui comprendeva quell'insegnamento. Eterno ritorno dell'Uno che sorge da ciò che è diviso, e si ammanta di splendore. Era un segreto ineffabile, e nondimeno tutti i misteri vi alludevano, ed esso, esso soltanto era il loro tema. Le vie della storia e le sue astuzie, che apparivano così intricate, conducevano a questa verità. Verità, alla quale si avvicinava anche ogni vita umana, giorno dopo giorno, passo dopo passo. Quell'Uno soltanto era il tema di tutte le arti e, sulla base dell'Uno, a ogni pensiero veniva assegnato il suo rango. Era la vittoria che tutti incoronava, e rendeva meno aspra qualsiasi sconfitta. Il granello di polvere, il verme, l'assassino vi erano compresi. Non c'era nulla di morto in quella luce, e non c'erano tenebre.
Un profondo silenzio, una pace immensa avvolgevano il palazzo. L'antica Madre aveva fatto il suo ingresso, Frina era lì. Ma com'era ringiovanita, circonfusa della rugiada su cui lampeggiava l'arcobaleno, scintillante al pari della siepe di Midgard dopo l'estremo tramonto! Impossibile fosse la giovinezza destinata a sfiorire, doveva essere piuttosto l'eterna giovinezza. Progenitrice e discendente in una; la Terra era come il Sole. Adesso si trovavano nel centro immobile della ruota, là dove convergono i raggi. Chi una volta fu accolto in tale cerchia, chi una volta fu invitato a tale desco, mai più poté cadere preda esclusiva del giorno, dell'inganno del tempo.
L'antica Madre era sempre presente, nel silenzio e nella pace, nella vivida luce del meriggio. Quello era il grande deposito, che riforniva ogni dispensa e granaio. Come poteva essere sopportabile la ricchezza? Non per altro, se non perché riportava all'infanzia, l'età delle favole.
Quel tempo non scorreva, non fuggiva, non si proiettava in avanti. Era un tempo ripiegato su se stesso, intento a cullarsi nell'eterno istante. L'antica Madre si rispecchiava nella propria immagine – poi vi si calò dentro e divenne, insieme, immagine primeva e immagine riflessa. Sempre però rimase presente, da nessun simbolo velata, gaia nella solennità, solenne nella gaiezza.
Era stato l'attimo in cui Erio aveva visto le mura d'oro vacillare e trasformarsi nell'Incommutabile. Anche Irzio sentì che quello era il limite estremo.
L'incanto ormai era spezzato; si ritrovarono nella stanza della torre a Eleusi. Le candele erano quasi mozziconi. Un monticello di cenere argentea copriva le braci. I tempi e le misure riacquisirono valore; gli orologi ripresero a funzionare.
© Paolo Melandri (11. 3. 2019)
*
Cranio di Corvo 2
Per trovare la strada del ritorno dalla fitta foresta alle lande bastava seguire la traccia che avevamo segnata venendo; e pensoso mi incamminai per il sentiero biancheggiante.
Mi sembrava strano di essermi trovato, durante la mischia, presso quei morti; e intendevo l'accaduto al modo di un simbolo e mi sentivo ancora preso in un'aura di sogno.
Questo stato d'animo non mi era interamente nuovo, lo avevo conosciuto altre volte, le sere dei giorni nei quali la morte mi era stata vicina. Il nostro spirito sembra allora liberarsi momentaneamente dal peso del corpo e procediamo al fianco di questa immagine fisica di noi stessi quasi ad essa compagni. Ma non avevo mai sin allora tanto intensamente sentito di esser libero dai legami carnali, e mentre seguivo la bianca traccia contemplavo il mondo come in uno specchio di oscuro ebano, ove immagini di avorio si riflettessero. Attraversai anche il padule presso il Corno del Carnefice e poco lungi dai tre grandi pioppi mi ritrovai nella Campagna.
Quivi con spavento vidi il cielo sinistramente illuminato da bagliori d'incendio, e un maligno affannarsi pareva regnare per quelle lande, e ombre frettolose mi passavano dappresso. Potevano essere servi sfuggiti al macello, ma evitai di richiamarli, poiché sembravano presi di ebbro furore; e ne vidi che agitavano tizzoni e udii anche il linguaggio della gente di La Picousière. Di costoro intere schiere cariche di preda già ritornavano verso la foresta, e dal boschetto del Toro Rosso veniva la vivida luce delle fiaccole, e urla di donne si mescolavano alle risate del banchetto di festa per la vittoria.
Nell'angoscia di cattivi presentimenti mi affrettai verso le fattorie e ancor lontano dovetti riconoscere che anche Sombor e i suoi avevano in quel frattempo dovuto soccombere alla ciurma della foresta. Le case e le stalle erano in fiamme e i tetti caduti, e i «Vermi di fuoco» si agitavano attorno a quell'enorme braciere. Il saccheggio era in pieno avvio: delle coperte dei letti la maramaglia si era fatta grandi sacchi, che riempiva di preda; e vidi gruppi di costoro gozzovigliare con le provviste tratte dalle dispense e dalle cantine, e avevano sfondati i barili, donde attingevano da bere con gli elmi.
Gli assassini erano presi dalla crapula. Questa loro condizione mi era favorevole, mentre quasi in sogno ne attraversavo i gruppi: accecati dal fuoco, dal sangue e dal vino si agitavano come bestie che si vedono nel fondo di una torbida pozza d'acqua, e mi passavano dappresso. Uno di costoro, che aveva rubato un otre pieno di vino distillato, lo sollevò verso di me con ambedue le braccia, ma poiché non gli feci accoglienza, se ne andò bestemmiando. Camminavo incolume fra quella gente come se dotato di una vis calcandi supra scorpiones.
Quando ebbi lasciato le rovine della fattoria osservai che il bagliore dell'incendio alle mie spalle sembrava impallidire, e non tanto perché mi allontanavo, quanto per il prevalere di nuovi e più aspri bagliori, che si elevavano dinanzi a me nel cielo; e il mio orrore se ne accrebbe ancora. La Campagna che percorrevo non era deserta, ma bestiame in fuga e pastori vi trascorrevano; e percepii inoltre, seppur da lungi ancora, l'abbaìo della rossa muta che si avvicinava. Perciò affrettai il passo, benché il mio cuore fosse invaso da angoscia, mentre andavo verso la spaventosa cerchia di fiamme: vedevo oscure elevarsi le Scogliere di Marmo simili a neri scogli in un mare di lava ardente. Alle spalle udivo l'ululare dei molossi, mentre mi arrampicavo per la balza scoscesa, donde il nostro sguardo inebriato aveva di sovente contemplata la bellezza di quella terra che vedevo avvolta ora nel mantello purpureo della distruzione.
L'ampiezza della rovina mi appariva evidente dalla vastità degli incendi: per l'intero orizzonte le armoniose antiche città presso la Marina fiammeggiavano e risplendevano, simili a una catena di rubini. La loro immagine risorgeva dalla profondità oscura delle acque, nelle cui onde si rispecchiavano. Anche i villaggi bruciavano e i borghi delle terre attorno, e dai castelli superbi sui colli e dai conventi alta si levava la vampa dell'incendio. Le fiamme erano simili ad aurei palmizi nell'aria immobile, e dalla loro corona cadeva una pioggia di scintille. Su di questi vortici ardenti nella notte svolazzavano sciami di colombi, che la luce delle fiamme irraggiava di un color rossastro, e aironi saliti dai canneti bruciati; e si aggiravano in volo, sin quando la fiamma si appendeva alle loro piume, e allora simili a meteoriti ardenti precipitavano nella vampa dell'incendio.
Come se lo spiazzo fosse vuoto d'aria, non un suono giungeva: lo spettacolo si svolgeva in un tremendo silenzio. Non udivo presso la Marina, all'orizzonte, il pianto dei bimbi e il lamento delle madri e neppure il grido di guerra delle fazioni, né il muggire del bestiame chiuso nelle stalle. Di tutti gli orrori della distruzione, solamente l'aureo bagliore vedevo delle Scogliere di Marmo: così fiammeggiano lontani mondi meravigliosamente per chi ne contempli il precipitare attraverso l'infinito cielo.
Non udii neppure il grido, che proruppe dalla mia bocca; e come se io stesso ardessi nell'incendio, solamente nell'intimo sentivo lo stridio del mondo in fiamme; e solo questo lieve stridio mi fu possibile percepire, mentre i palazzi ruinavano e i sacchi di granaglie dei magazzini portuali, trascinati dal vortice delle fiamme verso l'alto, si disfacevano in corrusco sfavillio. Il serbatoio di polvere nella grande torre della Porta dei Galli scoppiò, producendo un enorme spacco nel terreno; la pesante campana, che da un millennio era di ornamento alla torre del Battifredo e il cui suono aveva accompagnato il vivere e il morire d'innumera gente, si arroventò sempre più vivida e infine precipitò dai suoi appoggi, facendo ruinare la torre. Io vidi anche i frontoni del tempio a colonnati risplendere in rosso ardore, e dagli alti piedestalli le immagini degli dèi, con lancia e scudo, piegarono verso il basso e piombarono senza rumore nel braciere.
Dinnanzi al mare in fiamme per la seconda volta e in modo anche più forte fui preso da un irrigidimento di sonnambulo; ma come in simile stato è pur sempre possibile vedere, così anche udivo la muta e la ciurma del bosco sempre più avvicinarsi. I cani raggiunsero il ciglione delle Scogliere, e intesi il profondo anfanare di Chiffon Rouge, seguito dalla sua ululante muta. Tuttavia non ero capace di muovere un piede, e l'urlo di spavento mi rimaneva soffocato in gola. Solo quando vidi le belve avvicinarsi riuscii a muovermi, ma non libero ancora da quella magia. Mi sembrò di scivolare dolcemente giù per le gradinate delle Scogliere di Marmo e con lieve slancio saltai oltre la siepe, che cingeva il quieto giardino dell'Eremo della Ruta. La selvaggia muta urlante era alla mia caccia subito dietro di me, in fitto branco, lungo lo stretto sentiero fra le rocce.
© Paolo Melandri (10. 3. 2019)
*
Cranio di Corvo
Attraverso le ombre del fumo mi sembrò di intravedere più volte l'ombra del mostro, ma sempre troppo fuggevolmente per aver agio di colpirlo. Inoltre, nel vortice, false immagini mi trassero in errore, sicché infine mi vidi sperduto nella selva. E udii un fruscio e il pensiero m'intimorì che la fiera mi avesse aggirato per assalirmi alle spalle. Per esser sicuro da tal pericolo mi inginocchiai sul terreno, tenendo presso di me il fucile e avendo alle spalle, per difesa, un roveto.
Avviene che in simili situazioni a volte il nostro occhio si arresti sulle minime cose; ed io osservai, inginocchiandomi, una pianticella in fiore, e riconobbi il rosso “uccellino di bosco”. Mi dovevo dunque trovare là dove mi ero spinto un giorno assieme a fratello Ottone, cioè assai presso la cima del colle di Cranio di Corvo. E veramente, con un breve cammino, riuscii a raggiungere la non vasta cima, che al modo di un'isola sporgeva dall'onda di fumo.
Di qui vidi la radura presso Cranio di Corvo illuminata da pallidi riflessi di luci; ma il mio sguardo ne venne distratto verso un punto lontano nella profondità dei boschi, ove scorsi, minuscolo e costruito quasi di rossa filigrana, un castello, con i suoi pinnacoli e le rotonde torri, in fiamme; e rammentai che sulla carta di Fortunio quel punto era designato come la «Residenza meridionale». Quell'incendio mi rivelò che l'audacia del principe e di Brandimarte li aveva condotti sino alle gradinate stesse del palazzo e a colpire quivi; e come sempre, quando vediamo la prova di un'azione animosa, un sentimento di gioia mi gonfiò il petto. Ma tornandomi nella memoria la risata trionfante del Forestaro, il mio sguardo ansioso perlustrò Cranio di Corvo; e io vidi cose il cui spudorato orrore mi fece impallidire.
I fuochi che illuminavano Cranio di Corvo davano ancora riflessi e bagliori, ma similmente a una coppa argentea che sia coperta da uno strato di bianca cenere. Il riflesso ne cadeva sulla capanna dello scorticatore e per la porta spalancata, colorando di rossa luce il teschio che ghignava, fissato all'architrave. Da varie tracce, evidenti sul terreno attorno alle zone arse e nell'interno della capanna, e di cui non voglio dire, si poteva indovinare che i lemuri avevano colà tenuta una spaventosa festa, e i resti ne giacevano ancora sul luogo. Noi uomini guardiamo simili stregonerie orrende trattenendo il respiro e come a un mondo inconcepibile.
Sia sufficiente il dire che il mio occhio scoprì fra i teschi da lungo tempo scarnificati ancora altre due teste nuove, erette in cima a lunghe pertiche: quelle del principe e di Brandimarte. Dalle punte di ferro, al cui uncino erano infilate, esse fissavano i bracieri, che andavano ingrigendo nello spegnersi. Al giovane principe i capelli erano divenuti bianchi, ma i tratti del suo viso erano più nobili ancora di quella suprema bellezza che solamente il dolore educa e forma.
Le lacrime mi scesero per il viso a quello spettacolo, quelle lacrime nelle quali meravigliosamente con il dolore si confonde un moto di entusiasmo. Su di quella pallida maschera, donde la pelle pendeva a brandelli e che elevata sul palo del martirio di là considerava, a terra, il fuoco, vi era l'ombra di un sorriso di suprema dolcezza e serenità; e indovinai che in quel giorno, a ogni nuovo passo, ogni debolezza era caduta da quel nobile spirito come gli stracci da un re, che vada travestito da mendicante. Allora un brivido mi percorse: intesi come costui fosse degno dei suoi lontani antenati vincitori di mostri; egli aveva vinto, nel proprio petto, il drago che ha nome spavento. Ora finalmente fui libero da ogni dubbio: vi erano ancora tra di noi uomini nobili, e nel loro cuore viveva sempre la conoscenza dell'ordine e dei valori di cui la loro nobiltà ci era conferma. E poiché gli alti esempi ci muovono all'imitazione, io giurai, di fronte a quel capo mozzo, che in futuro, in qualsiasi istante, avrei preferito morire in solitudine tra uomini liberi piuttosto che trionfare in mezzo a un branco di servi.
I tratti del viso di Brandimarte invece erano immutati: dall'alto della sua stanga egli guardava con lieve ribrezzo e con scherno Cranio di Corvo, e l'espressione era di calma voluta, come chi sia preso da crampi dolorosi e non ne lasci apparire traccia in volto; né mi avrebbe sorpreso il vedere fisso nell'occhiaia il monocolo, che egli usava portare quando era vivo. I suoi capelli erano ancora neri e lucenti, e compresi che al momento giusto egli aveva ingoiata la pastiglia, che ogni Mauretano porta con sé. Codesta è una capsula di vetro colorato, che nel momento della minaccia più grave si pone in bocca; un morso è quindi sufficiente a rompere la capsula, nella quale è racchiuso un veleno di grande potenza. Questa è una procedura che nel linguaggio dei Mauretani si usa denominare «appello di terza istanza», in risposta al terzo grado di violenza; e la procedura risponde all'idea che quell'ordine si è formato della dignità umana. Si ritiene cioè che la dignità umana possa essere minacciata dal sopportare la bassa violenza, e ci si attende che ogni Mauretano sia pronto, a ogni ora, a rispondere all'appello mortale. Tale fu dunque l'ultima avventura di Brandimarte.
Non so quanto io sostassi colà, fissando impietrito quello spettacolo e quasi fuori dal tempo; ero caduto in una specie di sogno, pur vegliando, e avevo scordato l'incombere del pericolo. Ma in tale stato sonnambulare si procede fra i pericoli senza prudenza e tuttavia in comunione con l'intima anima delle cose. Io salii sulla radura di Cranio di Corvo, e quasi in una ebbra visione le cose mi apparvero chiare, eppure intime nel mio essere, come se conosciute e amiche già nei favolosi paesi dell'infanzia. I teschi pallidi fissati ai vecchi alberi mi guardavano interrogandomi e udivo i colpi echeggiare per la radura, il pesante ronzare del bolzone della balestra e l'acuto fischio della palla da schioppo. I colpi mi passavano così vicini da agitarmi i capelli sulle tempie, ma io ne avevo la percezione solamente al modo di una melodia che accompagnandomi segnasse il ritmo del mio passo.
Giunsi, alla luce delle fiamme residue, sino alla dimora dell'orrore e abbassai verso di me l'asta che portava la testa del principe. Con ambedue le mani la estrassi dalla punta di ferro e la deposi nella sacca di cuoio. Mentre inginocchiandomi adempivo questa cerimonia, sentii un forte colpo alla spalla. Un proiettile doveva avermi toccato, ma non provavo dolore e neppure vedevo sangue sulla mia giubba; e tuttavia il braccio destro pendeva paralizzato. Come se ridesto dal sonno, ora mi guardai attorno e mi affrettai a rientrare con il mio nobile trofeo nel bosco. Avevo dimenticato il fucile colà ov'era il rosso fiorellino, né ormai poteva più servirmi. Mi affrettai perciò a ritrovare il luogo ove avevo lasciato i combattenti.
Quivi era silenzio e le fiaccole non davano più luce. Un bagliore di rossa bragia vagava ancora fra i cespugli bruciati, e a quel barlume di luce l'occhio vedeva giacere sull'oscura terra i cadaveri dei lottatori e i cani uccisi, gli uni e gli altri mutilati e straziati spaventosamente. Belovar giaceva in mezzo ad essi, presso il tronco di una vecchia quercia, e il capo era spaccato e il sangue fluendo aveva macchiata la bianca barba. Anche la bipenne al suo fianco e il largo pugnale che la sua destra stringeva ancora saldamente erano rossi di sangue. Ai suoi piedi agonizzava il fedele molosso Leontodonte, il corpo segnato da ferite, e nel morire gli leccava la mano. Il vecchio aveva combattuto bene, attorno a lui giaceva una corona di uomini e di cani, ch'egli aveva uccisi, e così aveva trovato una morte degna di lui, nel pieno tumulto della lotta, dove rossi cacciatori perseguono per i boschi rossa selvaggina, e morte e voluttà sono profondamente confuse. Io fissai a lungo gli occhi dell'amico morto e con la mia sinistra gli posi sul petto un pugno di terra. La grande madre, di cui aveva compiute le selvagge feste ricche di sangue, è orgogliosa di simili figli.
© Paolo Melandri (10. 3. 2019)
*
Lanzo Vallecchi
E adesso Lanzo Vallecchi ode la lenta canzone della morte.
Lampeggiare, lampeggiare, lampeggiare, finisce di lampeggiare lampeggiare. Far presa, cader giù, far presa, cader giù, finito. È la seconda notte che Lanzo grida. Far presa, cader giù, finito. Non urla più. Sono cessati i lampi. I suoi occhi si aprono e si chiudono. Giace là immobile. Una stanza, una sala, gente che va e viene. Non devi serrare la bocca. Gli introducono in bocca qualcosa di caldo. Niente lampi. Niente colpi. Pareti. Un momentino, solo un momentino. Chiude gli occhi.
E come Lanzo ha chiuso gli occhi comincia a fare qualcosa. Voi non vedrete cosa fa, pensate soltanto che tra poco se ne andrà. Non muove più un dito. E chiama e si muove e cammina. Raduna insieme tutto quel che fu suo. Dalla finestra esce per i campi, fruga tra le foglie, si intrufola nei buchi dei topi: fuori, fuori, cosa c'è qui, cosa c'è di mio? E ruzzola fra l'erba, fuori, datemi tutto quello che avete, vasta con le chiacchiere, tutto è senza senso, ho bisogno di voi, non posso fare a meno di nessuno di voi, su allegri, ho bisogno di tutti quanti!
Gli fanno bere del brodo, ingoia, non rigetta. Non vuole, non ha voglia di rigettare.
La parola della morte Lanzo ce l'ha in bocca e nessuno gliela strapperà via, se la rigira in bocca ed è come un sasso, un sasso sasso, e nessun nutrimento ne sgorga. In questa condizione sono morti una infinità di uomini. Non c'è stato per loro nessun dopo. Non hanno saputo che dovevano chiamare su di sé un altro dolore ancora per poter andare avanti, un solo piccolo passo era necessario ancora per andare avanti, ma quel passo non lo hanno saputo fare. Non lo sapevano, non fecero a tempo, e fu un indebolimento, un crampo convulso di minuti, e già erano all'altro mondo, dove non si chiamavano più Carlo, Guglielmo, Mena, Francesca. Sazi, sazi di buio, rossi di furore, irrigiditi nella disperazione si addormentarono nell'al di là. E non sapevano che dovevano diventare bianchi dal calore e allora si sarebbero fatti duttili e tutto sarebbe stato nuovo.
Lasciarla avvicinare, la notte, anche se è così nera, anche se è così vuota. Lasciarla avvicinare la notte nera e con essa i campi su cui si stende immobile il gelo e i viali gelati. Lasciarle avvicinare le casette solitarie di mattoni, da cui viene una luce rossa, lasciarle avvicinare i viandanti infreddoliti, i conducenti dei carri della verdura, che vanno in città. Le grandi, piatte, silenziose pianure su cui passano i treni dei sobborghi e i diretti, lanciando nel buio di qua e di là una luce bianca. Lasciarle avvicinare gli uomini nella stazione, una bambina così piccola, che volete, finirà per abituarsi anche là, deve comportarsi come si deve e tutto andrà bene.
Infornano il pane.
Il forno è all'aperto, vicino a una casa di contadini, dietro c'è un campo, ha l'aria di un mucchio di mattoni. Le donne hanno segato un mucchio di legna, hanno raccolto sterpi e foglie secche presso il forno, e ficcano dentro tutto. Adesso una donna attraversa il cortile con le grandi forme e dentro la pasta. Un ragazzo apre il forno, c'è un gran fuoco dentro che arde, arde, un gran calore, sospingono la teglia, dentro è il pane, adesso si alzerà, l'acqua evaporerà, la pasta piglierà colore.
© Paolo Melandri (6. 3. 2019)
*
La immacolata concezione
Maria camminava pallida e con sguardo assorto tra le erbe umide, basse.
Dove il fogliame diventava alto e folto, Maria cercava un albero dai larghi rami che si ergeva solitario dietro a un fitto intrico di cespugli, in un boschetto che gli uomini evitavano. Il verde delle fronde si fondeva con le seriche ombre dell'aria; e lì, sotto quella cortina, sbocciavano corpi di fanciulle allacciati nell'amore, corpi bronzei, rosei, dorati o candidi come neve. Il fogliame ricadeva folto fino a terra.
Quando scendeva una pioggia violenta, Maria sedeva alla finestra del portico tra le compagne, nella sua veste biancoazzurrina, un ramo di mandorlo posato tra i capelli; le labbra delle fanciulle intonavano all'unisono un canto di supplica al dio della pioggia. Ma se vedeva un bimbo, Maria prorompeva in grida di gioia. A passi lenti gli si avvicinava, lo prendeva il braccio, si sedeva e, tenendolo in grembo, lo cullava dolcemente sulle ginocchia. Di tanto in tanto si fermava per incantarsi a osservare il candido pulviscolo del sole e l'azzurro intenso del cielo finché, d'un tratto, un brivido non le scuoteva le spalle infreddolite e allora riprendeva a cullarlo.
Un caro amico la desiderava in sposa; ma la vergine non poteva esaudire il timido spasimante.
Un giorno, mentre sotto quell'albero dalle larghe fronde assaporavano la loro giovinezza in soave letizia, tra baci e tenere effusioni, le fanciulle scorsero in cielo, tra le foglie, una nera nube immensa, sconfinata, che aveva la forma di una mano pronta ad afferrare e pareva obbedire al comando di una volontà irresistibile, quasi fosse la mano di Dio. Si misero allora a cantare, inquiete, tra il fogliame nelle loro vesti bianche e variopinte. In quell'istante, ecco avanzare laggiù, sopra il colle, un bagliore grigioazzurro che, sempre più frequente e chiaro, come un grande occhio fissava la terra dal nero di quel cielo. Le vesti svolazzavano al vento tra rigidi e scuri filari di alberi che presero a flettersi e a torcersi. Maria si aggrappò impaurita, scarmigliata, all'amico che le corse incontro dopo averla lungamente attesa nei pressi della sua dimora solitaria, si strinse al suo braccio. Esangui, sbigottiti, i suoi occhi non cessavano di rivolgersi, imploranti, alle dita protese dalla nube e a quel bagliore accecante. Quando la terra cominciò a tremare e, in una vampa giallopurpurea, nell'aria risuonò una voce di tuono, ella cadde tra le braccia dell'amico, pallida a morte. Nella fitta oscurità mani le sfiorarono il volto e i capelli; dopo quel tuono impetuoso, udì il sussurro di parole ardenti. Egli la prese che si aggrappava alla sua spalla, abbandonata e tremante come un ramoscello.
© Paolo Melandri (5. 3. 2019)
*
Appunti dal bar notturno
Durante il dîner, io me ne sto nel bar pronto a servire. Verifico l'aria, la temperatura, l'atomizzatore, i bicchieri davanti a me sul banco, le bottiglie dietro di me sullo scaffale. Chiedo giù in cambusa se tutto è a posto: la maggior parte dei vassoi preparati viene mandata su bell'e pronta, io poi trasmetto gli ordini con frasi convenute.
Il dîner è di regola assai semplice; dura tre quarti d'ora; c'è un trio che suona all'inizio, dopo gli antipasti, e al dessert. La sala da pranzo viene chiamata «la mensa» o anche «il refettorio». Quando il Condor lascia la tavola, alcuni convitati, tra cui sempre Attila e il Domo, lo accompagnano alla Sala Gialla, dove viene servito il moka e i liquori. È permesso anche fumare un sigaro, sebbene il Condor non lo gradisca. Secondo l'umore o l'atmosfera, non certo sempre, egli si compiace di recarsi lì accanto al bar notturno. Chi ne ha voglia (nello stile ad esempio di «Sire, Marly!») può seguirlo. Il Domo mi fa avvertire; i favoriti prendono i loro posti.
Prima del dîner il Domo ha già fatto il suo rapporto al Condor, dopo non si dovrebbe in effetti parlare più di servizio; tuttavia, è inevitabile che nei discorsi si inseriscano sempre delle allusioni. Per me sono più rivelatrici che se avessi assistito al rapporto: vere leccornie per la mia insaziabile curiosità. Mi permetto di ripetere che io antepongo la storia della civiltà a quella degli Stati. Con essa ha inizio e termine l'umanità. A ciò corrisponde anche il fatto che io, di preferenza, faccia posto alla storia delle corti, e persino dei cortili, piuttosto che a quella politica e partitica. La storia è fatta da uomini e regolata tutt'al più da leggi: è perciò che le sue sorprese sono inesauribili.
© Paolo Melandri (3. 3. 2019)
*
Zapparoni 5
Erano questi i pensieri che mi opprimevano mentre guardavo il fondo del ruscello, sulle cui sponde il contadino arava. Pian piano la superficie marrone, il terreno arato si allargava. Ecco un bilancio migliore del mio.
Ma i pensieri non ci assalgono come ho riferito. Siamo noi che li colleghiamo, che ce ne rendiamo conto. Li ordiniamo in un prima e un dopo, li disponiamo l'uno accanto all'altro, in una successione, una contiguità che non hanno quando nascono in noi. Allora nel firmamento interiore splendono, come stelle cadenti, luoghi, nomi, cose ora informi. Si mescolano i morti con i vivi, i sogni con le cose vissute. Quali segni sono mai questi, e dove vagabondiamo noi nella notte? Vidi il nobile volto di Lorenzo, che saltò dalla finestra. Non era quello il nostro destino, la nostra realtà? Un giorno avremmo toccato terra. C'erano stati tempi, in cui la vita era valutata quasi soltanto come la preparazione di quel momento; forse erano stati meno privi di senso del nostro.
Un tenue rumore mi fece sussultare. Qualcuno doveva essere entrato. Balzando in piedi mi trovai di fronte un vecchio che mi guardava. Doveva essere venuto da un gabinetto, che ora vedevo attraverso la porta aperta. Vidi l'angolo di un grosso tavolo, ancora illuminato da una lampada, nonostante l'ora meridiana, coperto di carte scritte e stampate e di libri aperti.
Lo sconosciuto era vecchio e piccolo ma mentre giungevo a queste conclusioni, sentivo subito che non dicevano nulla. Era davvero sconosciuto? ed era vecchio e piccolo? Ricco di anni certamente, infatti vedevo capelli bianchi brillare sotto la visiera che portava per proteggersi gli occhi. Inoltre i tratti del viso recavano l'impronta caratteristica lasciata da una lunga vita. Qualcosa di simile si trova nei grandi attori, che hanno impersonato lo spirito dei secoli. Però mentre in loro il destino li ha lavorati in superficie, il destino di quest'uomo aveva lavorato in profondità: egli non recitava.
Fissare l'età era cosa secondaria, perché lo spirito non ha età. Quel vecchio poteva affrontare un rischio, fisico, morale o intellettuale, più facilmente di innumerevoli giovani e subire la prova meglio, perché si univano in lui potenza e intuito, astuzia acquistata e dignità innata. Quale era il suo animale araldico? Una volpe, un leone, uno dei grandi uccelli da rapina? Dovetti piuttosto pensare a una chimera, di quelle che nidificano sulle nostre cattedrali e guardano giù la città con saggio sorriso.
Come era vecchio eppure non sembrava vecchio, così era piccolo eppure piccolo non sembrava; il suo essere cancellava quell'impressione.
Durante la mia vita avevo incontrato uomini significativi, uomini voglio dire che hanno da fare con le ruote più intime del nostro meccanismo, vicinissimi all'asse invisibile. Possono essere uomini di cui si trova il nome in ogni giornale, ma anche assolutamente sconosciuti, possono essere buoni o cattivi, attivi o inattivi. Eppure c'è in loro un'aura comune, imponente, che non tutti, ma molti, e in verità piuttosto gli esseri semplici che i complicati, percepiscono. Un filosofo, ad esempio, al quale è data questa forza, un nuovo ordinatore della sostanza mondiale, è capace di affascinare ascoltatori che non comprendono una sola parola del suo discorso. Eppure pendono incantati dalle sue labbra. Lo stesso è possibile in ogni altro campo. Deve esistere un'immediata percezione della grandezza, indipendente da ogni comprensione. Veniamo colpiti come magneti dalla corrente elettrica. Che questa forza si manifesti in lettere, parole o libri, è secondario; anzi spesso così si diminuisce addirittura la forza dell'attrazione. Non è facile interpretare questo fenomeno, perché è informe. Si trasforma in opere e atti, in simboli intellettuali e morali o agisce anche astraendosi magari nell'ascesi, nel sacrificio e nella meditazione. Ma la nostra percezione si trova al di fuori di questa evoluzione che la precede. Corrisponde come oscuro sentimento a un influsso indiscriminato. Non sentiamo forse: «Ecco, è lui» oppure: «A lui riuscirà» o sentiamo semplicemente il respiro dell'ignoto.
© Paolo Melandri (3. 3. 2019)
*
Isolamento e sicurezza
Gli scheletri, sull'albero-forca, sono di uccelli, ranocchi e lucertole. Gli uccelli dovevano aver avuto le dimensioni di passeri, da implumi ad adulti. Evidentemente là aveva avuto la sua riserva di caccia una ghierla. Il popolo la chiama anche ammazzasette, infilziere o mangiamorti. Se la fa in prossimità delle siepi di spini, che acconcia a propria dispensa. Là infilza la sua preda, o quella parte di essa che non divora subito. Secondo il fabbisogno, poi, ritorna per ingoiare in un boccone gli animali più piccini o per spolpare i più grossi, come ho potuto constatare qui sul luogo del supplizio. Una miniatura, ma sinistra.
Qui c'è molto da osservare. Trasporterà le sue vittime morte o vive? E come farà ad infilzarle? Probabilmente provvederà, come un buon padre di famiglia, che restino fresche il più a lungo possibile. Rostri conosce esempi del genere. La vespa paralizza la sua preda, un bruco che deve servire da nutrimento ai suoi figlioli, con una puntura nel ganglio. La vittima riesce ancora a masticare: le larve poi se ne nutrono prelevando quanto loro occorre dell'accrescimento di peso.
Forse era questa l'opera di una ghierla ancora poco nota. Più giù, nel canneto, si svolge la caccia di un grosso martin pescatore, l'alcedo grigio. Per l'estensione dei nostri fiumi e litorali, questo uccello è qui ovunque molto frequente e poco timoroso: si lascia quasi prendere con le mani. Una volta, mentre pescavo a lenza lungo il Serchio, si è seduto accanto a me sopra un palo, con un pesce che aveva appena catturato, e mi fece dei cenni col capo. Non avrei proprio nulla di nuovo da riferire sul suo conto, ma non è di questo che mi importa.
Di tutti questi animali, Rostri ne sa infinitamente più di me. Ma egli resta fermo agli accidenti, se mi è concesso riferirmi a quanto ho detto sopra.
© Paolo Melandri (26. 2. 2019)
*
Le tavole della legge
Subito si alzò, dicendo: “Vieni con me, e te ne mostrerò il perché: tu comunque capirai”. E, presa una candela dalla tavola, mi guidò, facendo luce, per una lunga galleria lastricata in pietra che portava alla sua cappella privata. Passammo in mezzo ai ritratti dei gesuiti e dei sacerdoti, alcuni dei quali molto famosi, che la sua famiglia aveva dato alla Chiesa; e alle stampe e alle fotografie dei quadri che lo avevano particolarmente colpito; e ai pochi dipinti che il suo modesto patrimonio, raggranellato a forza di rinunciare quasi con avarizia a tutto ciò che la maggior parte degli uomini desidera, gli aveva consentito di acquistare nei suoi viaggi. C'erano stampe e fotografie di molti capolavori di scuole diverse; ma in tutti la bellezza, sia che si trattasse della bellezza della religione, dell'amore, o di una visione fantastica di boschi e montagne, era la bellezza che si concede soltanto a quei temperamenti che cercano sempre un'emozione pura, assoluta, e che han trovato la loro espressione più continua, se non la più perfetta, nelle leggende, nelle preghiere e nella musica dei popoli. La certezza di un fervore fiero e leggiadro sui volti rapiti degli angeli di Piero della Francesca, e sui nobili volti delle Sibille di Michelangelo; e l'incertezza, come di anime in bilico tra i piaceri dello spirito e i turbamenti della carne, sui volti vacillanti degli affreschi delle chiese senesi, e sui volti, simili a fiamme sottili, immaginati dai simbolisti e dai preraffaelliti, mi aveva spesso fatto guardare a quel lungo corridoio, grigio e buio, vuoto e pieno di echi, come ad un vestibolo dell'eternità. Quasi ogni particolare della cappella, in cui si entrava per una porticina gotica la cui soglia consunta era stata levigata dai piedi di coloro che la frequentavano un tempo in segreto sfidando i rigori della legge, mi era rimasto impresso nella mente; perché era proprio in quella cappella che, ancor ragazzo, ero stato conquistato da quel medievalismo che oggi esercita, credo, un'influenza determinante sulla mia vita. L'unica cosa che mi parve nuova era una sorta di scatola quadrata, in bronzo, che stava sull'altare davanti a sei candele spente e al crocifisso d'ebano, e somigliava a quelle, più preziose, fabbricate anticamente per custodirvi i libri sacri. Attilio mi fece sedere in un vecchio banco di quercia, e, dopo essersi inchinato profondamente davanti al crocifisso, prese la scatola bronzea dall'altare e si sedette davanti a me con il libro sulle ginocchia.
© Paolo Melandri (25. 2. 2019)
*
Un viandante canta in sordina
Quest'anno ci son davvero molte bacche. Mirtilli, uva spina, lamponi. Non dico che si possa vivere di bacche. Ma è tanto bello, quando vengon fuori, e sono una gioia per gli occhi. E sono spesso anche un ristoro, quando si ha fame e sete, durano due o tre mesi, sino a che maturano le ultime, quelle d'autunno, lo so benissimo. Ci aspettano altre gioie però, fuori all'aperto, non le sole bacche. In primavera e d'estate le bacche son prima sanguinolente; ma ci sono allora campanule e trifoglio, e profonde foreste senza vento, il profumo degli alberi, silenzio. Risuona nel cielo quasi il rumore di un fiume lontano; nel tempo e nell'eternità non c'è altro suono così immenso. E quando canta un tordo, allora il suo richiamo si alza acutissimo, e mentre tiene il tono alto, fa improvvisamente un angolo retto, un passaggio chiaro e netto, come se tagliato col diamante. Poi comincia a cantare abbassando il tono, morbido e magnifico. Anche sulla riva regna la vita. Colombi, cornacchie, starne saltellano qua e là; la coditremola è fuori e cerca becchime, avanza a balzi, dondolandosi, graziosa con il suo becco aguzzo, poi vola su una siepe e canta, essa pure. Ma quando è tramontato il sole, un colombo intona il suo malinconico urrà, sognando un remoto lago alpestre. È l'ultimo. Poi non rimane che il grillo. Ma non c'è nulla da dire, esso è invisibile e non serve a nulla. Non fa che star là e stridere come resina.
Ripenso a tutto ciò: anche l'estate ha le sue gioie per il viandante e non occorre aspettare l'autunno.
Ma ora considero che me ne sto qui a scrivere parole serene su cose tranquille, come se non dovessero mai capitarmi avventure violente e pericolose. Non è un'astuzia, la appresi da un uomo dell'emisfero meridionale, da Roffo, un messicano. Attorno alle falde del suo enorme cappello tintinnavano piccole piastrine d'ottone, e appunto per questo me ne ricordo. E ricordo anzitutto con quanta calma raccontava il suo primo delitto: “Avevo una volta per amante una ragazza, che si chiamava Maria” raccontava Roffo con aria rassegnata “già, aveva appena sedici anni ed io ne avevo diciannove. Le sue mani erano tanto piccine; quando, per qualche motivo, mi ringraziava o mi salutava, non tenevo effettivamente in mano che due dita sottili, era così. Una sera il padrone del campo la condusse a casa con sé, perché gli cucisse qualcosa. Non era possibile impedirlo; e non passò più di un giorno che la condusse di nuovo a casa per cucire. Continuò così per due settimane, poi finì. Sette mesi dopo Maria morì e fu sepolta; e anche le sue manine furono sepolte. Andai da suo fratello Inez e dissi: “Domani presto verso le sei il padrone andrà a cavallo in città, e sarà solo”. “Lo so” mi rispose. “Dovresti prestarmi il tuo fucile piccolo, perché domani gli possa tirare”. “Servirà a me” rispose. Parlammo poi di varie cose, dell'autunno e di un nuovo grande pozzo, che avevamo scavato. Quando me ne andai, staccai il fucile e me lo presi. Nel bosco Inez mi inseguiva alle calcagna, e mi chiamava: che aspettassi. Ci sedemmo e parlammo del più e del meno, poi Inez si riprese il fucile e tornò a casa. L'indomani, di buonora, ero al cancello per aprirlo al padrone e anche Inez era là tra i cespugli. Gli dissi: “Tu devi andartene per i fatti tuoi, per non essere due contro uno”. “Lui ha pistole alla cintola, ma tu che hai?” chiese Inez. “No, io non ho niente, ma ho in mano il piombo, e questo non fa rumore”. Inez guardò il piombo, rifletté un po', quindi annuì con il capo e tornò a casa. Poi venne il padrone a cavallo, era tutto grigio e vecchio, almeno di sessant'anni. “Apri il cancello!” ordinò. Ma non aprii il cancello. Pensò che fossi impazzito? Minacciò con la frusta, ma non gli feci caso. Così dovette scendere per aprire il cancello. Gli detti allora il primo colpo, colpii sull'occhio, e feci un buco. “Oh!” gridò e vacillò a terra. Gli dissi un paio di parole, ma non le comprese, dopo qualche colpo era morto. Aveva in tasca molto denaro, ne presi quanto me ne occorreva per il viaggio, poi montai a cavallo e via. Inez stava sulla porta, quando giunsi. “Non hai che tre giorni e mezzo sino al confine”, disse.
Così Roffo raccontò quest'avventura e tranquillo continuava a guardar fisso davanti a sé, quando ebbe terminato.
Io non ho da raccontare delitti, ma gioie e dolore e amore. E l'amore è violento e pericoloso quanto un omicidio.
© Paolo Melandri (24. 2. 2019)
*
Il figlio del sole
Stanotte è caduta la neve. Uno spesso bianco mantello si stende sulla terra.
Si è destato col grato ricordo di aver ricevuto una lettera ieri, un sorprendente messaggio di liberazione, si sente giovane e felice e comincia a canticchiare. E poi se ne va alla finestra, alza le cortine e guarda la neve. D'un tratto il suo canto ammutolisce, un senso di scoraggiamento penetra nel suo animo; e scuote le povere spalle curve.
Con l'inverno veniva sempre un brutto tempo per lui, una sofferenza come nessun'altra e che nessun altro comprendeva. Soltanto la vista della neve gridava morte, gli gridava annientamento nelle orecchie. Le lunghe serate venivano col loro buio e col loro sciocco e insignificante silenzio; egli non poteva lavorare nel suo studio, la sua anima si richiudeva in se stessa e ammutoliva. Un'estate aveva abitato in una piccola città, in una grande camera luminosa dove i vetri più bassi della finestra erano bianchi. Tale colorazione in calce dei vetri gli ricordava il ghiaccio e non poteva vincere un senso di pena alla loro vista. Volle farsi forza, rimase in quella camera per più mesi, e ogni giorno si ripeteva che per molti il ghiaccio aveva la sua bellezza, che l'inverno e l'estate, tutt'e due, erano manifestazioni della stessa idea eterna e appartenevano a Dio, niente lo aiutava, non gli riusciva di continuare il lavoro e la diurna pena lo consumava. Dopo, più tardi, nella sua vita andò a stare a Parigi. Quando la città aveva le sue belle feste, andava volentieri fuori nei boulevards ed osservava i divertimenti. Poteva essere verso la metà di un'estate mite, le sere erano calde e dai grandi parchi veniva in città odor di fiori e di foglie; le strade brillavano sotto la luce elettrica, gente sorridente e felice ondeggiava su e giù, cantava, gettava confetti, tutto era pura felicità. Egli poteva anche uscire col fermo proposito di mescolarsi alla folla e partecipare alla gioia; ma dopo mezz'ora doveva prendere una vettura e ritornare a casa. Perché? Un lontano ricordo gli aveva parlato: nella luce elettrica i confetti cadevano come neve davanti ai suoi occhi e il divertimento ben presto finiva.
Tutto ciò si era ripetuto ogni anno.
Ma dove mai doveva stare la sua anima? Forse in una terra solatìa, in una terra di palme. Forse, sulle rive del Gange dove il loto non appassisce mai.
© Paolo Melandri (24. 2. 2019)
*
Osteria del Lupo 2
Stramba primavera. Rammento qualche particolare. Inverno restio alla resa. Dappertutto un costante senso di oppressione. C'era una specie di foschia quel giorno in cui, prima di raggiungere l'osteria, girai con l'auto nei dintorni della città. Un grigio inizio di tepore. Pomeriggio singolarmente coperto. Dappertutto una malinconia infinita, uno sguardo chino sulla terra, restio a staccarsene, le fronde quasi confuse nell'umidore della piana. Lì nei paraggi doveva esserci un ricovero, il suo contenuto incupiva ancor più il paesaggio. Molti anziani lungo la strada, gobbi, deformi, anche ciechi. Ovunque quel loro strascicarsi, passi malsicuri, un balbettare e tastare con la stampella. Primi castagni in fiore. Un'aria tropicale, s'è detto, era sospesa in silenzio tra le forme, un'indissolubile quiete univa le figure, tutto quel che si era innalzato, ricadeva, tutto cedeva alla malia delle bassure – unirsi, gridava una voce dentro di me; negli occhi sentivo bruciarmi sale e fuoco; spezzare il pane – ridurre i tormenti – sacrificare la propria carne contro lacrime e maledizione – ma chi si piega cosa potrà portare ancora su di sé, chi a questo si piega? –: a contare sono solo le sfere supreme, e quel che è umano ne è escluso. Un'altezza spietata, le frecce volano inesorabili, fa freddo, azzurro carico, qui contano solo gli strali lucenti, qui conta solamente una cosa: riconosci la situazione, serviti dei tuoi mezzi, devi attenerti al tuo metodo, là dove hai creato, non puoi cedere –: Tu rispondi di regni impossibili da interpretare e dove non esistono vittorie.
La sera, di nuovo all'osteria. Siedo e ascolto. Ascoltare l'essere insolito e l'insolita sostanza che spirano dalle voci della gente. Nel Tibet il vento, nella foresta vergine gli insetti, qui suoni articolati.
In me parla la disgregazione, è stato spesso osservato. No, rispodevo io, quando ancora rispondevo, in me parla lo spirito occidentale, che è come dire, comunque, disgregazione ricomposizione secondo la legge umana, quel principio antropologico che separò le acque dal firmamento e i profeti dai folli. Ebbene, dicevano i miei interlocutori, giust'appunto. Lei vuole disgregare la natura, questo è il colmo! Il nostro comune sangue e suolo? La vostra natura, ero costretto a replicare, è forse naturale? La si può considerare un punto d'avvio? Io posso dimostrare che è innaturale, procede in sommo grado a salti, sissignori, è il caso paradigmatico del Contro-natura. Inizia e non finisce, spende e spande e si dimentica. È sfrenata al largo delle isole, con falangi di cavallette che manda avanti come un rullo compressore, e con le cicale. Oppure: sulla terra regna la pace, tutto ha la temperatura delle pietre, mette davvero conto occuparsi del clima, all'improvviso spunta il pan di serpe con tanto di fiori a bocciolo a 40 gradi, scombussola tutto, e agli dèi viene voglia a sangue caldo –: e questo troverebbe il suo punto d'avvio nella natura o in chi, sennò? Oppure un altro dei suoi metodi: corrugamento, condensazione, compressione inaudita, sarebbe questo un metodo semplice e naturale? Oppure quell'altro suo uzzolo, la conduzione di tensioni enormi entro uno spazio microscopico, infinitesimale – e questo sarebbe ovvio e scontato? Eppure la vita, come fenomeno, si era sistemata così bene nella pianta, perché metterla in moto e spedirla in cerca di cibo? – non è forse questo un caso lampante di sradicamento? Quanto alla creatura umana, poi, la natura la sospinge a più riprese nell'innaturalezza, sprigiona batteri per annientarla, riduce il suo odorato, le attenua l'udito, l'occhio deve farsi snaturare dalle lenti, l'uomo dell'avvenire è pura astrazione – dov'è che agisce, questa natural natura? No, un altro è il volto che dovunque s'impone, assopito nella pietra, dischiuso nel fiore, esigente in questa specie tardiva – altri sono i connotati, ed eccomi giunto a un risultato inconsueto.
© Paolo Melandri (19. 2. 2019)
*
Misteri 2
C'era una palude aperta, senza alberi, solo una quantità di radici che si allungavano in tutte le direzioni come strani vermi attorcigliati. Ed ecco che un folle avanza tra tutte queste radici ritorte; mi sembra ancora di vederlo: pallido, con una barba scura ma così sparsa che gli luccicava per tutto il viso. Si guardava attentamente intorno e negli occhi tradiva una grande agitazione. Stavo nascosto dietro una roccia e lo chiamai. Immediatamente guardò dalla mia parte e non rimase per niente meravigliato che il grido giungesse da dietro una roccia, come se sapesse benissimo che io vi stavo nascosto. Fissava la roccia con insistenza. Al che io pensai: non mi scoprirà, nel peggiore dei casi tuttavia, se viene da questa parte, me la batto. E sebbene non gradissi affatto che lui stesse lì a fissarmi, tornai a gridare per spaventarlo. Fece un paio di passi verso di me, teneva la bocca aperta e faceva il gesto di mordere; ma non andò via. Le radici gli si accumulavano davanti ostacolandolo, tanto che non riusciva ad avanzare. Gridai di nuovo, gridai molte volte di seguito per eccitarlo, e allora lui attaccò le radici, cominciò a strapparle via, gettandone lontano grandi bracciate, lavorando di lena per avvicinarsi a me; ma inutilmente. Incominciò anche a gemere, e da dove mi trovavo lo sentivo, e vedevo il suo sguardo impietrito dal dolore. Ma quando capii che mi trovavo al sicuro, mi alzai e agitai il berretto, mostrandomi a lui in tutta la persona. Lo spaventai gridandogli continuamente: Salve! Battevo i piedi a terra e urlavo: Salve! Mi avvicinai anche di più per spaventarlo. Allungai persino le mani e, puntandogli contro il dito, urlai, sfacciatamente vicino: Salve! Per confonderlo ancora di più se possibile. Quindi tornai indietro e lasciai che, da dove si trovava, vedesse che gli ero stato tanto vicino. Ma non si arrese affatto, continuò a strappar radici, affaticandosi, inasprito dal dolore, graffiandosi a sangue, ferendosi al volto, sollevandosi sulla punta dei piedi e restando lì, gridando al mio indirizzo. Ve l'immaginate? Si alzava e abbassava sulla punta dei piedi, e mi guardava e gridava! E allora il volto gli si imperlò di sudore e prese a contorcersi in un'orribile smorfia di sofferenza per l'incapacità di afferrarmi. Pensai di attirarlo ancora più lontano e così mi avvicinai, gli scoccai le dita sotto il naso ed esclamai: Tihihihihi! In maniera quanto mai offensiva. Gli lanciai contro una radice d'albero, lo colpii sulla bocca e quasi riuscii a farlo vacillare; ma lui si limitò a sputare sangue e a portarsi le mani alla bocca, riprendendo a strappar radici. Allora ritenni di poter osare: allungai una mano perché volevo toccarlo, volevo poggiargli le dita sulla fronte e poi ritirarmi. Ma in quello stesso istante riuscì ad afferrarmi. Signore Iddio, che orrore quando mi afferrò! Strinse furiosamente, tenendomi ben salda la mano. Lanciai un urlo, ma lui si limitò a stringermi la mano, e così mi seguì. Uscimmo dalla palude, le radici d'albero ormai non gli creavano più alcun impedimento, visto che era riuscito a prendermi la mano. Arrivammo così fino alla roccia dietro la quale prima stavo nascosto. Quando vi giungemmo, lui si gettò ai miei piedi e baciò la terra che avevo calpestato. Lì, in ginocchio davanti a me, lacero e sanguinante, mi ringraziò perché ero stato buono con lui, mi benedisse persino, e pregò Iddio di benedirmi a sua volta. Quegli occhi spalancati inviavano pie preghiere a Dio per me, ma non mi baciò la mano e neppure la scarpa, solo la terra, là dove era stata calpestata dalle mie scarpe. Dissi: “perché baci la terra dove ho camminato?” “Perché” disse lui “la mia bocca sanguina e non voglio sporcarti le scarpe.” Non voleva sporcarmi le scarpe! Allora chiesi: “Ma perché mi ringrazi, se ti ho pur fatto male e ti ho procurato sofferenza?” “Ti ringrazio” rispose lui “perché non mi hai procurato maggior sofferenza, perché sei stato tanto buono da non torturarmi di più.” “Sì” diss'io allora “ma perché hai gridato al mio indirizzo e hai aperto la bocca per mordermi?” “Non volevo morderti” rispose lui “ho aperto la bocca per pregarti di aiutarmi, ma non sono riuscito a farmi sentire e tu non mi hai capito. Poi ho gridato per un dolore davvero forte.” “È per questo che hai gridato?” tornai a chiedere. “Sì, per questo!” Guardai quel folle, sputava ancora sangue eppure pregava per me; mi accorsi allora di averlo già visto, di conoscerlo già: era un uomo di mezza età, con i capelli grigi e la barba rada… era Minuto!
© Paolo Melandri (17. 2. 2019)
*
Pallade 2
Pallade si arresta, è sera, scioglie la corazza, sfilandosi il giaco con la testa della Gorgone, questa testa in cui sopravvivono il drago babilonese Tiamat e il serpente egiziano Apofi, ma battuti e vinti. È sera, lì giace la sua città, terra pietrosa, il monte di marmo e i due fiumi. Ovunque l'olivo, opera sua, grandi oliveti. Essa sta sul tribunale di allora, il colle di Ares, l'antica rocca delle Amazzoni distrutta da Teseo, il sollevatore del masso. Davanti a lei i gradini dell'altare sul quale si decise la sentenza. Vede le Furie, vede Oreste. Vede Apollo, il compagno della scena, e le torna in mente l'osservazione di Proteo, il signore delle vacche marine, che in questo stesso posto, non molto tempo dopo – misurato secondo le ore degli dèi – ci sarebbe stato un altro per annunciare la resurrezione dei morti. Clitennestra – Agamennone: uxoricidio – matricidio; idea paterna – idea materna –; uccisi e risorti; tutto nient'altro che un mormorio, nient'altro che idee – anche le idee sono prive di senso come i fatti, altrettanto caotiche, dato che anch'esse ordinano e illuminano solo una piccola parte dell'eone; – valgono solo le figurazioni conchiuse, le statue, i fregi, lo scudo d'Achille, questi sono senza idee, esprimono solo se stessi e sono perfetti.
Là tra le stelle scorse il corno di Amaltea, la capra cretese che aveva allattato il padre bambino, colombe gli portavano il nutrimento, pecchie dorate gli portavano miele. Ciò che è caotico, ciò che è informe, smisurato, egli poi lo distrusse, e ancora i Titani, i Giganti, ciò che è senza confini. Quella sera aveva una chiara luce verde, era più scura di Arianna, lì accanto, che Bacco aveva fatto ascendere al cielo nell'incanto dell'amore. Pensò al padre. Rea, sua madre, gli aveva salvato la vita con una pietra avvolta in pelo di capra. La diede da divorare a Saturno invece del pargolo divino appena nato. Quella pietra spesso ricordata! Ciò che viveva e aveva forma aveva guadagnato tempo per giungere nascostamente alla luce! Poi cominciò il suo dominio, e il corso delle cose cominciò a seguire la sua strada. Questa terra in cui la povertà era di casa e non meno l'abitudine ereditata dai padri di conquistare privilegi solo col lavoro e con la saggezza – ora lì i simulacri degli dèi, d'avorio e d'oro, lì ora la bianca, spettrale processione dei Propilei. In tutto ciò si riconobbe, si creò un popolo. Da quanto tempo i raggi di Helios non colpivano più solo dorsi e pinne di esseri con lo sguardo rivolto in basso, ma incontravano un fuoco di risposta, da quando un mortale era giunto, in posizione eretta, a guardare se stesso, interpretava se stesso e, rivolto intimamente a se stesso, a se stesso restituiva il proprio essere in manifestazioni e opere: ora – qui! Pallade si volse e avanzò verso la città. Riluceva di rami d'olivo e di rosse teste di cardo; i giocatori di domani ondeggiavano per le strade, schiere di pellegrini e la massa degli spettatori. Era la sera prima delle Panatenaiche. Quelli delle fonti, quelli delle terrazze montane, quelli dei tumuli sepolcrali nelle paludi intorno a Maratona; quelli che venivano dal mare avevano veleggiato orientandosi sulla lancia folgorante di Atena Promachos, questo era stato il faro. L'indomani sarebbero venuti davanti ai simulacri e alle statue e alle maschere preparate per i giochi. Tutti gli Elleni! Gli Elleni dei platani, gli Elleni dello scalpello, gli Elleni orestei! Di mezzo a loro scomparve ora Pallade, dea senza madre, di nuovo armata e sola.
© Paolo Melandri (17. 2. 2019)
*
Ipazia
Latifah mi serve anche da parafulmine – a Ipazia dispiacciono gli amplessi brutali. Ella si attiene allo stretto necessario – e persino quello che io ritengo sia per lei un di più, soltanto per farmi piacere. Non fa storie, ma si controlla, pur senza essere prude.
Nella nostra Eumene ha l'aspetto della ragazza straniera, un uccello migratore venuto dall'estremo nord nel quartiere d'inverno. È di statura più piccola che media, ma oltremodo proporzionata. Se il suo viso fosse ritrovato in una collezione antropologica, l'etichetta sarebbe “tipo svedese”. Come mai il termine “gemello” mi passò come un lampo per la mente, quando la incontrai la prima volta all'Istituto? La causa va forse ricercata in questa armonica simmetria, che sembrava uscita da uno stampo. In casi del genere, la razza sopraffà l'individualità.
Il suo colore è l'azzurro; veste di lino, dal quasi bianco fino alle più intense sfumature di azzurro, e vi aggiunge la lavanda. Quasi nessun gioiello, all'infuori di un cammeo e talora di una collana, niente anelli. A tavola, come in genere nelle sue abitudini, è di gusti semplici; la zuppa di legumi senza zafferano, e naturalmente anche senz'aglio – – – “con pepe” quando avviene che mangiamo insieme: io poi mi adeguo. Lei e Latifah sanno l'una dell'altra: io non ne faccio mistero. Inoltre, la zona di caccia di Latifah e il pied-à-terre, ove io mi riposo dai rapporti col mio paparino, sono vicinissimi tra loro. Ipazia non è gelosa; Latifah non ha diritto di esserlo.
Nel suo lavoro, Ipazia è seria e fidata; a tal riguardo, io sono per lei quel che si suol chiamare il “padrino” di laurea. È su questo che si basa la sua dedizione: che culmina nell'incesto. Era appunto quello che ho fiutato fin dal primo incontro.
Vigo appartiene a quei profeti che godono maggior fama all'estero anziché in patria. Il suo nome ha valore tra iniziati, e con segreta rabbia dei suoi colleghi, rappresenta un mot de passe da Beirut a Uppsala.
Quella volta, quando mi congedai da lui dopo una delle nostre serate, disse: “A proposito, un'oca iperborea si è di nuovo presentata a me, vuol lavorare qui da noi. Ha buoni diplomi, e ha già fatto delle scoperte al Luminar. Vorrei che lei se ne occupasse in mia vece”.
Finge che la cosa gli dia fastidio: in fondo, gliene deriva considerazione.
La mattina dopo, ci ha presentati l'un l'altro all'Istituto. Ed ha anche proposto subito un tema: la differenziazione autoritaria negli imperi dell'antichità. Doveva estendersi alle colonie delle potenze occidentali, e con riguardo particolare alla autonomia proconsolare.
Avviene che la casta dei guerrieri venga spodestata dal Demos oppure dal Senato e che emigri in contrade lontane. La madrepatria si sbarazza in tal modo dei suoi cervelli, irrequieti, aristocratici e reazionari; laggiù, come in una riserva naturale, si concede loro che guerreggino all'antica contro nomadi e tribù montanare. Avventure di servizio. D'altra parte, possono anche diventare pericolosi, quando, come Cesare, si creano una Gallia, oppure quando, come un generale iberico denominato Franco, ritornano durante una crisi con i loro legionari.
Tale era stato, press'a poco, il disegno di Vigo. Disse: “È un vasto campo. Occorrerebbe un leitmotiv – – – forse l'estrapolazione. (Da un punto di vista matematico, l'estrapolazione diventa sempre più incerta quanto più ci si allontana dalla sfera originaria, e in taluni casi già dal momento in cui la si è lasciata.) Comunque, veda un po' che cosa si può fare” – – –, e così dicendo ci lasciò soli.
Aveva ragione: il campo era vasto. La distanza, a dir vero, non aveva quasi più importanza alcuna, da quando esistevano truppe autotrasportate. Ipazia lavorava in una delle nostre stanze, uno stanzino piuttosto, al Piccolo Luminar. Notai allora ch'ella armonizzava l'azzurro dei suoi abiti con la lavanda.
Di fatto, ella fece rapidamente eccellenti scoperte: così ad esempio, alla Casa delle Lettere, di una nuova variante del suicidio di Lord Clive. La cosa è stata vantaggiosa anche per me, per la definizione dell'anarca. Nei Dodici articoli di Memmingen, redatti da un anabattista durante la Guerra dei Contadini in Germania, le riuscì di trovare un particolare relativo al tema. Vi si diceva che le guerre tra i popoli cristiani, e con esse il diritto di bando, dovevano cessare. Ove, tuttavia, vi fosse in giro gente di indomabile spirito bellicoso, bisognava inviarla a battersi contro i Turchi.
© Paolo Melandri (16. 2. 2019)
*
Misteri
Si avviarono subito verso la casa di Marta; Nino si guardò intorno ma non vide nessuno. Disse:
“Se mi lascia entrare un momentino gliene sarò molto grato”.
Lei esitava.
“Come sa, le ho promesso di non recarle mai in alcun modo fastidi. Tuttavia devo parlarle.”
Marta aprì la porta.
Quando furono entrati, accese la luce mentre Nino di nuovo disponeva qualcosa davanti alla finestra. Tacque finché l'altra non ebbe finito, allora disse:
“Dunque, questa sera si è divertita, vero?”.
“Sì, grazie.”
“Be', ma non è neppure di questo che voglio parlare. Venga a sedersi un po' più vicino. Non deve aver paura di me, promesso? Bene, diamoci la mano.”
Lei gli tese la mano, che lui trattenne.
“E non creda nemmeno che menta, che voglia mentirle, d'accordo? Ho in mente di dirle qualcosa. Non pensa dunque che mentirò?”
“No.”
“Bene, perché io a poco a poco le spiegherò tutto… Ma fino a che punto mi crede? Intendo dire: quanto credito mi accorda? Ma quante sciocchezze! Quanto chiacchiero! La verità è che mi risulta un po' difficile. Mi crede se, per esempio, le dico che lei è davvero molto… molto cara? Sì, perché deve averlo notato. Ma se ora aggiungessi, voglio dire… Insomma, le sto semplicemente chiedendo se vuole essere mia moglie. Sì, mia moglie. Ora l'ho detto. Non la mia fidanzata soltanto, ma mia moglie… Che Dio mi assista, come si è rattristata! No, no, lasci che le tenga la mano; mi spiegherò certo meglio, così capirà senz'altro. Ora immagini di avere sentito bene: che io, di punto in bianco e senza tante storie, le chieda di sposarmi e che ogni mia parola sia veramente sincera; immagini prima questo e poi mi conceda il permesso di proseguire. Bene, quanti anni ha? Be', non intendevo chiederlo: personalmente, io ho ventinove anni, ho superato l'età delle facili volubilità; lei magari avrà cinque o sei anni in più, e ciò non ha niente a…”
“Ho dodici anni in più” dice lei.
“Dodici!” esclama lui, contento che lo stia a sentire, che non abbia perduto completamente la testa. “Dodici anni in più, dunque: perfetto, magnifico! Be', e lei crede che dodici anni costituiscano un ostacolo! Secondo me sbaglia, amica mia! Ma, comunque sia: ammesso che fosse tre volte dodici anni più vecchia, se mi è cara e io sono veramente convinto di quel che dico in questo momento, che ostacolo c'è? Ci ho pensato su a lungo, be', in effetti non tanto a lungo, ma per parecchi giorni; non mento, mi creda, per l'amor del cielo, visto che la prego con tanta insistenza! Ci ho pensato su per parecchi giorni, e per questa ragione la notte non ho dormito. Ha anche occhi così strani, mi hanno attratto fin dal primo momento che l'ho vista; perché io posso essere attratto sino a sconvolgermi da un paio di occhi. Ahimè! Una volta un vecchio riuscì a trascinarmi in giro per un bosco per quasi una notte intera solo con i suoi occhi. Questo vecchio era invasato… Be', questa è un'altra storia. I suoi occhi però mi hanno affascinato. Ricorda? Una volta si trovava qui, al centro di questa stanza, e mi vide passare là fuori. Non voltò la testa. Mi seguì soltanto con lo sguardo: non lo dimenticherò mai. Ma anche quella volta, quando l'incontrai e le rivolsi la parola, rimasi colpito dal suo sorriso. Credo di non aver mai visto qualcuno ridere con tanta cordialità, ma lei non può rendersene conto. E questo è meraviglioso, cioè che non se ne renda conto… Be', ora sto dicendo cose abbastanza sballate. Me ne accorgo e tuttavia ho l'impressione di dover parlare senza interruzione, altrimenti lei non mi crede; e questo porta a confondermi. Se solo non stesse tanto sul chi vive, voglio dire pronta ad alzarsi e ad andar via, certamente me la sbrigherei meglio. La prego, lasci che le prenda di nuovo la mano, mi sarà facile parlare più chiaro. Ecco così, grazie… Sa, da lei desidero solo quel che ho detto; non ho riserve. Cosa c'è, dunque, nelle mie parole che la sconcerta? Non deve pensare che io abbia avuto quest'idea pazzesca, non deve credere che io… che io… voglia… no, e a lei non pare che ciò sia possibile. È questo che sta pensando, vero?”
“Certo… no, Dio mio, lasciamo andare!”
“Ma stia a sentire, ora: non merito che lei ancora sospetti che sto mentendo…”
“No” replica Marta, pentendosi poi immediatamente, “non sospetto di niente, ma è ugualmente impossibile.”
“Perché poi è impossibile? È impegnata con qualcun altro?”
“No, no.”
“Proprio nessuno? Già, perché se fosse impegnata con qualcun altro, diciamo, tanto per fare un nome, con Minuto per esempio…”
“No!” esclama lei ad alta voce. E stringe forte la mano.
© Paolo Melandri (14. 2. 2019)
*
Il sentiero del bosco 3
La foresta si ergeva come una muraglia: nessuna ascia poteva averla ancora mai sfiorata. La catastrofe doveva averne incrementato la crescita, quasi che l'alito della vampa, e il diluvio ch'era seguito, ne avessero scatenate le forze primigenie. Il che andrebbe a favore della teoria di Cuvier.
Gli alberi isolati erano cresciuti ad un'altezza che oltrepassava quella delle torri più elevate. Altri avevano sviluppato chiome così fronzute che sarebbero bastate come rifugio ombroso ad un esercito. Solo più tardi mi colpì, nel loro intrico, una circostanza singolare: i rami si erano innestati per copulazione. In sé, non si tratta di un fenomeno nuovo per il botanico, e nemmeno per il giardiniere che pratica l'innesto a occhio. Ne ho conosciuto uno che da un solo tronco traeva sette specie di frutta. Qui, il fatto straordinario era che l'incrocio era cresciuto alla cieca. Delle specie assolutamente estranee tra loro si erano accoppiate e avevano prodotto frutti, che avrebbero tratto alla disperazione perfino un Linneo, se li avesse visti.
Anche questo fatto mi fece pensare ai laboratori. Non eravamo riusciti, se così posso esprimermi, a produrre forme gigantesche, esseri dalle molte braccia come deità indiane, donne dalle molte mammelle come la Diana di Efeso. Attraverso labirinti genetici, noi avevamo trovato a tentoni la via di reviviscenza di antenati, noti unicamente da cave di ardesia e di marna.
Ma in quel luogo spirava aria proteica e vi era riuscito, per intere foreste, ciò che noi avevamo tentato di ottenere nelle storte con immenso dispendio di fatica. Io lo avvertivo in modo immediato, quasi come un alchimista che, già disperando della grande trasmutazione, scorga risplendere l'oro dentro la fornace. E avvertivo anche me stesso trascinato nella metamorfosi – – – in un modo nuovo, che solo tardi l'esperienza ha confermato nel singolo particolare.
La via del ritorno dall'Albero della Conoscenza all'Albero della Vita è inquietante. Ma non esisteva ritorno nel deserto, che avevo alle mie spalle. Là vi era la morte certa. Ero costretto dunque ad attraversare la foresta, malgrado il pericolo di smarrirmi, fino al mare aperto. Come tutte le foreste vergini, era circodata da una cintura di sterpaglia spinosa. Nella penombra interna, era più praticabile. In cambio però il sole, che unicamente poteva indicarmi la direzione, veniva occultato dal fogliame.
© Paolo Melandri (14. 2. 2019)
*
Il sentiero del bosco 2
È avvenuto dopo una delle grandi devastazioni. Era già trascorsa da anni. Il deserto, fin da prima coperto di scarsa vegetazione, era ormai del tutto inaridito. Le carovaniere apparivano orlate di scheletri di uomini e di animali. Le ossa rilucevano al sole come opali: erano calcinate. Non era stata la decomposizione a sbiancarle. La carne deve esser stata consumata in un attimo. Anche le capanne di argilla delle oasi, le case intorno ai pozzi di trivellazione si erano fuse allo stesso modo: la creta e le pietre erano vetrificate. Sui muri si disegnavano profili di palme, cammelli e uomini, riflessi delle radiazioni cui era seguita la vampa. Da una torre di trivellazione pendevano giù le putrelle superiori, come uno zampillo che si fosse congelato. L'imboccatura di un cannone era piegata come quella di un tubo di gomma; sotto, gocce d'acciaio maculavano la sabbia. Anche le catastrofi hanno il loro stile.
Ero solo. Dei miei compagni, taluni avevano già rinunziato dopo le prime marce, perché erano morti all'altezza di quegli orrori; molti dovevano esser morti di sete o dentro le vallate contaminate. Ancora una volta ero l'ultimo: fa parte delle esperienze dell'età, si diventa stanchi di sopravvivere.
Non so come raggiunsi la foresta. Probabilmente nubifragi avevano colmato le antiche pozze d'acqua. Inoltre, mi ero allontanato dal centro della devastazione; nell'aria roteavano i primi avvoltoi. Poi scorsi piante e animali, tra i quali alcuni a me sconosciuti. Taluni rammentavano illustrazioni di vecchi libri di favole, come se un demiurgo le avesse raccapezzate qua e là.
Si sa che le marce, spinte fino alla spossatezza, provocano delle visioni. D'altra parte, quelle figure mi ricordavano esperimenti cui un tempo mi ero dedicato, e può darsi che una tale reminescenza le avesse proiettate, ingrandite, nel deserto. Anche un fatto simile può acquistare realtà: dopotutto, ogni esperimento è una reminescenza realizzata.
© Paolo Melandri (13. 2. 2019)
*
Il sentiero del bosco
Poi, di nuovo, isole di sterpaglia, negli spiazzi deserti. In una di tali isole si scorgeva un sentiero battuto, una pista di selvaggina. Sfinito a morte, la seguii ciecamente, a tastoni. Conduceva ad un pianoro libero; vi cresceva un cipresso, la cui altezza sfuggiva ad ogni immaginazione. Se il cielo fosse stato nuvoloso, non ne avrei scorto la cima. Il tronco era cavo; l'accesso all'interno non risultava dalla decomposizione del legno ma era intagliato a riquadro dentro l'alburno, come un portale. Gli alberi sono i nostri migliori amici: mi azzardai a entrarvi.
Nel buio, guadagnai l'interno a quattro zampe; il suolo era ricoperto di pelli, o piuttosto di un vello che sembrava esser scaturito da esso come dal dorso di un animale. Un giaciglio magnifico: mi distesi sopra e in un baleno piombai in un sonno simile alla morte.
Non so quanto tempo io abbia riposato là. Quando mi destai, mi sentii rinato, come dopo un bagno dentro la fonte dell'eterna giovinezza. L'aria era deliziosa: profumava di legno di cipresso, la cui resina bruciando si muta in incenso.
Il sole del mattino penetrava nel portale aperto nel legno. Mi drizzai: la mia pelle riluceva, lavata dal sangue, e delle spine non vi era più traccia alcuna. Dovevo aver sognato. Ma, nel frattempo, qualcuno si era preso cura di me. Che significa fra-tempo? Una pausa fra due istanti, o anche fra due forme di esistenza.
Accanto a me, vi era una veste, una sorta di burnus: era tessuta del medesimo oro come il tappeto. Inoltre dei sandali e un vassoio con pane e vino – una elargizione grande e immeritata. Ma da chiunque venisse – qui non era possibile altra forma di risposta che la preghiera.
© Paolo Melandri (13. 2. 2019)
*
Colonna dorica
Dietro l'immagine della Grecia, commista panellenicamente, sta la colonna grigia senza basamento, il tempio fatto di pietre squadrate, sta l'accampamento virile sulla riva destra dell'Eurota, i suoi cori oscuri –: il mondo dorico. I Dori amano la montagna, Apollo è il loro dio nazionale, Eracle il loro primo re, Delfi il santuario, rifiutano le fasce e bagnano i bambini nel vino. Sono i portatori dell'alta antichità, della lingua antica, il dialetto dorico era l'unico che fosse ancora conservato nell'epoca imperiale romana. I loro ideali sono allevamento selettivo ed eterna giovinezza, uguaglianza con gli dèi, grande volontà, fortissima fede aristocratica nelle origini, cura – al di là di se stessi – per tutta la stirpe. Sono i portatori della musica antica, degli antichi strumenti: al citaredo Timoteo di Mileto tolsero lo strumento, perché aveva elevato il numero delle corde da sette a undici, e lo impiccarono. A un altro tolgono a colpi d'accetta due corde da uno strumento a nove corde: devono essere solo le sette antiche. “Nel fuoco la canna che sputa saliva” grida Pratina contro il flauto, perché secondo la nuova moda il flauto pretendeva di guidare il coro invece di accompagnarlo, come fino allora.
Nei templi appendono catene e ceppi destinati ai nemici, agli dèi chiedono nelle loro preghiere tutta la terra del vicino. I re esercitano un potere assoluto, possono muovere guerra contro qualunque paese, cento uomini scelti si alternano giorno e notte nel far loro la guardia; di ogni animale che viene macellato ricevono la pelle e il tergo, nei banchetti vengono serviti per primi e di tutto ricevono il doppio degli altri. È una monarchia ereditaria, per novecento anni regnarono gli Eraclidi, anche i nemici non osavano più, nella battaglia, porre loro le mani addosso per soggezione e timore della vendetta divina. La loro morte viene annunziata da cavalieri per tutta la Laconia, ma nella città corrono donne e percuotono una casseruola.
Mondo dorico: sono i pasti in comune, per essere sempre pronti, quindici uomini, e ciascuno porta una cosa con sé: farina d'orzo, formaggio, fichi, selvaggina e niente vino. L'educazione tende a un solo fine: battaglie e sottomissione. I ragazzi dormono nudi su giunchi che devono strappare senza coltello dell'Eurota, mangiano poco e in fretta; se vogliono aggiungere qualcosa allo scarso cibo, debbono rubarla alle case e alle fattorie, ché i soldati vivono di saccheggio. La terra suddivisa il novemila parti, beni ereditari, ma non proprietà privata, invendibili, tutte della stessa grandezza. Niente denaro, solo monete di ferro il cui valore era così modesto, nonostante il peso e la massa ingenti, che una somma di dieci mine (seicento euro) richiedeva, per conservarla in casa, una camera a sé e, per trasportarla, un carro a due cavalli. Tutti gli altri Stati intorno avevano monete d'argento e d'oro. E anche questo ferro veniva per di più reso inutilizzabile: immerso rovente nell'aceto e in tal modo privato della sua durezza. Per novecento anni regnò la stirpe regale, per altrettanto tempo si conservarono le stesse ricette per i cuochi e per i fornai. Proibizione di viaggi all'estero, divieto di entrata per gli stranieri, rispetto per i vegliardi. L'esercito, nel periodo della monarchia, era costituito di sola fanteria d'urto: opliti, pedoni di linea con armatura pesante e muniti di lancia.
© Paolo Melandri (10. 2. 2019)
*
La pazza gioia 2
Più o meno a quell'epoca, Cerutti, in giro di lavoro attraverso il Lombardo Veneto, il ducato di Parma e la riviera di Genova, incontrava quasi dovunque adunanze dell'Armata. Gli animi erano sostenuti da considerevoli brani di letteratura. Egli ne ammirò l'efficacia. Quegli opuscoli erano redatti, molto evidentemente, da qualcuno che conosceva benissimo il cuore umano. Era una conoscenza estremamente sottile che giungeva a toccare con esattezza corde molto segrete, di solito affondate nelle latebre. Doveva essere prerogativa di un uomo rotto all'esercizio di una intelligenza caustica, capace di generalizzare i propri difetti. Queste le riflessioni che Cerutti faceva tra sé. Era lietissimo di avere valutato Bondino alla prima occhiata. Da quando lavorava per la polizia dello stato piemontese, Cerutti aveva perduto il bisogno di innamoracchiarsi. Si interessava ormai agli uomini come a oggetti d'arte di un museo. Quando fu informato del trasporto dei fondi, si disse unicamente che poteva essere interessante andare a vedere più da vicino quel fenomeno.
Sandro, che era stato un poco seccato di quel cinque per cento, domandò ai suoi ospiti a che cosa servisse tutto quel danaro. Gli fu risposto che occorreva comperare armi e che ne erano già state fatte ordinazioni cospicue a certi armaioli di Sheffield. Allora i due uomini si erano gettati le braccia al collo singhiozzando. La moglie, che era francese e carina, guardò quelle effusioni d'entusiasmo con un certo disprezzo.
Da quell'incontro di Mareuil, Sandro sognava i gradi di tenente. Inviava a Londra buoni documenti contabili in bella scrittura e accuratamente addizionati da Carolina. Creò gruppi di aderenti a Soissons, Fismes, Orléans, Avallon, nei boschi del Gâtinais, nella pianura di Beauce, nella foresta di Othe, nella valletta del Vesle e persino sull'altipiano di Langres. Superò le cinquecento ghinee l'anno. Infine rifiutò di trattenere il cinque per cento e pagò le false spese di propria tasca. Quel modo di procedere fu molto apprezzato a Colbeck House. Gli furono conferiti i gradi di aiutante e miss Learmonth, in un bigliettino molto affettuoso, lo incaricò di una missione di fiducia.
Mentre l'Armata aveva grande fortuna in Guascogna, non reclutava quasi nessuno in Provenza. Marsiglia era un focolaio di agitazione contraria. Il signor Bondino sospettava che vi fosse gente invidiosa la quale anteponeva i propri interessi e il proprio bisogno egoistico di agitazione, alla causa di un grande ideale. Il compito dell'aiutante era questo: scegliere fra i suoi uomini un ragazzo intelligente, celibe e fervente e inviarlo sul posto per vedere esattamente come stavano le cose. Quell'osservatore doveva nello stesso tempo essere munito di una collezione di diciassette proclami pubblicati fino a quel giorno. Occorreva distribuirli nel modo più efficace, cioè consegnarli a uno a uno, nell'ordine e personalmente, in mano di persone preparate a quella lettura da un poco di conversazione preliminare. Dodici dozzine della edizione completa dei diciassette proclami poteva essere ceduta all'aiutante al prezzo di quattro scellini ogni sei, ossia cinque franchi e settantacinque in moneta francese. L'emissario scelto e inviato doveva essere di scrupolosa onestà (l'aiutante era caldamente pregato di assicurarsene). Egli avrebbe portato con sé i moduli della situazione settimanale numero 4 e li avrebbe inviati a Colbeck House ogni sabato, datati, firmati, dichiarati conformi, anche se con niente di fatto. I fondi, come al solito, alla Società delle Spezie.
Sandro suggerì il calzolaio di Crépy-en-Valois. Questi aveva preso il nome di Vasseur, ma in realtà si chiamava Doria. Munito di una tessera di circolazione fino ad Avignone, vestito da capo a piedi dai suoi fratelli d'arme e bene al caldo in una comoda carrozza chiusa di Sandro, Doria lasciò Parigi ai primi di novembre.
Non gli dispiaceva piantare in asso la calzoleria. In realtà, chi faceva tutto il lavoro era il suo operaio, uno zoppo, semplice di spirito, abituato alla schiavitù. Doria aveva scelto quel mestiere senza rapporto con la sua professione di avvocato, per nascondersi bene. Per la stessa ragione aveva scelto il nome di Vasseur. Non gli piaceva affatto quanto era accaduto dopo il furto delle cartucce a Genova. Quella faccenda era stata montata da cinque o sei compagni che si eccitavano a vicenda, a parole, da più di un anno. Per dimostrare a se stessi di valere qualcosa, prima avevano già assalito e svaligiato il corriere postale da Cuneo a Mondovì. La carrozza portava soltanto i sacchi, difesi dal cocchiere, che preferì prendere parte alla bazza. Quella spedizione aveva fruttato quattromila lire di cui non si era saputo cosa fare. I compari alla fine avevano acquistato fazzoletti da collo e cravatte rosse con il frutto dell'assalto e, poiché era difficile portare quegli emblemi a Mondovì e nei dintorni, erano andati a sfoggiarli a Genova.
Doria aveva lasciato la scuola di Diritto appena da due anni ritrovò qualche amico. Si ricominciò a parlare, molto sul serio e specialmente di un certo numero di pacchi di cartucce, che erano provvisoriamente in deposito in un capannone dell'Arsenale, facilmente accessibile. Le informazioni erano state date da un affiliato, nostromo di un veliero. Fu stabilito di attaccare l'Arsenale. Furono formati cinque gruppi di dieci, saltati i muri, imbavagliate le prime sentinelle e si arrivò quasi senza rumore fino al padiglione indicato. Tutto era andato benissimo. Non era stato più difficile della carrozza di posta. A forza di dipingere il coraggio, Doria ne aveva acquistato un poco. Non poteva darne prova migliore se non ragionando nel colmo del rischio. Sostenne che le cartucce senza i fucili non servivano a nulla. Era tanto giusto che, lasciando tre gruppi provvedere allo sgombero delle cartucce, il quarto gruppo seguì Doria alla ricerca dei fucili. Per disgrazia, si imbatterono in una sentinella che si difese come un leone, impugnando la baionetta, bucando pance a destra e a sinistra, mentre Doria disorientato gli gridava: “Ehi, attenzione, signore, attenzione!”. Rimasero sul campo due morti e un ferito che il giorno dopo spifferò tutto, pur di avere un poco di laudano, poiché soffriva molto.
Doria, a briglia sciolta, ritornava a Mondovì quando, al cambio di Millesimo, venne a conoscenza dell'arresto dei suoi amici. Abbandonò la via maestra e deviando sopra Cuneo per vie traverse passò in Francia. Il governatore militare di Genova disponeva di poco tempo e aveva paura. Il consiglio di guerra fu senza pietà: condannò a morte quindici dei venti imputati e i quindici furono fucilati.
© Paolo Melandri (3. 2. 2019)
*
La adorazione dei magi
La vecchia disse, “Sì, sono arrivati finalmente; adesso potrà morire in pace”, e uscì.
“Siamo stati ingannati dai diavoli,” disse uno dei vecchi “perché gli Immortali non parlerebbero per bocca di una donna come questa”.
“È vero,” disse un altro “siamo stati ingannati dai diavoli, e dobbiamo andarcene in fretta”.
“Sì,” disse il terzo “siamo stati ingannati dai diavoli, ma inginocchiamoci un momento, poiché siamo accanto al letto di morte di una che è stata bellissima”. Si inginocchiarono, e la donna che sedeva accanto al letto sussurrò a capo chino, come se avesse paura, “Nell'istante in cui avete bussato è caduta in preda alle convulsioni e ha gridato con voce da partoriente ed è ripiombata sul letto come in deliquio”. Poi osservarono per un po' quel volto sul cuscino, stupiti della sua espressione, come di inestinguibile desiderio, e della squisita finezza, come di porcellana, del vaso in cui aveva bruciato una fiamma così maligna.
Improvvisamente il secondo vecchio cantò come un gallo, finché la stanza non sembrò tremare sotto la forza di quel canto. La donna che giaceva sul letto si svegliò dal suo sonno di morte, ma la donna che sedeva al suo capezzale si fece il segno della croce e impallidì, mentre il più giovane dei tre vecchi gridava, “Gli è entrato un diavolo in corpo, e se non ce ne andiamo di qui faremo la stessa fine”. Ma prima che riuscissero ad alzarsi in piedi, una voce stentorea uscì dalle labbra che avevano cantato come un gallo, e disse salmodiando: “Non sono un diavolo, ma sono Ermes, Pastore dei morti e messaggero degli dèi, e quello che avete udito è il mio segnale. La donna che giace su quel letto ha partorito, e ha dato alla luce un essere che ha l'aspetto di un unicorno ed è, di tutti gli esseri viventi, il meno simile all'uomo, poiché è freddo, duro e virginale. Sembrò che nascesse danzando; e lasciò questa stanza quasi all'istante, poiché è nella natura dell'unicorno il capire la brevità della vita. Ella non sa che se n'è andato, perché mentre l'unicorno danzava cadde in uno stato di stuporosa incoscienza, ma voi chinate il capo e porgete orecchio in modo da apprendere i nomi cui esso deve obbedire”.
Gli altri due vecchi tacquero, ma certamente guardarono perplessi quello che aveva parlato, perché la voce riprese: “Qualora gli Immortali volessero rovesciare le cose che sono oggi e restaurare le cose che erano ieri, nessuno potrebbe aiutarli se non qualche reietto messo ai margini delle cose che sono oggi. Inchinatevi, e profondamente, ché essi hanno prescelto questa donna nel cui cuore si sono raccolte tutte le follie, e nel cui corpo si sono risvegliati tutti i desideri; questa donna che è stata sottratta al tempo e ha giaciuto sul seno dell'Eternità”. La voce si spense in un sospiro, e subito il vecchio si risvegliò dal sonno e disse, “Una voce ha parlato attraverso la mia bocca, come quando mi addormentai leggendo Virgilio, oppure ho soltanto dormito?”. Il più vecchio dei tre disse, “Una voce ha parlato attraverso la tua bocca. Dov'era la tua anima mentre quella voce parlava?”.
© Paolo Melandri (3. 2. 2019)
*
Pallade
Atena, balzata dalla tempia di Zeus, glaucopide, splendente in armi – la divinità senza madre. Pallade – un inebriarsi di battaglie e di distruzione, la testa di Medusa sullo scudo davanti al petto, sopra il capo il fosco uccello notturno ignaro della gioia; – essa arretra un po' e d'un colpo solleva dal campo l'enorme pietra confinaria librandola contro Marte, che tiene le parti di Troia, di Elena; – Venere si lamenta per la mano feritale da Diomede: risa su questo sangue, si sarà graffiata urtando contro una fibbia d'oro nel fare qualche carezza in basso, vicino a una qualche armatura; – Pallade, ancora più in là di Saffo e di Maria, una volta quasi sopraffatta nel buio di una grotta, sempre chiusa nell'elmo, mai fecondata, dea senza figli, fredda e sola.
Ha inizio il cataclisma. Detronizzazione della donna come sesso primario e supremo. Abbassamento della donna a etèra da fecondare. Comincia un'epoca di maledizione. Platone, Eschilo, Agostino, Michelangelo – tutti rappresentano un'età di esecrazione, in parte addirittura pederasti. Dove un contrappeso?
Fra le api! L'ape è l'animale prediletto dal paladino dello spirito matriarcale. Il miracolo sociale-religioso della vita delle api. Mille metri al di sopra del suolo, dove cantano le allodole e volano le nuvole, lì ha luogo l'accoppiamento. Lì il fuco più robusto raggiunge la regina, si aggrappa al suo corpo odoroso di melissa e le infonde vita nel grembo per morire subito dopo. È il cielo stesso, per così dire, a fecondare la regina nella solitudine dello spazio azzurro. Dopo le api vengono le formiche. Esemplari di sesso maschile si trovano nello Stato delle formiche solo per breve tempo. Alle attività sociali essi non prendono parte. Infine gli afidi. Si potrebbe enunciare la legge che tutti gli organismi statali non fondati sullo spirito matriarcale non vanno oltre il principio dei conglomerati di afidi. Gli insetti contro Pallade!
Iside, Demetra – quelli erano tempi! Ishtar-Madonna, Nostra Signora, con la vacca, il mammifero per eccellenza, come simbolo materno; inoltre la mancanza di un padre come caratteristica di tutti i redentori dell'Asia anteriore – certe incarnazioni di divinità dovettero tornare fino a cinque volte nel grembo materno (Cristo nella tomba di roccia, agli Inferi, Cristo discese alle Madri –: et resurrexit) –; pure anche Diotima si pettinava, dapprima, specchiandosi ancora nel cranio calvo di Socrate, e qualunque cosa egli fosse capace di meditare in quel suo cranio, glielo offriva a sua volta – ma poi il cataclisma! Pallade! Ora il suo grande simulacro di bronzo sta all'aperto fra i due templi. E che cosa combinava Socrate subito dopo, assieme a Fedro, sulla riva dell'Ilisso? Di certo questo non piace alla Grande Madre! Il flusso di vita generatrice, destinato solo al suo grembo, raffreddato dialetticamente fra le mani di vegliardi filosofanti dal volto butterato! (Ah, il nostro patrocinatore del diritto matriarcale!).
Pallade, la protettrice del maschio, colei che apporta chiarezza mentre tutto dovrebbe restare humus originario, oscurità originaria, sussurro originario! Pallade, che fece salire in alto Achille, Teseo, Eracle, che fece salire in alto la forza con sembianze leonine, il muggente toro universale che quando non ottiene subito la giovenca, pensa, per astuzia e vendetta, con le corna e i testicoli! Dapprima pensa in quanto essere che emette profumi e seduce con aromi, vaporatore di essenze cerebrali – fin qui niente da obiettare! Se almeno fosse rimasto toro, essenza profumata, pavone, scimmietta, guardiano delle stalle come Giuseppe! Invece è diventato questo trascendentale soggetto maschile, androcrate maniaco, pederasta del tempio! Quello che nella foia è l'essere più infantile e più pericoloso, ancora fa schioccare la lingua e fischia, si gira intorno come il gallo in calore, e subito dopo è privo di ogni freno e va assassinando. Il suo pensiero, originariamente nient'altro che spettacolo, un tubante schiamazzare, un convogliatore di erezioni, riempitivo ornamentale di un sesso fatto per essere soppresso, non destinato ad altro che ad essere collaboratore nell'aprire la porta delle nascite – questo cupo apriscatole, ora si rendeva indipendente con i suoi sistemi, puramente negativi, e con le sue illusioni contrastanti – tutti questi lama, Buddha, uomini-dio, re-dèi, salvatori e redentori: e nessuno ha realmente redento il mondo – tutte queste tragiche figure di maschi celibi, estranee all'originario humus materico della natura, aliene al segreto senso materno delle cose, involontarie fratture della forza formatrice, ragione impura, “tristi ospiti” cui sono di gran lunga superiori le campagne propagandistiche a base di musica compiute collettivamente da cicale e rane e che nei più alti e più sociali Stati degli imenotteri, dove tutto sbocca in maniera normale nell'atto dell'accoppiamento, verrebbero dichiarati nemici dello Stato e tollerati solo temporaneamente –, tutto ciò l'ha fatto sorgere Pallade, da Pallade alla schizofrenia c'è solo un passo, – Pallade e il nichilismo, Pallade e la cerebralizzazione progressiva, – sotto quei platani essa cominciò nel grosso, disgustoso cranio di Socrate, in quel cranio i primi rispecchiamenti e le prime proiezioni – ahi, e un tempo rispecchiava i tuoi capelli e le tue labbra, o Diotima!
Ciò che vive è qualche cosa di diverso da ciò che si pensa. Questo è un dato fondamentale di oggi, con cui dobbiamo fare i conti. Un tempo potrebbe essere stato diverso, da mondi più tardi potrebbe avvicinarsi lucente un'unione siderale; comunque adesso, in quest'ora, essa non esiste. Non solo farci i conti: riconoscere, difendere l'epoca orestea, il mondo come costruzione spirituale, come appercezione trascendentale, l'esistenza come costruzione spirituale, l'essere come un sogno della forma. Tutto ciò è stato duramente conquistato attraverso la lotta, fortemente sofferto, questo e altro ancora. Pallade ha inventato il flauto – canna e cera –, una piccola cosa. Anche il nostro cervello si trova di fronte a una limitazione spaziale. Noi possiamo formare solo centri parziali di ambito molto ridotto; sviluppare prospettive ampie, orizzontalmente e temporalmente, non ci è dato. Sistemare piccoli spazi, dar forma con lo scalpello a superfici grandi quanto il palmo della mano, sintesi anguste, tesi ristrette –: tutto il resto sta al di fuori dell'epoca.
© Paolo Melandri (31. 1. 2019)
*
Avvicinamenti 2
Un bambino che ha già le stesse difficoltà di un adulto, per quanto riguarda il tempo e la società: tra gli altri bambini corre senza meta per il giardino, si ferma, mima un gioco, interrompendosi subito perplesso; poi di nuovo tenta di imitare miserabilmente la vivacità degli altri bambini, senza muoversi, producendo una tristissima e ridicola serie di azioni del tutto prive di senso, che vorrebbero però essere virtuosistiche, saltando su e giù per il giardino, strisciando furtivamente, girandosi su se stesso, tutto ciò in piena solitudine rispetto a tutti gli altri che invece seguono un ritmo ben preciso; una volta, poi, l'unica volta che riesce a inserirsi nel ritmo altrui e che si guarda intorno tutto orgoglioso, nessuno lo nota, perfino i cani, verso i quali vorrebbe chinarsi, fuggono via, e così continua ad andare avanti in cerchio, le mani dietro la schiena, saltellando talvolta nella sua tristezza in un modo apparentemente vivace.
2.
Quell'abitudine degli attori americani di parlare puntando l'indice come un revolver; persino i più giovani cominciano a ripetere questo gesto.
3.
Per la prima volta dopo lungo tempo sono nuovamente in grado di osservare il mio corpo, non come se volessi registrarne i contorni, ma con una specie di attrazione, con una sensazione di appartenenza.
© Paolo Melandri (28. 1. 2019)
*
La pazza gioia
Ai primi di marzo del 1848, un calesse entrava in Novara dalla strada di Vercelli. Si era presentato alla porta della città alle dieci di sera. Da un pezzo, a fanale spento, aspettava a cento passi di là, nascosto fra i salici. Vi fu un cambio della guardia e il carrozzino si inoltrò. Scambiate poche parole, il sergente diede il passo.
Il cocchiere all'aspetto pareva francese. Il passeggero, con qualche indicazione in quella lingua, si fece portare in giro al passo, per i viali deserti dei rioni borghesi. Il vento di Lombardia misto a un poco di pioggia faceva dondolare i fanali.
A San Gaudenzio suonarono le ore.
– Non vorremo comunque aspettare mezzanotte, – disse il passeggero.
Fece la risatina un poco volgare degli uomini grassi molto soddisfatti. Ordinò di inoltrarsi in un viale costeggiato da giardini.
La carrozza entrò nel parco di casa Ansaldi. I cancelli le furono aperti senza indugio da qualcuno che doveva essere in vedetta. Nell'aria, profumo di ciuffi di lillà già fioriti. Alla luce leggermente rossastra dei fanali del viale, filtrata attraverso gli alberi, si distinguevano sulla scalinata d'ingresso due persone in attesa. Una era una donna con una casacca molto attillata e il cappello piumato, nonostante la pioggia; l'altro era un uomo in finanziera. Il calesse si fermò dinanzi a loro. Il cavallo stanco sbuffò rumorosamente nel morso.
– Buonasera, marchesa, – disse il viaggiatore.
Si fece un dovere di uscire dal calesse. Il cocchiere andò ad aiutarlo, sorreggendogli a due mani il treno posteriore. L'uomo scese a fatica; era un vecchio corpulento: Bondino, detto Brutus alla rosa, e ritornava a Novara.
L'aveva lasciata nel 1821; l'aveva rivista per l'ultima volta nell'aprile del 1821, e per di più non era se non un fantasma di città in mezzo al fumo. Egli comandava una compagnia di soldati costituzionali di Alessandria. Durante la marcia fino all'Agogna, non aveva smesso di ripetere ai suoi uomini che stavano per riunirsi con i fratelli di Novara. Non era mai stato tanto stupido da credere a ciò che diceva. Alla prima cannonata partita dalle mura della città, aveva riconosciuto l'artiglieria leggera. Si era dunque a quel punto: vivere o morire? Egli girò il cavallo e attraversò di galoppo tutta la colonna. Alle porte di Vercelli gli venne l'intenzione di unirsi ai pochi cavalieri che sostenevano la carica di un plotone di cavalleggeri. Ma la sera stessa era a Casale e due giorni dopo a Genova.
Non aveva ancora finito i suoi studi. Schiavo zelante di un giornale di mode, la sua erudizione non andava più in su. Dimenticare un corpo ben fatto non è possibile a tutti. E spesso è un errore: quando, misurando con cura l'altezza della sua cravatta e dando con un elegante buffetto una spolveratina ai risvolti di seta della sua giacca, egli parlava con coraggio, si faceva ascoltare. Il contrasto fra i suoi fazzoletti da collo color tortora e le parole audaci che pronunciava con aria distratta era tanto violento che aveva dato origine al suo soprannome.
A Genova aveva saputo che l'esercito negoziava con Enrico, capo della guarnigione insorta, la resa dell'arsenale di Torino. Si parlava di centocinquemila lire. Poiché questa cifra fu riferita dai braccianti del porto, Bondino si limitò a sorridere. Quando Asinari e Morozzo gli confermarono la realtà del negoziato, egli diede al fatto tutta la sua importanza.
Partito da Genova l'otto aprile di buon mattino (doveva incontrare Asinari che cambiava i cavalli in piena montagna a Cortemilia) arrivò a Torino nel pomeriggio del 10, mentre il generale de La Tour alla testa del grosso delle sue forze vi faceva il suo ingresso alla chetichella. Il signor de La Tour non considerava la ritirata dei costituzionali a Novara una ragione sufficiente a una sfilata trionfale. Ostile d'altronde a ogni specie di spettacolarità e di solennità, egli spiegava così gli avvenimenti che lo inducevano a entrare in Torino con il bicorno da generale:
– Vittorio Emanuele, – egli diceva, – è stato costretto ad abdicare da gente che pretendeva di agire in nome del re. Abbiamo avuto alcuni giorni di reggenza nei quali sono state rovesciate le leggi fondamentali del regno, senza mai parlare se non di rispetto e di fedeltà al re. È venuta una giunta che ha organizzato un corpo d'armata e, in nome del re, l'ha spedito a battersi contro il re. Dopo tutte queste stranezze, arrivo io, sempre in nome del re, e mi impadronisco della città. Per chi volete che mi si prenda, in realtà?
Non si fece precedere da alcuna pubblicazione atta a persuadere e a rassicurare gli animi. Egli entrò in Torino (aveva naturalmente comperato la cittadella in contanti) sul cadere della notte. Si infilò modestamente per le stradine secondarie con due battaglioni di Cacciatori Reali. Il pubblico lo accolse con freddezza.
Poiché esattamente per le stradine secondarie si inoltrava anche Bondino, questi fu costretto a far fermare il suo carrozzino a un crocicchio per lasciar passare i soldati. Fu sinceramente scontento di aver ceduto il campo a gente che non aveva neppure un trombettiere per entrare nella capitale. Assicurò in seguito di aver visto Carlo Alberto seguire la truppa come un umile vivandiere. Ma è dimostrato che il re giunse soltanto il giorno dopo.
Orbene, il giorno dopo, Bondino era di nuovo, a cose fatte, sulla strada di Genova, Enrico era un infimo personaggio. Era già stato scoperto una volta che portava via in tasca le posate d'argento della sua ospite. Ora, oltre a ciò che Bondino chiamava la quota del popolo, Enrico gli aveva consegnato quarantamila lire da versare a una persona della sua famiglia. Bondino annotò sul retro di una busta: “Non fare mai custodire le cittadelle da un pezzente”.
Genova, dove le decorazioni del governo si cambiavano con meravigliosa facilità, aveva reinsediato il conte Des Geneys, dopo averlo letteralmente nella polvere. Quel generale, non avendo assolutamente nessuno ai suoi ordini, credette di potersi limitare a vietare con qualche cartello l'ingresso dei fuggiaschi in città. Poiché quelli erano entrati ugualmente, egli, non potendo fare nulla di meglio, sollecitò la loro partenza… Molti si imbarcarono per la Spagna. I capi più autorevoli si rifugiarono in Francia e in Svizzera.
Bondino ritrovò, sulla goletta, Asinari molto sostenuto ma dignitoso, Regis, l'ex generale francese Guillaume de Vaucourt, l'abate Patrioli, Viancini, Castelbergo, il medico Andreone e persino il generale Lisio. Su quest'ultimo correva voce che avesse predato la cassa del reggimento. Era molto corteggiato.
Dopo cinque giorni di maltempo, Asinari che non sopportava il mare domandò di essere sbarcato vicino a Golfe-Juan. Bondino lo avrebbe seguito volentieri. Gli piacevano le vittime. Aveva osservato che Asinari non aveva bagaglio, né probabilmente danaro. Se lo figurava nelle solitudini del Var. Tenendosi a distanza accanto a lui, forse aveva il modo di godersi un piacevole spettacolo.
Vaucourt, con la sua faccia insignificante e la persona trascurata, era molto attratto dal lato rosa del Brutus. Parlò di Platone. Disse sopra tutto rozzamente, ma con buon senso: – È meglio continuare a vomitare ancora un poco, ma continuare a tenere il manico della padella –. Questa idea, senza essere del filosofo greco, interessò Bondino.
© Paolo Melandri (27. 1. 2019)
*
Afrodite 7
Quella sera Criside arrivò per prima.
Vestiva un abito verde ricamato di enormi rami di rose, che le venivano a sbocciare sui seni.
Arezia le aprì la porta senza ch'ella avesse bisogno di bussare, e secondo il costume greco, la condusse in un piccolo vano appartato, le sciolse le rosse calzature e dolcemente lavò i suoi piedi nudi. Poi sollevando la veste, o aprendola, secondo il bisogno, la profumò in ogni parte che fosse necessario, giacché ai convitati si risparmiava qualsiasi preoccupazione, anche quella di acconciarsi, prima di recarsi a pranzare. Le si presentò poi un pettine e alcune spille per sorreggere la sua pettinatura, come pure diverse pomate grasse e secche, per lavare le labbra e le guance.
Quando Criside fu finalmente pronta:
– Chi sono le ombre? – domandò alla schiava.
Così veniva chiamato ogni convitato, salvo uno solo che era l'Invitato. Questi, in onore del quale si dava il pranzo, conduceva con sé chi più gli talentava, e le ombre altra cura non avevano da prendersi, che quella di portare con loro i cuscini del letto, e di essere ben educati.
Alla domanda di Criside, rispose Arezia:
– Naucrate ha invitato Filodemo con la sua amante Faustina che ha condotto dall'Italia. Ha invitato anche Frasilao e Timonte e la sua amica Seso di Cnido.
In quel momento stesso, Seso entrò.
– Criside!
– Cara!
Le due donne si baciarono, effondendosi in esclamazioni sul felice caso che le riuniva.
– Temevo di essere in ritardo – disse Seso. – Quel povero Archita mi ha trattenuta…
– Come? Sempre lui?
– Sempre così. Quando vado a pranzare in città, si immagina che tutti mi abbiano da possedere: allora vuole vendicarsi in anticipo ed è una storia che non finisce più! Ah, cara! se mi conoscesse meglio! Non ho nessuna voglia di ingannarli, i miei amanti, ne ho abbastanza di loro.
– E il piccino? Sai che non si vede per nulla?
– Lo credo bene! sono nel terzo mese. Spinge, questo piccolo mascalzone! Ma per ora non mi dà fastidio. Fra sei settimane mi metterò a ballare e spero che questo gli riuscirà tanto indigesto da persuaderlo ad andarsene.
– Hai ragione – disse Criside. – Non ti far deformare la persona. Ho visto ieri Filematina, la nostra piccola amica di una volta, che da tre anni vive a Bubaste con un mercante di granaglie. Sai che mi ha detto? Le sue prime parole? “Ah se tu vedessi i miei seni!” e aveva le lacrime agli occhi. Le dissi che era sempre bella, ma lei ripeteva: “Se tu vedessi i miei seni! Ah! Ah! se tu vedessi i miei seni!” piangendo come una bambina. Allora ho visto che aveva quasi desiderio di mostrarmeli e glie l'ho chiesto. Cara mia! due sacchi vuoti! E tu sai se li aveva belli. Non se ne vedeva la punta, tanto erano bianchi. Non ti rovinare i tuoi, Seso mia, lasciali giovani e diritti come sono. I seni di una cortigiana valgono più della sua collana.
Così parlando le due donne si abbigliavano. Finalmente entrarono insieme nella sala del banchetto, dove Bacchide attendeva in piedi, con la vita serrata nella fascetta e il collo pieno di collane d'oro che le salivano fino al mento.
– Ah! belle mie, che buona idea ha avuto Naucrate di riunirvi questa sera!
– Siamo felici che lo abbia fatto in casa tua – rispose Criside, fingendo di non comprendere l'allusione. E per dire immediatamente una cattiveria aggiunse:
– Come va Doriclo?
Era un giovane amante, molto ricco, che aveva abbandonato Bacchide per sposare una Siciliana.
– L'ho… l'ho licenziato – disse Bacchide sfrontatamente.
– È mai possibile?
– Sì; si dice che per dispetto prenda moglie. Ma lo aspetto al domani delle nozze: è pazzo di me.
© Paolo Melandri (25. 1. 2019)
*
Presso la torre saracena
Il Castello edificato da Michelangelo è là come un titano nella sabbia. Intorno alla sua sagoma cui si avvinghia la decadenza come nelle incisioni di Piranesi, qualcosa di oscuro e possente nel cielo grigio annuncia l'avvicinarsi di un temporale. Qua e là si mettono mattoni su mattoni o si rabberciano casupole. Accanto alla muraglia sta emergendo dall'acqua l'elmo di rame di un sommozzatore. In un secchio hanno lasciato per lui pietre e malta. Nuove costruzioni crescono in mezzo al vecchio disordine. Ma subito dopo si offrono allo sguardo le scogliere marine su cui pende biancheria cenciosa.
Facciamo di nuovo conoscenza con lo spettacolo truffaldino di parrucchieri, camerieri e facchini. Quando presentano il conto, sempre troppo salato, la commedia si trasforma nell'ammirabile assistenza di un'ostetrica. Osservano il cliente mentre gli tolgono dalla mano, tormentandole con le dita, una banconota dopo l'altra, pronti a smettere quando vedono che l'atteggiamento dell'interlocutore non è molto confortante. L'errore è sempre possibile, anzi inevitabile. Poi c'è la divertente commedia della mancia. Non si è mai tanto generosi da scongiurare un'ulteriore richiesta. Disattenderla serebbe un palese errore tattico. È istruttivo, in merito, osservare un atteggiamento che conosce solo il mercanteggiare, non la limpida conclusione di un rapporto d'affari. Il mercanteggiamento tiene conto del caso individuale, non di un sistema preciso di prezzi e tariffe. Ciò aumenta indubbiamente l'anarchia, ma d'altra parte offre il vantaggio d'immergere il cliente nel proprio concreto bisogno, non nelle astrazioni e finzioni dello Stato. Egli non accetterà mai di essere ripagato con una manciata di sudici stracci. La perspicacia cresce quanto più ci si avvicina al Levante, e là il commercio raggiunge perciò la sua più alta maestria quando si tratta di mercanteggiare con cose di cui è difficile vedere esattamente la qualità, per esempio tappeti e cavalli.
Mi avventuro in queste riflessioni mangiando una zuppa di fagioli. Subito dopo arriva il caffè nero, e vado a passeggiare sulla spiaggia.
© Paolo Melandri (23. 1. 2019)
*
Una giornata nella casbah
Il mio servizio è irregolare, può trascorrere anche una settimana senza che il bar notturno venga aperto. Lo è soltanto in presenza del Condor. Probabilmente, il Domo vuole prevenire la possibilità che si formino, qui, dei piccoli circoli stabili.
Il moka viene servito già a mensa; spesso qui non si tratta che di un digestivo. Poi, invece, si può addirittura tirar l'alba. A me fa piacere: mi apporta buoni frutti. Dopo aver chiuso e sbarrato il bar, cerco di sopra, davanti a un bicchiere di vino, di decifrare la mia scrittura luminescente, e rifletto sui discorsi fatti.
Durante il servizio non bevo nemmeno un goccio, perfino se il Condor, messo di buonumore, mi invita a farlo. Non bevo nemmeno acqua, neanche se ho sete. “Non tocco bicchiere”, salvo che per servire: e ciò per una serie di ragioni – a prescindere dal fatto che amo esprimermi in modo preciso. Qui sono sciatti: dicono per esempio “dormo con lei”, anche quando hanno in mente ben altra cosa che il sonno.
A tal riguardo, mi trovo d'accordo col Domo, che anche lui annette valore all'esattezza del linguaggio, come ho già esposto. Lo vedo farmi cenni di consenso quando si accorge che io rimango fermo nei miei propositi perfino nei confronti del Condor – – – sì, di me ci si può fidare. Sia detto senza ironia.
Se mi corico tardi, mi attardo anche nell'alzarmi: il giorno appartiene a me. Il sole, allora, è già alto sulla casbah; l'aria sfavilla sopra le euforbie. Quando l'aria condizionata si interrompe, fa un caldo torrido. Di solito, la innesto se ho intenzione di lavorare. Peraltro, la tecnica è infida, sebbene uno stuolo di elettricisti e di altri artigiani stia a disposizione. Talvolta mi sembra quasi che essa venga convocata come un sogno e poi di nuovo trascurata. Comunque, non viene più presa tanto sul serio; e perfino il Domo sembra preferire un juste milieu alla perfezione tecnica.
Quando egli diventa impaziente, si tratta meno di guasti agli apparecchi quanto, piuttosto, di défaillance degli artigiani. Ciò ricorda i princìpi del tardo rococò, che consideravano il fucile in prima istanza uno strumento per maneggi di esercitazione.
Se avviene ch'io rimanga dietro il bar fino al mattino, fuori può essere già giorno fatto, spesso addirittura mezzogiorno, quando poi mi sveglio. Me ne sto sdraiato al buio, perché dormo dentro l'alcova dietro una fitta cortina. Dopo il risveglio, rimango là ancora un quarto d'ora, prima di alzarmi.
Se ora dico “per pregare” si troverà singolare tale espressione. In effetti, il termine è logoro e corrotto dal clericume. “Religio”, come si sa, si ricollega a “legame”, e proprio questo è ciò che l'anarca rifiuta. Egli non si impegola né con Mosé e i Dieci Comandamenti, né in genere con i Profeti. E nemmeno vuole saperne di divinità e delle dicerie che le concernono, se non in qualità di storico – – – o nel caso che gli si presentino in persona. Hanno allora inizio i conflitti.
Se quando dico “per pregare”, seguo un istinto innato, che non è più debole dell'istinto sessuale, anzi, ancora più forte. Entrambi si somigliano per il fatto che contrasti spiacevoli incombono ove vengano repressi.
Nemmeno in tale esigenza l'anarca si distingue da tutti gli altri. Gli dispiace soltanto di lasciarsi legare. Non dissipa la sua parte migliore. Per il proprio oro non accetta surrogati. Conosce la propria libertà, ma anche il suo contrappeso. L'equazione si risolve quando gli viene offerta una soluzione credibile. Il risultato è l'Uno.
Che gli dèi siano apparsi, non soltanto nella preistoria, ma fino alla tarda epoca storica, non è da mettere in dubbio; essi hanno banchettato e lottato con noi. Ma che giova all'affamato lo splendore dei festini trascorsi? Che giova al povero il tintinnìo dell'oro, da lui percepito attraverso il muro del tempo? È la presenza che bisogna esigere.
L'anarca lascia stare la cosa com'è: ha tempo di aspettare. Egli ha il proprio ethos, ma nessuna morale. Là dove l'ethos si piega a norme e comandamenti, è già corrotto. Certo, però, egli può vivere in armonia con essi, secondo il luogo e le circostanze, per un tempo lungo o breve, come faccio io qui col tiranno, finché mi garba.
Un errore di ragionamento degli anarchisti consiste nel fatto che essi ritengono gli uomini buoni per natura. In tal modo castrano la società, similmente a quanto fanno i teologi (“Dio è il Bene”) col Buon Dio. È una caratteristica saturnia.
Il diritto naturale è stato strapazzato in tutti i sensi – dalla legittimazione al brutale atto di violenza, fino all'idillio paradisiaco. Ciò avviene a motivo del fatto che dalla natura è possibile trarre tutto quel che si vuole. “Tutto essa è in una volta sola.” E va bene: ciascuno tragga dall'essere la propria parte. Nel regno delle molecole hanno inizio il caso e l'arbitrio. Deve esistere, fin dal principio, una frattura nell'universo. Perfino il termine “origine” vi accenna. La Genesi offre allusioni mirabili – – – però soltanto voci, come se un pastore avesse origliato ad una porta socchiusa.
Il diritto va ricercato negli atomi e più in fondo ancora, anche nei propri. È di là che il giudizio etico ed estetico reagisce alle più sottili oscillazioni. È perciò che il torto si presenta anche, di solito, con aspetto laido. Con l'elevarsi aumentano i rischi, come per il funambolo cui nessuna rete dà sicurezza, oppure nel passaggio sul monte Sirat, esiguo come una lama di coltello. Mai la tentazione di invocare gli dèi risulta più forte, e mai più grande il merito di resistervi.
Come storico, ma soltanto come tale, io sono positivista. Il diritto è valido fin tanto che è rispettato e può essere rispettato. La buona coscienza – da non intendersi certo come arroganza moralistica – fa parte delle premesse. Non esiste soltanto la sopravvivenza di chi è valente, ma anche quella di chi è onesto. Che entrambi non coincidano nel tempo, riconduce di nuovo all'origine, alla separazione dell'Albero della Vita da quello della Conoscenza.
Si intende che l'anarca, quando prega, non implora né ringrazia. Né cerca nella preghiera una forza magica. Quante ardenti preghiere non sono state esaudite! Come storico, mi trovo dentro le celle dei condannati, come anarca vorrei dispensare loro un conforto postumo; e so che il colpevole ne ha più bisogno dell'innocente.
Sono stato in carcere con Boezio, e con Maria Antonietta al Tempio, quando i suoi capelli imbiancarono. Ero presente mentre le masse fuori ululavano e il padre indossava le filatterie. Il bambino cercò a tastoni la sua mano. Ma né il padre né il bambino sono stati esauditi.
Ciononostante, la preghiera obbedisce a un istinto innato. È più importante del mangiare e del bere, poiché testimonia più che la vita peritura. Conduce dietro le squallide quinte con cui il sapere deforma l'universo. L'acqua è riconosciutamente diversa nella ritorta e negli acquedotti, che guidano alle metropoli, e diversa ancora nei mari – – – come acqua di vita, nella preghiera.
Il clericume annette valore al fatto che la preghiera sia rivolta a deità personificate.
“Autentica preghiera esiste soltanto nelle religioni in cui vi sia un dio dotato di volontà, di persona e di figura.”
Così un celebre protestante. L'anarca non vuole avere a che fare con roba del genere. L'Uno è certo capace di plasmare persone, ma non di essere lui stesso persona, e già quel “lui” è un pregiudizio paternalistico.
L'Uno è inafferrabile, mentre l'uomo s'intrattiene da eguale con molti dèi, sia che li inventi o che li scopra. In ogni caso, ha dato loro nomi. Il che non deve confondersi con un monologo su un piano più elevato. Qualcosa di divino vi è indubbiamente in noi e deve, come tale, esser riconosciuto, altrimenti non potremmo avere nozione alcuna degli dèi.
“Giacché un dio opera in noi” (Hölderlin). “Uno è il principio di tutto” (Filolao). “Un dio è tra gli dèi e tra gli uomini il maggiore, non comparabile ai mortali né per forma né per idee” (Senofonte). “Un turbine di forme multiple si distacca dal Tutto” (Democrito).
E sempre si torna ad Eraclito. Sul numinoso non vi è da far scalpore: ciascuno lo incontra – ciascuno ha il suo Sinai, e anche il suo Golgota.
Il pavimento, davanti all'alcova, è di maiolica; le piastrelle sono esagonali, adeguate l'una all'altra come favi di alveare. Sono ancora fresche, gradevoli al piede. Il loro disegno riluce agli occhi riposati con un incanto particolare. Farebbe forse un effetto ancora maggiore, se io non avessi mai sentito parlare di matematica.
Un bagno è contiguo. È privo di finestre e rischiarato da una sorgente luminosa celata nel soffitto. Mi metto davanti allo specchio e misuro, osservando la mia immagine a mezzo busto, il grado della mia presenza. Come tutti nella casbah, sono ben abbronzato. L'azzurro delle pareti conferisce un rilievo plastico al corpo.
Di solito, dunque, mi vedo a contorni ben definiti; ma non vi è alcun dubbio: questa è la mia immagine riflessa. La giornata arride ai vari compiti da svolgere; riuscirò ad espletare, con mano lieve, ciò che mi si presenterà. Troverò la giusta distanza per cose e persone. Me ne accorgo subito dopo, nei miei esercizi. Al biliardo, oggi, mi riuscirebbero grandi serie. Tale è l'atmosfera generale nella rocca – particolarmente marcata nel Condor, quando scende d'arcione dopo la cavalcata mattutina.
Vi sono, però, anche giorni in cui l'immagine riflessa quasi si confonde, come se lo specchio fosse appannato, pur guadagnando in evidenza quanto più a lungo la fisso. In ugual misura il corpo perde la sua realtà. Occorrerà allora aver prudenza, durante il giorno; potranno facilmente accadere degli incidenti. In compenso, il moto nell'àmbito spirituale diverrà più fluido. Gli studi se ne avvantaggeranno, tanto nelle biblioteche che al Luminar.
Noto anche che mi si rivolge la parola con maggiore facilità, e che a me avviene altrettanto con gli altri. La porta dell'amicizia si spalanca a due battenti, Eros srotola il suo tappeto. Perfino il Domo sorride, se mi sfugge un errore, il che capita con tale umore. L'“Emanuelo” del Condor suona, allora, particolarmente gradevole. Devo badare a non impegnarmi troppo a fondo.
© Paolo Melandri (17. 1. 2019)
*
Irene
Ho perso il conto degli anni. Nei primi tempi, spiavo la mano che strappava i fogli dal calendario nero, posto giusto al limite del mio campo visivo. Lunedì, martedì, non capivo più tanto bene queste distinzioni stabilite dagli uomini. I giorni erano talmente uguali per il mio corpo! Solo la data era un po' più eloquente ai miei occhi indeboliti. Questo numero in continua progressione, appeso al muro, non raggiungeva mai il valore che avrei voluto dargli. Ogni mese speravo sconsideratamente che sarebbe stato varcato una volta per tutte il confine al di là del quale l'uomo ricomincia a contare iniziando dal pollice. Che cosa è sucesso poi? Mi hanno forse leggermente spostato la poltrona, oppure mi si è ulteriormente ridotto il campo visivo? Fatto sta che non ho più visto il calendario, ho confuso giorni e mesi. Solo le stagioni mi hanno permesso di orizzontarmi, ma in definitiva ho perso il conto degli anni.
Avevo venticinque anni quando mi sono seduto per la sempre. E ora la figlia di mia figlia ha l'età per ispirarmi l'amore. Ho dunque superato ampiamente la sessantina e questo fuoco non si spegne, non può spegnersi in seno alla mia immobilità. All'inizio, quando speravo in una guarigione remota – e sì che ne ho visti di rimbambiti e paralitici – facevo degli sforzi sovrumani per far capire con lo sguardo a mia moglie, quando mi sfiorava, che ero ancora un uomo e lo ero proprio in quel preciso istante. Allora mettendomi la mano sulla spalla, lei diceva: “Si agita, oh come si agita!” mossa in questo dalla dolce, luminosa speranza, percettibile solo ai miei occhi, che una buona congestione mi avrebbe alla fin fine portato via. Restava lì per ore e ore a infondermi calma, a consigliarmi, molto vicina, vicinissima, senza vedere – non ho mai saputo se vedesse – senza vedere nelle mie pupille tragiche l'odio e il desiderio mescolati, la mia sete di sangue. Nel silenzio e nella quiete muovevo gli occhi per suscitare compassione. Una marea d'immagini mi invadeva, interponendosi poco a poco tra il mondo e me. Corpi, corpi di tutta la gente attorno a me, le mie mani inchiodate vi strappavano i vestiti, ve li strappavano, corpi, quei vestiti che tradivano le vostre forme – o mia dannazione! – e strappavano anche, graffiavano la vostra pelle tentatrice lasciando sul vostro bianco incarnato e sulla mia cornea grandi strisce rosse tali da farmi morire di mala morte senza confessore, di quella morte divina e tonante che invocava sordidamente la mia carne sconvolta sulla sponda irrinunciabile del piacere, di quel piacere proibito a chi non può far uso delle mani inchiodate lungo le cosce inerti, tra le quali si rizza derisoriamente enorme – bontà del cielo succhia, mena e chiava! – quel cazzo pronto a sfondare i muri, erigendosi fino alle stelle. Un mattino, la mia pietosa sposa si mise in testa di leggermi, allorché i miei occhi tradivano una preoccupazione selvaggia, le preghiere degli agonizzanti. Alle volte faceva sedere mia figlia ai miei piedi e nella mia mente in subbuglio, l'incesto univa allora la sua grande voce tonante alla scarica di bestemmie che mi travolgeva. “Non dovrai mai dimenticare tuo padre, Vittoria mia, né come sono stata paziente nella sua disgrazia,” mormorava la buona madre “né come lo curavo e lo amavo. Gli ammalati hanno già un piede nel paradiso. Godono già in parte del riposo eterno e possono vedere il buon Dio in mezzo alle nuvole. Lo spirito del peccato li lascia poco a poco. Non muoiono mai improvvisamente, né improvvisamente diventano angeli: ma la grazia li invade come una marea crescente. Vittoria, tesoro, guarda bene negli occhi di tuo padre e vi vedrai crescere lentamente l'azzurro livello celestiale”. E Vittoria alzava verso di me gli occhi, quegli occhi di bambina ingenua, oscuramente turbata. Leggevo in quegli occhi un mistero nascente, simile ai segreti dei grandi boschi, quando sotto il fogliame palpitano le prime viole. Poi dall'orlo delle palpebre pure di mia figlia il mio sguardo scendeva lungo la sua pelle di madreperla; e lungo il percorso, mi soffermavo un istante sulle labbra. Una macchia vi rivelava l'inchiostro succhiato di nascosto. Il cordoncino dello scapolare veniva fuori dal colletto sull'esile nuca. Due manine leste mi toccavano a volte le ginocchia.
No, non ho mai saputo se vedeva, mia moglie. In certi momenti, passava senz'altro tra noi – l'avrei giurato – una specie di brivido che non era dovuto al ricordo. Proprio così, e subito dopo più niente. Ho forse sognato? Scambiavo la mia febbre per la sua. Lei sta lì, la dignità fatta persona, va e viene, tutta vestita di nero, perché si addice di più alla sua situazione. Ah, quanta rabbia ho provato per questo lutto preventivo! Avrei voluto vestirla come una donna da circo, spogliarla, truccarla, lasciarle solo le calze nere. Lei, invece, recitava il rosario e talvolta mi baciava in fronte. Che mostro! Però mi portava la piccola, ed io credevo di cogliere sul suo volto un'espressione di complicità sorniona e così non sapevo più che pensare. Tanto più che un altro sentimento si impadroniva dei miei sensi, e cercavo di sorridere a Vittoria. Macché, era solo un nuovo delirio: mia moglie sta parlando infatti con quella voce fredda che conosco. Mi racconta le ultime nuove. La sua solita pietà, spietata. Tuttavia, un pomeriggio… lo rivivo ancora, mi aveva appena fatto bere. Agosto nel suo pieno fulgore rendeva la stanza opprimente. Non un filo d'aria aveva fatto sbattere le porte da più settimane. In cortile qualcuno spennava un pollo. Sono stato colto all'improvviso. Una ventata. Uragano immobile tra i nostri volti ravvicinati. Sentivo violentemente la bellezza matura e prossima allo sfacelo di questa compagna inaccessibile, meravigliosa qualità della pelle leggermente umida, odore bruno, immenso calore. Non mi toccava, stava lì impietrita. Ho davvero capito? Mi sembra che ora si allontani chiudendo gli occhi, che si irrigidisca, che silenzio! Mi sembra. Mi sembra. Ecco ora gira la testa e scappa via. Dopo tutto, era soltanto tristezza, la mia e la sua. La sua probabilmente.
© Paolo Melandri (17. 1. 2019)
*
Sogni
È tempo di abbozzare il corso delle mie giornate, nella misura pertinente all'argomento. Meglio sarebbe se cominciassi dalla notte, giacché la mia giornata non ne rappresenta che il riflesso. Lo deduco già dal fatto che mi sveglio malvolentieri: ogni giorno sono costretto a rivestire da capo la mia armatura.
La notte è buia, il giorno chiaro. Secondo Bruno, questa luce del giorno non è altro se non oscurità derivata, attenuata e filtrata. Vi sarà qualcosa di vero. Quando chiudo gli occhi, non si fa buio, ma chiaro, come se dai celletti scenici cominciasse a calare una luminosità mentre il sipario si leva. Appaiono fiori che lentamente discendono, ruote variopinte che girano, innumerevoli volti che anelano all'individuazione; e tra essi il mio. Tutto ciò prima che io mi addormenti. Poi, penetro più a fondo.
Il grido della civetta, con le sue ali ovattate, mi è più familiare del canto del gallo. Preferisco gli archi agli ottoni. L'intervallo è l'oscurità. Avverto la luce come una scalfittura; è più un disagio che un dolore. Volentieri torno ad immergermi.
Il sonno privo di sogni, dopo la mezzanotte, è il più profondo; è allora che lo spirito entra da padrone nel mondo dei sogni. Non soltanto egli vi orchestra i fatti, ma li inventa anche a suo piacere, liberamente, apprestando dalle sue riserve inesauribili personaggi e arredamenti.
È una proprietà vivente. Lo spirito si tramuta in torrente; inonda la propria messinscena. È in grado di aprire gli occhi dovunque – – – negli esseri umani, nelle cose, dentro animali e piante; dà respiro alle proprie creature e le fa parlare: ne diviene il suggeritore. Ma quel che dicono, lo ricolma di stupore, quasi che la sua parola si spiritualizzasse nell'eco. “Nel sogno siamo dèi”, diceva a ragione un greco.
© Paolo Melandri (13. 1. 2019)
*
Zapparoni 4
Dopo che il servitore mi ebbe condotto nella biblioteca, mi lasciò solo. Era di una cortesia perfetta. Accenno a questo particolare, perché illumina in quale stato d'animo sospettoso mi trovavo. Osservavo tutti quelli con cui venivo a contatto, ed ero pronto a offendermi molto più facilmente di prima. Il contegno del servitore lasciava concludere, a ogni modo, che il padrone di casa non aveva detto qualcosa di sfavorevole sulla mia visita. Be', dubitavo ancora di vederlo, probabilmente tra breve sarebbe entrato uno dei suoi segretari.
La biblioteca era tranquilla e piacevole. Dai libri emanava una calma dignità. Erano ordinati negli scaffali, rilegati in pergamena chiara, in pelle di vitello sbalzato e in marocchino marrone. I volumi di pergamena portavano i titoli scritti a mano; quelli col dorso di pelle lo avevano su tasselli rossi o verdi o direttamente in lettere d'oro. Nonostante fosse antica, quella raccolta di libri non dava l'impressione di servire da tappezzeria, ma di essere adoperata. Lessi alcuni titoli, che mi dicevano ben poco: tecnica primitiva, cabala, rosacroce, alchimia. Forse una mente si riposava lì, lungo antiche vie tortuose nascoste dagli sterpi.
Per lo spessore dei muri la stanza sarebbe stata oscura se non avesse ricevuto molta luce attraverso le finestre, che giungevano quasi sino in terra. La porta a vetri era spalancata sopra una ampia terrazza.
Lo sguardo mi cadde nel parco come sopra un quadro antico. Gli alberi erano raggianti nel fresco splendore delle fronde; l'occhio sentiva come bagnavano le radici nel terreno, schierati lungo le sponde di un ruscello che scorreva pigro e a volte si allargava formando piccoli stagni sui quali riluceva un corpetto verde di muschi acquatici. Un tempo erano quelle le peschiere dei monaci; i cistercensi avevano costruito, come i castori, nelle paludi.
Era stata una vera fortuna che i muri fossero ancora in piedi. Per lo più, e soprattutto nella vicinanza delle città, questi recinti sono stati demoliti e hanno servito come cave di pietre. Qui invece si vedeva ogni tanto attraverso le fronde degli alberi la pietra grigia. Pareva che le mura chiudessero anche campi coltivati, infatti vidi lontano un contadino che camminava dietro all'aratro. L'aria era limpida; il sole luccicava sopra la pelle dei cavalli e sulla zolla che tagliata ricadeva. Il quadro era sereno, anche se lasciava perplessi nel campo di un uomo che tra l'altro commerciava in trattori per giardino, i quali come talpe rendevano soffice il terreno delle aiuole. Intanto in casa sua tutto rivelava il suo gusto per le muse. Secondo ogni apparenza, egli non voleva vedere macchine, quando contemplava i suoi alberi e le sue peschiere dalla terrazza.
Questo gli procurava anche il vantaggio che sul suo tavolo giungevano soltanto frutti coltivati secondo le antiche norme. Anche qui valeva l'osservazione che le parole hanno mutato significato. Infatti il pane non è più pane e il vino non è più vino. Sono prodotti farmaceutici sospetti. Bisogna essere eccezionalmente ricchi oggidì per evitare gli avvelenamenti. Quello Zapparoni era senza dubbio un volpone che sapeva vivere nel castello Malepartus e precisamente a spese degli stupidi, come un farmacista il quale si facesse pagare oro le sue droghe e panacee mantenendosi sano secondo le regole dei padri.
In quel luogo c'era davvero una gran pace. Il ruggito delle officine, dei parcheggi e delle strade vi arrivava soltanto come un sottile brusio attraverso le cime frondose. In compenso si sentivano le melodie degli storni e dei fringuelli, e nei tronchi marci il martellio del picchio. I tordi saltellavano e si posavano sui tappeti erbosi e a volte risuonava in fondo allo stagno il tonfo di un carpione che guizzava. Sulle aiuole piccole e grandi folte di fiori davanti alla terrazza, incrociavano le api e si dividevano con le farfalle la dolce preda. Era una giornata di maggio nel suo pieno splendore.
Dopo avere contemplato le pitture e i libri dagli strani titoli sedetti a un tavolino, davanti al quale stavano due sedie; e guardai attraverso la porta spalancata. L'aria era più pura che in città, quasi inebriante. L'occhio riposava sugli annosi alberi, sui verdi stagni e sul campo bruno in distanza, dove il contadino tracciava i solchi tornando indietro quando arrivava in fondo.
© Paolo Melandri (13. 1. 2019)
*
Zapparoni 3
Per farla breve, nel salire la scala di Zapparoni sentivo di inoltrarmi in una avventura equivoca, sia pure forzatamente. Ma nel medesimo tempo la vecchia coriosità si destava in me e mi aizzava. Avevo il prurito di sapere che cosa voleva il vecchio potente e perché si degnava di occuparsi di me. La curiosità mi spronava quasi più della prospettiva di guadagnare. Dopo tutto, nella mia vita avevo già saputo trarre fuori la testa da diversi lacci, avevo assaggiato diverse esche, senza aver abboccato l'amo.
Perciò seguii il servitore nella vecchia casa. Pareva una proprietà di campagna. L'ingresso era seguito da un vestibolo, dove pendevano non soltanto cappelli e mantelli, ma anche fucili e canne da pesca. Poi c'era una sala alta a due piani, con trofei e incisioni di Riedinger. Seguivano due o tre vani, più grandi di una camera, ma più piccoli di una sala.
Davano tutti a mezzogiorno, infatti il sole cadeva sul tappeto attenuato dai vetri smerigliati. Venni condotto nella biblioteca. A una prima occhiata nessuna di queste stanze pareva oltrepassare le possibilità di un privato benestante, il loro aspetto deludeva la mia attesa. Sotto l'influsso dei giornali avevo supposto di entrare in una specie di gabinetto delle meraviglie, dove il visitatore accerchiato da sorprese meccaniche, fosse preso da stupore, da costernazione. Vidi subito che su questo punto avevo sbagliato. Certo avrei potuto immaginare che un mago e signore degli automi non amasse avere simili cose nell'intimità. Tutti quanti siamo abituati a divertirci in un modo diverso il più possibile dalle nostre occupazioni professionali. Un generale difficilmente gioca con i soldatini di piombo, e un portalettere la domenica non fa marce forzate. Similmente si dice che i pagliacci fra le loro quattro mura sono per lo più seri, anzi malinconici.
In quell'arredamento non ci si imbatteva nel cattivo gusto di gente arricchita dalla mattina alla sera. Non c'era nulla di trimalcionesco. Zapparoni doveva non soltanto avere un ottimo arredatore, ma essere anch'egli una persona di buon gusto. Lo si capiva dal luogo. Vi regnava quell'armonia che non si può ottenere per ordinazione, ma che nasce soltanto da una necessità interiore, soltanto dalla dignità di chi vi abita. Non c'era né gelido splendore, né ostentazione che vuole abbagliare: le stanze erano abitate da un essere intelligente e colto, che vi si trovava bene.
Questi meridionali, anche se vengono da un villaggio siciliano o da un basso napoletano, posseggono spesso un gusto sicuro, come può essere soltanto se è istintivo. Hanno un orecchio infallibile per la musica e un occhio che distingue infallibilmente la mano del maestro nelle belle arti. Lo avevo spesso notato. L'unico pericolo sta nella loro vanità.
L'insieme era di una robusta sobrietà, non splendido, ma raggiante di vita. E questo si dica anzitutto per le opere d'arte. Avevo talvolta avuto l'occasione di vedere, nelle case di uomini diventati rapidamente ricchi o potenti, celebri pitture o statue, quali si vedono soltanto nei calendari artistici o nei musei. La loro vista deludeva, perché avevano perduto la loro espressione, il loro linguaggio, come uccelli che perdono il canto e lo splendore quando sono chiusi in una gabbia. Un'opera d'arte si spegne, impallidisce nelle stanze dove ha un prezzo ma non un valore. Può risplendere soltanto dove è circondata di amore. Non si può fare a meno di deperire in un mondo dove i ricchi non hanno tempo e la gente colta non ha denaro. Mai però aderisce a una grandezza presa in prestito.
Zapparoni, lo vedevo di sfuggita, tempo doveva averne. I cinque o sei quadri appesi alle pareti davano l'impressione di oggetti sui quali lo sguardo del padrone si posa giornalmente e con amore: nessuno di essi poteva essere stato dipinto dopo il 1750. C'era anche un Poussin. Tutti respiravano una tranquilla vita e rinunciavano a ogni effetto. E non alludo agli effetti odierni, i quali si limitano a far colpo con la novità, ma agli effetti dei maestri. Le pitture che Zapparoni aveva radunato intorno a sé non potevano mai, nemmeno nei contemporanei, essere giudicate sorprendenti. Dovevano sin dal principio essere sembrate familiari.
La medesima impressione era comunicata dalla casa. E si intonava a un'altra, che riguardava la potenza, e da essa veniva confermata. Dicevo già che viviamo in tempi in cui le parole hanno perduto o mutato il loro senso e sono diventate ambigue. Ciò vale anche per la parola “casa”, che prima significava solidità e continuità e che oramai da molto tempo è divenuta una specie di tenda, senza che gli abitanti godano la libertà dei nomadi. Viene innalzata frettolosamente, con la stessa facilità con cui se ne distruggono migliaia. E non sarebbe nemmeno il peggio, se almeno per un poco di tempo si potesse avere la sensazione di trovarci nel nostro e al sicuro. È tutto il contrario. L'uomo che oggi possiede il coraggio di costruirsi una casa, innalza un punto d'incontro per gente che lo assale a piedi, in vettura e telefonicamente. Vengono gli impiegati delle società del gas, della luce e dell'acqua, gli agenti delle assicurazioni sulla vita e contro l'incendio, la polizia edile e gli esattori della radio, i creditori ipotecari e i funzionari della finanza che vogliono fissare il valore locativo che devi pagare per vivere in casa tua. Se il clima politico si intorbida un poco, allora viene gente ben diversa, la quale sa subito dove trovarti. A queste piaghe si aggiunge che tu sei odiato come possidente.
Nei tempi passati era più semplice. Si conoscevano, certo, meno comodità, però si aveva la coscienza tranquilla, quando si allungavano le gambe sotto il proprio tavolo. Fu questa precisamente la sensazione che ebbi da Zapparoni: lì mi trovavo da uno che era ancora padrone in casa sua. Avrei voluto scommettere che non vi erano né contatori né linee elettriche allacciate fuori del suo terreno. Probabilmente Zapparoni aveva copiato nella propria vita privata il modello del chiuso Stato mercantile di altri tempi, e i suoi automi gli avevano consentito di farlo funzionare. Negli automi la forza astratta diventa concreta, torna nell'oggetto. Intanto non vedevo nulla del genere, si trattava piuttosto di una intuizione che respiravo nell'aria. C'erano persino candele sui tavoli e una clessidra sul caminetto.
Qui abitava palesemente uno che non incassava una rendita, che piuttosto distribuiva rendite. Qui la polizia non poteva irrompere non importa con quale mandato o con quale pretesto. Zapparoni aveva la propria polizia che eseguiva soltanto i suoi ordini. Il terreno delle sue officine e le sue strade di comunicazione inoltre venivano vigilati da poliziotti e da ingegneri statali e militari, i quali in teoria dovevano agire “di buon accordo” con lui, ma nella realtà non potevano avere un parere diverso dal suo.
Sorge naturalmente la domanda: perché un uomo con tali prerogative avesse bisogno di rivolgersi proprio al mio aiuto, all'aiuto di un uomo che aveva l'acqua alla gola? Qui sta precisamente il mistero al quale ho già accennato. È un fatto degno di nota, e deve avere ragioni profonde; un uomo per quanto disponga di appigli legali è pur sempre costretto, per eseguire i suoi piani a ricorrere a vie traverse. Lo spazio giuridico, sia piccolo o grande, confina sempre con l'illegale. Il confine si sposta con le prerogative. Perciò riscontriamo fra i grandi signori più ingiustizia che fra gli uomini comuni. Dove le prerogative diventano assolute, si giunge a una condizione in cui i confini minacciano di sfumare e la giustizia e l'ingiustizia sono difficili a distinguersi. Allora si ha bisogno di gente con la quale andare a rubare i cavalli.
© Paolo Melandri (10. 1. 2018)
*
Zapparoni 2
Questa disposizione presentava il vantaggio che Zapparoni si trovava sempre sul proprio dominio, e rendeva possibile un preciso controllo di tutte le visite. In questo modo il padrone di casa era protetto contro l'invadenza dei giornalisti e soprattutto dei fotografi. Sempre aveva avuto cura di lasciare in penombra tutto quanto riguardava la sua persona e le sue abitudini. Conosceva la forza logorante della propaganda. Infatti, si doveva parlare molto di lui, ma soltanto in modo vago, per accenni. Come i suoi prodotti dovevano dare l'impressione di essere soltanto la parte minore di una quantità nascosta; la scelta delle riproduzioni e dei rapporti che uscivano sul conto suo veniva curata da lui e dal suo personale tecnico.
Il suo capo ufficio stampa aveva elaborato un sistema di rapporti indiretti che aizzava la curiosità e non l'appagava mai. Un uomo di cui si sente parlare come di un grosso personaggio, senza mai vederlo in faccia, viene immaginato bello, forse maestoso. Un uomo il cui nome corre su tutte le bocche, ma che non si sa nemmeno dove abita, lo si pensa dappertutto; pare che si moltiplichi in modo prodigioso. Un uomo così potente, che non si osa più parlare di lui, diventa quasi onnipresente, perché domina la nostra vita interiore. Pensiamo che ascolti i nostri discorsi e che i suoi occhi si posino su di noi, perfino nella nostra camera. Un nome che si sussurra soltanto, ha maggior potere di uno che si grida nelle piazze. Zapparoni lo sapeva. D'altronde, non poteva trascurare la propaganda. Ma vi faceva introdurre sorprese enigmatiche. Era un sistema nuovo.
© Paolo Melandri (7. 1. 2019)
*
Zapparoni
Teresa aveva messo in ordine la mia roba. La notizia l'aveva riempita di gioia. Mi vedeva già in un posto importante nella cornice della ditta mondiale. Se c'era qualcosa di consolante in tutta la faccenda era il suo entusiasmo. Teresa era di quelle donne che sopravvalutano il proprio uomo, di cui si sono fabbricate un'immagine idealizzata. Aveva di me un'opinione troppo buona; forse per lei questa era una necessità. In quanto a se stessa era scoraggiata, convinta di essere una palla di piombo, un inciampo, un danno. Era vero il contrario. Se in questo mondo che si faceva sempre più tetro avevo qualcosa di simile a una patria, la trovavo accanto a lei.
Se le nostre cose andavano male, come negli ultimi tempi era di regola, la notte sentivo spesso vicino a me il leggero tremito che scuote la donna quando vuole nascondere il pianto. Se la interrogavo e insistevo, sentivo sempre la vecchia canzone, che sarebbe molto meglio non fosse mai nata, non l'avessi mai conosciuta. Era lei che mi aveva intralciato la carriera, che mi avrebbe rovinato. Inutilmente le dicevo che ero sempre stato uomo da rovinarmi da solo e senza aiuto; e che non ero riuscito mai in nulla, al di fuori di quello. Ma Teresa insisteva nelle sue fissazioni.
Del resto, il sentirci sopravvalutati incute un certo ritegno. Stimola quel che c'è di buono in noi. Ho già detto che vi ero stato abituato da mia madre, al cui ricordo l'immagine di Teresa del resto si confondeva senza che me ne accorgessi. Quante volte la mamma aveva preso le mie parti davanti al babbo, quando c'era burrasca in casa. “Eppure il ragazzo non è cattivo”, diceva; e il vecchio rispondeva: “È e resta un buono a nulla”. E la mamma ripeteva: “Però cattivo non è”, infatti bisogna che le donne abbiano sempre l'ultima parola.
Le officine Zapparoni sono situate piuttosto fuori di città. Avevano del resto succursali più o meno grandi, ditte sorelle, ramificazioni o rappresentanze e depositi, officine per ricambi e riparazioni, un poco dappertutto. Qui c'era la testa, il grande opificio dei modelli, da dove anno per anno scorrevano come da una cornucopia nuove e prodigiose sorprese nel mondo. Qui abitava anche Zapparoni, quando non viaggiava.
Il sabato dunque era arrivato il telegramma di Twinnings: mi avvertiva di andare a presentarmi. Domenica mi era riuscito scovare il medico di Caretti, infatti seguitava a frullarmi per la testa quel che Twinnings aveva detto sulla soglia. Il colloquio con il medico mi rassicurò. Egli riteneva di non tradire nessun segreto informandomi di quel che era accaduto a Caretti. Molti lo sapevano. Come parecchi altri impiegati di Zapparoni carichi di scrupoli, Caretti piano piano era diventato strambo, e alla fine aveva varcato il segno. Una “mania di precisione”, come dicono i medici, si era accoppiata alla mania di persecuzione, alimentata da allucinazioni meccaniche. In simili casi i pazienti credono di essere minacciati da macchine raffinatamente congegnate, e a poco a poco il mondo si trasforma per loro in un quadro simile a quelli ideati da alcuni pittori del medioevo. Caretti credeva che di continuo minuscoli aeroplani gli aleggiassero intorno per fargli del male. Non è insolito che tali malati scompaiano senza lasciare traccia. Il medico, un piccolo psichiatra nervoso, si ricordava di un paziente i cui resti vennero ritrovati dopo anni nella tana di un tasso: vi era strisciato dentro e si era ammazzato. Il dottore era chiacchierone e descriveva i sintomi con tale gusto e pedanteria che sulla via di ritorno già mi pareva di essere minacciato da manie di quel genere. In fondo mi aveva rassicurato.
Già in distanza apparivano le officine: basse torri bianche e cantieri piatti in grande numero, senza antenne né ciminiere, vestiti di colori vivaci, perché il muro di cinta era coperto da innumerevoli manifesti. Un'attività secondaria, coltivata da Zapparoni con cura particolare, era il cinema, al quale con i suoi robot e i suoi automi egli dava una perfezione quasi fiabesca.
Vi è chi prevede che la nostra tecnica un giorno sboccherà in pura magia; dunque tutto ciò a cui ora partecipiamo sarebbe soltanto un inizio, in questo caso la meccanica si raffinerebbe in modo da non dovere ricorrere a grossolane soluzioni. Segnali luminosi o parole, basteranno, anzi basterà il pensiero.
Zapparoni con i suoi film si avvicinava già chiaramente a simili previsioni. Al paragone, quanto era stato inventato da vecchi utopisti pareva soltanto un abbozzo. Gli automi avevano acquistato una libertà e una eleganza da danzatrici che schiudevano un nuovo regno. Dove sembrava realzzato quanto a volte si crede di cogliere in sogno: una materia che pensa. Perciò questi film possedevano una forza d'attrazione potente. Specialmente i bambini ne rimanevano stregati. Zapparoni aveva spodestato i vecchi personaggi delle fiabe. Come uno di quei cantastorie che seggono sopra un tappeto in un caffè arabo e trasformano l'ambiente, egli tesseva le sue favole. Creava romanzi, che si potevano non soltanto leggere, sentire e vedere, ma in cui si entrava, come si entra in un giardino.
Era del parere che la natura non basta né per bellezza né per logica, e che si debba superarla. Aveva creato uno stile al quale si adattavano anche gli attori umani, che ne erano stati il modello. Da lui si incontravano i più incantevoli pupazzi, visioni di sogno che stordivano.
I film soprattutto avevano reso popolare Zapparoni. Egli era il buon nonno che racconta storie. Lo si immaginava con la gran barba bianca come prima il Babbo Natale. I genitori si lamentavano addirittura che occupasse troppo i bambini. Non potevano prendere sonno e sognavano irrequieti, sovraeccitati. Però la vita in fondo era faticosa dappertutto. Così la stirpe si temprava, e questo doveva bastare.
I manifesti di questi film coprivano il muro di cinta che inquadrava le officine, ed era a sua volta circondato da una strada, la cui larghezza faceva pensare piuttosto allo spalto di una fortezza. Senza i manifesti multicolori avrebbe senza dubbio avuto un aspetto troppo simile al muro di una fortezza, interrotto com'era a intervalli da grandi torri pallide: un pallone giallo dominava il gruppo degli edifici.
Ai margini della strada, cartelli indicatori ricordavano che si era entrati in una zona privata. Il conducente doverosamente vi richiamò la mia attenzione. Si doveva rallentare la marcia, ed era vietato portare armi, contatori Geiger e attrezzi ottici. Non erano consentiti né apparecchi ottici, né occhiali da sole. Sulla strada e anche intorno al muro di cinta, il traffico era animato, mentre le vie secondarie erano deserte.
Pian piano i manifesti diventavano più visibili. Rappresentavano la visita di Enrico-Otto alla regina delle termiti: Tannhäuser sul monte di Venere, adattato per i ragazzi. Qui i robot di Zapparoni comparivano come nani ricchi e potenti. Lo splendore, la meraviglia dei palazzi sotterranei già non tradivano più traccia di sforzi tecnici. Simili film si dividevano in dodici puntate, una per ogni mese dell'anno. I bambini si consumavano nell'attesa del seguito. Lo spettacolo comune influiva sui loro modi e sui loro gusti. Li si vedeva nei loro campi di gioco, fare i viaggiatori spaziali, gli scopritori di caverne, i marinai di sommergibili o i trappolatori. Con queste fiabe e avventure a colori Zapparoni provocava un grande e cronico entusiasmo. I bambini vivevano nel suo mondo. Tra i genitori e gli insegnanti i pareri erano divisi. Gli uni pensavano che in quel modo i bambini imparavano giocando, mentre gli altri temevano che si eccitassero troppo. Certo, si potevano spesso osservare conseguenze strane e preoccupanti. Ma quanto appartiene al corso del tempo non si lascia arrestare. Del resto non ci si poteva domandare se il mondo reale non fosse anche più fantastico? Dove non si sovreccitano i bambini?
Voltammo verso il parcheggio degli operai. La mia vettura pubblica di fronte alle loro limousines pareva una cornacchia smarrita in una fagianaia. Pagai il conducente e mi recai all'ufficio di ricevimento.
Sebbene il sole fosse già alto nel cielo, l'andirivieni all'ingresso era animato. Nessuna circostanza meglio di questa dimostrava che gli operai di Zapparoni erano davvero signori. Non erano vincolati da nessun orario. Andavano e venivano a capriccio, infatti non lavoravano mai a squadre, fuorché nell'officina dei modelli. Tuttavia devo aggiungere che questo sistema o, piuttosto, non sistema testimoniava a favore di Zapparoni. La morale lavorativa nelle sue officine non lasciava nulla a desiderare; si creava là secondo lo stile degli artisti, i quali sono ossessionati dalla loro creazione. Non c'era orario di lavoro, vale a dire, piuttosto, che si lavorava quasi sempre. I lavoratori sognavano le loro opere d'arte. Che fossero signori, si poteva dedurre da questo, che avevano tempo. Ma non voleva dire che lo sprecassero. L'avevano piuttosto come la gente ricca ha il denaro nel portafogli. La sua ricchezza sta nella borsa, non in ciò che spende, e lo si nota dal suo contegno.
Chi entrava e chi usciva era egualmente coperto da camici bianchi o colorati e passava senza formalità alcuna. Dovevano dunque essere ben conosciuti; infatti l'androne dove si trovava anche l'ufficio di ricevimento era sorvegliato. Vi vedevo gruppetti fermi, come quelli che accolgono il passeggero quando sale a bordo di una grande nave. Là si imbatte in marinai, camerieri e altri impiegati, che osservano chi arriva con discrezione e attenzione. L'androne era largo e profondo, con pareti interrotte da molte porte: lessi “Visite”, “Corpo di guardia”, e altre iscrizioni.
Nell'ufficio venni accolto come una persona già attesa. Appena ebbi pronunciato il mio nome, si presentò un usciere. Era rimasto lì per aspettarmi.
Con mia sorpresa non mi introdusse nello stabilimento, ma mi guidò di nuovo fuori fino a una piccola ferrovia sotterranea, che sboccava accanto al parcheggio. Usciti di lì salimmo su una minuscola vettura ferma sul binario e comandata come un ascensore. Dopo due minuti eravamo arrivati alla mèta. Ci fermammo davanti a un edificio all'antica entro il muro di un parco. Mi trovavo nella residenza privata di Zapparoni.
Mi ero aspettato, nel migliore dei casi, di essere introdotto in una sezione dell'ufficio personale; e da lì, se il mio interrogatorio avesse dato esito favorevole, di essere ammesso forse alla presenza del capo del personale; perché ero stato raccomandato da Twinnings. Perciò rimasi senza fiato nel vedermi improvvisamente introdotto, risalendo dalle viscere della terra, nel sancta sanctorum, nella diretta sfera di un uomo che come alcuni asserivano non esisteva, ma era forse la migliore invenzione delle officine Zapparoni. Già vedevo un servitore scendere la scala per sostituire l'uscere. “Il signor Zapparoni l'attende.”
Non fu possibile nessun dubbio, mi trovavo nella residenza di Zapparoni. La sua officina principale dapprima era situata altrove, finché, seccato dalle perpetue ricostruzioni e aggiunte, egli non decise di trasferirla lì dove ora si trovava e di portarla, seguendo un piano nuovo, a quella perfezione che nelle grandi come nelle piccole cose distingueva le sue creazioni. Nell'esaminare il terreno si era scoperto che a qualche distanza esisteva un convento cistercense, diventato già da molto tempo proprietà pubblica, ma poco adoperato. La chiesa e l'edificio principale avevano ceduto al tempo, mentre il muro di cinta e il refettorio comprendevano oltre alla grande sala dove mangiavano i monaci, anche le stanze, le dispense e la foresteria. Qui si stabilì Zapparoni.
La casa era di dimesioni imponenti. Ne avevo ogni tanto veduto la riproduzione sulle riviste illustrate.
Il grande cancello nel muro di cinta rimaneva sempre serrato; per i familiari e per gli ospiti serviva la piccola ferrovia sotterranea. Avevo notato che non mi avevano fatto salire a uno dei due capolinea. Probabilmente conduceva non soltanto al parcheggio, ma anche nell'interno dell'officina.
© Paolo Melandri (6. 1. 2019)
*
La domanda della terra
Notte. Tutto il giro dell'orizzonte è mangiato dai lontani falò di San Giovanni.
Il pianoro. Quattro fuochi agli angoli di un quadrato di terra battuta. Accanto a ogni fiamma c'è un uomo in piedi con una pesante frasca in mano. Attorno a quell'area illuminata, il buio e, fino all'orlo del buio, come un ribollire di schiuma, i pastori sono seduti nei loro gabbani, nelle loro gualdrappe, nei giacconi di velluto.
Il sardo. Si alza. Guarda a destra e poi a sinistra e, al contempo, si fa silenzio a destra e poi a sinistra.
“Allora, cominciamo?”
Proprio in quella, senz'altro ordine che quel silenzio, il vento scende, lavorato dalle arpe. I flauti si mettono a fare il rumore di un uomo che cammina sul mare.
Il Sardo (avanza in mezzo all'aia; alza la mano in segno di saluto):
Ascoltate, pastori:
I mondi erano nella rete del dio come tonni nella tonnara:
Colpi di coda e di schiuma; un rumore che echeggiava facendo uscire vento da ogni dove.
Il dio aveva cielo fino alle ginocchia.
Ogni tanto si chinava, prendeva in mano un po' di quel cielo che gli colava tra le dita. Bianco come latte. E pieno di bestie come una fiumana di formiche. E, lì dentro, immagini si accendevano e poi spegnevano come le cose che vivono nei sogni.
Il dio si lavava tutto il corpo con il cielo. Pian piano, per abituarsi al freddo della vita. Aveva il ventre sensibile. Perché tutto accadeva nel suo ventre.
Dopo, si mise a camminare nel cielo fino al punto in cui era più profondo di lui, dove non toccava più, e si mise a nuotare. La sua manona si alzava e affondava come un cucchiaio; i suoi piedoni fendevano come zappe con le unghie in avanti. Era seguito da un vortice di lunghe erbe strappate. Dopo un po', lontano, laggiù, non fu altro che una specie di isola con la schiuma.
Se ne andava perché il principio era finito.
Sangue! Grumi di sangue!
La terra è aggomitolata nel ventre del cielo come un bambino nella madre.
È in mezzo a sangue e budella. Sente la vita, tutt'intorno, che ronfa come fuoco.
Una vena azzurra entra come una serpe nella sua testa. È da lì che si empie di carità.
Un'arteria rossa entra come una serpe nel suo petto. È da lì che si empie di cattiveria.
S'ingrossa. Più s'ingrossa, più ha luce.
Infine, preme contro il portale; vuole nascere; è greve della ragione della sua semenza.
D'un tratto, nasce in un getto di fuoco e prende il volo.
È la giovinezza della terra!
Rotola nell'universo come fosse nell'erba. È tutta bagnata da grandi acque in fiore. Fuma di sudore come un cavallo che ha galoppato al sole.
Si porta dietro un buon odore di latte. La si sente ridere da lontano come uno spaccanoci.
La sua pelle si sta asciugando. Ci sono colori che la contornano come arcobaleni. Quando una placca della sua pelle è secca, diventa verde.
È la giovinezza della terra!
È la bella domenica!
Tutti gli alberi mettono fiori nello stesso momento. Sull'acqua ci sono vasti orti di zucche azzurre. Passano rocce cariche di vigne che sembrano scie di peli; sassolini rotondi corrono sotto le erbe. Tutti i fiori hanno la salute del rosso. Le foglie sono spesse come braccia. Si sentono i frutti che maturano tutti insieme. Le grosse zucche galleggiano sul mare. Ogni volta che la terra si muove, torme di frutti maturi scorrono da ogni dove nelle pieghe della collina. Si comincia a sentire odor di zucchero. Le colline se ne vanno pian pianino, curve sotto quel gran peso. Le distese di sabbia cercano di sollevare il carico di erbe mature e poi restano appiattite. Le montagne piangono acqua. Fiori aspri spuntano nel fondo dei ruscelli. Le rocce si fermano, estasiate. Quell'odor di domenica che è la salsa al pomodoro!
Per tutto questo tempo, il sardo è rimasto con la mano alzata in segno di saluto e la musica ha fatto quel rumor d'acqua e di terra che sprofondano. Si sono viste colline camminare; si sono sentiti i loro piedoni che scalpicciavano nel fango, nella poltiglia dei ruscelli di frutti. Adesso il recitante lascia cadere il saluto dal braccio, le arpe eoliche sono sole solette a cimentarsi con la bella domenica. È un rumore di lenzuola che sbattono sullo stenditoio; sono vortici di rondini; è il vento venuto da lontano su una lunga scivolata e che ora si aggrappa con forza agli alberi.
Comincia una musica secca, fatta soltanto con il timpon: accenni di gioia sulla gamma e grosse note sonore come richiami; ciò perché il sardo ha mosso le braccia come fossero ali: ha cambiato personaggio. Non è più il recitante anonimo, è il recitante-terra. È la terra, tra poco ci dirà il suo cruccio; arriva il dramma.
Il Sardo: Le grandi erbe hanno mangiato tutta la mia forza. Me ne sono accorta perché ho tentato di fare un salto in cielo e non ci son riuscita, e rimango piantata qui, senza forza.
Ho trascurato troppo tutti quei begli alberi. Già tutto ciò che, su di me, correva e danzava, le colline e le montagne, e le alte rupi, tutto ciò si è fermato, intralciato da boschi e roveti.
Ah! Ho voluto andare più lontano e non ho potuto, e mi giro, e mi rigiro, ma è come se in me ci fossero radici uncinate. Sono come una mela tutta muffita.
Le estati mi si sono posate addosso come grosse api, e hanno succhiato il mio umidore. Non si muovevano. Stavano sopra di me ad ali spiegate.
Lo sapevo: avevo visto i grandi orti di zucche avvizzire sulle acque. Le zucche si staccavano e poi, di colpo, sprofondavano nell'acqua. E poi, altre volte, vedevo salire delle bolle, e poi, altre ancora, tutta l'acqua muoversi.
Lo sciame delle estati ha bevuto quasi tutto il bello spessore dell'acqua. Allora, ho visto la schiena del grosso serpente.
C'è questo grosso serpente che è una bestia del fango. Poi ci sono quelli con quattro zampe e che sono fatti a modello del cielo perché hanno mammelle da cui si può bere. Ce n'è uno che è quasi soltanto una bocca; inghiotte grandi piattate di abeti e betulle e un intero ciliegeto con terra e tutto, coperto d'erba e di ombra. Ce ne sono molti altri.
E io sono stata più leggera d'erba, ma sono stata più pesante di carne e sono sprofondata nel cielo come un piombo da scandaglio perché tutte le bestie si saltavano, si montavano addosso, facendo dei piccoli che facevano dei piccoli.
E poi, un bel giorno, ho smesso di fluttuare perché le bestie si erano messe a mangiar carne. Ce n'erano che mangiavano erba e altre che mangiavano le bestie che mangiavano l'erba. Ciò ha fatto l'equilibrio.
E io poggio sull'equilibrio.
Ma, adesso, questa corda d'equilibrio, la sento ancora tutta allentata, e oscilla. È arrivato altro. Ah! Che cruccio avere una pelle e una pancia!
Sono proprio preoccupata, perché mi hanno detto che quest'altro vuole comandare.
Per di più, è piccino; io alzo, abbasso le sopracciglia e gonfio gli occhi, e li giro, e li rigiro: non vedo niente.
Intanto, questa corda d'equilibrio oscilla. Devo domandare.
© Paolo Melandri (6. 1. 2019)
*
Notte di luna
Mi trovavo in dolce compagnia.
Di fronte a me, vicino al massiccio caminetto rinascimentale, sedeva Venere, proprio lei, la Dea dell'Amore in persona e non una qualsiasi donnetta che, come Mademoiselle Cleopatra, avesse preso quel nome per combattere il sesso nemico.
Sedeva in poltrona e il fuoco scoppiettante da lei ravvivato le lambiva con riverberi rossastri e guizzanti il viso pallido dagli occhi chiari e, di tanto in tanto, quando cercava di scaldarli, i piedi.
Aveva una testa stupenda, malgrado i morti occhi di pietra, ma non riuscivo a veder altro di lei. La sublime donna aveva il corpo marmoreo avvolto in un'ampia pelliccia in cui si era rannicchiata, tremando, come una gatta.
“Non la capisco, gentile signora,” le dissi “a dire la verità non fa più freddo, e da due settimane poi abbiamo una primavera splendida. Evidentemente lei è nervosa”.
“Bella primavera!” mi rispose con voce profonda e dura come il sasso, e dopo due rapidissimi e celestiali starnuti aggiunse “io non ne posso più e ora comincio a capire…”.
“Che cosa, mia graziosa signora?”.
“Comincio a credere l'incredibile, a comprendere l'incomprensibile. Non avete la più pallida idea di che cosa sia l'amore”.
“Mi permetta, Madame,” replicai indignato “non le ho dato nessun motivo di dir questo”.
“Già, lei…” la divina starnutì per la terza volta e si strinse nelle spalle con grazia inimitabile “per questo anch'io sono sempre stata gentile con lei e ogni tanto vengo persino a farle visita, sebbene ogni volta prenda freddo, nonostante questa mia pelliccia. Ricorda ancora come ci siamo conosciuti?”.
“E come potrei dimenticarlo;” dissi “lei aveva allora folti capelli castani e occhi dello stesso colore e una bocca rossa, ma io la riconobbi dalla linea del volto e da quel suo pallore marmoreo… Portava sempre una giacca di velluto color violetto, guarnita di una pelliccia grigio argentea”.
“Già, lei aveva perso la testa per il mio abbigliamento, e come se ne intendeva!”.
“Lei mi ha insegnato che cos'è l'amore, e la gioia di servir lei, mia dea, mi ha fatto dimenticare tutto”.
“E io le sono stata fedele come più non avrei potuto!”.
“Ah, quanto a questo…”.
“Ingrato!”.
“Non le farò nessun rimprovero. Lei è una donna divina, ma pur sempre una donna, e quindi crudele in amore, come tutte”.
“Lei chiama crudeltà” obiettò vivacemente la Dea dell'Amore “quel che è l'elemento primo della sensualità, dell'amore più vivo, la natura stessa della donna, ossia il darsi completamente quando ama, e amare tutto ciò che le piace”.
“Esiste forse, per chi ama, una crudeltà più grande dell'infedeltà della persona amata?”.
“Oh!” rispose lei “noi siamo fedeli finché amiamo, ma voi pretendete dalla donna fedeltà senza amore, e dedizione senza godimento. Chi è crudele, allora, la donna o l'uomo? Voi del nord prendete sempre l'amore troppo sul serio. Parlate di doveri, quando non si dovrebbe parlar che di piaceri”.
“Sì, Madame, ma abbiamo anche sentimenti molto rispettabili e virtuosi e relazioni durature”.
“Certo, però avete anche un'eterna, intensa e insaziabile nostalgia per il paganesimo nudo” intervenne Madame. “Ma quell'amore che è la gioia più alta, la serenità degli dèi, non è cosa per voi uomini moderni, per voi figli della riflessione. Vi arreca sventura. Non appena volete esser naturali, diventate volgari. La natura vi si presenta come qualcosa di ostile, avete trasformato in demoni gli dèi sorridenti della Grecia, e di me avete fatto un essere diabolico. Sapete solo mettermi al bando e maledirmi oppure scannarvi come vittime sacrificali davanti al mio altare, in preda a un furore orgiastico, e se mai uno di voi ebbe l'ardire di baciare la mia bocca vermiglia, se ne andò poi pellegrino a Roma, a piedi scalzi e con indosso il cilicio, sperando che il suo bastone secco fiorisse, mentre sotto i miei piedi spuntano ogni momento rose, viole e mirti, ma il loro profumo non giunge sino a voi. Restatevene pure fra le vostre brume nordiche e fra le nubi del vostro incenso cristiano; ma lasciate noi pagani in pace sotto le ceneri e la lava, non dissotterrateci. Pompei non fu certo costruita per voi, non per voi furon costruite le nostre ville, i nostri bagni, i nostri templi. Voi non avete bisogno di dèi! E noi nel vostro mondo moriamo di freddo!”. La bella signora di marmo tossì e si strinse ancor più nella pelliccia di zibellino scuro.
“Grazie per la bella lezione,” le risposi “ma lei non può negare che l'uomo e la donna, tanto nel vostro mondo sereno e solatio quanto nel nostro così brumoso, sono nemici per natura e che l'amore per breve tempo li rende un essere unico, con un solo pensiero, un solo sentimento, una sola volontà, per poi separarli ancor più profondamente, e allora – e lei lo sa meglio di me – chi non è in grado di mettere il giogo all'altro dovrà ben presto sentire il suo piede sulla propria nuca…”.
“E di regola è l'uomo a esser premuto sotto il piede della donna, come lei sa meglio di me” esclamò Monna Venere con sovrano disprezzo.
“Certo, ed è proprio per questo che non mi faccio illusioni”.
“Ciò significa che adesso lei è il mio schiavo senza illusioni, e io quindi la calpesterò senza pietà”.
“Madame!”.
“Non mi conosce ancora? Sì, sono crudele – usiamo pure questa parola che le piace tanto – e non ho ragione a esserlo? L'uomo concupisce, la donna è concupita, il suo privilegio consiste solo in questo, ma è un privilegio decisivo. La natura ha consegnato in suo potere l'uomo, preda della propria passione, ed è sciocca colei che non sa renderlo suo suddito, suo schiavo, anzi il giocattolo, per poi tradirlo ridendogli in faccia”.
“Le sue argomentazioni, mia gentilissima…” osservai disarmato.
“Si basano su un'esperienza millenaria” rispose Madame in tono di scherno, mentre le sue bianche dita giocavano con la pelliccia scura. “Più la donna mostra dedizione, più rapidamente l'uomo diventa freddo e dispotico; ma più sarà crudele e infedele, più lo tratterà male, giocando con lui malvagiamente e senza misericordia, più lo infiammerà e ne sarà amata, venerata. È stato sempre così, dai tempi di Elena e Dalila sino a Caterina II e Lola Montez”.
“Non lo nego” dissi “per l'uomo non c'è nulla di più seducente dell'immagine di una bella, voluttuosa e crudele tiranna che avvicenda i suoi favoriti a seconda del proprio capriccio con superba noncuranza…”.
“E che indossi la pelliccia” aggiunse la Dea.
“Questo che c'entra?”.
“Conosco bene le tue predilezioni”.
“Ma lo sa” intervenni “che da quando ci siamo visti l'ultima volta lei è diventata molto civetta?”.
“In che senso, se è lecito?”.
“Nel senso che non potrebbe esserci guaina più bella per il suo corpo candido di questa pelliccia scura, e lei lo…”.
La dea rise.
“Lei sta sognando” esclamò “si svegli!”, e mi afferrò per il braccio con la sua mano marmorea “avanti, si svegli!” tuonò ancora una volta la sua voce. Aprii faticosamente gli occhi.
Mi accorsi allora che la mano che mi scuoteva era color del bronzo, e la voce era quella, roca di acquavite, del mio cosacco, in piedi davanti a me in tutta la sua altezza di due metri.
“Si alzi, coraggio,” mi diceva quel brav'uomo “è proprio una vergogna!”.
“Ma quale vergogna?”.
“Addormentarsi vestito e per di più con un libro accanto,” smoccolò le candele consumate e raccolse il volume che mi era sfiggito di mano “un libro di… Hegel,” precisò aprendolo “ma è ormai tempo di andare dal signor Severino, che ci aspetta per il tè”.
© Paolo Melandri (2. 1. 2019)
*
Il Natale
La nostra Chiesa celebra diverse feste che toccano il cuore. È difficile immaginarne una più dolce della Pentecoste e più grave e sacra della Pasqua. La tristezza e la malinconia della Settimana Santa e quindi la solennità della domenica ci accompagnano tutta la vita. Una delle feste più belle la Chiesa la celebra quasi nel mezzo dell'inverno, quando le notti sono pressoché le più lunghe e le giornate le più brevi dell'anno, quando il sole sta più obliquo sui nostri campi e la neve copre tutta la campagna: la festa di Natale. Come in molti paesi la sera che precede la festa della Natività del Signore si chiama Vigilia di Natale, così da noi si chiama la Sera santa, il giorno seguente, il Giorno santo, e la notte di mezzo, la notte di Natale. La Chiesa cattolica festeggia il giorno di Natale, quale giorno della nascita del Redentore, con la massima solennità, quasi dappertutto si celebra già la mezzanotte, come l'ora della nascita del Signore, con una splendida cerimonia notturna. Le campane chiamano attraverso l'aria buia e silenziosa della notte invernale e gli abitanti con lanterne o per scuri sentieri ben noti, giù dai monti nevosi lungo boschi coperti di brina, attraverso frutteti scricchiolanti accorrono alla chiesa, da cui vengono i rintocchi solenni, e che con lunghe finestre illuminate si alza in mezzo al paese nascosto tra gli alberi bianchi di ghiaccio.
Alla festa religiosa è congiunta una festa familiare. In quasi tutti i paesi cristiani i fanciulli imparano a salutare la venuta di Gesù Bambino – un bambino anche lui, il più mirabile che mai si sia veduto sulla terra – come una cosa festosa, splendida, solenne, che ci accompagna tutta la vita, e qualche volta anche nella vecchiaia, al sorgere di ricordi tristi, malinconici o commoventi ci riconduce ai giorni di allora, passando a volo con le ali variopinte e rilucenti per la tetra, desolata notte senza stelle. Si usa rallegrare i bambini con i doni che Gesù bambino ha portato. Questo si fa di solito la vigilia di Natale, quando è scesa la sera. Si accendono lumi e per lo più in gran numero, spesso sospesi con le candeline sui bei rami verdi di un piccolo abete che sta in mezzo alla stanza. I bambini non possono entrare fino a che non si dà il segnale che Gesù è venuto e ha lasciato i doni che aveva portato con sé. Allora la porta si apre, i piccoli possono entrare e al meraviglioso scintillio delle luci vedono appese all'albero o disposte sulla tavola cose che sorpassano di gran lunga ogni loro immaginazione, che non osano toccare, e, finalmente ricevute, tengono tutta la sera tra le braccine e portano a letto con sé. Se poi talvolta odono in mezzo ai loro sogni i rintocchi delle campane di mezzanotte che chiamano i grandi alle funzioni della chiesa, forse parrà loro che gli angioletti passino a volo nel cielo, o che Gesù ritorni a casa dopo esser stato da tutti i bambini e aver lasciato a ciascuno un dono meraviglioso.
Quando poi arriva il giorno seguente, il giorno di Natale, tutto acquista un'aria solenne: la mattina presto starsene nel tinello ben caldo coi loro vestiti migliori, mentre il babbo e la mamma si fanno belli per andare in chiesa; a mezzogiorno un pranzo festivo, un pranzo più buono che in tutti gli altri giorni dell'anno; e nel pomeriggio o verso sera vengono amici o parenti e siedono in circolo sulle seggiole e sulle panche, ragionano tra loro e possono comodamente guardare attraverso le finestre il paesaggio invernale, dove cadono lentamente i fiocchi di neve o un velo di nebbia fascia le montagne o scende all'orizzonte il freddo sole color sangue. Qua e là per la stanza o sopra una seggiolina o sulla panca o sul davanzale giacciono i doni favolosi di ieri sera, ormai più noti e familiari.
© Paolo Melandri (2. 1. 2018)
*
Afrodite 6
Nell'angolo tra l'isola del Faro e la gettata, Rodide, nella moltitudine, riconobbe Criside vicina a lei.
– Ah! Criside! Abbi un po' cura di me, ho paura! Mirto è là; ma la folla è così vasta… ho paura che ci separino. Prendimi per la mano.
– Sai tu – disse Mirtocleia – sai tu quello che succede? Conosci il colpevole? È alla tortura? Da Erostrato in poi non s'è visto mai nulla di simile. Gli dèi olimpici ci abbandonano. Che avverrà di noi?
Criside non rispose.
– Noi abbiamo donato le colombe – disse la piccola suonatrice di flauto. – Se ne ricorderà la dea? Deve essere sdegnata. E tu, tu, mia povera Criside! Tu oggi dovevi essere o del tutto infelice o sommamente potente…
– Tutto è compiuto – disse la cortigiana.
– Come dici?
Criside fece due passi indietro, alzò la destra presso la bocca.
– Guarda bene, Rodide mia, guarda, Mirtocleia. Ciò che voi oggi vedrete, gli occhi umani non l'hanno visto mai, dal giorno in cui la dea è discesa dal monte Ida. E fino alla fine del mondo, non si vedrà più sulla terra.
Le due amiche stupefatte indietreggiarono, credendola folle. Ma Criside, perduta nel suo sogno, camminò fino al Faro mostruoso, montagna di marmo fiammeggiante, a otto piani esagonali, spinse la porta di bronzo e profittando della disattenzione del pubblico, la richiuse dall'interno, abbassando le sbarre sonore.
Passò qualche istante.
La folla perpetuamente rumoreggiava: l'onda vivente aggiungeva il suo rumore agli scrosci regolari delle acque.
Improvvisamente si levò un urlo, ripetuto da cento petti:
– Afrodite!!!
– Afrodite!!!
Scoppiò un clamore di grida. La gioia, l'entusiasmo di tutto un popolo cantava in un indescrivibile tumulto di allegria ai piedi dei muri del Faro.
La ressa che copriva la gettata violentemente affluì nell'isola, invase le rocce, salì sulle case, sugli alberi da segnali, sulle torri fortificate. L'isola era piena, più che piena, e la folla arrivava sempre più compatta come un'ondata di fiume straripato che sospingesse in mare lunghe schiere umane, dall'alto della scogliera scoscesa.
Non si vedeva la fine di questa inondazione di uomini; dal palazzo dei Tolomei fino alle mura del Canale, le rive del Porto Reale, del Gran Porto e dell'Eunoste, rigurgitavano di una massa serrata che senza fine aumentava agli sbocchi delle strade. Al di sopra di questo oceano, agitata da riflussi immensi, schiumosi, di braccia e di visi, galleggiava come una barca in pericolo la lettiera dalle vele gialle della regina Berenice. E di momento in momento, aumentato da nuove bocche, il rumore diventava formidabile.
Né Elena alle Porte Scee, né Frine nelle onde di Eleusi, né Tebaide quando suscitò l'incendio di Persepoli, conobbero che cosa sia il trionfo.
Criside era apparsa attraverso la porta d'Occidente sulla prima terrazza del rosso monumento.
Nuda era come la dea, teneva con le due mani gli angoli del suo velo scarlatto che il vento gonfiava sul cielo della sera, e con la mano destra lo specchio dove si rifletteva il sole morente.
Lentamente, con la testa inclinata da un movimento di una grazia e di una maestà infinite, ella salì la scala esterna che cingeva di una spirale l'alta torre vermiglia: fremeva il suo velo come una fiamma. Il crepuscolo di bragia arrossava la collana di perle come un vezzo di rubini. Ella saliva e in tutta quella gloria la sua pelle luminosa sfoggiava tutta la magnificenza della carne: il sangue, il fuoco, il carminio azzurrino, il rosso vellutato, il rosa vivo; e girando con le grandi muraglie di porpora, ella se ne andava verso il cielo.
© Paolo Melandri (31. 12. 2018)
*
Collina
Quattro case fiorite di orchidee fin sotto le tegole emergono dalle spighe gonfie e alte.
Fra le colline, là dove la carne della terra si aggrinza in cuscinetti grassi.
Il sanfieno in fiore sanguina sotto gli ulivi. Le pecchie danzano attorno a betulle viscose di linfa dolce.
Lo scolmo di una fontana canta in due rivoli distinti. Cadono dalla pietra e il vento li scompiglia. Fremono sotto l'erba, poi si uniscono e scorrono insieme in un letto di giunco.
Il vento parlotta nei platani.
Sono i Masi Bianchi.
Quel che resta di un paesotto, a metà strada fra il piano dove romba la vita tumultuosa delle trebbiatrici e il gran deserto di lavanda, il paese del vento, nell'ombra fredda delle cime della Lure.
La terra del vento.
La terra, anche, degli animali selvatici: la biscia emerge dal cespuglio di spigo, lo schiratto, al riparo della coda a pennacchio, corre con una ghianda stretta nella zampa; la donnola saetta il muso nel vento, una goccia di sangue le splende sull'estremità di un baffo; la volpe legge nell'erba l'itinerario delle pernici.
La cignala bofonchia sotto i ginepri; i cinghialini, la bocca piena di latte, tendono gli orecchi agli alti alberi gesticolanti.
Poi, il vento supera gli alberi, il silenzio cheta il fogliame, col muso ingrugnito i piccoli cercano i capezzoli.
La selvaggina e la gente dei Masi si incontrano alla fonte, su quell'acqua che cola dalla roccia, così dolce per le lingue e i peli.
Nottetempo, nella landa, è la reptazione, zampa felposa, verso la fresca e canterina.
E anche di giorno, quando la sete è troppo forte.
Il cinghiale solitario fiuta verso i casolari.
Conosce l'ora della siesta.
Trotta per un'ampia svolta sotto le fronde, poi dal corno di vegetazione più vicino, si fionda.
Eccolo. Si voltola nell'acqua. Il fango contro la pancia.
La frescura lo passa da parte a parte, dalla pancia alla schiena.
Azzanna la fonte.
Contro la sua pelle sballotta il dolce frescore dell'acqua.
D'un tratto, però, si strappa alla delizia e galoppa verso il bosco.
Ha sentito cigolare la persiana del casolare.
Sa che la persiana cigola quando viene aperta con cautela.
Giacomo tira una scarica di pallettoni alla cieca.
Casca una foglia di tiglio.
“A cos'hai sparato?”
“Al cinghiale. Guardalo là, quel figlio di puttana.”
La Lure, calma, azzurra, domina il paesaggio, chiudendo l'occidente col suo corpaccione di montagna insensibile.
È abitata da grigi avvoltoi.
Volteggiano tutto il giorno nell'acqua del cielo, simili a foglie di salvia.
A volte, si mettono in viaggio.
Altre volte, dormono stesi sulla forza piatta del vento.
Poi, la Lure sale fra terra e sole, e allora, molto prima di notte, è la sua ombra che abbuia i Masi.
Le case incorniciano una piazzetta di terra battuta, aia comune e campo di bocce.
Il lavatoio è sotto il quercione.
Si sciacquano i panni in un sarcofago di arenaria, intagliato all'interno a forma di uomo fasciato.
Il cavo del cadavere è colmo di un'acqua verde, marezzata e che si increspa, graffiata dagli insetti acquatici.
I bordi di questo pesante avello sono ornati di donne che si flagellano con fronde di alloro.
È stato Angelo Camogli a dissotterrare quell'antica pietra sradicando un ulivo.
È arrivato ai Masi tre anni fa, una sera d'estate, mentre si finiva di spulare il grano al vento notturno.
I bragoni tenuti su da uno spago; non aveva camicia.
Il labbro pendulo, l'occhio smorto, ma azzurro, azzurro… due dentoni gli uscivano dalla bocca.
Sbavava.
Gli fecero delle domande; lui rispose soltanto: Gagù, ga-gù, su due note, come una bestia.
Poi ballò, come una marmotta, facendo dondolare le braccia ciondoloni.
Uno scemo.
Ebbe minestra e paglia.
I Masi, una volta, erano stati un borgo, al tempo dei tempi, quando ai signori piaceva respirare l'aria rude delle colline.
Tutte le loro belle case sono tornate alla terra, crollando; soltanto quelle contadine sono rimaste in piedi.
Di là dal lavatoio, però, due alti pilastri coperti di erbe segnano ancora l'imbocco di un vialetto.
Pilastri che reggono la sfera del mondo, incappucciata di muschio e con scritte in latino.
Una porta di ferro, lì, doveva proteggere qualche «casino».
Balconi mirabilmente panciuti, terrazze, dove ondeggiavano sottane e risuonavano tacchi alti.
Fra i due pilastri, proprio al centro, e quattro metri all'interno, Gagù si è fatto una baracca nelle ortiche.
È industrioso e tutt'altro che impacciato con le dita, l'ha costruita in latta, con bidoni di benzina sventrati.
Adesso che ha liberato lo zoccolo dei pilastri dall'erba, si può leggere un gran nome, con tanto di particella nobiliare, inciso in un cartiglio laureato.
La città è lontana, i sentieri sono duri.
Quando viene il vento da sud si sente, in basso, il fischio del treno e il suono delle campane.
Vuol dire, semplicemente, che il tempo è alla pioggia.
Dalla città, quando il caligo del caldo si squarcia, si scorgono i Masi Bianchi come colombi posati sulla spalla della collina.
© Paolo Melandri (27. 12. 2018)
*
Afrodite 5
Il giorno finiva: Criside si sollevò nella sua piscina, uscì dall'acqua, camminò verso la porta. L'orma dei suoi piedi brillava sulla pietra. Barcollante e quasi sfinita, spalancò la porta, si fermò col braccio allungato sul saliscendi, poi entrò e vicino al letto, dritta e gocciolante, disse alla schiava.
– Asciugami.
La Malabrese prese con la mano una grossa spugna, e la passò nei dolci capelli d'oro di Criside, pregni d'acqua e che grondavano sulle spalle, li asciugò, li sparpagliò, li agitò mollemente e tuffando la spugna in un orcio d'olio, ne accarezzò fino al collo la sua padrona, prima di fregarla con una stoffa ruvida che fece rosseggiare la sua pelle ammorbidita.
Criside si affondò rabbrividendo nella freschezza di un sedile di marmo e mormorò:
– Pettinami.
Nel raggio orizzontale della sera, la capigliatura ancora umida e pesante brillava come un acquazzone illuminato dal sole.
La schiava la prese nel pugno e la torse, la fece girare su se stessa, come un grosso serpente di metallo che le diritte spille d'oro trafiggevano come frecce, vi avvolse intorno una fettuccia verde incrociata tre volte per dar, con la seta, risalto ai riflessi. Criside teneva a distanza uno specchio di rame terso. Guardava distrattamente le mani scure della schiava muoversi nei capelli profondi, arrotondare le ciocche, far rientrare i folli riccioli e scolpire la sua capigliatura come un blocco d'argilla ritorta.
Quando tutto fu finito, Djala si inginocchiò davanti alla sua padrona e rase il suo pube rigonfio, perché la fanciulla avesse, agli occhi dei suoi amanti, tutta la nudità di una statua.
Criside divenne più grave e disse a bassa voce:
– Acconciami.
Una piccola scatola di legno rosa, che proveniva dall'isola di Dioscoride, conteneva cosmetici di ogni tinta. Con un pennello di peli di cammello, la schiava prese un po' di pasta nera e la dispose sulle belle ciglia lunghe e ricurve, perché gli occhi si aprissero più azzurri: due tratti decisi di matita li allungarono e li ammorbidirono: una polvere azzurrina colorò le palpebre, due macchie di vivo cinabro accentuarono gli angoli delle lacrime. Per fissare i cosmetici, bisognava ungere di fresca cera il viso e il petto: con una piuma dalle morbide barbe intinta nella biacca. Djala dipinse strisce bianche lungo le braccia e sul collo: con un pennellino impregnato di carminio, insanguinò la bocca e toccò la punta dei seni: le sue dita, che sulle guance avevano disteso una leggera nube di polvere rossa, segnarono all'altezza dei fianchi le tre profonde pieghe della vita, e nelle anche arrotondate due fossette qualche volta mobili; poi con un tampone di cuoio imbellettato, colorì vagamente i gomiti e ravvivò le unghie. L'acconciamento era finito. Allora Criside si mise a sorridere e disse all'Indiana:
– Canta.
Lei restava seduta e inarcata nel suo seggio di marmo. Gli spilloni, dietro al volto, formavano un'aureola dorata; le mani applicate sulla gola mettevano tra le spalle la rossa collana delle sue unghie dipinte e i piedi bianchi si riunivano sopra la pietra.
Djala, accoccolata vicino al muro, si ricordò dei canti d'amore dell'India.
– Criside…
Cantava con voce monotona.
– Criside i tuoi capelli sono come uno sciame di api sospese lungo un albero. Il vento caldo del sud le penetra con la rugiada delle lotte d'amore e l'umido profumo dei fiori notturni.
La fanciulla alternò con voce più dolce e più lenta:
– I miei capelli sono come un fiume infinito, nella pianura, dove la sera infiammata trascorre.
E cantarono l'una dopo l'altra.
– I tuoi occhi sono come gigli d'acqua azzurra, senza stelo, immobili sopra gli stagni.
– I miei occhi sono all'ombra delle mie ciglia, come laghi profondi sotto frasche nere.
– Le tue labbra sono due fiori delicati ove è caduto il sangue di una cerva.
– Le tue labbra sono due fiori delicati dove è caduto il sangue di una cerva.
– Le mie labbra sono gli orli di una ferita ardente.
– La tua lingua è il pugnale sanguinoso che ha fatto la ferita della tua bocca.
– La mia lingua è incrostata di pietre preziose. Ella è rossa perché guarda le mie labbra.
– Le tue braccia sono rotonde come due zanne d'avorio e le tue ascelle sono due bocche.
– Le mie braccia si protendono come due steli di giglio di dove le mie dita si inchinano come cinque petali.
– Le tue cosce sono due bianche proboscidi di elefante, che portano i piedi come due fiori rossi.
– I miei piedi sono due foglie di nanùfaro galleggianti sull'acqua; le mie cosce sono due bottoni di ninfea rigonfi.
– I tuoi seni sono due scudi d'argento le cui cuspidi sono intinte nel sangue.
– Le mie mammelle sono la luna e il riflesso della luna sull'acqua.
– Il tuo ombelico è un pozzo profondo in un deserto di sabbia rosa e il tuo basso ventre un giovane capriolo inginocchiato sul seno di sua madre.
– Il mio ombelico è una perla rotonda su una coppa arrovesciata e il mio grembo è la falce chiara di Febo sotto le foreste.
Successe una pausa. La schiava levò le mani e si inchinò.
La cortigiana proseguì:
– Essa è come un fiore di porpora pieno di miele e di profumi.
– Essa è come un'idra marina viva e molle, aperta di notte.
– Essa è la grotta umida, il giaciglio sempre caldo, il natale del sole, l'asilo dove l'uomo si riposa dal camminare verso la morte.
La prosternata mormorò piamente:
– Essa è spaventosa; è la faccia di Medusa.
Criside posò il piede sulla nuca della schiava e disse tremando:
– Djala…
A poco a poco era venuta la notte; ma la luna era così luminosa che la camera si riempiva di una azzurra chiarità.
Criside, nuda, guardava il suo corpo dove i riflessi erano immobili e di dove cadevano nerissime le ombre.
Si alzò repentinamente:
– Djala, basta. A che pensiamo? È notte e ancora non sono uscita. Sull'Eptastadio non ci saranno più che marinai addormentati. Dimmi, Djala, sono bella?
Dimmi, Djala, sono io più bella che mai questa notte? Io sono la donna più bella di Alessandria, lo sai? Colui che fra poco passerà sotto lo sguardo obliquo dei miei occhi, mi seguirà come un cane, nevvero? E io ne farò ciò che più mi piacerà, anche uno schiavo, se questo è il mio capriccio, perché io posso aspettarmi anche dal primo venuto la più servile obbedienza, nevvero? Vestimi, Djala.
Attorno alle braccia le si avvolsero due serpenti di argento. Ai piedi si fissarono due suole di sandalo, che si attaccarono alle sue gambe brune con bande di cuoio incrociato. Agganciò ella stessa sotto il suo ventre caldo una cintura da fanciulla, che dall'alto delle reni, si inclinava seguendo la linea concava dei fianchi; passò grandi anelli circolari alle orecchie, alle dita anelli e cammei, al collo tre collari di falli d'oro cesellati a Pafo dagli ieroduli.
Si contemplò qualche tempo così nuda tra i suoi gioielli; poi, traendo dal cofano ove l'aveva ripiegata un'ampia stoffa trasparente di lino giallo, la fece girare intorno alla persona e se ne drappeggiò fino ai piedi: le pieghe diagonali solcavano quel poco che del suo corpo si vedeva attraverso il leggero tessuto: un gomito sporgeva sotto la tunica stretta e l'altro braccio, rimasto nudo, rialzava il lungo strascico, per evitare che strisciasse nella polvere.
Prese in mano il suo ventaglio di piuma e uscì con noncuranza.
In piedi sugli scalini della soglia, con la mano appoggiata al muro bianco, Djala sola guardò la cortigiana che si allontanava.
Ella camminava lentamente, lungo le case, nella strada deserta, dove cadeva il lume di luna. Una piccola ombra mobile palpitava dietro i suoi passi.
© Paolo Melandri (23. 12. 2018)
*
Eddo Cromo 3
E allora incominciò la visita di quello strano edificio sito in una via severa, ma distinta e senza tristezza. Visto dalla strada l'edificio faceva pensare a un consolato tedesco a Napoli. Grandi negozi occupavano tutto il pianterreno. Benché non fosse né domenica, né altro giorno festivo, i negozi erano chiusi in quel momento e ciò conferiva a quella parte della strada un aspetto di noia malinconica, una certa desolazione, quell'atmosfera particolare che hanno di domenica le città morte. Nell'aria fluttuava un leggero odore di depositi di mercanzie e di derrate alimentari; odore indefinibile e altamente suggestivo che si sprigiona dai magazzini vicino alle banchine, nei porti. L'aspetto di consolato tedesco a Napoli era un'impressione personale di Eddo Cromo e quando ne parlò ai suoi amici essi sorrisero e trovarono che il paragone era buffo, ma non insistettero e tosto parlarono d'altro. Da ciò Eddo Cromo dedusse che forse essi non avevano ben capito il senso delle sue parole. Del resto non lo aveva inteso nemmeno lui. Cominciarono a salire le scale che erano assai larghe e interamente di legno verniciato; in mezzo c'era un tappeto; ai piedi delle scale, sopra una piccola colonna dorica tagliata nel legno di quercia, era posta una statua policroma, anch'essa di legno, raffigurante un africano che sollevava con le braccia, sopra il capo, una lampada a gas il cui becco era rivestito di un cappuccio di amianto. Eddo Cromo aveva l'impressione di salire da un dentista o da uno specialista per malattie veneree; ne risentì una leggera emozione e qualcosa come il principio di una piccola colica. Cercò di sormontare questo turbamento pensando che non era solo, che due amici lo accompagnavano, uomini robusti e sportivi, che nella tasca posteriore dei calzoni portavano pistole automatiche e caricatori di ricambio. Accorgendosi di avvicinarsi al piano che era stato loro segnalato come il più ricco in fatto di apparizioni strane, cominciarono a salire più lentamente e sulla punta dei piedi; i loro sguardi si fecero più attenti. Si scostarono un po' l'uno dall'altro, pur tenendosi sulla stessa linea, per poter ridiscendere le scale liberamente e al più presto, nel caso che qualche apparizione di un genere speciale li avesse costretti a farlo. Eddo Cromo pensò in quel momento ai sogni della sua infanzia; quando sognava di salire con angoscia e in una luce indecisa larghe scale di legno verniciato, in mezzo alle quali uno spesso tappeto soffocava il rumore dei suoi passi. In genere le sue scarpe, anche fuori dei sogni, scricchiolavano di rado poiché si faceva calzare su misura da un calzolaio chiamato Perpignani, favorevolmente noto per la buona qualità delle sue pelli; il padre di Eddo Cromo, invece, non aveva alcuna disposizione per comprarsi le scarpe; che facevano un rumore abominevole, come se avesse schiacciato a ogni passo sacchetti pieni di nocciole. Poi era l'apparizione dell'orso, dell'orso inquietante ed ostinato, che vi segue per le scale e attraverso i corridoi, con la testa bassa e l'aria di pensare ad altro; la fuga sperduta attraverso le camere dalle uscite complicate, il salto dalla finestra nel vuoto (suicidio nel sogno) e la discesa in volo planato, come quegli uomini-condor che Leonardo si divertiva a disegnare tra le catapulte e i frammenti anatomici. Era un sogno che prediceva sempre dispiaceri e soprattutto malattie.
“Eccoci!” disse Eddo Cromo aprendo le braccia davanti ai suoi compagni, col gesto classico del capitano temporeggiatore che frena lo slancio dei suoi soldati. Giunsero sulla soglia di una sala vasta e alta di soffitto, ornata secondo la moda del 1880. Completamente vuota di mobili questa sala, per la luce e il tono generale, faceva pensare alle sale da gioco di Montecarlo; in un angolo due gladiatori dalle maschere di scafandri si esercitavano senza convinzione sotto lo sguardo annoiato di un maestro, ex-gladiatore in ritiro, che aveva il profilo di un avvoltoio ed il corpo coperto di cicatrici.
“Gladiatori! questa parola contiene un enigma”, disse Eddo Cromo rivolgendosi a voce bassa al più giovane dei suoi compagni. E pensò ai teatri di varietà, il cui soffitto illuminato evoca le visioni del paradiso dantesco; pensò anche a quei pomeriggi romani, alla fine dello spettacolo, quando il sole declinava e l'immenso velario aumentava l'ombra sull'arena da cui saliva un odore di segatura e di sabbia inzuppate di sangue.
In un angolo del salotto un enorme pianoforte a coda, aperto; senza sollevarsi sulla punta dei piedi si potevano vedere i suoi intestini complicati e la chiara anatomia dell'interno; ma si indovinava facilmente quale catastrofe se uno dei candelieri carichi di candele, alcuni di cera rosa e altre di cera turchina, fosse caduto nell'interno del pianoforte con tutte le candele accese. Quale disastro nell'abisso melogeno! La cera che cola lungo le corde metalliche, tese come l'arco di Ulisse, e impedisce il gioco preciso dei martelletti rivestiti di feltro. “Meglio non pensarci”, disse Eddo Cromo voltandosi verso i suoi compagni e allora, tutti e tre, tenendosi per mano, come davanti ad un pericolo, guardarono intensamente e in silenzio quello spettacolo straordinario; si immaginarono di essere i passeggeri di un sottomarino perfezionato e di sorprendere attraverso i vitrei sportelli della nave i misteri della fauna e della flora oceaniche. Del resto lo spettacolo che si offriva ai loro sguardi aveva ben qualcosa di subacqueo. Faceva pensare ai grandi acquari non foss'altro che per quella luce diffusa che sopprimeva le ombre; un silenzio strano e inspiegabile pesava gravemente sopra tutta la scena: quel pianista, seduto davanti al suo strumento e che suonava senza far rumore; quel pianista che dopo tutto non si vedeva, poiché non vi era nulla in lui che fosse degno di esser visto, e quei personaggi di dramma che andavano intorno al pianoforte, tenendo una tazza di caffè in mano, con gesti e movimenti da saltatori filmati col rallentatore; tutte quelle persone vivevano in un mondo proprio, un mondo a parte; esse ignoravano tutto; esse non si riconoscevano perché non avevano mai conosciuto; non si preoccupavano di nulla e nulla aveva presa su di loro: né l'acido prussico, né lo stiletto, né la pallottola blindata. Se un ribelle (chiamiamolo così) avesse pensato di accendere la miccia di una macchina infernale, tutti i cinquanta chili di liddite contenuti nell'ordigno sarebbero bruciati lentamente, fischiando come ceppi umidi. Vi era di che disperarsi. Eddo Cromo sosteneva che tutto questo era effetto dell'ambiente, dell'atmosfera e che non conosceva nessun mezzo per cambiare le cose; non restava altro da fare che vivere e lasciar vivere. Ma qui sta la domanda, vivevano essi realmente?… Sarebbe stato difficile dare una risposta, soprattutto così, subito, senza dedicarvi alcune notti di profonda meditazione, come faceva Eddo Cromo ogni volta che un problema complicato occupava il suo spirito.
Egli temeva di intavolare una discussione coi suoi amici sulle eterne questioni di: Che cos'è la vita? Che cos'è la morte? È possibile la vita in un altro pianeta? Credete voi alla metempsicosi, all'immortalità dell'anima, all'inviolabilità delle leggi naturali, ai fantasmi che predicono la venuta di calamità, al subcosciente nei cani, ai sogni delle nottole, a ciò che contiene di enigmatico la cicala, la testa della quaglia e la pelle ocellata del leopardo? Egli aveva in orrore questo genere di discussioni benché in fondo si sentisse istintivamente attirato dal lato enigmatico degli esseri e delle cose. Ma erano gli altri a ispirargli diffidenze, quelli che discutevano con lui. Prendiamo l'esempio del vaso rotto. Quella reputazione di fanciullo-martire, al quale la matrigna col minimo pretesto affibbiava un sacco di legnate, era completamente falsa. Si poteva vedere facilmente in quel momento in cui tutta la famiglia era riunita in mezzo alla camera intorno ai cocci di quel famoso vaso di Rodi che durante novantadue anni era rimasto posato sull'alto della credenza. Con gli occhi fissi a terra, le mani aperte posate sulle ginocchia piegate, i gomiti in fuori, i sette membri della famiglia, come se fossero seduti sopra invisibili sgabelli, guardavano quei cocci biancastri. Ma nessuno si muoveva, nessuno lo accusava. Essi guardavano come archeologi incuriositi avrebbero guardato apparire la statua che si dissotterra, o come paleontologhi appassionati avrebbero guardato il fossile che la zappa ha ricondotto alla luce del giorno. Si parlava di incollare insieme i cocci e, a questo proposito, ognuno diceva la sua. Alcuni affermavano di conoscere artigiani specialisti i quali facevano questo genere di lavoro in modo così perfetto che poi nulla della rottura rimaneva visibile. La padrona di casa (quella che tutto il quartiere accusava di essere l'incubo del giovane Achille) era la meno impressionata di tutti; fu lei per prima a interrompere l'incanto di quella contemplazione. Il fratello maggiore di Achille asseriva che la disposizione dei cocci del vaso sparsi sul pavimento aveva largamente contribuito ad affascinare in tal modo i sette membri della famiglia. Quei cocci, infatti, formavano sul pavimento un trapezio, come una costellazione ben nota e l'idea del cielo rovesciato incantava, sino all'immobilità, tutte quelle brave persone le quali, dopo tutto, e tranne il fatto che invece di guardare in alto guardavano in basso, erano, durante quella contemplazione, i degni colleghi di quei primi astronomi, caldèi o babilonesi, che vegliavano, durante le belle notti d'estate, coricati sulle terrazze, con lo sguardo rivolto alle stelle. Ma nella camera accanto non si entrava. Di qua stavano la credenza, la teiera d'argento e la paura dei grandi scarafaggi neri in fondo ai vasi vuoti. Eddo Cromo non aveva mai pensato ad accostare nella sua immaginazione l'idea degli scarafaggi a quella dei pesci, ma due parole: grande e nero gli ricordavano tutta la scena straziante, semiomerica, semibyroniana, intravista una volta verso sera, sulle rive sassose di un'isola arida. Questa scena fu per Eddo Cromo la causa di una delusione tosto seguita da un sentimento di vergogna. Il mare era liscio e rifletteva perfettamente il cielo rischiarato dal tramonto. Di quando in quando, con una regolarità cronometrica una lunga onda nasceva a poca distanza dalla riva, si gonfiava, accelerava la sua corsa e veniva precipitosamente a rovesciarsi sulla spiaggia con un rumore di tuono tagliato a metà. Tra un'onda e l'altra erano il silenzio e la calma più assoluti. In un simile scenario Eddo Cromo udì per la prima volta la supplica della moglie del pescatore.
© Paolo Melandri (23. 12. 2018)
*
Visione
Mentre, meccanicamente, mi arrotolo una nuova sigaretta, mentre il pulviscolo marrone vacilla e cade con un lieve picchiettio sulla superficie bianco-giallognola della carta assorbente, sempre più mi pare improbabile di essere ancora sveglio. E mentre l'aria della sera, che mi lambisce calda e umida entrando dalla finestra aperta, modella capricciosamente le nuvolette di fumo e dal verde alone dell'abat-jour le sospinge nell'indistinta oscurità dell'ombra, non ho più dubbi: sto sognando.
Questo pensiero, com'è ovvio, mi infastidisce: imbriglia la fantasia. Dietro di me lo schienale della sedia scricchiola furtivo, irridente; i miei nervi ne sono urtati come da un brivido improvviso. È irritante, mi disturba nella mia assorta analisi dei segni bizzarri tracciati dal fumo, quasi lettere che mi folleggiano intorno, lettere con le quali mi ripromettevo di tessere una trama.
Ora, invece, la quiete è sconvolta. Movimento frenetico in tutti i sensi. Nervoso, febbrile, delirante. Clamore di suoni disparati. E in questo tumulto ecco affiorare dall'oblio percezioni che un giorno mi si impressero nella mente e che adesso, stranamente, si rinnovano e ridestano lo stesso stato d'animo di allora.
Noto con interesse che il mio sguardo si dilata avidamente, come ad abbracciare lo spazio immerso nel buio. Quello spazio in cui, sempre più nitido, si profila un rilievo luminoso. Assorbe, questo mio sguardo; vaneggia, ma è, il suo, un vaneggiamento gioioso. E accoglie sempre più: sempre più si dà; sempre più si fa; sempre m'incanta… sempre… più.
Ora è là, limpidissima, vivida come allora, l'immagine, l'opera d'arte del caso. Recuperata dall'oblio, ricreata, plasmata, dipinta da quell'artista geniale e fiabesca che è la fantasia.
Non grande: piccola. Non un tutto organico, eppure compiuta come allora. Al tempo stesso indefinita, da ogni parte sfumante nell'oscurità. Un mondo. Un universo. Una vibrazione di luce una sensibilità profonda. Non un suono, però. Nulla vi penetra del frastuono che, ridendo, la circonda. O meglio, che la circondava.
Sotto, un drappo abbacinante di damasco; obliqui, frastagliati, vi turbinano, vi ondeggiano fiori e foglie. Sopra, poggiando su un supporto traslucido, si erge la forma slanciata di un calice di cristallo, colmo a metà di pallido oro. Una mano si protende con gesto sognante. Le dita cingono delicatamente la base del calice. Serrato intorno a un dito, spicca in argento opaco il cerchio di un anello su cui sanguina un rubino.
Ma mentre, in un crescendo di plasticità, sta per divenire braccio, la morbida articolazione svanisce nel nulla. Un dolce enigma. Riposa trasognata, inerte, la mano di fanciulla. Solo dove attraverso il suo candore esangue serpeggia una vena azzurrina, solo là pulsa la vita, lentamente, violentemente palpita la passione. E come percepisce il mio sguardo, la pulsazione si fa sempre più veloce, concitata, sino a un ultimo spasimo supplichevole: Smetti…
Ma implacabile, con spietata, opprimente voluttà, il mio sguardo, come allora, si concentra. Grava su quella mano in cui freme la lotta con l'amore, la vittoria dell'amore… come allora… come allora…
Lentamente, dal fondo del calice si distacca una perla, si libra verso l'alto. Giunta nel campo di luce del rubino, si accende di riflessi sanguigni, poi bruscamente si spegne in superficie. Finché, come per un nuovo sconvolgimento, tutto dilegua, sebbene lo sguardo si sforzi di ridisegnare, di risuscitare i morbidi contorni.
La visione si è dissolta nell'oscurità. Respiro, respiro profondamente: mi accorgo che finora avevo trattenuto il fiato. Come allora…
Mentre aderisco affranto allo schienale, una fitta mi strazia. Adesso lo so con certezza, con la stessa certezza di allora: Tu mi amavi… Ed è per questo che posso abbandonarmi al pianto.
© Paolo Melandri (20. 12. 2018)
*
Il ritorno di Pan
I gesti erano lì, di una naturale semplicità. Si fece un pasto d'erba e di buio. Si era posata sul bordo dell'aia una gran ciotola piena di quell'insalatina delle colline, chiara chiara, colta all'ombra e che formicolava, lucida d'olio, come un nido di ragni verdi. Ci pescavamo dentro con le dita, uno per volta; eravamo tutti in cerchio, con la ciotola nel mezzo; una larga fetta di pane tenuta sulla sinistra serviva da piatto e da tovagliolo, e quando quel pane si era imbevuto ben bene di gocce d'olio e aveva ben asciugato le dita, lo si mangiava, e aveva il sapore di un pomeriggio di mietitura.
Il buio lo masticavamo con l'insalata, il buio che scaturiva dal cratere in lienti fiotti, e le bocche erano piene di buio quando addentammo i tozzi sfregati con l'aglio. Avevamo dunque delle erbe da mangiare, poi il buio – ed era un buio di macchia –, poi le strane occhiate gialle della streghetta quattordicenne. Tutto ciò dava pastura alla pancia e al cervello; non so se il cervello facesse parte a sé; credo piuttosto che tutto, insalata, olio, pane nero, buio e occhiate di genziana, tutto scendesse nella pancia, tutto vi facesse calore e peso, tutto si mutasse in succhi e in effluvi, tanto da renderci alla fine ebbri della triplice forza del cielo, della terra e della verità.
© Paolo Melandri (16. 12. 2018)
*
Padre e figlio
Ora la barca scivolava, illuminata dal fervido sole meridiano, lungo il fiume, brezze miti rinfrescavano l'aria calda, molli rive ai due lati lasciavano godere un paesaggio semplice, ma riposante. I campi di grano si avvicinavano fino alla corrente, e il terreno fertile era così prossimo alla riva, che in qualche punto le acque scroscianti, gettandosi oltre i margini, avevano assalito violentemente la terra friabile trascinandola con sé, così che si erano costituite delle rapide scarpate di una notevole altezza.
Su in alto, sull'orlo di una di queste, dove forse una volta era stato un ciglione, il nostro amico vide galoppare un giovanotto di bell'aspetto, dalla figura vigorosa. Lo si voleva osservare meglio, quando l'orlo erboso su cui cavalcava cede e l'infelice d'improvviso precipita con tutto il cavallo nel fiume, a capofitto. Non c'era da indugiare e da far domande, i barcaioli remano veloci come saetta verso il vortice, in un attimo hanno già ripescato la bella preda. L'amabile giovane, apparentemente esanime, giaceva nella barca, dopo breve riflessione gli abili barcaioli si spinsero verso una specie di isolotto ghiaioso che si era formato in mezzo al fiume. Approdare, portare il corpo a riva, spogliarlo, asciugarlo, fu tutt'uno. Ma ancora non si poteva notare alcun segno di vita, il tenero fiore posava lì immobile fra le loro braccia!
Guglielmo afferrò subito una lancetta per aprire una vena del giovane, il sangue sprizzò copioso e mescolandosi con l'onda che s'insinuava lì scherzosa, rifluì con essa nel fiume. La vita ritornò; il premuroso chirurgo ebbe appena il tempo di fermare la fasciatura, che il giovane era già di nuovo coraggiosamente in piedi. Guardò Guglielmo in volto ed esclamò: «Se devo vivere, che io viva con te!». Con queste parole si gettò fra le braccia del suo salvatore che lo aveva riconosciuto, che era riconosciuto, e scoppiò in lacrime. Così stavano fortemente abbracciati, come Castore e Polluce, i fratelli, quando si incontrano nella luce, nel loro alterno cammino verso l'Ade.
Lo pregarono di calmarsi. I bravi compagni avevano già preparato un comodo giaciglio, metà al sole, metà nell'ombra, sotto rami e cespugli leggeri. Ora giaceva là, sul mantello del padre: la più attraente figura giovanile, i ricci bruni, già asciutti, tornavano a inanellarsi, sorrideva tranquillo, e si addormentò. Il nostro amico lo guardò con compiacimento. «Tu risorgi sempre a nuova vita, splendida immagine di Dio! – esclamò – e subito torni di nuovo a soffrire, ferita nel corpo o nell'anima». Il mantello cadde su di lui, il calore moderato del sole scaldava dolcemente e profondamente le sue membra, le sue guance si arrossavano, apparve di nuovo del tutto rimesso.
Gli uomini dell'equipaggio, lieti per la buona azione compiuta e per la generosa ricompensa che si aspettavano, avevano già asciugato sulla ghiaia calda le vesti del giovane perché, appena desto, potesse di nuovo presentarsi nel modo più decoroso.
© Paolo Melandri (13. 12. 2018)
*
Il sapore della terra
Una grossa edera accovacciata nel cavo di una conca rodeva le ossa scarnite di una fattoria morta: dondolava il testone, gettava succhioni verdi nell'erba, se ne andava con un pigro desiderio, carica di branche e di foglie nere, verso l'ovile gemebondo. La terra era graffiata da grossi unghioni; in altri punti, conciata e pesta come il suolo di una porcilaia, anche se sembrava per quanto era lunga e larga lo svoltolone di qualche bestia più massiccia del cielo. A parte ciò, non si vedevano uccelli; non si sentiva lo squittio sorcino dei cespugli né quel rumore di sorgente che fanno i biscioni quando strisciano assonnati nell'erba; c'era soltanto il fermento delle linfe, ma tutto era così caldo di vita che se ne sentiva l'ustione feroce soltanto a toccare lo stelo leggero di un caprifoglio.
Anche se ci sono abituato, rimasi davanti a tutto questo per un bel po', nudo e freddo. Infine, mi feci coraggio, scesi nel ribollio degli alberi. Il mezzodì mi trovò smarrito e con la gola in fiamme in quella prigione ondulata che è il fondo del gran cratere. Da ogni parte girarsi quando, a ogni passo, un albero gesticolante ti urla dietro? Già tre volte, scostando le braccia dei meli matti, avevo visto, dietro, la parete dritta della rupe. Il sole aveva succhiato tutto il mio umidore, ero secco come legno morto, tanto da sentirmi cricchiare la pelle, il mio cervello faceva la ruota, rossissima, nel nero della mia testa, quando giunse un flagioletto a tre tonalità, umanissimo, più che umano, così umano che con quanto restava del mio umidore urlai un «Oh!» pieno di speranza. Il flauto tacque. In capo a un momento zufolò più lontano, verso le canne di un fontanile abbandonato. Ci andai: nessuno! Un'acqua sola che fiottava a scatti dal cancello di legno, un'acqua greve dall'odor di zolfo, un'acqua così carica di terra da aver riempito la vasca di una fanghiglia gialla e che da lì traboccava.
Il flauto suonò sotto i pini. Trovai in quella direzione un pertugio tra due massi; lottando alla disperata con le serpi di un sambuco, passai. Avevo semi tra i peli, pezzi di fiori nei capelli; una gran foglia viscosa mi si era incollata alla guancia. Ma, a emergere così quando più non ci speri, ti torna subito il coraggio. Il sentiero mi spuntò sotto i piedi; il flauto suonava davanti a me come il sonaglio di un cane da caccia. Camminai, alberi si scostavano dalla mia strada, erbe erano fresche contro le mie gambe e, tutt'a un tratto, vidi lassù, nella collina, una profonda ferita scura e da cui sanguinava l'argilla.
«E allora» mi urlò lui vedendomi arrivare, «viene dal fondo? Sembra un uomo-pianta. Ce l'avrà una bella testa, lei…»
Mi aspettava sotto l'aia e, l'ultimo passo, lo feci tirato dalla sua manona che aveva afferrato la mia. Mi dette l'orcio a due becchi; mi rifeci una scorta di umidore sia dentro sia fuori succhiando l'acqua a golate, bagnandomi tutto il petto con quella spera chiara; dopo, sentii una bava di vento, tutto si mise in ordine nella mia testa e mi parve di essere di nuovo padrone di me.
© Paolo Melandri (12. 12. 2018)
*
La nascita di Ulisse
Disteso sulla sabbia umida, Ulisse aprì gli occhi e vide il cielo. Null'altro che il cielo! Sotto di lui, la carne esangue della terra che partecipa ancora all'ipocrisia delle acque.
Il mare perfido ululava dolcemente: le sue molli labbra verdi baciavano senza sosta, con baci feroci, la dura mascella delle rocce.
Tentò di sollevarsi: le gambe, solo alghe! Le braccia due nugoli di spruzzi. Controllava le sole palpebre ed esse erano aperte sulla desolazione del cielo. Chiuse gli occhi. La disperazione cominciò a rodergli il fegato.
Risuonarono calpestii di piccoli piedi, e poi esclamazioni, così umane che erano come fiorite.
Le voci svolazzavano sopra il suo corpo. La sua pelle sentiva il tepore del soffio che impastava la lingua. Sollevò un poco le palpebre: era attorniato da un cerchio di gambe nude. Il suo sguardo ne fece il giro, poi risalì lungo di esse. Ginocchi scolpiti dallo sforzo dietro l'aratro, cosce… Due salivano senza peli sotto la tunica, due cosce ombrate di azzurro!
Il suo sguardo salì ancora: due seni! Era una donna!
Mentre lo sollevavano, vide un po' più lontano altra gente che si affacendava attorno a un altro relitto.
Sulle erbe della scogliera alzavano Archiade. Era scampato allo schianto dello sciabecco afferrandosi all'albero spezzato. Gesticolava e muggiva come un vitello marino. Una vecchia cicatrice color zolfo gli illuminava la fronte. La veemenza del suo discorso gli scuoteva la barba e la forza delle parole che sgorgavano in un pulviscolo di saliva e d'acqua di mare era tale che, sbalorditi, i portatori meditavano sul modo più dignitoso di abbandonare la barella e fuggire.
Poiché, dopo il colpo di clava che lo aveva steso dinanzi alla porta Scea, Archiade possedeva il triste privilegio di vedere gli dèi.
Pur senza l'aiuto della ghirlanda di nubi o del sussurro dei venti nei boschi, Archiade viveva sempre in mezzo agli dèi, e dalle sue labbra, come da una sorgente solforosa, colava un sogno terribile.
Durante il lungo susseguirsi dei giorni fioriti di margheritine, di grano maturo, di pomi, Ulisse incontrò per tre volte la donna.
La prima, ella correva danzando sotto le tamerici. Prima di sparire nella pineta, voltò la testa verso di lui.
Poi fu al bagno. Aveva frugato tutte le cale prima di scoprire l'ansa dove si bagnava. Ma ella lo vide e, tuffandosi, scomparve nell'acqua glauca. La seguì un folto grappolo di bollicine d'oro.
Infine, in un torrido meriggio, nella campagna immota Ulisse la intravvide ancora una volta davanti alla sua casa; ella spiava dallo spiraglio della porta. Gli sorrise: il suo sorriso aveva la potenza che sconvolge le leggi immutabili. La terra si piegò, gli alberi, l'erba gettarono Ulisse verso l'uscio che lentamente si apriva. Entrò. L'ombra era fresca, profumata, densa come la polpa di un frutto. Lo zampillo di una fontana gorgogliava. La donna si chiamava Circe.
Ora, quando la conca delle barche da pesca risuonava all'imboccatura del porto, Ulisse scendeva al villaggio.
Spingeva l'uscio dell'Eros Marino, una bettola del porto. Ritrovava là Capitan “Danza nell'Ombra”, padron Fotiade, l'equipaggio della Venere, il mozzo della Dorade dalle guance così graziose e dallo sguardo tanto equivoco. Tutti un giorno già conosciuti da Circe e da allora rimasti suoi buoni amici. Crepitavano sulle tavole di legno interminabili partite agli aliossi.
Ulisse andava all'Eros Marino soprattutto per la piccola Lidia che serviva da bere. Essa odorava di molluschi e di vino e di quell'amaro profumo di sudore che sconvolgeva Ulisse. Quando gli altri se ne andavano, la prendeva sulle ginocchia, l'accarezzava, raccontava… Non lo imbarazzava inventar frottole.
Già quando trasportava il suo carico di maiali a Pilo, seguiva la scia delle donne. Si spacciava, talvolta, per un re vagabondo o per un cacciatore di belve feroci. Una volta, in Elide, aveva perfino indossato la pelle di un dio, per assalire nel fondo di un bosco Musarione, la pastorella.
Al calar della sera, risaliva verso la casa di Circe.
Baci e graffi lo accoglievano già nel vestibolo.
© Paolo Melandri (10. 12. 2018)
*
Primo amore
Primo amore
A una svolta del sentiero, appena passato il cimitero di Santa Lucia, mi appaiono i cipressi delle Sacca. Sono anni e anni che non torno a salutarli. Mi sento, con orrore, tornare bambino, e a poco a poco, senza accorgermene, affretto il passo, quasi fuggendo incontro a loro. Entro così nella selva di cipressi che dalla villa dei Da Filicaia si stende fino a quella dei Fossombroni, e, a mano a mano che penetro nell'ombra odorosa di resina amara, mi nasce nel cuore una tristezza vile.
Non appena mi volto e mi rivedo bambino, laggiù, in fondo agli anni tristi dell'infanzia, mi prende un senso di sgomento e di umiliazione. Ho paura e ribrezzo di me bambino. Di me uomo ho confidenza. Conosco i miei segreti, la mia forza, le zone oscure e le zone luminose del mio spirito, quel che c'è di già morto in me, di ancora vivo. So come deludermi, come rifiutarmi. Ma di me bambino che cosa conosco? Uno spettro dolente. Nella vita di ogni uomo non c'è nulla di più segreto e di più misterioso dell'innocenza e della castità dell'infanzia. Quel che di impuro affiora ogni tanto nei nostri gesti, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, ci viene da quell'età torbida e infelice. Dentro ogni uomo c'è un bambino morto: un groviglio di paure, di istinti, di sentimenti corrotti, disfatti. Chiudo gli occhi, e mi rivedo ragazzo camminare per questi poggi, sotto questi cipressi e questi olivi, e i grilli scricchiolano all'orlo dei prati, le cicale cantano aggrappate alla scorza nera e rugosa delle viti, le serpi strisciano fra i sassi, e viene dagli Abatoni, dalla fabbrica dei Franchi, l'ansito di un motore, il rantolo di una bestia in agonia. Eccolo lì, davanti a me, il bambino che ero. Mi vedo fermarmi ad ascoltare lo scricchiolio dei grilli, il canto funebre delle cicale, curvarmi a frugare tra l'erba rossa e turchina, cogliere i fiori gialli delle ginestre, scovare i granchi di sotto le pietre immerse nell'acqua limpida e fredda. Mi guardo intorno, nulla è mutato, i pagliai ronzano come alveari, il sole al tramonto si riflette roseo nel lastrico grigio delle aie, nelle foglie argentee degli olivi, già le prime ombre della sera salgono lentamente dalla valle del Bisenzio, su per i fianchi nudi dello Spezzavento, con moto ambiguo di ragni, gli uccelli volano bassi, un morbido sonno cade dal cielo.
Son vissuto per tanti anni prigioniero fra questi monti, questi alberi, dentro questo orizzonte troppo breve per la mia ansia infantile, che l'antico furore mi scuote, l'antico odio. Mi risento all'improvviso umiliato dal ricordo di quella prima schiavitù. Ho vergogna di essere stato un bambino. Vorrei, con un gesto, liberarmi del bambino morto che è in me, con quello stesso gesto col quale mi liberai, allora, dell'essere misterioso che già cominciava a formarsi nel fondo della mia coscienza. Fu proprio lì, sotto quei cipressi, fra quei cespugli di ginestre dove biancheggiano come un cielo stellato i fiori di cicuta. Era la figlia di un carrettiere di Santa Lucia, una ragazza dai capelli rossi, un'enorme testa ricciuta, una fronte bianca sparsa di lentiggini gialle. Distesa sull'erba, dormiva. Sulle prime non mi ero accorto della sua presenza, camminavo respirando l'aria densa di resina, quella polvere verde che si alza dai boschi al tramonto. Erano gli ultimi giorni di primavera, la terra mandava un soffio caldo, un alito di mucca malata. Il cielo appariva tutto incrinato, come un antico specchio sbiadito, gli alberi e i monti vi si riflettevano capovolti, come in un lago. I cipressi nel vento mandavano un suono strano, le foglie degli ulivi urtandosi facevano un tintinnio di conchiglie.
La ragazza mi apparve all'improvviso supina nell'erba, le mani incrociate sotto la nuca. Il viso era chiuso, inespressivo, lontano. Era un sonno vuoto di sogni, una specie di estasi pigra e incosciente. Si era tolta la leggera camicetta di cotone, le braccia nude affondavano morbide nell'erba di un verde lucido. Di sotto le ascelle spuntavano due ciuffi di peli rossi. Un odore acre e violento di sudore mi bruciava le narici. Respiravo con fatica, il sangue mi batteva nelle tempie con un tonfo che pareva un urlo. Quella chioma rossa, quella fronte bianca illuminata di lentiggini gialle, mi avevano sempre dato uno stordimento febbrile. La vedevo passare tutte le sere davanti al cancello della nostra villa, prendere su per la viottola che sale al poggio delle Sacca, camminare con quella sua andatura pigra e amorosa. Una sensualità già matura si sprigionava dal suo seno ancora acerbo, dai fianchi lisci, dalle spalle larghe e ossute. La seguivo con gli occhi per un lungo tratto, una strana inquietudine mi faceva tremare il cuore. Era un dolce terrore, una tenerezza timida e spaurita. I contadini e i barrocciai le rivolgevano sottovoce parole misteriose con un furbesco atteggiare del viso, un sospettoso ammiccare degli occhi. Mi sentivo attirato da lei, spinto verso di lei da un'oscura forza, alla quale tentavo resistere con una sorta di spavento.
Quella stessa forza da cui mi ero sentito attirato la prima volta che avevo visto un morto, nella cappella mortuaria del cimitero di Santa Lucia. Era una contadina ancora giovane, tutti le portavano fiori, la bara scoperchiata era piena di fronde di ginestra. Ero entrato in punta di piedi, non osavo avvicinarmi alla bara, eppure una strana forza mi spingeva verso la morta, camminavo a piccoli passi, tutto curvo in avanti, ansando, in un silenzio gelido e vuoto. Tutti mi fissavano in viso, e io mi accorgevo di ogni mio gesto, di ogni mio passo, mi pareva di vedermi in uno specchio appannato, avevo paura e curiosità di quel che facevo, avrei voluto fermarmi, tornare indietro, ma non potevo, un avido spavento mi spingeva innanzi. Era come se la morta mi chiamasse per nome, a voce bassa, muovendo appena le labbra bianche, guardandomi di sotto le ciglia socchiuse, perfino nel gesto delle mani incrociate sul petto c'era come un richiamo, un invito. A un tratto allungai con violenza la mano verso quel viso di cera, come per colpirlo, e qualcuno in quell'istante mi afferrò il braccio, udii un grido, il mio grido, voci concitate intorno a me, un rumore di passi, mi trovai fuori all'aperto, disteso per terra, tutto tremante e piangente.
La ragazza dormiva, il vento le aveva rialzato la sottana fin sopra il ginocchio, e appariva la carne rosea e ferma della coscia, sparsa di una lucente peluria color rame. Mi rivedo nascosto dietro un cespuglio, curvo, ansante, gli occhi opachi e fissi. Ho paura e ribrezzo di quel ragazzo, sento che la vista della donna addormentata gli accende nelle vene un'ansia crudele, un furore lucido e preciso. Mi accorgo che una forza irresistibile sta per vincerlo, una violenza calda e rossa, un istinto di rivolta e di liberazione. O il primo istinto del delitto. Mi guardo intorno: il luogo è deserto, lo stesso luogo, la stessa ora. Sono solo, solo davanti a quel ragazzo che ero, di cui ho vergogna e paura. Vorrei corrergli incontro, trascinarlo via con me, prima che possa compiere il gesto che già vedo incidersi nell'aria dura e lucente. Quel gesto di cui all'improvviso mi assale l'orrore antico: ma un orrore che ha in sé ancora un'ombra di orgoglio, di pudore ferito.
A un tratto vedo il ragazzo curvarsi, afferrare un sasso, scagliarlo con tutte le sue forze contro la donna addormentata. Il sasso la coglie in mezzo alla fronte, la donna si solleva di colpo sui gomiti, un urlo le rompe la bocca, un rivo di sangue le inonda il viso. Il ragazzo rimane in ginocchio, immobile, per qualche istante, un sorriso stanco e deluso sulle labbra esangui. Poi adagio adagio si allontana, fugge lento e cauto fra le ginestre, si ferma, appoggia la fronte al tronco di un cipresso, un tremito convulso gli scuote le mani.
Il sole intanto è scomparso, l'aria trema intorno alle foglie immote, non soffia alito di vento, ma l'aria trema, i profili dei monti impallidiscono a poco a poco, si sciolgono nella carne viva del cielo. Il ragazzo all'improvviso si volta e mi guarda. Sono io, mi riconosco, sono io quel bambino pallido, dalla fronte ansiosa, dagli occhi opachi e tristi. “Va' via!”, gli grido, curvandomi a roccogliere un sasso. Il ragazzo mi guarda fisso con un'intensa espressione di pietà, e io a poco a poco mi sento umiliato dalla pietà di quel bambino, ho rimorso di avere avuto paura e vergogna di lui, vorrei chiedergli perdono, gli son grato di avermi salvato con quel gesto dall'incubo del delitto, di avermi liberato per sempre da quella misteriosa schiavitù, che fa dell'amore il sentimento più vicino alla speranza e all'umiliazione della morte.
© Paolo Melandri (9. 12. 2018)
*
Afrodite 4
Sul mare si levò l'alba oscura; tutte le cose furono tinte di lilla. Il focolare fiammeggiante acceso sul faro si spense con la luna. Fuggevoli barlumi gialli apparvero nelle onde viola, come visi di sirene sotto capigliature di alghe paonazze. Di colpo si fece giorno.
La gettata era deserta, la città morta. Era la triste luce che precede i primi chiarori dell'alba, che rischiara la vetta del mondo e apporta gli snervati sogni del mattino. Non esisteva che il silenzio.
Simili a uccelli addormentati, le lunghe navi lungo le banchine lasciavano pendere i loro remi nell'acqua. La prospettiva delle strade si disegnava con linee architettoniche, che non un carro, non un cavallo, non uno schiavo turbava. Alessandria non era che una vasta solitudine, un'apparenza di antica città, abbandonata da secoli.
Un leggero rumore di passi fremette sul suolo e due fanciulle apparvero, l'una vestita di giallo, l'altra di azzurro.
Portavano entrambe la cintura delle vergini, che girava attorno ai fianchi e si congiungeva bassissimo, sotto i loro giovani ventri. Erano le cantatrici della notte e una delle suonatrici di flauto. La suonatrice era più giovane e più bella della sua amica. Pallida come il celeste del suo vestito, i suoi occhi semiperduti sotto le palpebre debolmente sorridevano. I due flauti esili pendevano dietro all'elegante nodo sulla spalla. Una duplice ghirlanda d'iris attorno alle sue gambe ondulava sotto la stoffa leggera e sulle caviglie si attaccava a due braccialetti d'argento. Ella disse:
– Mirtocleia, non rattristarti per avere perduto le nostre tavolette. Avresti dimenticato tu che l'amore di Rodide ti appartiene, o puoi pensare, cattiva che sei, che saresti stata la sola a leggere quella riga scritta dalla mia mano? Sono forse una di quelle cattive amiche che incidono sull'unghia il nome della loro sorella di letto e vanno a unirsi a un'altra quando l'unghia è spuntata del tutto? Hai bisogno di un mio ricordo quando mi hai tutta viva ed intera? Giungo ora all'età in cui le giovani si maritano e non avevo la metà dei miei anni quando ti vidi per la prima volta. Ti ricordi? fu al bagno. Le nostre madri ci tenevano sotto le braccia e ci dondolavano l'una verso l'altra. Noi abbiamo a lungo giocato sul marmo prima di rivestirci, da quel giorno non ci siamo più lasciate e cinque anni dopo ci siamo amate.
Mirtocleia rispose:
– C'è un altro primo giorno, Rodide, lo sai: il giorno in cui tu hai scritto queste tre parole sulle mie tavolette unendo i nostri nomi. Fu il primo: non lo ritroveremo più. Ma non importa: ogni giorno è nuovo per me, e quando tu verso sera ti svegli, mi sembra di non averti mai vista. Io sono persuasa che tu non sei una ragazza: sei una piccola ninfa d'Arcadia, che ha abbandonato le sue foreste perché Febo ha inaridito la sua fontana. Il tuo corpo è snello come un ramo di olivo, dolce è la tua pelle come l'acqua dell'estate, l'iris gira attorno alle tue gambe e tu porti il fiore del loto come Astarte il fiore aperto. In quale bosco popolato di immortali si è addormentata tua madre, prima della tua nascita felice? e quale Egipan indiscreto o qual dio del fiume divino si è a lei unito sull'erba? Quando noi lasceremo questo crudele sole africano, tu mi condurrai alla tua sorgente, lontano, oltre Psofide e Feneo, nelle vaste foreste piene di ombre, ove sulla terra molle si vede la duplice orma dei satiri alternata ai passi leggeri delle ninfe. Là tu cercherai una roccia liscia e inciderai sulla pietra ciò che avevi scritto sulla cera: le tue parole che sono la nostra gioia. Ascolta, ascolta Rodide! Per la cintura di Afrodite dove tutti i desideri sono ricamati, tutti i desideri mi sono estranei, perché tu sei più del mio sogno! Per le corna di Amalteia, donde scaturiscono tutti i beni del mondo, il mondo mi è indifferente, perché tu sei il solo bene che io abbia trovato! Quando ti guardo e quando tu mi vedi, non so più perché tu mi ricambi d'amore. I tuoi capelli sono biondi come le spighe di grano, i miei neri come i peli del capro; la tua pelle è bianca come il formaggio dei pastori, la mia abbronzata come la sabbia sulle spiagge; il tuo seno tenero è fiorito come l'arancio dell'autunno, il mio è magro e sterile come il pino delle rocce. Se il mio viso è abbellito, è perché ti ho amato. O Rodide, tu lo sai, la mia singolare verginità è simile alle labbra di Pan che mangino un po' di mirto; la tua è rosea e graziosa come la bocca di un bambino. Non so perché tu mi ami, ma se un giorno cessassi di amarmi, se, come tua sorella Teano, che vicino a te suona il flauto, tu restassi mai a dormire nelle case dove suoniamo, allora io non avrei neppure il desiderio di dormir sola nel nostro letto e ritornando mi troveresti strangolata con la cintura.
I lunghi occhi di Rodide si riempirono di lacrime e di sorriso, tanto l'idea era folle e crudele. Posò il piede su un paracarro.
– Mi danno fastidio i fiori tra le gambe; scioglili, Mirto adorata. Per questa notte non danzo più.
La cantatrice ebbe un sussulto.
– Oh! è vero. Li avevo già dimenticati, quegli uomini e quelle ragazze. Vi hanno fatto danzare entrambe, tu in questa veste di Coos che è trasparente come l'acqua, e tua sorella nuda, con te. Se non ti avessi difeso ti avrebbero preso come una prostituta, come hanno preso tua sorella davanti a noi, nella stessa camera… Oh! che abominio! tu sentivi le sue grida e i suoi lamenti! Come è doloroso l'amore dell'uomo!
Ella si inginocchiò vicino a Rodide e staccò le due ghirlande, poi i tre fiori posti più in alto, mettendo un bacio al posto di ognuno di essi. Quando si rialzò, la fanciulla le cinse il collo e vacillò sotto la sua bocca.
– Mirto, tu non sei gelosa, vero, di questi viziosi? Che ti importa che mi abbiano veduta? Teano basta per loro e gliela ho lasciata. Non mi avranno, Mirto mia. Non essere gelosa di loro.
– Gelosa!… ma io sono gelosa di tutto ciò che ti si avvicina. Perché i tuoi vestiti non ti abbiano essi soli, io li indosso quando tu li hai portati. Perché i fiori dei tuoi capelli non restino innamorati di te, li abbandono alle cortigiane povere che li sporchino nelle orge. Non ti ho mai dato nulla, perché nulla ti possieda; ho paura di tutto ciò che tocchi e detesto ciò che guardi. Vorrei, per tutta la vita, essere fra le mura di una prigione dove non fossimo che tu ed io, e unirmi a te così profondamente, nasconderti così nelle mie braccia che nessun occhio ti potesse scoprire. Vorrei essere i frutti che tu mangi, il profumo che ti piace, il sonno che entra sotto le tue palpebre, l'amore che contrae le tue membra. Sono gelosa della felicità che ti do; e malgrado ciò vorrei darti anche quella che mi viene da te. Ecco di che sono gelosa; ma non temo le tue amanti di una notte quando esse mi aiutano a soddisfare i tuoi desideri di bambina; quanto agli amanti so benissimo che tu non apparterrai mai a loro, e so che non puoi amare l'uomo, l'uomo intermittente e brutale.
Rodide esclamò sinceramente:
– Piuttosto andrei come Nausitoe a sacrificare la mia verginità al dio Priapo adorato a Tasos. Ma questa mattina no, mia cara. Ho danzato a lungo e sono troppo stanca; vorrei già essere a casa e dormire nelle tue braccia.
Sorrise e continuò:
– Bisognerà dire a Teano che il nostro letto non è più per lei. Gliene facciamo un altro alla destra della porta: dopo ciò che ho visto questa notte non potrei più baciarla. Mirto, è davvero una cosa orribile. È possibile amarsi così? È questo che essi chiamano amore?
– È questo.
– Si ingannano, Mirto: non sanno.
Mirtocleia la prese tra le braccia e tacquero tutte e due.
Il vento confondeva i loro capelli.
© Paolo Melandri (6. 12. 2018)
*
Diospolis
Opht (è il nome egizio della città che l'antichità chiamava Tebe dalle cento porte o Diospolis Magna) sembrava addormentata sotto l'azione divorante di un sole a picco. Era mezzogiorno; una luce bianca cadeva dal cielo pallido sulla terra in deliquio per il calore; il suolo lucente di riverberi brillava come metallo limato, e l'ombra tracciava alla base degli edifici nient'altro che una sottile striscia bluastra, simile alla riga d'inchiostro con cui l'architetto disegna il suo progetto sul papiro; le case, dai muri leggermente inclinati a scarpa, erano incandescenti come mattoni al forno; le porte erano chiuse e alle finestre, tappate con stuoie di canne intrecciate con la paglia, non si affacciava anima viva.
In fondo alle strade deserte e sulle terrazze, si stagliavano nell'aria di una purezza incandescente, la punta degli obelischi, la cima dei piloni, le trabeazioni dei palazzi e dei templi i cui capitelli a effigie umana o con fiori di loto emergevano a metà, interrompendo le linee orizzontali dei tetti ed ergendosi come scogli nella massa degli edifici privati.
Di quando in quando, oltre il muro di un giardino, qualche palma dardeggiava il fusto a scaglie che finiva con un ventaglio di foglie assolutamente immobili, poiché nessun alito muoveva l'aria; acacie, mimose e fichi del Faraone riversavano una cascata di foglie, macchiando con una sottile ombra blu la luce sfavillante del terreno; quei tocchi verdi animavano e rinfrescavano l'aridità solenne del quadro che, senza di loro, sarebbe parso una città morta.
Qualche sparuto schiavo della razza Nahasi, nero, scimmiesco, divinamente animalesco nell'andatura, sfidando l'ardore del giorno, portava al padrone l'acqua attinta dal Nilo in giare sospese a un bastone appoggiato sulla spalla; benché non avessero per indumento che una sorta di braghette a righe, strette sui fianchi, i torsi lucenti e levigati come basalto grondavano sudore mentre affrettavano il passo per non bruciarsi la pianta ispessita dei piedi sul selciato caldo come il fondo del forno. I marinai dormivano nel naos delle loro cange ormeggiate alla banchina di mattoni del fiume, certi che nessuno li avrebbe svegliati per passare sull'altra riva, nel quartiere dei Memnonia. Altissimi nel cielo volteggiavano i gipeti di cui, nel silenzio generale, si sentiva il pigolio acuto che in un altro momento del giorno si sarebbe perduto nel rumore della città. Sui cornicioni dei monumenti, due o tre ibis, una zampa piegata sotto il corpo, il becco nascosto nel gozzo, sembravano meditare profondamente e disegnavano il loro contorno gracile sul blu calcinato e biancheggiante che serviva loro da sfondo.
Eppure non tutto dormiva a Tebe; dai muri di un grande palazzo la cui trabeazione ornata di palmette tracciava una lunga linea diritta nel cielo infiammato, usciva come un vago mormorio musicale; quelle onde di armonia si spandevano di tanto in tanto attraverso il tremolio diafano dell'atmosfera dove l'occhio avrebbe quasi potuto seguire le ondulazioni sonore.
Soffocata dagli spessi muri come da una sordina, la musica aveva una delicatezza strana; era un canto di una voluttà triste, di un languore estenuato che esprimeva la fatica del corpo e lo scoramento della passione; vi si poteva anche avvertire la noia luminosa dell'eterno azzurro, l'indefinibile prostrazione dei paesi caldi.
© Paolo Melandri (26. 11. 2018)
*
Afrodite 3
Le cortigiane erano in mostra nelle loro “camere esposte” come i fiori in vetrina. I loro atteggiamenti e i loro costumi non erano meno differenti di quello che non fossero la loro età, i loro tipi, le loro razze. Le più belle, secondo la tradizione di Frine, non lasciavano scoperto che l'ovale della loro faccia, si tenevano coperte nei capelli fino ai talloni, nei loro grandi abiti di lana leggera. Altre avevano adottato la moda dei vestiti trasparenti, attraverso i quali misteriosamente si distinguevano le loro bellezze, come attraverso un'acqua limpida si vedono i muschi verdi in macchie nere sul fondo. Coloro che per unico fascino non avevano che la loro giovinezza, restavano nude fino alla cintola, e incurvavano il dorso in avanti per far apprezzare la solidità dei loro seni. Ma le più mature, che sapevano come i tratti del viso femminile invecchino prima della pelle del corpo, stavano sedute interamente nude, sostenendo le mammelle nelle mani e divaricando le loro gambe pesanti come se volessero dimostrare che erano ancora femmine.
Demetrio passò loro davanti lentamente senza stancarsi di ammirare.
Non gli era mai successo di vedere la nudità della donna senza un'intensa commozione; non comprendeva né il disgusto davanti alle giovinezze tramontate, né l'insensibilità davanti a bambine troppo giovani. Purché restasse silenziosa e non dimostrasse più ardore del minimum che esigeva la cortesia del letto, egli le perdonava di non esser bella. Meglio ancora, egli preferiva che ella avesse un corpo grossolano, perché con più il suo pensiero si soffermava su forme perfette, con più il suo desiderio se ne allontanava. Il turbamento che gli cagionava la bellezza vivente era di una sensualità esclusivamente cerebrale, che riduceva a nulla l'attività genetica. Si ricordava con angoscia di esser rimasto un'intera ora, impotente come un vecchio, vicino alla più meravigliosa donna che egli avesse mai tenuta nelle braccia. E da quella notte egli aveva imparato a scegliere amanti di una bellezza meno pura.
– Amico – disse una voce – non mi riconosci più?
Si volse, fece segno di no e continuò la sua strada, poiché egli non spogliava mai due volte la stessa donna. Era l'unico principio che seguisse durante le sue visite ai giardini. Una donna che non si è ancora posseduta, ha qualche cosa di una vergine; ma qual buon risultato, quale sorpresa aspettarsi da un secondo incontro? È quasi un matrimonio.
Demetrio non si esponeva alle delusioni della seconda notte. La regina Berenice bastava alle rare sue velleità coniugali, e al di fuori di lei, egli aveva cura di rinnovare ogni sera la complice dell'indispensabile adulterio.
– Clonarietta!
– Gnatena!
– Plango!
– Mnaide!
– Crobila!
– Ioessa!
Gridavano i loro nomi al suo passare e qualcuna vi aggiungeva l'affermazione della propria natura ardente o l'offerta di una pratica anormale. Demetrio continuava la strada: si disponeva, secondo la sua abitudine, a prendere a caso nel gregge, quando una bambina vestita di azzurro inclinò la testa sulla spalla e gli disse dolcemente senza alzarsi:
– Non c'è proprio verso?
Questa formula imprevista lo fece sorridere. Si fermò.
– Aprimi la porta – disse. – Voglio te.
La piccola, con un movimento allegro, balzò in piedi e batté due colpi col martello fallico. Venne ad aprire una piccola schiava.
– Gorgo – disse la piccina – ho qualcuno; presto, del vino di Creta, dei dolci e fa il letto.
Ella si volse verso Demetrio.
– Hai bisogno del satiron?
No – disse il giovane ridendo. – Ne hai?
– Bisogna pur che ne abbia – fece la bambina; – me lo domandano molto più spesso che tu non creda. Vieni da questa parte, sta attento agli scalini, ce n'è uno rotto. Entra in camera mia; ritorno subito.
La camera era molto semplice come quelle delle cortigiane novizie. Un grande letto, un secondo letto di riposo, qualche seggiola e qualche tappeto la ammobiliavano scarsamente, ma da una apertura si vedeva il mare, la duplice rada di Alessandria.
Demetrio rimase in piedi a guardare la città lontana.
Soli cadenti dietro ai porti! incomparabili glorie di città marinare, calma del cielo, porpora delle acque, su quale anima ardente di dolore o di gioia, non sapeste gettare il silenzio? Quali passi non si sono arrestati, quale voluttà non si è sospesa, quale voce non si è spenta a voi davanti?… Demetrio guardava: un'ondata di fiamma torrenziale sembrava uscire dal cielo a metà tuffato nel mare, e direttamente incurvarsi fino all'altra riva del bosco di Afrodite. Dall'uno all'altro dei due orizzonti, la sontuosa gamma della porpora invadeva il Mediterraneo. Tra questo splendore semovente e lo specchio torboso del lago Mareotide, la massa bianca della città era tutta rivestita di riflessi paonazzi. Le diverse orientazioni delle sue ventimila case basse si macchiettavano di mille zone di colore, in perpetua metamorfosi, a seconda delle fasi decrescenti dell'irraggiamento occidentale.
Tutto ciò fu rapido come l'incendio: poi il sole affondò quasi improvvisamente e il primo riflusso della notte fece ondeggiare su tutta la terra un brivido, una brezza vellutata uniforme e trasparente.
– Ecco fichi, dolci, un favo di miele, del vino, una donna. Bisogna godere i fichi mentre c'è luce, la donna quando non ci si vede più!
La piccina rientrava ridendo: ella fece sedere il giovane, si mise a cavalcioni sulle sue ginocchia e con le sue mani dietro la testa, assicurò nei capelli castani una rosa che stava per cadere.
Demetrio ebbe, suo malgrado, una esclamazione di sorpresa. Lei era interamente nuda, e così spogliato dalla sua veste a sbuffi, il suo corpicino appariva così giovane, con un seno così infantile, con anche così strette, così visibilmente impubere, che Demetrio si sentì come invaso di pietà, come un cavaliere sul punto di far sopportare tutto il suo peso a una puledra così gracile.
– Ma tu non sei una donna! – esclamò.
– Non sono una donna? Per le due dee, che cosa sono dunque io? Un Trace, un facchino, un vecchio filosofo?
– Che età hai?
– Dieci anni e mezzo. Undici anni: si può dire undici anni. Sono nata nei giardini; ma mia madre è di Mileto; è Pizia, detta la Capra. Vuoi che te la mandi a chiamare, se mi trovi troppo piccina? Ha la pelle morbida, la mamma, è bella.
– Sei stata al Didascalion?
– Ci sono ancora, al sesto corso. Fra un anno avrò finito: prima no, purtroppo.
– Ti ci annoi?
– Se sapessi quanto sono esigenti le maestre! La stessa lezione la fanno ricominciare venticinque volte: cose inutili, che gli uomini non domandano mai. Ci fanno stancare per nulla: a me tutto ciò non piace. To', prendi un fico; no questo, non è maturo. Ti insegnerò una nuova maniera di mangiarli: guarda.
– La conosco: è la più lunga e non è la migliore. Mi pare che tu sia una brava allieva.
– Oh! ciò che so, l'ho imparato da sola. Le maestre vorrebbero far credere che sono più abili di noi: hanno più pratica, questo è vero, ma non hanno inventato nulla.
– Hai molti amanti?
– Tutti troppo vecchi: è inevitabile! I giovani sono così stupidi: non vanno che dalle donne di quarant'anni. Certe volte ne vedo passar di quelli che sono belli come amori, e se tu vedessi chi scelgono! C'è da impallidire. Spero di non vivere fino all'età di quelle donne: avrei troppa vergogna a spogliarmi. Se tu sapessi come sono contenta di essere ancora così giovane! I seni spuntano anche troppo presto: mi pare che il primo mese in cui vedrò colare il mio sangue mi crederò vicina alla morte. Lasciati dare un bacio: mi piaci.
La conversazione prese qui un andamento meno grave e più silenzioso: Demetrio si accorse ben presto che non era il caso di far lo scrupoloso con una donnina così esperta. Pareva che lei si rendesse conto di essere un pascolo un po' magro per un giovanotto e sconcertava il suo amante con una prodigiosa attività di contatti furtivi, che egli non poteva né prevedere, né permettere, né dirigere, e che mai gli lasciavano il riposo di una stretta amorosa. Il piccolo corpo agile e sodo si moltiplicava attorno a lui, si offriva e si ricusava, scivolava, girava, lottava. Finalmente si presero. Ma quella mezz'ora non fu che un lungo gioco.
Lei scese dal letto per prima, intinse il dito nella coppa di miele, se ne imbrattò le labbra; poi con mille sforzi per non ridere, si chinò su Demetrio fregando la bocca sulla sua. I suoi riccioli rotondi danzavano da ogni parte sulle sue guance.
Sorrise il giovane, alzandosi sui gomiti.
– Come ti chiami? – disse.
– Melitta. Non hai visto il mio nome sulla porta?
– Non avevo guardato.
– Potevi vederlo nella camera. Me l'han tutti scritto sui muri e fra poco sarò obbligata a farli ridipingere.
Demetrio sollevò il capo; le quattro pareti della camera erano coperte di iscrizioni.
– Toh, è curiosa! – disse. – Si può leggere?
– Certo, se vuoi. Non ho segreti.
Lesse: trovò parecchie volte ripetuto il nome di Melitta, accompagnato con nomi di uomini e barbari disegni. Frasi tenere, oscene e comiche si incrociavano bizzarramente. Erano amanti che vantavano il loro vigore o enumeravano i fascini della piccola cortigiana o burlavano le sue buone colleghe. Tutto ciò non aveva interesse, se non come testimonianza scritta della generale abiezione.
Ma verso la fine della parete destra Demetrio sussultò:
– Che è questo? che è? Dimmi!
– Ma chi? che cosa? dove?… – disse la bambina – che hai?
– Qui. Questo nome, chi l'ha scritto?
Il suo dito si fermò su questa duplice linea: Melitta a Criside – Criside a Melitta.
– Ah! – rispose lei. – Sono io. L'ho scritto io.
– Ma chi è questa Criside?
– È una mia grande amica.
– Comprendo, ma non ti domando questo. Quale Criside? Ce ne sono molte.
– Ma la mia è la più bella: Criside di Galilea.
– La conosci? Tu la conosci? Ma parlamene dunque! Da dove viene? Dove abita? Chi è il suo amante? Dimmi tutto!
Si sedette sul letto da riposo e si prese la piccina sulle ginocchia.
– Sei innamorato, allora! – disse lei.
– Non ti riguarda. Raccontami ciò che sai; ho fretta di saper tutto.
– Oh! ma io non so nulla affatto. È subito detto: è venuta due volte da me, e capirai bene che non le ho chiesto informazioni sulla sua famiglia. Ero troppo felice di averla e non ho perduto tempo in conversazioni.
– Come è fatta?
– È fatta come una bella ragazza, che vuoi che ti dica? Devo enumerarti tutte le parti del suo corpo, aggiungendo che è tutto bello? E poi, lei è una donna, una vera donna… quando penso a lei mi viene subito desiderio di qualcuno.
Si gettò al collo di Demetrio.
– Tu non sai nulla – riprese lui – nulla sul suo conto?
– So… so che viene dalla Galilea, che ha quasi vent'anni, che abita nel quartiere degli Ebrei, a oriente della città, vicino ai giardini: ecco tutto.
– E della sua vita? dei suoi gusti? non puoi dirmi nulla? Se viene da te, vuol dire che le piacciono le donne, ma è soltanto lesbica?
– No, certamente. La prima notte che passò qui portò un amante e ti giuro che non simulava nulla. Quando una donna è sincera lo vedo dai suoi occhi. Ciò non impedisce che una volta sia venuta affatto sola… E mi ha promesso una terza notte.
– Non ha altre amiche, che tu sappia, nei giardini? Nessuna?
– Sì, una donna del suo paese, Chimairide, una povera.
– Dove abita? Bisogna che io la veda.
– Dorme nel bosco da un anno, ha venduto la sua casa. Ma conosco il suo buco. Se lo desideri posso condurti. Vuoi mettermi i sandali?
Demetrio con mano rapida allacciò i sandali sulle gracili caviglie di Melitta i cordoni di cuoio intrecciato; le porse la corta veste che ella prese semplicemente sul braccio, e uscirono in fretta.
Camminarono a lungo. Il parco era immenso. Di tratto in tratto, di sotto un albero, una ragazza diceva il suo nome aprendo la veste, poi si ricoricava con il viso tra le mani. Melitta ne conosceva qualcuna, che senza fermarla la baciava. Passando davanti a un logoro altare, ella colse tre grandi fiori e li depose sulla pietra.
La notte non era ancora nera. La luce intensa dei giorni estivi ha qualche cosa di durevole che vagamente si attarda nei lenti crepuscoli. Le stelle deboli e umide, appena più chiare del fondo del cielo, occhieggiavano con palpito dolce e le ombre dei rami restavano indecise.
© Paolo Melandri (25. 11. 2018)
*
Bolivia
Jaime Torrijos era un tenente del reggimento di cavalleria di Agreda, di stanza, in quel periodo, a Cochabamba. Era amato e ammirato da ufficiali e soldati, giacché tutto il suo corpo esprimeva un vigore e un'audacia straordinari. Per lo stesso motivo le donne lo amavano.
Quando lo conobbi la sua fama cominciava a diffondersi fuori dal reggimento e dalla città. E spensieratamente ne godeva. Suonavo la chitarra e mi legai a Jaime che mi voleva compagno delle sue orge. Era sempre privo di denaro a causa delle carte e dell'amore.
Ero chitarrista, ma ero stato anche seminarista; quando non strimpellavo la chitarra, leggevo libri di teologia. Osservavo uomini e donne di ogni tipo e mi rendevo conto di quanto fosse facile dominarli. Il potere che il corpo fiero di Jaime esercitava sugli uomini e sulle donne, immediatamente mi affascinò. Io che disprezzavo ogni forma di potere, mi chiedevo incuriosito come fosse possibile sfruttare quel dono anche al di fuori del suo ambito specifico. La chitarra, è vero, bastava a rendermi la vita incantevole, ma provavo il desiderio di introdurre forme rischiose nel cerchio intimo del mio essere.
Durante le orge, guardavo Jaime e improvvisavo canzoni che lodavano il suo coraggio e quello dei cavalleggeri di Agreda. Tutti le apprezzavano e si gonfiavano di orgoglio.
A quei tempi il Protettore dello Stato era Benito Ramirez, un uomo quanto mai energico e astuto, ma il suo potere era durato abbastanza, e amici e nemici se n'erano stancati.
Nelle mie canzoni cominciai a insinuare il disprezzo per il Protettore e a minacciarlo della disistima dei cavalleggeri di Agreda. Dapprima scherzavo soltanto, ma Jaime, che si annoiava e aveva bisogno di nuove avventure – da me aveva imparato chi egli fosse realmente – cominciò a decifrare il segreto significato delle canzoni.
Ubriaco, una sera esclamò:
«Benito Ramirez resta al potere soltanto perché sono io a volerlo.» Il giorno seguente mi recai a trovarlo nella camera di una donna e chiesi una spiegazione delle sue parole. Non se ne ricordava, ma ben presto ammise non solo di aver detto quelle cose, ma di conoscere anche l'idea che c'era dietro.
In quel periodo conobbe Conception. Conception era la più bella puttana della Bolivia e, quando giunse a Cochabamba, Jaime non ebbe occhi per lei. Nella capitale lei aveva avuto un gran numero di amanti distinti e disprezzava quel tenentino.
Lui non si sentiva così sicuro con lei come con le altre e richiese, con una certa umiltà, i favori del suo letto. Vi andò soltanto perché era forte e Conception non poteva negarsi a nessuno che fosse forte e, inoltre, nessuno del reggimento di Agreda avrebbe osato mettersi nel mezzo.
Lei si compiacque di quella forza.
Anch'io, come tutti, ero rimasto turbato dalla bellezza di Conception e, per un certo periodo, le sole canzoni che composi erano per lodare lo splendore dei suoi seni e dei suoi fianchi e per prometterli a Jaime. In seguito cantai l'imeneo, finché la tristezza non mi vinse e mi ributtai nella teologia.
Qualche tempo dopo, don Benito Ramirez, che da La Paz andava a Santa Cruz, si fermò a Cochabamba. Il reggimento di Agreda rese gli onori militari nella pianura antistante le porte della città, dando prova di un'innegabile bravura. Ero andato anch'io, a dorso di una mula, a godermi lo spettacolo, perché, nonostante la mia debole costituzione, mi piaceva la bellezza degli uomini e dei cavalli e il sobbalzare vigoroso dei loro pettorali liberava le note della chitarra quanto la vista dei seni delle belle donne e le incredibili idee dei teologi.
Ramirez si reggeva a stento in sella; era un uomo piccolo e curvo che si trascinava dietro la propria autorità con aria afflitta. Dopo le manovre si fermò davanti al reggimento schierato a battaglia e, da lontano, immaginai come muovesse lo sguardo profondo su quegli uomini di cui le spie gli avevano rivelato gli umori recenti. Un tempo era stato il reggimento di Agreda ad appoggiare il suo colpo di Stato.
Rapidamente smontò di cavallo e si sedette stancamente sotto un albero. Mi avvicinai e vidi il colonnello del reggimento che, venuto a mettersi a sua disposizione, si voltava e chiamava Jaime. Provai una certa emozione.
«Tenente Torrijos, mi si dice che non vi piaccio affatto», disse il Protettore con voce maschia e calma, sorprendente in una bocca tormentata dal dubbio. «Forse non ho fatto il mio dovere non scoprendo prima i vostri meriti. Vi nomino capitano dei dragoni a La Paz.»
Jaime parve dapprima sconcertato, ma, senza smettere di frugare negli occhi del Protettore, esclamò:
«Eccellenza, vi ringrazio per la nomina a capitano, ma vi prego di non concedermi promozioni se questo comporta il mio allontanamento dal reggimento di Agreda.
– Capitano, è un ordine. Potete ritirarvi.»
Ammirai con quale eleganza la bella voce del Protettore si librasse nell'aria. Sembrava la voce di un uomo grande e serenamente forte. Ero affascinato da quella voce e, quella sera, al club degli ufficiali, improvvisai una canzone accompagnandomi con la chitarra. Cantavo la tristezza di chi può solo dominare gli altri per placare la propria frenesia di disprezzo e si stupisce poi dell'odio che pure continua a ferirlo.
Jaime era di cattivo umore e beveva moltissimo; accanto a lui Conception lo osservava con ironica curiosità.
«Capitano», gridò, «finalmente conoscerai le belle donne di La Paz.»
Non provava più alcun piacere per il potere che esercitava sulle altre donne, da quando aveva capito che Conception gli resisteva. Si rendeva perfettamente conto che a La Paz sarebbe stato circondato da spie e certamente destinato a qualche attentato.
Gli ufficiali erano molto inquieti dopo aver appreso che il loro preferito se ne sarebbe andato e parlavano niente di meno che di marciare su La Paz durante l'assenza di Ramirez.
Allora, all'improvviso, cominciai un'altra canzone. Le prime parole stupirono i presenti.
Cantavano la forza e la gloria di Ramirez e la sua giustizia, perché aveva riconosciuto nel suo esercito il suo più grande capitano e aveva voluto mostrarlo come esempio a tutti i cavalleggeri. Agreda non avrebbe dimenticato Jaime Torrijos e presto i dragoni avrebbero amato Torrijos come l'aveva amato Agreda.
Chi mi ascoltava rimase sconcertato, ma poi finì col capire quello che intendevo dire e con l'ultima nota si scatenò il baccano degli applausi e delle risate.
Qualche giorno dopo il capitano raggiunse il nuovo posto ed io, alle calcagna, entrai a La Paz con Conception, che chiamavamo di preferenza Conchita, e con la vecchia mezzana che, secondo l'uso, amministrava i suoi disordini.
2.
Ed ora Jaime Torriijos era costretto a complottare contro Ramirez: questione di vita o di morte. Avevo molto fantasticato, spingendo avanti la mia mula, su quell'istinto che spinge gli uomini a forzare il proprio destino e sulle oscure complicità che si creano tra i nemici; senza l'appassionata attenzione dimostrata da Ramirez, forse Jaime sarebbe rimasto un semplice tenente a Cochabamba.
Era rimasto molto sorpreso per l'onore che gli era toccato. Pur ignorando la paura, provava un profondo senso di smarrimento perché non sapeva come trarre profitto da quella situazione.
Io ero un musicista e non mi facevo più scrupoli nel procurargli uomini e donne, quantunque fossi disposto a cantare gli uni e le altre quando, uomini e donne, si avvicinavano all'oggetto del mio desiderio. Tuttavia, tra due sogni che di notte uscivano senza sosta dalla mia chitarra, mi venne in mente un'idea.
In seminario avevo conosciuto uno strano tipo che era nato per recitare la parte, come diremmo noi, dell'eminenza grigia. Era professore di teologia, ma si occupava di tutt'altro.
Andai a trovarlo nella sua cella sempre piena di pretini bisbiglianti e sogghignanti, nel cui servilismo egli frugava con un'ironia diabolica che mandava tutti in visibilio. Si serviva dei più raffinati cavilli della scolastica con una voce che di quando in quando sarebbe apparsa falsa a chi avesse saputo ascoltarla. Eppure era un ex-ufficiale che aveva preso gli ordini abbastanza tardi.
Guidai le nostre chiacchiere verso il problema isolato di Ramirez e lessi nei grandi occhi di padre Florida, in quegli occhi tenebrosi, colmi di sottigliezze imprevedibili e brucianti come ferri divenuti incandescenti sotto i carboni, che qualche tutore dell'ordine gli aveva già detto dei miei rapporti con Jaime.
“Certo, don Ramirez entra nell'età ingrata”, bofonchiò, fissando il taglio rossiccio di un grosso in-folio, ma un istante prima il suo sguardo mi aveva percorso il viso come una carezza acuminata.
“Insomma, padre, chi verrà in aiuto dello Stato?”
Udito questo, mi trascinò su di un terrazzino pieno di fiori, che nella sua vita contrastava deliziosamente con una camera nuda, ornata solo delle smorfie che egli sapeva cavar fuori da quanti gli facevano visita.
“Il colonnello dei dragoni è dominato da un unico vizio. Quest'uomo che non beve, non mangia, non fuma, vive per il suo reggimento ma, ahimè, la sua sollecitudine si estende fino alle mogli dei suoi ufficiali.”
Padre Florida mi fornì questa informazione di soppiatto, con la sua voce dal tono alto e cantilenante, mentre mangiava con gli occhi un grosso fiore rosso e offriva al mio sguardo un profilo spossato e distratto. Ero così immerso nella contemplazione di quel profilo infido che si sentì in dovere di aggiungere:
“E delle loro amanti.”
Né il colonnello dei dragoni né Conchita ebbero bisogno di grandi incitamenti per incontrarsi. Lui era stato rapidamente informato della bella preda che era a portata di mano e lei non perse questa prima occasione per tradire Jaime, il che non le era stato facile a Cochabamba, almeno con qualcuno che ne lusingasse la volgare vanità.
Tuttavia, la ragazza non pensava minimamente a lasciare il nostro capitano. Correva voce che sarebbe divenuto padrone della Bolivia. Lei non ci credeva affatto, perché la sua prima impressione era stata di aver avuto a che fare con un tenentino da niente, ma il dubbio, oltre che la prestanza del maschio, la tratteneva accanto a lui.
© Paolo Melandri (22. 11. 2018)
*
Afrodite 2
Il tempio di Afrodite-Astarte si innalzava fuori dalle porte della città, in un parco immenso pieno di fiori e di ombre, dove l'acqua del Nilo, trasportata da sette acquedotti, manteneva in qualsiasi stagione prodigiose verzure.
Questa foresta, fiorita sulle rive del mare, questi ruscelli, questi laghi, questi prati cupi, erano stati creati in mezzo al deserto, due secoli prima, dal primo dei Tolomei. Da allora, i sicomori piantati per ordine suo erano diventati giganteschi: beneficati dalle acque feconde le aiuole erano diventate praterie, i bacini s'erano allargati in laghi, la natura, di un parco, aveva fatto una contrada.
I giardini erano più che una valle, più che un paese, più che una patria: erano un mondo compiuto, chiuso da limiti di pietra, retto da una dea, che era anima e centro di questo universo. Tutto intorno si elevava una terrazza in forma anulare, lunga ottanta stadi e altra trentadue piedi. Non era un muro, era una colossale cinta, fatta di millequattrocento case. Un ugual numero di prostitute abitava questa città santa e riassumeva in questo unico luogo settanta popoli diversi.
Il piano delle case sacre era uniforme: la porta di rame rosso (metallo sacro alla dea) portava un fallo in guisa di martello, che picchiava su un controbattente fatto a immagine del sesso femminile; e al di sopra era inciso il nome della cortigiana con le iniziali della formula liturgica usuale.
Da ogni lato della porta si aprivano due camere in forma di bottega, cioè senza muro dalla parte del giardino. Quella di destra, detta “camera esposta” era il luogo dove la cortigiana abbigliata sedeva sopra un'alta cattedra, nell'ora in cui arrivavano gli uomini. Quella di sinistra era a disposizione degli amanti che desideravano passar la notte all'aria aperta, senza però coricarsi sull'erba.
Oltrepassata la porta un corridoio dava accesso ad una vasta corte lastricata di marmo, occupata nel centro da una vasca di forma ovale. Un peristilio circondava d'ombra questa grande zona di luce e proteggeva, con un'oasi di freschezza, l'entrata delle sette camere della casa. Nel fondo si innalzava l'altare che era di granito rosa.
Tutte le donne avevano apportato dal loro paese un idolo della dea e lo tenevano sull'altare domestico, adorandolo nella loro lingua, senza mai comprendersi tra di loro.
Lachmi, Aschtoreth, Venere, Ischtar, Freia, Militta, Cipride, tali erano i nomi religiosi della loro Voluttà divinizzata. Qualcuna la venerava sotto una forma simbolica, un ciottolo rosso, una pietra conica, una grande conchiglia spinosa. La maggior parte elevava, sopra uno zoccolo di legno tenero, una statuetta grossolana dalle braccia magre, dai seni pesanti, dai fianchi eccessivi e che accennava con la mano il suo ventre increspato a forma di delta. Deponevano ai suoi piedi un ramo di mirto, seminavano l'altare di foglie di rose e bruciavano un piccolo grano d'incenso per ogni voto esaudito.
L'idolo era il confidente delle loro pene, il testimone dei loro lavori, causa immaginaria di ogni loro piacere. E quando morivano, le seguiva nella fragile bara, come un guardiano nella loro sepoltura.
Le più belle fra queste ragazze venivano dall'Asia. Tutti gli anni, le più belle navi che portavano ad Alessandria i doni dei tributari o degli alleati sbarcavano con le balle e gli otri cento vergini scelte dai preti per il servizio del giardino sacro: erano Misane e Ebree, Frigie e Cretesi, figlie di Ecbàtana e di Babilonia e delle rive del golfo delle Perle, e delle sponde sacre del Gange. Le une erano bianche di pelle, con visi da medaglie e seni inflessibili, le altre, brune come la terra sotto la pioggia, portavano anelli attraverso le narici e scuotevano sulle spalle capigliature corte e fosche.
Ne venivano da più lontano ancora: piccoli esseri fragili e lenti di cui nessuno sapeva la lingua e che rassomigliavano a giovani scimmie divine. I loro occhi si allungavano verso le tempie, i loro capelli neri e diritti erano bizzarramente pettinati. Queste ragazze restavano timide per tutta la vita, come animali sperduti. Conoscevano i movimenti dell'amore, ma rifiutavano il bacio sulla bocca. Le si scorgevano, tra due unioni passeggere, sedute sui loro piccoli piedi a divertirsi puerilmente.
In un prato solitario, le figlie bionde e rosee dei popoli del Nord, vivevano in greggi, coricate sull'erba: erano Sarmate dalla triplice treccia, dalle gambe robuste, dalle spalle quadrate, che con fronde di albero si facevano corone e lottavano a corpo a corpo per divertirsi; Scite camuse, poppute, vellose, che non si accoppiavano se non nella posa delle bestie; Teutoni gigantesche che terrificavano gli Egiziani con i loro capelli pallidi come quelli dei vecchi e le loro carni più molli che quelle dei bambini; Galle rosse come vacche e che ridevano senza motivo; giovani Celte dagli occhi color verde-marino e che non uscivano mai ignude.
Altrove le Iberiche dai bruni seni si riunivano durante il giorno: avevano capigliature pesanti che pettinavano con ricercatezza e ventri nervosi che non depilavano mai. La loro pelle soda e il loro dorso vigoroso piaceva agli Alessandrini.
Le prendevano per danzatrici e per amanti con la stessa frequenza.
Sotto l'ombra larga delle palme abitavano le figlie dell'Africa: le Nubiane velate di bianco, le Cartaginesi vestite di garze nere, le Nere avvolte in costumi multicolori.
Erano millequattrocento.
Quando una donna entrava là, non ne usciva più, se non al primo giorno della sua vecchiaia. Davano al tempio la metà del loro guadagno e il resto doveva bastar loro per i pasti e i profumi. Non erano schiave, ed ognuna di loro possedeva veramente una delle case della Terrazza, ma non erano tutte ugualmente amate e le più fortunate, sovente, compravano delle case vicine, che le rispettive abitanti vendevano per non dimagrire di fame. Costoro trasportavano allora la loro statuina oscena nel parco e cercavano un altare costruito con una pietra levigata, in un angolo che non abbandonavano più. I mercanti poveri lo sapevano e di preferenza si rivolgevano alle fanciulle che dormivano così sul muschio, all'aria libera, vicino al loro santuario; ma qualche volta non si presentavano neppure questi, e allora le povere ragazze riunivano a due a due le loro miserie in appassionate amicizie, che diventavano amori quasi coniugali, famiglie ove ogni cosa veniva divisa, persino il lembo di lana, e nelle quali gli alternativi favori consolavano le lunghe castità.
Coloro che non contavano amiche si offrivano come schiave volontarie alle loro compagne più ricercate. Era proibito a costoro di avere più di dodici di queste disgraziate al loro servizio; ben venticinque cortigiane avevano raggiunto questo massimo e fra tutte le razze avevano scelto una servitù variopinta.
Se per caso concepivano un figlio, era allevato nella cinta del tempio per la contemplazione della forma perfetta, e al servizio della sua divinità: se partorivano una figlia, la bambina nasceva per la dea.
Il giorno stesso della sua nascita si celebravano le nozze con il figlio di Dioniso, e lo Ierofante la deflorava lui stesso con un coltellino d'oro, poiché la verginità spiace ad Afrodite.
Dopo ella entrava al Didascalion, grande e splendido monumento che serviva da scuola, situato dentro il tempio e dove le bambine in sette classi imparavano la teoria e il metodo di tutte le arti erotiche: lo sguardo, la stretta, i movimenti del corpo, le complicazioni della carezza, i segreti della morsicatura, del glottismo e del bacio. L'allieva liberamente sceglieva il giorno della sua prima esperienza, essendo il desiderio un ordine della dea, che non bisognava contrariare; le si dava in quel giorno una delle case della Terrazza; e alcune di queste fanciulle, che qualche volta non erano neppure puberi, erano tra le più infaticabili e spesso tra le più richieste.
La parte interna del Didascalion, le sette classi, il piccolo teatro e il peristilio della corte erano ornati da novantadue affreschi, che riepilogavano gli insegnamenti dell'amore. Era l'opera di tutta quanta una vita umana: Cleocarete d'Alessandria, figlio naturale e discepolo di Apelle, li aveva finiti poco prima di morire.
Recentemente, la regina Berenice, che prendeva vivo interesse alla celebre scuola, e che vi mandava le sue giovani sorelle, aveva ordinato a Demetrio una serie di gruppi marmorei per completare la decorazione; ma uno solo fino allora era stato collocato nella classe infantile.
Alla fine di ogni anno, in presenza di tutte le cortigiane riunite, aveva luogo un gran concorso, che faceva nascere in questa folla femminile una eccitazione straordinaria, poiché i dodici premi assegnati conferivano il diritto alla suprema gloria che potessero sognare: l'entrata al Coditteion.
Questo ultimo monumento era circondato da tanto mistero, che non se ne può dare una descrizione particolareggiata. Sappiamo soltanto che era compreso nel peribolo, che aveva forma triangolare la cui base era un tempio alla dea Coditto, in nome della quale si compivano spaventose orge sconosciute. I due altri lati del monumento si componevano di diciotto case; vi abitavano trentasei cortigiane, così ricercate dai ricchi amatori, che non si concedevano per meno di due mine; erano le Bapti di Alessandria. Una volta al mese, durante il plenilunio, si riunivano nella cinta chiusa del tempio, rese folli da bevande afrodisiache e cinte di falli rituali. La più vecchia delle trentasei doveva prendere una dose mortale del terribile filtro erotogeno. La certezza di una subita morte le faceva tentare senza timore tutte le voluttà pericolose che spaventavano i vivi.
Il suo corpo, spumante in ogni parte, diventava il modello e il centro della vorticosa orgia; fra le lunghe urla, grida, lacrime e danze le altre donne nude la stingevano, bagnavano i loro capelli al suo sudore, si fregavano alla sua pelle ardente e attingevano nuovi ardori nello spasimo ininterrotto di questa furiosa agonia.
Vivevano così tre anni, alla fine del trentaseiesimo mese era questa l'ebbrezza della loro morte.
Altri santuari meno venerati erano innalzati alle donne, in onore degli altri nomi della multiforme Afrodite. C'era persino un altare consacrato a Urania che riceveva i casti voti delle cortigiane sentimentali; un altro ad Apostrofia che faceva dimenticare gli infelici amori; un altro a Crisea che attirava gli amanti ricchi, un altro a Coliade che approvava le più basse passioni, poiché tutto ciò che aveva attinenza con l'amore, per la dea era pietà. Ma gli altari particolari non avevano efficacia e virtù che per i piccoli desideri. Erano serviti di giorno in giorno, i loro favori erano quotidiani e familiare il loro commercio. Le supplici esaudite deponevano al di sopra di essi semplici fiori; coloro che non erano contente li lordavano con i loro escrementi. Non erano né consacrati né mantenuti dagli altri preti e di conseguenza la loro profanazione non era peccaminosa.
La disciplina del tempio era ben differente. Il Tempio, il Gran Tempio e la Grande Dea, il luogo più sacro di tutto quanto l'Egitto, l'inviolabile Astarteion, era un colossale edificio lungo trecentotrentasei piedi, innalzato di diciassette scalini al di sopra dei giardini. Le sue porte d'oro erano vigilate da dodici ieroduli ermafroditi, simboli dei due oggetti dell'amore e delle dodici ore notturne.
L'entrata non era rivolta verso oriente, ma nella direzione del Faro, cioè verso nord-ovest; mai i raggi del sole penetravano direttamente nel santuario della grande Immortale notturna. Ottantasei colonne sostenevano l'architrave, fino a metà erano tinte di porpora, e tutta la parte superiore si librava da queste rosse vestimenta con una ineffabile bianchezza, come dei tronchi di femmina eretti.
Tra l'epistilio e la coronide, il lungo zooforo snodava in cerchio la sua bestiale ornamentazione, erotica e favolosa; vi si scorgevano centauresse coperte da stalloni, capre assoggettate da magri satiri; vergini macchiate da tori mostruosi, naiadi possedute da cervi, baccanti amate da tigri, leonesse afferrate da grifoni. La grande moltitudine degli esseri si svolgeva così, sollevata dall'irresistibile passione divina. Il maschio si tendeva, la femmina si apriva, e nella fusione delle sorgenti creatrici si risvegliava il primo fremito di vita. La folla delle coppie oscure si apriva a caso, qualche volta, attorno a una scena immortale: Europa inclinata sopportante il bell'animale olimpico; Leda che guidava il robusto cigno fra le sue giovani gambe incurvate. Più lungi l'insaziabile Sirena sfiniva Glauco spirante; il dio Pan in piedi possedeva un'amadriade scapigliata; la Sfinge levava la sua groppa al livello del cavallo Pegaso e all'estremità del gran fregio lo scultore si era effigiato lui stesso in cospetto della dea Afrodite, modellando vicino a lei nella molle creta una vulva perfetta, come se ogni suo ideale di bellezza e di gioia e di virtù si fosse raccolto da gran tempo in quel fiore fragile e prezioso.
© Paolo Melandri (18. 11. 2018)
*
Afrodite
Bocconi con i gomiti in avanti, le gambe aperte e la guancia sulla mano, ella trapungeva con piccoli fori simmetrici un guanciale di lino verde, con una lunga spilla d'oro.
Da che si era svegliata, due ore dopo il mezzogiorno e tutta stanca per aver troppo dormito, era rimasta sola sul letto in disordine, coperta soltanto da una parte da una vasta ondata di capelli.
Questa capigliatura era rifluente e profonda, soave come una pelliccia, più lunga di un'ala, morbida, folta, animata, piena di calore; copriva metà del dorso, dilagava sotto il ventre nudo, brillava ancora vicino al ginocchio in anelli spessi e rotondi. La giovane donna era avvolta in questo velo prezioso, i cui riflessi erano quasi metallici e l'avevano fatta chiamare Criside dalle cortigiane di Alessandria. Non erano i capelli lisci delle Siriache della corte, né i capelli tinti delle Asiatiche, né i capelli bruni e neri delle figlie d'Egitto. Erano quelli delle figlie di Efeso e di Cesarea, delle Galilee, al di là delle sabbie.
Criside: questo nome le piaceva. I giovani che venivano a vederla la chiamavano aurea come Afrodite, nei versi che scrivevano sulla sua porta, con ghirlande di rose, il mattino. Ella non credeva ad Afrodite, ma le piaceva che la si comparasse alla dea; e qualche volta andava al tempio per portarle, come ad un'amica, scatole di profumi e veli azzurri.
Era nata sulle sponde del lago di Genezareth, in un paese di ombra e di sole, invaso dagli oleandri. Sua madre, alla sera, andava sulla strada di Gerusalemme ad attendere i mercanti, e si dava loro fra le erbe, in mezzo al silenzio campestre. Era una donna molto amata nella Galilea; i preti non abbandonavano la sua porta perché ella era caritatevole e pietosa; gli agnelli e le pecorelle del sacrificio erano sempre pagati da lei; la benedizione dell'Eterno si stendeva sulla sua casa. Orbene, quando divenne incinta, poiché la sua gravidanza era uno scandalo (giacché non aveva marito), un uomo, celebre per avere il dono della profezia, disse che ella avrebbe messo alla luce una figlia che avrebbe portato attorno al suo collo “la ricchezza e la fede di un popolo”. Non comprese bene come ciò sarebbe avvenuto ma chiamò la bambina Sarah, cioè principessa in ebraico; ciò fece tacere le maldicenze.
Criside aveva sempre ignorato ciò perché l'indovino aveva detto a sua madre quanto fosse pericoloso rivelare alle persone le profezie di cui si è l'oggetto. Ella nulla sapeva del suo avvenire, per questo vi pensava di frequente.
Della sua infanzia ricordava poco e non le piaceva parlarne. Il solo sentimento preciso che gliene fosse restato, era lo spavento e la noia che le causavano ogni giorno la sorveglianza ansiosa di sua madre che, venuta l'ora di uscire in strada, la chiudeva sola nella camera per ore interminabili. Ricordava anche la finestra rotonda per dove scorgeva le acque del lago, i campi azzurrognoli, il cielo trasparente, l'aria leggera del paese di Gâlil. La casa era circondata di lini rosei e di tamarindi. Capperi spinosi innalzavano a caso le loro teste verdi sulla nebbia fine delle gramigne.
Le giovinette si bagnavano in un ruscello limpido dove si trovavano conchiglie rosse sotto i ciuffi di oleandri in fiore: c'erano fiori sull'acqua e fiori in tutta la pianura e grandi gigli sulle montagne.
Aveva dodici anni quando scappò per seguire una compagnia di giovani cavalieri che andavano a Tiro come venditori di avorio e che lei fermò davanti a una cisterna: stavano adornando cavalli dalla lunga coda con pennacchi variopinti. Si ricordava bene come essi l'avevano sollevata, pallida di gioia, sulle loro selle, e come si fermarono una seconda volta, durante la notte, una notte così chiara che non si vedeva neppure una stella.
E neppure aveva dimenticato l'entrata a Tiro: in testa, sopra i cesti di un cavallo da soma si teneva col pugno alla criniera, lasciando orgogliosamente spenzolare i suoi polpacci nudi, per mostrare alle donne della città che lungo le gambe ella aveva del sangue. La stessa sera partì per l'Egitto: seguì i venditori d'avorio fino ad Alessandria.
E là, in una piccola casa bianca con terrazzo e colonnine, essi la lasciarono due mesi dopo, con il suo specchio di bronzo, con tappeti, cuscini nuovi, e una bella schiava indiana che sapeva pettinare le cortigiane.
Altri erano venuti alla sera della loro partenza e altri il domani.
Poiché ella abitava il quartiere dell'estremo levante che i giovani greci di Bruchion sdegnavano frequentare, per lungo tempo, come sua madre, non conobbe che viaggiatori e mercanti. Non rivedeva più i suoi amanti passeggeri, sapeva trarre da loro il piacere, ma lasciarli presto prima di amarli. Si erano visti padroni di carovane vendere a vil prezzo le loro mercanzie per rimanere dove era lei, e rovinarsi in qualche notte. Con la fortuna di questi uomini si era comprata gioielli, guanciali, profumi rari, vestiti a fiori, e quattro schiave.
Era arrivata a comprendere molte lingue straniere, e conosceva i racconti di molti paesi.
Gli Assiri le avevano detto gli amori di Douzi e di Ischtar; i Fenici quelli di Aschthoreth e di Adôni; le ragazze greche delle isole le avevano raccontato la leggenda di Iftide insegnandole strane carezze che a tutta prima l'avevano sorpresa, ma in seguito deliziata a tal segno che ella non poteva starne senza un solo giorno. Sapeva anche gli amori di Atalanta e come, sul loro esempio, suonatrici di flauto ancora vergini sfiniscano i più robusti uomini.
Infine la sua schiava indiana pazientemente, in sette anni, le aveva insegnato fino agli ultimi particolari l'arte complessa e voluttuosa delle cortigiane di Palibotra.
Poiché l'amore è un'arte, come la musica, dà emozioni dello stesso ordine, altrettanto delicate, altrettanto vibranti, qualche volta persino più intense, Criside, che ne conosceva i ritmi e tutte le sottigliezze, si stimava, con ragione, artista più grande di Plango stessa, che pure era musicista del tempio.
Sette anni ella visse così, senza sognare una vita più felice, né più intensa della sua. Ma poco prima del suo ventesimo anno, quando da fanciulla divenne donna, e vide sotto i seni la prima piega deliziosa della maturità che sta per nascere, le vennero d'improvviso delle ambizioni.
E una mattina, poiché si risvegliò due ore dopo il mezzogiorno, tutta stanca per aver troppo dormito, si voltò bocconi attraverso il letto, divaricò le gambe, mise la guancia sulla mano e con una lunga spilla d'oro trafisse con piccoli fori simmetrici il suo guanciale di lino verde.
E rifletteva profondamente.
Furono a tutta prima quattro piccoli punti che formavano un quadrato e un punto nel mezzo, poi quattro altri punti per fare un quadrato più grande, poi tentò di fare un cerchio… ma era un po' difficile. Allora ella gettò le punture a caso e cominciò a gridare:
– Djala! Djala!
Djala era la sua schiava indiana che si chiamava Djalantachtchandratchapalâ, ciò che significa: “Mobile come l'immagine della luna sopra l'acqua”. Criside era troppo pigra per dire il nome tutto intero.
La schiava entrò e rimase vicino alla porta, senza chiuderla del tutto.
– Djala, chi è venuto ieri?
– Non lo sai?
– No, non l'ho guardato. Era bello? Credo di aver dormito tutto il tempo, ero stanca, non mi ricordo più nulla. A che ora è partito? Questa mattina per tempo?
– Al levar del sole, ha detto…
– Che cosa ha lasciato? Molto? No, non dirmelo, mi è indifferente. Che cosa ha detto? Nessuno è venuto da me da che se ne è andato? Ritornerà? Dammi i braccialetti.
La schiava portò un cofano, ma Criside non lo guardò punto e innalzando il braccio quanto più poté:
– Ah! Djala! – disse – ah! Djala! vorrei avventure straordinarie.
– Tutto è straordinario – disse Djala – oppure nulla. I giorni si rassomigliano.
– Ma no, in altri tempi non era così. In tutti i paesi del mondo, gli dèi sono discesi sulla terra e hanno amato le donne mortali. Ah! su quali letti bisogna dunque attenderli, in quali foreste bisogna mai cercarli, coloro che sono un po' più degli uomini? Quali preghiere bisogna dire perché vengano coloro che mi insegneranno qualche cosa o che mi faranno dimenticare tutto? E se gli dèi non vogliono più discendere, se sono morti o se sono troppo vecchi, Djala, morirò io così, senza aver veduto un uomo che metta nella mia vita tragici eventi?
Ella si rivoltò sul dorso e torse le dita le une sulle altre.
– Se qualcuno mi adorasse mi pare che avrei tanta gioia a farlo soffrire fino a che morisse. Coloro che vengono da me non sono degni di piangere. E poi, è anche mia colpa: sono io che li chiamo, come mi potrebbero amare?
– Che braccialetto oggi?
– Li metterò tutti. Ma lasciami, non ho bisogno di nessuno. Va' sugli scalini della porta e se viene qualcuno digli che sono col mio amante, uno schiavo nero, che io pago… Va'.
– Non esci?
– Sì, uscirò sola, mi vestirò da sola, non rincaserò. Vattene, vattene.
Lasciò cadere una gamba sul tappeto e si stirò fino ad alzarsi. Djala era uscita dolcemente.
Ella camminò lentissimamente per la camera, con le mani incrociate attorno alla nuca, intenta alla voluttà di applicare sulle lastre i piedi nudi dove il sudore ghiacciava. Poi entrò nel bagno. Guardarsi attraverso l'acqua era per lei una delizia: si vedeva come una grande conchiglia di madreperla aperta sopra una roccia; la sua pelle diventava omogenea e perfetta, le linee delle sue gambe si allungavano in una luce azzurra, tutta la sua figura era più elastica non riconosceva più le sue mani. L'elasticità del suo corpo era tale che ella si sollevava su due dita, si lasciava galleggiare un po' e ricadeva mollemente sul marmo, sotto un risucchio leggero che le urtava il mento. L'acqua le entrava nelle orecchie col solletico di un bacio.
L'ora del bagno era quella in cui Criside cominciava ad adorarsi: tutte le parti del suo corpo diventavano una dopo l'altra oggetto di un'ammirazione tenera e motivo di una carezza. Con i capelli ed i seni, faceva mille giochi deliziosi. Qualche volta anzi, accordava ai suoi perpetui desideri una compiacenza più efficace, e nessun luogo di riposo si offriva così bene alla minuziosa lentezza di questo delicato sollievo.
© Paolo Melandri (14. 11. 2018)
*
Eddo Cromo 2
Verso la fine del giorno la piazza si vuotava lentamente; in lunghe file nere i trafficanti sifilitici e blenorragici tornavano nelle città o nei paesi vicini e la piazza diventava deserta come se delle truppe l'avessero spazzata con scariche ripetute di moschetti. Sul selciato, sola traccia della folla partita, spazzature d'ogni sorta erano sparse; ma ciò che predominava soprattutto erano le bucce d'arance e i mozziconi di sigari schiacciati; su questa desolazione i guerrieri in bronzo dei monumenti continuavano il loro gesto bellicoso, come se fossero stati seguiti da falangi di soldati fanatizzati e visibili per essi soli, i grandi uomini di pietra, i portici di marmo, gli scienziati famosi e calvi, indossanti giacche e pantaloni di pessimo taglio, si chinavano sui loro libri, i loro strumenti e i loro rotoli di bronzo o di marmo. Il sole scendeva all'orizzonte, allungando i suoi raggi sulla grande via provinciale, quella via che collegava la città alle altre città, sue vicine. I pastori, che a quell'ora seguivano quella via, per tornare ai loro casolari, verso ponente, ricevevano in pieno negli occhi tutta quella tardiva ricchezza di luce; ciò impediva loro di vedere i greggi e li irritava enormemente. Allora si arrabbiavano, sgridavano i loro cani che, resi come matti dai rimproveri del padrone, cominciavano a correre ad abbaiare a destra e a sinistra creando così più confusione che altro; per vedere meglio, i pastori, mentre continuavano a bestemmiare, mettevano la mano sinistra sulla fronte a mo' di una visiera e con la destra brandivano il loro lungo e inseparabile vincastro che, visto di profilo, rassomigliava agli elmi dei guerrieri dipinti sopra i vasi greci. I raggi del sole si allungavano ora quasi orizzontalmente sulla strada di cui imporporavano la polvere e l'ombra dei pastori e dei vincastri si allungava essa pure; si allungava smisuratamente, mostruosamente, incredibilmente; traversava le città, le contrade ed i mari; arrivava assai lontano, fino al paese dei Cimmerî, laggiù, ove i venti freddissimi conservavano a lungo la neve sulle montagne; l'ombra dei pastori e dei vincastri toccava ora quei paesi i cui abitanti sono tutto l'anno vestiti con spesse pellicce ed hanno una mitologia erotica e complicata.
Poi il sole spariva completamente dietro la linea delle colline basse, all'orizzonte; allora le ombre salivano nel cielo e si stendevano sulla terra; mentre lassù, a sinistra, nello spazio chiarificato, la falce della luna brillava dura e fredda e i soffi purificatori della notte vicina passavano sulla città dove gli ultimi rumori del lavoro degli uomini si spegnevano lentamente.
Avendo lasciato il lavoro Eddo Cromo si fermò in una valle a breve distanza dalla montagna principale, che stava a levante. Doveva intraprendere da un momento all'altro una lunga ascensione notturna e aveva bisogno di raccogliersi; si sedette quindi sopra una pietra dove mise prima il suo soprabito piegato con cura e si immerse in profonde meditazioni; piano piano, davanti ad ogni ricordo del passato il sipario si alzò. Eddo Cromo si lasciò andare con gioia a questa nostalgia; era una delle sue principali debolezze quella di avere sempre una certa nostalgia del passato, anche di un passato che non aveva nessun motivo di rimpiangere; e per questo gli piaceva dormire nel pomeriggio; diceva che nulla evoca tanto profondamente i ricordi del passato come i momenti che precedono o seguono immediatamente il sonno pomeridiano.
© Paolo Melandri (11. 11. 2018)
*
Eddo Cromo
La cena, nel piccolo giardino dell'albergo tutto sparso di sassolini politi, fu ben triste in mezzo a quei due uomini dalle barbe di satiri, che portavano panciotti di tela bianca, spiegazzati e un po' sudici e ciondoli complicati alla catena dell'orologio. Uno di loro diceva che a volte, di notte, si svegliava avendo fame; pertanto aveva preso l'abitudine di far mettere alla domestica, sul comodino, al momento in cui la sera essa gli preparava il letto, una grande ciotola piena di latte, e, una volta coricato, prima di addormentarsi, afferrava la ciotola, la sollevava come una liberazione e poi la vuotava d'un fiato. L'altro, ancora più bestiale, benché più anziano, raccontava che le notti d'estate, quando la città era quasi deserta (poiché gli abitanti cercavano un rifugio contro la canicola in riva al mare o in campagna) risaliva verso le tre del mattino il viale degli alberi di limone in mezzo a due giovani donne di facili costumi alle quali offriva il braccio.
Mentre ascoltava questi discorsi con orecchio distratto, Eddo Cromo inseguiva un ricordo che non riusciva a precisare nella memoria. Si ricordava vagamente una camera che non aveva finestre dalla parte del mare; dall'unica apertura esposta al nord, ciò che conferiva all'ambiente una luce da studio di pittore, si scorgeva in lontananza una parte di quella lunga montagna di cui l'altra parte scendeva verso il golfo, e più vicino, apparivano alcuni alberi, specialmente pini. I venti violenti che spesso venivano dal mare li avevano piegati in pose estetizzanti di danzatrici eccentriche; ciò contrastava in quel momento in modo assai curioso con la calma assoluta che regnava nell'atmosfera. Nella chiarezza di quella bella giornata d'autunno, i disgraziati pini sembravano condannati al purgatorio di una eterna tempesta; dietro gli alberi, al nord (lato diametralmente opposto al mare) l'orizzonte brillava di una purezza elvetica. Eddo Cromo pensò allora a Basilea, ai ponti sul Reno, che rotola con una violenza di torrente i suoi flutti color smeraldo. Più lontano ancora, montagne eroiche drizzavano le cime incappucciate di neve, tutta brillante al sole. Laggiù si trovavano quelle famose caverne abitate da semidei bellicosi e millantatori fintanto che eran giovani. Più tardi, verso la sera della loro vita, quando si avvicinava il momento di varcare la soglia per entrare nel regno dolcissimo degli Eterni, diventavano sapienti e poeti e allora, con una disinvoltura da pederasti platonici, insegnavano ai loro nipoti l'arte di preparare le medicine macinando le piante amare e di accordare la lira, enorme e pesante come una piccola cattedrale. Benché l'autunno avesse spogliato gli alberi secolari, tutto quel vasto orizzonte rimbombava d'eternità.
Davanti ai santuari, ove sotto le pietre infrangibili, finivano di marcire e di arrugginirsi le sacre armi di Eracle, vegliavano guerrieri barbuti dal profilo purissimo e pieno di bellezza virile. Lungo i muri di mattoni, dal lato ove mai giungevano i raggi del sole, s'arrampicava l'edera e verdeggiava il muschio. Era il tempo in cui Valtadoro, il cuoco, tirava fuori dalle casse i tappeti invernali e ne scuoteva la naftalina di cui erano coperti.
© Paolo Melandri (10. 11. 2018)
*
La parabola del figliuol prodigo
La parabola del figliuol prodigo
Un uomo aveva due figliuoli. I quali si chiamavano Elihu e Carmi; e vivevano entrambi nella casa del padre, levandosi la loro giovinezza eccellente come i cedri presso le soglie scure. E, mentre il maggiore a fianco del padre noverava la sacca del grano, il più giovane insidiava le piccole volpi che guastano le vigne fiorite. E, mentre quegli a fianco del padre noverava le mine prodotte dal traffico, questi spiava le donne mercenarie che riponevano nei vaselli il miele il nardo e il croco accompagnando col riso e col canto il lavoro odorato.
Venivano i debitori del padre portando bati d'olio, cori di frumento, in gran numero; e il giovane Carmi, assiso sulla più alta loggia, dopo aver considerato quella dovizia che si adunava nei granai vasti e nelle cisterne profonde, mirava la potenza del fiume che si spandeva per la valle distribuendo la copia delle acque alle terre felici.
Ed amava il fiume parendogli che secondasse il suo desiderio e gli promettesse paesi più belli; e vedeva nel suo pensiero tutta quella adunazione inerte di beni, fatta viva, propagarsi per quella via liquida fino alle città lontane e convertirsi quivi in ogni sorta di allegrezze.
Allora discendeva nei giardini; e, avendo tessuto ghirlande dei più freschi fiori, andava ad adornarne le cisterne colme e i granai pieni, forse per segno del suo pensiero voluttuoso.
Gli disse un giorno Elihu, il fratello, cogliendolo in quell'atto singolare:
– O Carmi, perché fai tu questo?
E Carmi, che aveva conosciuto la grazia nel linguaggio di taluni mercatanti loquaci, i quali veneravano un dio chiamato Ermes, rispose e disse:
– Perché il frutto non ti faccia dimenticare del fiore, o Elihu. Quando sei nei campi, ricordati dei giardini.
Ed Elihu, adiratosi, disse:
– Tu non altro sai, o Carmi, che oziare per le logge e per i giardini mentre io servo il padre. Io ho vigilato i lavoratori e noverato i bati d'olio e i cori di frumento a uno a uno. Tu hai scelto le rose.
E Carmi, che aveva appreso la grazia da quegli stranieri, disse:
– Perché t'adiri? Non vedi tu come per la mia arte l'abbondanza ti sorrida?
E le porte, robuste e rudi come quelle delle prigioni, inghirlandate, sorridevano tuttavia, parendo da quei cerchi floridi fosse per versarsi la ricchezza raccolta, come dagli occhi si versa l'intima gioia.
Or avvenne che una donna, fuggita da una nave giunta per la via del fiume, riparasse alla casa doviziosa e, avendo ottenuto di rimaner quivi tra le mercenarie addette a conservare il miele e gli unguenti nei vaselli, fosse vista da Carmi nella stanza del soave odore.
Quale è la regina fra le api, tale sembrò ella fra il numero delle lavoratrici. E come le api avevano riempito i favi accompagnando la lor fatica col murmure, or così quelle riempivano i vaselli cantando in coro per non cedere alla voluttà dei profumi ond'elle si sentivano prese come da un lene sonno. E nella pienezza delle voci la straniera operando si muoveva con tal misura che pareva danzasse una danza studiata. E gli occhi di Carmi ne avevano tal diletto che nessuna cosa da quel giorno stimarono più desiderabile; e videro l'immagine delle belle membra nel palpitare delle fonti, nel piegar degli steli, nell'ondeggiare dei velarii.
Ella si chiamava Lyde, nata in un'isola nutrice di colombe. I suoi capelli erano così biondi che Carmi dapprima illuso credette le colasse lungo le gote quel miele stesso di cui ella aveva le dita intrise operando; e le api stesse patirono l'inganno. I suoi occhi erano come l'aria cerulea che tremola di mezzogiorno nella gran calura. Le sue labbra ardevano nel suo respiro come due bacche di mirto in una fiamma tacita.
Una sera ella venne al desiderio di Carmi, presso un roseto intatto. Senza parlare ella aprì la sua tunica; e offrì al giovane le sue mammelle simili a due rose tiepide e pesanti. Ne fu egli ebbro così che credette aver dissipato sul corpo di lei in un'ora sola, come in un festino interminabile, tutte le spezie accumulate per anni nella casa del padre. Udendo contro la sua gota battere il cuore misterioso della fuggitiva, navigò nel suo pensiero per il fiume lusinghevole verso il mare lontano. E a lui, giacente nella stanchezza d'amore come in una dolce morte, riempiva gli orecchi il rombo confuso del mare ch'egli non aveva mai veduto.
L'isola nutrice di colombe gli apparve allora nell'azzurro delle ciglia dilette, gli apparvero quivi le città bianche spase intorno ai golfi lunanti, popolate di musici di fanciulli e di meretrici, ricche di statue d'inni di bei letti di belle vesti di belle tazze, religiose, ospitali, ove gli uomini cinti di ghirlande gioivano di un perpetuo convivio, obbedienti al potere di una dea che Lyde chiamava Afrodite.
Gli disse Lyde:
– O Carmi, non vuoi tu adorare Afrodite? Chi non mirò il suo volto, non conosce la gioia perfetta. Ella alzata sul plinto ride lungi nel tempio aperto su molte colonne ai venti del mare.
Disse Carmi:
– O Lyde, io voglio con te adorare Afrodite e, se mi sia concesso, pur quelle che tu chiami le Cariti dai fusi d'oro, e tutte le cose amabili che allietano il cuore dell'uomo.
Ed egli si levò, e venne al cospetto del padre, e disse:
– Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca.
E il padre, ch'era saggio, non si stupì, né si adirò, ma chiamò il figliuolo primogenito e disse:
– O Elihu, il tuo fratello domanda la sua parte di beni.
Disse Carmi sorridendo:
– O Elihu, io vado a tessere ghirlande in altri giardini. Vuoi tu venire con me?
Disse Elihu:
– Tu hai già la tua compagnia. Io servo il padre.
Disse Carmi:
– Bene ti sia, fratello. Che molti bati di olio entrino nelle tue cisterne e molti cori di frumento nei tuoi granai; e che alcun comandamento del padre non ti sia grave. Io ti porterò dal paese di lungi qualche dono singolare.
E il padre spartì i beni.
© Paolo Melandri (8. 11. 2018)
*
La Porta dei Galli
Voi tutti conoscete la selvaggia tristezza che suscita il rammemorare il tempo felice: esso è irrevocabilmente trascorso, e ne siamo divisi in modo spietato più che da quale si sia lontananza di luoghi. Le immagini risorgono, più ancora allettanti nell'alone del ricordo, e vi ripensiamo come al corpo di una donna amata, che morta riposa nella profonda terra e che simile a un miraggio riappare, circonfusa di spirituale splendore, suscitando in noi un brivido di sgomento. Sempre di nuovo ritroviamo negli affannosi sogni il passato, in ogni suo aspetto, e come ciechi brancoliamo verso di esso. La coppa della vita e dell'amore ci sembra non esser stata colma sino all'orlo, per noi, e nessun rimpianto vale a ridonarci tutto ciò che non abbiamo avuto. Oh, fosse questa tristezza almeno d'insegnamento per ogni nuovo attimo di felicità!
Il ricordo di quegli anni di luce solare e di calmo splendore della luna ne diviene più dolce ancora, se l'orrore li terminò d'improvviso. E ora comprendiamo come già un felice caso per noi uomini sia il proseguire la vita nelle nostre piccole comunità, in una casa dove la pace regni, fra buoni conversari, accolti da un saluto affettuoso a mattina e a sera. Ahi, troppo tardi riconosciamo che la fortuna ci era in tal modo prodiga di doni.
Non altrimenti io rammemoro i tempi, quando vivevamo alla Grande Marina; e solamente il ricordo me ne significa ora la magia. Mi sembrava allora che varie cause di ansia e qualche afflizione oscurassero i nostri giorni, e in primo luogo dover stare in guardia contro il Forestaro. Noi vivevamo perciò secondo un certo rigore e in vesti semplici, seppure nessun voto ci legasse; e due volte per anno tuttavia ci concedevamo una maggiore libertà, una volta in primavera e una volta in autunno.
L'autunno festeggiavamo al modo dei saggi, facendo onore ai preziosi vini che maturano sulle colline della Grande Marina. Quando negli orti, fra le rosse foglie e i grappoli scuri, udivamo i vicendevoli scherzosi richiami dei vendemmiatori, quando nelle piccole città e nei villaggi i torchi cominciavano a gemere e l'odore delle fresche vinacce in fermento aleggiava nei cortili, quasi lieve nebbia soffusa, noi scendevamo a cercare i venditori di vino e i cantinieri e i vignaioli, e bevevamo con loro dal boccale panciuto. Incontravamo sempre quivi altri lieti compagni, perché il paese è ricco e bello, sicché la spensieratezza vi ha luogo e la scherzosità e il buon umore vi hanno il valore della moneta contante.
Così trascorrevamo le sere in liete cene. In queste settimane i guardiani dei vigneti si aggirano mascherati dal primo albeggiare sino alla notte per gli orti e con schioppi e raganelle tengono lontani gli avidi volatili. A notte i guardiani se ne tornano dalla ronda con corone di quaglie, di tordi screziati e di beccafichi, e ben presto la loro preda è servita a tavola in piatti adorni di pampani. E mangiavamo volentieri anche le castagne arrosto e le noci fresche assieme al vino nuovo, e in primo luogo gli squisiti funghi dei quali colà si va in cerca con i cani nei boschi, e il bianco tartufo e il rosso orecchia d'orso.
Sino a quando il vino era dolce ancora e color del miele sedevamo concordi a tavola, fra pacifici conversari, spesso cingendo amichevolmente con il braccio la spalla del vicino. Ma quando il vino principiava a perfezionarsi, separandosi dalla feccia, si risvegliavano argutamente gli spiriti vitali; e avvenivano quindi magnifici duelli, che le risate decidevano, e nei quali gli schermitori si distinguevano per il libero e agile svolgersi del pensiero, come solamente può acquistarsi in una lunga vita, ricca di studioso ozio.
Ma più altamente che non queste ore di umore giocoso e che trascorrevano lievi, noi avevamo in pregio il quieto ritorno verso casa, camminando, un poco ebbri ancora, fra campi e giardini, mentre già la rugiada mattutina stillava dalle foglie colorite dall'autunno. Quando avevamo passata la Porta dei Galli della piccola città, vedevamo luccicare la spiaggia alla nostra destra, e alla nostra sinistra le Scogliere di Marmo s'innalzavano risplendendo alla luce lunare. Tra le montagne e il mare si adagiavano le colline coltivate a vigne, e per quei pendii si perdeva il sentiero.
© Paolo Melandri (8. 11. 2018)
*
Emy
Emy, la tedesca
Bionda, evanescente come un fantasma, Emy – o Emmy – è al centro della vita del Vittoriale. Si è sempre creduto che a presentarle d'Annunzio, all'inizio del 1932, sia stato l'orafo Quintarelli, mentre da una lettera negli Archivi risulta che l'iniziativa fu di Maria, la principessa, che il 18 maggio 1936 scrive a Gabriele: “Vorrei cogliere nel giardino le rose bianche che Eleonora [Duse] amava per affidarle alla cara e fedele Emy. Ogni giorno ringrazio il buon Dio che mi ha fatto conoscere questa giovane che ho voluto accanto a te perché più d'ogni altra degna. Ella ti adora servilmente, ricambiala con la tua fiducia, Gabri, ne sarà lieta”.
Come al solito viene ribattezzata da d'Annunzio, il suo vero nome è Emma. Probabilmente Gabriele la chiama Emy perché è la sostituta di Emilia, la cameriera consolatrice sessuale morta di tubercolosi. Al suo arrivo Emy non ha vent'anni, come si è scritto finora, ma quasi trenta, essendo nata il 16 gennaio 1903 a Bolzano, dunque cittadina austroungarica.
Luisa Baccara intuisce subito che si tratta di una concorrente insidiosa. Anche Aélis commenta con un “ahinoi” l'arrivo dell'enigmatica valchiria, e decide di farle terra bruciata intorno. Ma gli intrighi della coppia, ormai affiatatissima e solidale, non sortiscono effetti: Emy Heufler, glaciale come il suo nome, non sarà una meteora.
Dopo tre giorni ha già concesso le sue grazie a Gabriele. E lui – ecco l'allarme per Luisa, che sprofonda sulla sua poltrona in un accesso “di collera e di stupore” – la tiene con sé tutta la notte. Aélis si mette alle calcagna della bolzanina, annotandone movimenti, descrivendone controvoglia sul diario ogni successo e gettandosi sulla pagina, con bulimica soddisfazione, se c'è da registrare uno scacco. Trasuda felicità quando sente Gabriele apostrofarla “puttana” e ordinarle di restituire tutti i regali solo perché la ragazza ha deciso di andarsene qualche giorno, per vedere suo figlio Rodolfo Mario, nato nel 1927 a Verona.
Eppure Aélis sa che, se lui non trattiene l'ira, vuol dire che l'amante di turno è più di una badessa qualsiasi. Infatti, dopo poco, Emy viene riammessa nelle sacre stanze, devota e pronta a servire – annota la francese – “il Comandante e il principino”. Verso la fine Aélis scriverà rabbiosamente che la devozione rende a Emy quattro o cinquemila lire al mese, fra stipendio e doni: più di quanto tocca a lei.
Emy è il servizievole conforto delle clausure di Gabriele, sempre più misteriose e impenetrabili, con tanto di catenaccio; giorni e notti interi prima di tornare, allucinato e sfiancato, alla luce del mondo. In una lettera del 10 novembre 1936 all'oculista Paolo Nichelatti, Gabriele affida Emy alle sue cure definendola “la più gentile e la più diligente” fra le donne del Vittoriale, e alla cuoca scrive: “Cara Albina, tu sei la sola che – per la tua grazia verso il Comandante – non fai il viso arcigno a una “foresta” che deve fare il servizio del mio appartamento con attenzione. Emy arriva fra poco. Ti prego di serbarle qualcosa da mangiare, e di soffocare l'ostilità delle Grasse contro la Magra”.
Cameriera, amante e infine infermiera: ma perché affidare a una figura così ignota la salute del sempre più malfermo Poeta? Aélis e Luisa, impotenti contro il processo di consunzione, non lo accettano, ora che nella caduta del Comandante si specchia la loro. Danno la colpa all'algida bolzanina, la immaginano tramare ogni inganno. È lei che dovrebbe curare Gabriele e invece non lo fa, però non hanno prove per denunciarla, solo sospetti, i fiori più rigogliosi della gelosia.
Il caso – il caso? – poi vorrà che, alla morte di d'Annunzio, Emy si metta al servizio di Joachim von Ribbentrop, il ministro degli Esteri nazista che appena qualche anno più tardi dimostrerà di saper ben piazzare belle e giovani spie bionde accanto agli uomini che giudica pericolosi: come Frau Beetz, che mise a disposizione di Galeazzo Ciano, nel carcere di Verona, per scoprire dove fossero nascosti i suoi preziosi diari politici.
Questa, almeno, è la voce che si è affermata, anno dopo anno, senza alcuna prova, sui rapporti di Emy con le gerarchie naziste. Si sta ancora cercando di appurare la verità, o almeno di trovare tracce, negli archivi tedeschi.
Di certo Emy non arrivò al servizio di Ribbentrop – se ci arrivò – “il giorno dopo” la morte di d'Annunzio, come si è scritto. Dai documenti risulta che nell'ottobre 1938 si trasferì nel comune di Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e che emigrò in Germania soltanto il 1° gennaio 1941. Nel frattempo, e questa è un'altra scoperta, si trasferì a Livorno, probabilmente al servizio di una ricca famiglia, visto che l'indirizzo di viale Regina Margherita – oggi viale Italia – corrisponde a una delle zone più eleganti della città.
Livornese era Costanzo Ciano, e può darsi che il vecchio compagno di guerra di d'Annunzio abbia trovato un lavoro alla prediletta dell'amico scomparso. Agli amanti dei complotti sembrerà altrettanto normale credere che il potente ministro fascista facesse parte di un piano teso a eliminare il Vate.
Pare più sospetto che Rizzo trattasse Emy con un riguardo e una considerazione speciali: una lettera di d'Annunzio dimostra che il prefetto usava Emy anche come tramite per comunicazioni private. Del resto nessuno avrebbe potuto stare così vicino al Vate senza il consenso di Rizzo che, come sappiamo, riferiva direttamente a Mussolini, sulla via dell'alleanza con Hitler.
La repulsione di d'Annunzio per Hitler era nota. Secondo Aélis, nel 1934, Gabriele si sarebbe rifiutato di ricevere il duce dopo l'incontro con il capo nazista, avvenuto a Venezia; meno intransigente, l'anno seguente avrebbe accettato di incontrarlo, reduce dalla conferenza di Stresa, ma solo se prima Mussolini si fosse lavato le mani.
È dunque sorprendente la notizia, di cui sappiamo dal diario di Aélis, che il 31 novembre (sic) 1935 Gabriele abbia consegnato a Guido Manacorda un portasigarette e una medaglia d'Africa, perché li desse a Hitler, “ma senza aggiungere una parola, non volendosi compromettere” sottolinea Aélis. Manacorda, germanista cattolico e fascista, stava cercando di attenuare la politica antivaticana dei nazisti, e può darsi che abbia insistito con d'Annunzio, per arrivare dal Führer con un dono che – a suo dire – Hitler accolse “arrossendo”.
Può essere che in quel periodo d'Annunzio apprezzasse l'appoggio dato dalla Germania alla guerra d'Etiopia. E poi gli piaceva mandare doni, che però senza lettera accompagnatoria avevano ben poco valore. Per esempio aveva spedito una spilla da cravatta a Laval, pur considerandolo “una nullità” e spiegando – proprio a Manacorda – che “la Francia si sarebbe ridotta malissimo” per la sua debola risposta politica a Hitler. Allo stesso modo aveva respinto le insistenti richieste di Rizzo di scrivere un messaggio ai volontari fascisti nella guerra civile spagnola. Dagli archivi del Vittoriale, che d'Annunzio voleva perfettamente aggiornati, risulta che in quelle settimane venne inviato un portasigarette soltanto al colonnello francese La Rocque, sempre attraverso Manacorda. Il quale, probabilmente, millantava con Aélis sul presunto dono a Hitler.
© Paolo Melandri (4. 11. 2018)
*
Vana
– Che orrore! Che orrore! – disse Orietta Malispini ritraendo graziosamente la sua bocca piccola rotonda e rossa come una corbezzola dietro il gran mazzo di mammole doppie che portava appuntato molto in alto, a sinistra del collo, contro la gola, quasi grande come la sua faccia. – Io non ho dormito tutta la notte.
– Ah, io confesso che mi piacerebbe di essere amata così – disse Adimara Adimari, con un largo brivido che parve correre su per la sua giacca di chinchillà tanto squisitamente accordata alle due perle grige e tiepide del suo sguardo.
– Compresa la catastrofe? – chiese Dorothy Hamilton, con quell'accento strambo che dava qualcosa di buffo a ogni sua parola, accavallando una gamba sull'altra e scuotendo la cenere della sua sigaretta.
– La catastrofe ma con salvazione.
– Con Salvatore… Serra di Lubrano, dei Lancieri di Novara.
– Dolly, sei insopportabile.
– Io sono certa che se Driade potesse risuscitare dalle sue ceneri si metterebbe a riamare disperatamente il suo assassino – disse Novella Aldobrandeschi senza cessare di toccar sé stessa con quei suoi gesti carezzevoli, ora strisciandosi il manicotto di martora sotto il mento, ora premendosi sulle labbra qualcuno degli amuleti che portava in fascio appesi alla lunga catena, ora lisciandosi con le dita il ginocchio che tondeggiava sotto la gonna color tanè come i suoi caldissimi occhi. – Non ho ragione, Vana?
– Ma non so di chi parli – disse Vana Lunati, che s'era scossa udendo il suo nome.
– Tu caschi sempre dalle nuvole, Vanina – fece Simonetta Cesi ridendo con quella sua larga bocca dagli angoli rilevati, che all'ombra della capigliatura fulva e indocile la assomigliava a una faunella coronata di pino.
– Passione nascosta. Tutti i segni.
– Per chi? per chi?
– Passione non corrisposta. Ahi! Ahi!
– Come quella del pastore di Fondi?
– Non vedete che è diventata uno stecco?
– E ogni giorno più scura.
– Con nessuna di voi si confida?
– Con me no.
– E neppure con me.
– Con me, niente.
– E con me, niente affatto.
– Quanto siete sciocche! – disse Vana con un riso impaziente. – Non sono stata sempre così?
– La Vergine del Cilizio.
Tutto era odio e oltranza e costrizione, dentro di lei. Lei era là, seduta nella poltrona bassa, accanto alla sua tazza di tè, accanto alle paste e alle confetture che l'ospite aveva accumulato sopra un deschetto, nella fragranza dei fiori sparsi ovunque, nel tepore blando, nel suo grazioso abito di casimir nero a cui un poco d'oro un poco di blu e una striscia sottile di zibellino davano un'impronta che rivelava il gusto di Isabella Pallavicini; ma la sua anima nascosta non respirava se non nel più arido orrore. Turbini di forza nascevano dentro di lei, roteavano, si dissolvevano. Una certezza le sovrastava evidente come le cose che vedeva, come le cose che poteva toccare. “Dunque, è vero. Non c'è dubbio. È vero, è proprio vero” ripeteva dentro di sé con la continuità di chi nel primo urto della sciagura spera tuttavia che la voce risponda: “No, non è vero. Hai sognato. Rientra in te”. E lei stessa, infatti, si sforzava di sfuggire a quella certezza; piegava la sua attenzione verso le lievi amiche, verso la futilità della vita; beveva un sorso di tè, sorrideva a Simonetta; immaginava di essere come una di loro, contenta del suo bel vestito, occupata specialmente nell'attesa del gran ballo ch'era per dare Ortensia Serristori, con un peccato di gola per i pistacchi tostati e salati, con un fidanzato molto ricco o con un amoretto molto dispettoso. E pensava: “Come siete felici, come siete felici! Ci vuole così poco per essere felice! Se io ora potessi levarmi quest'orribile male, se potessi prendere una cartina di qualche cosa come quando ho l'emicrania e liberarmene, se potessi scrollare da me quest'incubo, sarei felice anch'io. Stasera canterei, domani ballerei. Ridiventerei bella come nella miniatura persiana. Proprio stamani ho ricevuto un vestito da ballo, delizioso. Volete che ve lo descriva, per farvi un po' di rabbia? Mia sorella non è mai stata tanto generosa con me...”. Irresistibile come la frana, una massa compatta di dolore si rovesciava sopra i suoi pensieri incoerenti, schiacciava tutto, seppelliva tutto. Una volontà disperata di nuocere vi risorgeva per entro, accompagnata da un balenìo di immagini violente.
© Paolo Melandri (1. 11. 2018)
*
Un luogo senza tempo
Ci chiedete che impressione ci facessero gli agenti di Canopo ai tempi della Glaciazione.
Di solito veniva Giano, ma chiunque arrivasse lo faceva senza preavviso e in circostanze che sembravano casuali. Si fermava per periodi più o meno lunghi, e durante quei piacevoli soggiorni – che noi tutti attendevamo sempre con entusiasmo – dispensava consigli, ci mostrava come utilizzare le risorse del pianeta in modo più efficace, suggeriva accorgimenti, metodi e tecniche. Poi ripartiva, senza dirci quando ci saremmo dovuti aspettare di rivedere Canopo.
Gli agenti di Canopo si somigliavano tutti. Insieme ai pochi che erano stati portati su altri pianeti colonizzati per essere istruiti o addestrati in vari modi, io sapevo che gli ufficiali del servizio coloniale di Canopo si riconoscevano dall'autorità che emanava da ciascuno di loro. Questa autorità era un'espressione delle loro qualità interiori e non di una posizione gerarchica. Dopo aver capito cosa cercare, fummo sempre in grado di distinguere gli emissari di Canopo dai nativi di quei pianeti. E questo ci rese più consapevoli del contributo di Canopo al nostro pianeta, il numero 8.
Tutto quanto era stato progettato, costruito, fatto su Pianeta 8 – tutto ciò che non esistesse già in natura – era stato creato seguendo le loro indicazioni. La presenza del nostro popolo sul pianeta derivava da loro, da Canopo. Erano stati loro a portarci qui, generando la nostra specie a partire da razze che provenivano da vari altri pianeti.
Per queste ragioni parlare di obbedienza non è esatto. È all'obbedienza che facciamo riferimento quando si tratta delle nostre origini e della nostra esistenza?
O parlare di ribellione…
Una volta arrivammo quasi a ribellarci.
Fu quando Giano ci disse che avremmo dovuto circondare il nostro piccolo globo con una muraglia alta e massiccia, e ci impartì istruzioni su come produrre materiali da costruzione che a quel tempo non conoscevamo. Dovevamo mescolare in dosi precise alcune sostanze chimiche con le pietre sbriciolate della nostra terra. La costruzione del muro avrebbe richiesto tutta la nostra forza, il nostro impegno e le nostre risorse per un lungo periodo.
Gli facemmo notare una cosa: come se Canopo non lo avesse saputo! Quella fu la nostra protesta, o meglio, così la chiamammo tra noi. E fu l'apice della nostra “ribellione”. Il silenzio sorridente di Giano ci fece capire che la muraglia doveva essere costruita.
Per quale scopo?
L'avremmo scoperto in futuro, fu la risposta.
Quando il muro fu completato, coloro che erano stati bambini all'inizio dei lavori erano ormai vecchi, e io ero uno di loro; i figli dei loro figli assisterono alla cerimonia, quando l'ultima lastra nera e lucente fu posta in cima a una costruzione che superava di cinquanta volte il nostro edificio più alto, e che non era da meno neanche in spessore.
Era un prodigio, quella muraglia.
Quella cosa nera che delimitava la circonferenza del nostro globo – benché non lo facesse lungo la sua maggiore ampiezza, un fatto che ci rendeva ancora più perplessi e dubbiosi – ci tirava a sé, attraeva le nostre menti, la nostra immaginazione, ci assorbiva. Si vedevano sempre capannelli, gruppi o folle di persone in piedi sulla cima o sulle piattaforme di osservazione appositamente collocate lungo tutta la muraglia, oppure sulle alture che la sovrastavano – ma che erano a una certa distanza, perché nulla che fosse nei pressi del muro consentiva una visibilità sufficiente. Stavamo sulla muraglia il mattino presto, quando il sole vi dardeggiava sopra, e a mezzogiorno, quando il nero lucente restituiva al cielo lampi di luce e colore, e la notte, quando i grappoli brillanti delle stelle di Pianeta 8 sembravano riflettersi sul muro, come in un'acqua scura. Il nostro pianeta non aveva lune.
© Paolo Melandri (29. 10. 2018)
*
La mendicante di Locarno
Ai piedi delle Alpi, presso Locarno, in Alta Italia, sorgeva un vecchio castello, appartenente a un marchese, che ancora oggi, venendo dal San Gottardo, si vede, ridotto in macerie e in rovina: un castello dalle stanze alte e spaziose, in una delle quali una volta, sulla paglia che vi era stata ammucchiata, era stata messa a giacere per compassione, dalla padrona di casa, una vecchia donna malata, che si era presentata alla porta chiedendo l'elemosina. Il marchese, che, di ritorno dalla caccia, entrò distrattamente nella stanza, dove soleva deporre la sua carabina, ordinò irritato alla donna di alzarsi dall'angolo in cui era stesa, e di mettersi dietro la stufa. La donna, tirandosi su, scivolò con la gruccia sul pavimento liscio, e si fece una grave ferita all'osso sacro; tanto che si alzò, bensì, con incredibile sforzo, e attraversò di sbieco la stanza, come le era stato prescritto, ma dietro la stufa, fra gemiti e sospiri, si lasciò cadere e spirò.
Alcuni anni dopo, quando il marchese, a causa della guerra e dei cattivi raccolti, si trovava in una brutta situazione finanziaria, venne a trovarlo un cavaliere fiorentino, che, per la sua bella posizione, voleva comprare il castello. Il marchese, che teneva molto all'affare, disse alla moglie di alloggiare l'ospite nella stanza di cui abbiamo parlato, che era vuota, ed era stata arredata splendidamente. Ma quale fu la costernazione della coppia quando il cavaliere, nel bel mezzo della notte, scese in camera loro pallido e turbato, giurando e spergiurando che in quella stanza c'erano gli spiriti, perché qualcosa che era rimasto invisibile allo sguardo si era alzato da un angolo della stanza, con un rumore come di paglia smossa, aveva attraversato di sbieco la stanza, con passi lenti e interrotti, ma ben udibili, e si era lasciato cadere, fra gemiti e sospiri, dietro la stufa.
Il marchese, spaventato, egli stesso non sapeva bene perché, canzonò il cavaliere con simulata allegria, e disse che si sarebbe alzato immediatamente e, per sua tranquillità, avrebbe trascorso la notte con lui in quella stanza. Ma il cavaliere lo pregò, per cortesia, di consentirgli di pernottare nella sua camera da letto, su una poltrona, e, quando venne il mattino, fece attaccare i cavalli, si congedò e partì.
L'incidente, che destò grande scalpore, scoraggiò, con estremo disappunto del marchese, molti compratori. E poiché tra i suoi stessi domestici si diffondeva, in modo strano e incomprensibile, la voce che in quella stanza, a mezzanotte, si muovessero gli spiriti, egli, per metterla decisamente a tacere una volta per tutte, un giorno decise di esaminare egli stesso la cosa la notte seguente. All'imbrunire fece dunque portare il suo letto in quella stanza, e attese senza dormire la mezzanotte. Ma quale fu il suo sgomento quando in effetti, allo scoccare dell'ora degli spiriti, percepì l'incomprensibile rumore; era come se un essere umano si alzasse dalla paglia, che frusciava sotto di lui, attraversasse di sbieco la stanza e si lasciasse cadere, fra rantoli e lamenti, dietro la stufa.
La marchesa, il mattino seguente, gli domandò, appena fu sceso, come si fosse svolta la sua indagine. E, quando egli si guardò intorno, con occhiate incerte e timorose, e, dopo aver chiuso la porta, le assicurò che i fantasmi c'erano davvero, lei si spaventò come non le era mai successo in vita sua e lo pregò, prima di divulgare il fatto, di tentare un'altra prova, a mente fredda, in sua compagnia. Ma la notte successiva, insieme a un fedele domestico che avevano portato con sé, udirono ancora una volta lo stesso incomprensibile, spettrale rumore. Solo il pressante desiderio di sbarazzarsi del castello a qualunque costo poté far loro reprimere, in presenza del domestico, il terrore che li prese, e attribuire l'incidente a una causa qualsiasi, indifferente e fortuita, che prima o poi si sarebbe scoperta.
La sera del terzo giorno, quando entrambi, per venire a capo della cosa, salirono di nuovo, con il cuore che batteva, la scala della camera degli ospiti, il loro cane da guardia, che era stato sciolto dalla catena, si trovò per caso davanti alla porta; tanto che i due, senza dirlo esplicitamente, forse con l'intenzione di avere con sé un terzo essere vivente, fecero entrare il cane nella stanza.
La coppia, due candele sul tavolo, la marchesa senza spogliarsi, il marchese tenendo accanto a sé la spada e le pistole che aveva preso da un armadio, si siede, verso le undici, ognuno sul proprio letto; e, mentre cercano di passare il tempo come possono, facendo conversazione, il cane si corica in mezzo alla stanza, testa e gambe acciambellate, e si addormenta. A mezzanotte in punto, l'orribile rumore si fa udire di nuovo; qualcuno che nessun occhio umano può vedere si alza sulle grucce, nell'angolo della stanza; si sente la paglia frusciare sotto di lui; e al primo passo, tapp!, tapp!, il cane si sveglia, drizza le orecchie, si solleva di colpo sul pavimento e, ringhiando e abbaiando, proprio come se un essere umano venisse passo passo verso di lui, indietreggia verso la stufa. A quella vista la marchesa, con i capelli ritti, si precipita fuori dalla stanza e, mentre il marchese, afferrata la spada, grida: “Chi è là?” e, poiché nessuno risponde, mena fendenti in aria come un pazzo, in tutte le direzioni, dà ordine di attaccare i cavalli, decisa a partire immediatamente per la città. Ma, prima che, radunati alcuni bagagli, esca dal portone con fracasso, vede il castello tutto avvolto dalle fiamme. Il marchese, sopraffatto dall'orrore, aveva preso una candela e, stanco della vita, aveva appiccato il fuoco ai quattro angoli dell'edificio, interamente rivestito di legno. Invano la marchesa mandò gente dentro, a salvare l'infelice: era già perito nel modo più miserando, e ancora oggi le sue bianche ossa, raccolte dai contadini, giacciono nell'angolo della stanza dal quale egli aveva fatto alzare la mendicante di Locarno.
© Paolo Melandri (25. 10. 2018)
*
Eumene
Il mio nome è Manuele Venatore; sono steward notturno nella casbah di Eumene. Non ho un aspetto appariscente; nelle gare posso contare su un terzo premio e quanto a donne, non ho problemi. Ho quasi trent'anni; il mio carattere sembra faccia una impressione gradevole – premessa indispensabile per la mia professione. Per quanto riguarda la politica, vengo giudicato persona fidata, sebbene non particolarmente impegnata.
Tanto, in breve, circa la mia persona. I dati forniti sono sinceri, quantunque ancora vaghi. Li preciserò a poco a poco: a tal riguardo contengono lo spunto d'una predisposizione.
Precisare ciò ch'è vago, definire sempre più nettamente l'indefinito, è questo il compito di ogni evoluzione, di ogni fatica esplicata nel tempo. In tal modo si rilevano, nel corso degli anni, sempre più distinte le fisionomie e i caratteri. Questo vale anche per le grafie.
Sulle prime, lo scultore si trova di fronte il blocco grezzo, la materia pura, che racchiude tutte le possibilità. Essa risponde allo scalpello, che può distruggere o farne scaturire acqua di vita, potenza spirituale. Tutto ciò resta nell'indefinito, anche per chi è maestro: non dipende cioè interamente dalla sua volontà.
Ciò ch'è vago, indefinito, anche nelle scoperte, non è falso. Può essere errato, ma non necessariamente insincero. Un'asserzione – vaga, ma non falsa – può venir chiarita frase per frase, finché la faccenda si assesta e si centralizza. Se però l'affermazione s'inizia con una menzogna, dovrà essere sostenuta da sempre nuove menzogne, finché l'edificio crolla. Da qui il mio sospetto che già la Creazione abbia avuto origine con una falsificazione. Fosse stato un semplice errore, con l'evoluzione sarebbe possibile ripristinare il paradiso. Ma il Vecchio ha tenuto segreto l'Albero della Vita.
È questo che incrina la mia sofferenza: l'irreparabile imperfezione, non solo della Creazione, ma anche della propria persona. Porta all'inimicizia verso gli dèi da una parte, e dall'altra all'autocritica. Forse, in queste cose io inclino all'esagerazione, comunque entrambe infiacchiscono l'azione.
Ma niente preoccupazioni: un trattato logico-morale non è previsto.
2.
Precisare bisogna, anzitutto, che io mi chiamo, sì, Venatore, ma non Manuele, bensì Martino: è questo, come dicono i cristiani, il mio nome di battesimo. Da noi viene conferito dal padre: che, mentre solleva il neonato, lo chiama per nome e lascia che riempia di strilli le pareti.
Manuele, invece, è il nome con cui vengo chiamato durante il tempo in cui presto servizio qui nella casbah; mi è stato assegnato dal Condor. Il Condor è il mio padrone in quanto attuale despota di Eumene. Risiede da anni nella casbah, la roccaforte che corona, a circa due miglia al di là della città, una collina brulla, chiamata da sempre il Pagos.
Questo rapporto tra città e fortezza si ritrova in molti luoghi: è il più comodo, non soltanto per la tirannide, ma per ogni regime personalistico.
I tribuni, rovesciati dal Condor, invece, avevano soggiornato con discrezione in città, dominati e guidati dal Municipio. “Dove esiste un braccio solo, il suo effetto è maggiore se il manico è lungo; dove hanno voce in capitolo molti, occorre il fermento: così le giacenze di fondo s'intridono come fa il lievito col pane”. Così Vigo, il mio maestro; di lui dirò più oltre.
Perché dunque era stato desiderio – e quindi un ordine – da parte del Condor che io venissi chiamato Manuele? Preferiva la consonanza iberica, oppure non gli era gradito Martino? Così avevo supposto sulle prime, e in effetti esiste un'avversione o per lo meno una suscettibilità nei confronti di certi nomi, di cui non teniamo sufficientemente conto. Certuni impongono ad un bambino per tutta la vita un nome, che corrisponde alla realizzazione di un proprio sogno. S'avanza uno gnomo e si presenta col nome di Cesare. Altri scelgono il nome del signore che, in quel momento, ha nelle mani il comando, così come anche qui tra i poveri e i ricchi esistono già dei piccoli Condor. Anche questo può riuscir dannoso, specialmente in tempi di malcerta successione.
Troppo poco, e ciò vale per la maggioranza, si fa invece attenzione se il nome armonizzi col cognome. Schach von Wuthenow, per esempio, è faticoso, quasi una pretenziosità fonetica. Invece, Emilia Galotti, Eugenie Grandet – fluttuano lievi e armoniosi nello spazio acustico.
Ecco che ci avviciniamo alla questione: la spiccata musicalità del Condor, che è in contrasto con “Martino”. Ciò è comprensibile, perché le consonanti mediane suonano dure e staccate, raschiano l'orecchio. Il patrono del nome è Marte.
Singolare è, certo, tale delicatezza in un signore che deve il suo potere alle armi. La contraddizione l'ho capita soltanto dopo una lunga osservazione, sebbene getti la propria ombra su tutti. Ognuno infatti possiede la propria zona di luce e la zona d'ombra, e più di uno si diversifica col crepuscolo. Nel Condor, tale differenza è particolarmente e inconsuetamente rimarchevole. Nell'aspetto esteriore, beninteso, resta il medesimo: uno scapolone di mezza età dal portamento lievemente curvo dell'uomo che passa molto tempo a cavallo. Si aggiunga un sorriso, che ha conquistato molti – una accattivante giovialità.
Però il sensorio muta. L'uccello rapace diurno, il predatore, che scruta la lontananza e insegue movimenti remoti, diventa notturno; gli occhi si rilassano nell'ombra, l'udito si fa più sottile. È come se davanti al viso calasse un velo e si aprissero nuove fonti di percezione.
Il Condor ci tiene alla vista lunga; raramente avrà fortuna con lui un aspirante che porti gli occhiali. Questo vale in special modo per posti di comando nella truppa e nella guardia costiera. Chi è in attesa di nomina, viene invitato a una breve chiacchierata, durante la quale il Condor gli tasta il polso. Il suo studio privato sopravanza il tetto piatto della casbah con una cupola di vetro, rotonda e girevole. Durante il colloquio, il Condor ha l'abitudine di assicurarsi delle qualità visive dell'aspirante additando una nave oppure una lontanissima vela e chiedendo ragguagli sulla sua caratteristica e direzione. Certo, accurati esami devono aver preceduto tale colloquio; ma la conferma è lasciata al giudizio personale.
© Paolo Melandri (25. 10. 2018)
*
Vittoria e gli Orsini
Un buio freddo calava già sul cortile, dove le voci di un gruppo di bambini indicavano a chi arrivava al cancello grande dove dirigere lo sguardo: era già difficile distinguerli. Per una specie di empatia, i bambini del gruppo più numeroso erano in grado di individuare tra le persone che arrivavano chi era lì per loro, e da soli o a coppie schizzavano fuori per essere presi in consegna e accompagnati a casa. Al centro dello spazio, circondato da muri alti con sopra cocci di vetro, c'erano due bambini isolati. Facevano chiasso. Un bambino tirava calci e pugni nel vuoto e urlava: “Si è dimenticato, te l'avevo detto che se lo dimenticava”, mentre una ragazzina cercava di consolarlo e calmarlo. Lui era un bambino in carne, lei magra, con due codini puntuti legati da nastri rosa umidi e flosci. Era più grande di lui, ma non più alta. E tuttavia era con la sicurezza dei suoi anni di più che lo ammoniva: “Insomma, Tommaso, non fare così, non strillare, adesso vengono”. Ma non c'era verso di tranquillizzarlo. “Lasciami, lasciami andare… No, non se l'è dimenticato.” Al cancello arrivarono nello stesso momento varie persone, tra cui un ragazzino alto e biondo di circa dodici anni, che era incaricato di prelevare, mentre altri già tendevano le mani e avanzavano. Era una piccola scena di tumulto e confusione. Il ragazzino alto, Eraldo, afferrò Tommaso per la mano e rimase lì fermo mentre il bambino continuava a dimenarsi e a lamentarsi. “Ti eri dimenticato di me; sì, ti eri dimenticato” e guardava i compagni sparire in strada. Si girò e scomparve insieme a Tommaso.
Faceva freddo. Vittoria non era vestita a sufficienza. Adesso che non aveva il bambino recalcitrante a tenerla in movimento, tremava. Se ne stava in piedi con le braccia strette intorno a sé, piangendo. Il custode della scuola emerse dal buio, tirò il cancello e lo chiuse a chiave. Non l'aveva vista. Lei portava dei pantaloni marrone scuro e una giacca nera, ed era un punto nero nel buio vorticoso del cortile: si stava alzando il vento.
L'orrore della giornata, cominciata con la zia che veniva portata di corsa all'ospedale e culminata in quell'abbandono, adesso le tagliava le gambe e la faceva oscillare, gli occhi pieni di lacrime, serrati, fino a che la paura di essere sola glieli fece riaprire e fissò il grande cancello nero chiuso. Le sbarre erano larghe. Cauta, come se fosse intenta a qualche nefandezza, si avvicinò al cancello per vedere se riusciva a infilarcisi in mezzo. Era magra, e le dicevano spesso che non aveva abbastanza carne addosso da saziare un gatto. Quello era stato il verdetto di sua madre, e il pensiero della mamma morta la faceva piangere e gemere. Pochi minuti prima aveva fatto la parte della bambina grande di fronte a quell'infante di Tommaso, ma adesso era lei a sentirsi piccola, e i suoi nove anni si stavano sciogliendo in lacrime. E poi era rimasta incastrata lì, tra le sbarre. Sul marciapiede la gente passava davanti senza vederla, tutta ingobbita sotto gli ombrelli; il cortile alle sue spalle era vasto, buio e minaccioso. Dall'altra parte della strada, il negozio di dolci e giornali del Signor Valgimigli era tutto un luccichio. I lampioni emanavano aloni gialli lattiginosi, e proprio mentre Vittoria decideva di cercare di nuovo di liberarsi, il Signor Valgimigli uscì sul marciapiede a prendere delle arance dalle cassette di frutta esposte fuori e la vide. Lei passava per il negozio ogni giorno di scuola, ma di solito in mezzo a branchi di altri ragazzini, e sapeva che lui doveva starle simpatico, perché la zia, anche la mamma, prima di morire, avevano detto: “È una brava persona, quel Valgimigli”.
Il Signor Valgimigli alzò la mano per bloccare il traffico, che consisteva solo in una macchina e una bicicletta, e corse verso di lei. Quando la raggiunse, lei a forza di contorcersi si liberò e gli cadde fra le mani, grandi e buone, che la scossero. “Vittoria, ma sei tu?”
Salva, si abbandonò alla disperazione. Lui la prese in braccio e di nuovo alzò la mano – solo una, con l'altra la reggeva – per fermare un'altra macchina e una moto. Raggiunto il caldo luminoso del bar, il Signor Valgimigli la mise a sedere sul bancone e disse: “Allora, piccola, cosa ci fai qui tutta sola?”.
“Non lo so” rispose piangendo, e davvero non lo sapeva. In classe le era arrivato un messaggio che diceva che qualcuno sarebbe andato a prenderla in cortile con Tommaso Orsini, che lei quasi non conosceva, perché era due classi indietro. C'erano dei clienti che aspettavano, e il Signor Valgimigli si guardò intorno in cerca di aiuto e vide due ragazze sedute a un tavolino. Erano studentesse più grandi che si prendevano un momento di pausa prima di tornare a casa. “Sentite, date un occhio a questa creatura per un minuto” disse rivolto a loro; la sistemò con cura su una sedia lì accanto. Le ragazze certo non avevano voglia di occuparsi di una mocciosa, ma le fecero grandi sorrisi e dissero che doveva smettere di piangere. Vittoria continuava a singhiozzare. Il Signor Valgimigli non sapeva cosa fare. Mentre serviva dolci, focacce e apriva altre bibite per le ragazze, come sempre facendo venti cose insieme, pensava che forse doveva chiamare la polizia, ma all'improvviso, sull'altro marciapiede, comparve, come un fantasma che ha perso la memoria, il ragazzo alto che aveva trascinato via il fratellino recalcitrante. Si guardò intorno agitato, e poi, afferrandosi con entrambe le mani alle sbarre superiori del cancello, sembrò sul punto di issarsi in cima. “Scusa”, gridò il Signor Valgimigli precipitandosi alla porta, “vieni qui”, ed Eraldo rivolse il viso afflitto verso di lui e le luci accoglienti del bar e, senza guardare se ci fossero veicoli in arrivo, attraversò d'un balzo la strada, schivato per un pelo da una moto e insultato da un guidatore.
“Una bambina”, ansimò Eraldo, “sto cercando una bambina.”
“Eccola qui, sana e salva.” Il Signor Valgimigli rientrò e rimase vicino al bancone, tenendo d'occhio il ragazzino alto, che si era seduto accanto a Vittoria e le asciugava il viso con dei tovagliolini di carta disposti a ventaglio in un portasalviette. Sembrava sul punto di sciogliersi anche lui in lacrime. Le due ragazze, decisamente troppo cresciute per lui, si produssero comunque in manifestazioni di femminilità, protendendo petto e labbra. Ma non le notò. Vittoria piangeva ancora e lui stesso era in uno stato d'animo di estrema tensione emotiva.
“Ho sete” sbottò Vittoria, e il Signor Valgimigli le porse una spremuta d'arancia, con un gesto che indicò a Eraldo di non sognarsi nemmeno di pagare.
Eraldo le resse il bicchiere, e ne fu indignata – lei, una bambina grande, trattata come un'infante – ma grata, perché in quel momento avrebbe tanto voluto esserlo.
© Paolo Melandri (21. 10. 2018)
*
Le Pietre di Venezia
Lungo le fondamenta delle Zitelle, dopo un inutile tentativo di raggiungere forse l'ultimo dei rari vaporetti che la notte traghettano il canale della Giudecca, Marco camminava adagio e guardava le stelle. Era una notte di fine estate, la brezza gentile che soffiava sulla laguna gli correva tra i capelli e il viso, pareva bucare la calura. A lui, nel sollievo di quelle carezze fresche e invisibili, piaceva indovinare la mano amica della solitudine, pronta a raccoglierlo anche da questi minimi fallimenti. Guardava il battello attraversare il canale, poi di nuovo il cielo.
S'immaginava il silenzio, e che i pensieri si nascondessero tra le sfumature buie della notte: le onde, le nuvole, le ombre. E il cielo era vuoto e, se la gravità non lo avesse tenuto stretto alla terra, la velocità della rotazione terrestre o qualunque altro suo movimento l'avrebbe gettato nell'infinito, solo, per una distanza senza limite. Immaginava di non morire, di non poter mai più morire, di resistere alla fame, alla sete, a qualunque bisogno. Immaginava la fine dei piedi e delle mani, del respiro; gli occhi invece rimanevano aperti a fissare quella caduta in cui anche i pianeti, i meteoriti, le galassie intere non erano che corpi dispersi nel vuoto, i frammenti di un'esplosione, gettati dal caso nelle direzioni diverse. Immaginava di non aver più bocca per urlare, ma neppure più paura. Anche le orecchie restavano aperte, costrette ad ascoltare da una parte e dall'altra il silenzio, a non perderne una sillaba. Non avrebbe più avuto sonno né avvertito la stanchezza, non vi sarebbe stata più alcuna distrazione a risparmiargli la coscienza: la veglia non avrebbe avuto sosta, né fine. Seguendo in cielo l'itinerario immaginario di quella caduta per un attimo si credette morto; poi percepì il movimento dell'acqua, il rumore delle onde che si rompevano contro i gradini di pietra delle fondamenta: no, non era morto, si era solo dimenticato.
Tornò con gli occhi alle stelle, le narici filavano l'aria in un respiro sottile. Trattenne il fiato per qualche istante e pensò d'essersi finalmente adeguato al suo viaggio siderale. L'ansia di respirare ancora lo costrinse a rifiatare, come il dolore costringe a urlare, ma già ansia e dolore erano scomparsi, forse non era accaduto nulla, aveva immaginato anche questo. I suoi occhi volavano ora a pelo dell'acqua, come i gabbiani quando cercano cibo, inseguendo fra le onde un riflesso di luce fino all'altra riva; alto e solitario, un lampione interrompeva la lunga linea nuda delle Zattere e a lui parevano poggiarsi ora tutti i suoi pensieri, sfiancati dalla corsa attraverso i riverberi della laguna. Marco guardava il bacio dell'acqua e della pietra, il cadenzato fluire della marea e così sfiniva, come un naufrago che non ha speranza ma nuota ancora, fino a esaurire le proprie energie, fino a che il mare, di cui a fatica non fende che la superficie, lo inghiotte nelle profondità.
Ma le sue gambe andavano ancora e lo portavano tra gli odori e la fioca luce dei rari lampioni a sfiorare l'incanto, il sogno, la memoria e l'abbandono. Giunse un altro vaporetto, Marco s'imbarcò a prua per godere la brezza; guardava oltre il parapetto l'acqua che lo circondava, pensava al cuore balordo che dall'interno lo trafiggeva rendendogli impossibile il sollievo della leggerezza. Si figurava a mente una per una le calli, i campi, i ponti che lo separavano da casa e il solo pensiero della strada da fare lo sfiniva. Pensò che sciocchezza fosse immaginarsi di poter morire a quel modo, ma i suoi pensieri erano a questo proposito ancora troppo contraddittori, non gli permettevano il distacco che desiderava e di nuovo, improvvisa e violenta come una fitta, la sensazione del proprio fallimento, dell'insufficienza della sua vita, dell'incapacità e della vaghezza di cui si sentiva prigioniero e altri numerosi pensieri, strazianti e senza nome, ripresero a braccarlo come cani che, assaggiato il sangue della preda, la incalzino ora con una ferocia incontenibile. Come la povera bestia guarda avanti, perché quella è l'unica direzione in cui la morte non è certa, così Marco guardava l'acqua e più in là, l'altra riva, tentando di fuggire con gli occhi le lacrime, avanti, verso un frammento di realtà qualunque estraneo a quella caccia di cui era la preda.
D'un tratto gli parve che qualcuno si fosse infilato in una calle: pensò che vivi sono gli uomini, le alghe e i pesci, e fu tacitamente grato al proprio cuore per quella pausa che in quel momento aveva concesso.
Arrivò a casa che era ormai quasi mattino, l'aurora si alzava dai tetti a oriente dilagando per l'intera superficie del cielo, nell'azzurro ancora chiarissimo le sagome scure dei palazzi in campo San Polo parevano giganti addormentati intorno a un fuoco spento. Marco portò una sedia davanti alla finestra che guardava sul campo e sedette a respirare il mattino, ad ascoltarne i rumori: verande che si aprivano e donne senza età che si affacciavano a salutare il giorno dopo il riposo. Qualcuno s'affrettava sul listone in fondo al campo e il riverbero dei passi si perdeva tra i muri delle calli. E il canto degli uccelli che da una parte all'altra del cielo già volavano in stormo, le splendide volute dei più giovani mentre gli altri vagavano solitari, ancora pieni di sonno, planando dalle nuvole ai tetti e riportandosi in quota con un solo colpo d'ala. Volavano a Sud, pensò Marco, ora che comincia l'autunno, e con la fantasia generosa che da sempre lo condannava a ingoiare il prossimo respiro, posò le sue pene sul dorso di una rondine e così si sentì sollevato. Si infilò nel letto e si attardò a vagare con gli occhi fuori dalla finestra, tra le nuvole e i cavi elettrici tesi attraverso il campo fino a quando la città fu sveglia e il rumore del giorno, dolce e continuo come una cantilena, lo addormentò.
Si risvegliò dopo qualche ora, sereno e senza paura; i pensieri, ancora asciutti, s'alzavano già uno a uno dal letto e andavano alle mille possibili cose da fare, si disponevano in ordine nella giornata futura e la organizzavano. Osservava la grande attività della sua mente e se ne stupiva: avrebbe lavorato a una traduzione che da mesi aveva abbandonato, poi avrebbe telefonato alla padrona di casa per lamentarsi di una macchia d'umido sul soffitto, forse avrebbe anche comprato un giornale. Ma queste intenzioni non duravano che qualche istante, le vedeva scoppiare come bolle di sapone nel fumo della prima sigaretta, lasciando solo uno sputo sul pavimento. Fuori c'era il sole, la giornata viva, piena di uomini e di cose; dal campo le voci alte dei bambini e il mormorio degli adulti giungevano fino in camera. Socchiudeva gli occhi, come se in questo modo gli fosse possibile non ascoltare. Avrebbe voluto interrogarsi, esaminare i perché disertati la sera precedente, ma il pudore e una strana paura avevano avvolto il cuore di un silenzio morboso; di nuovo esistevano solo colori, movimenti, senza relazione o perché. La morbidezza e il tepore del suo nido erano spariti, ma ancora non riusciva ad alzarsi dal letto. Avrebbe atteso la sera. Cercava con gli occhi un appiglio, uno spigolo, una fessura attraverso cui far scorrere il pensiero fuori di sé, ma non riconosceva certezza neppure alle pareti: la luce, il fumo, le voci, brandelli di realtà senza storia.
Volava così la vita, come in un soffio, nel cielo chiuso di quella stanza. Voleva morire, lo voleva disperatamente e presto, per sottrarsi alla guardia che montava al proprio decadimento; avrebbe voluto ridistribuire per la coscienza gli eventi trascorsi come le carte di un solitario, e cercare di chiudere questa volta. Ma la morte non gli appariva in nulla una conclusione, era solo stanchezza.
Di nuovo era la sera di una giornata inutile, Marco non era riuscito a far nulla, non aveva guardato l'azzurro del cielo, né il sole, non si era riposato nel sonno, si era consumato nella pena e nel niente; questo gli doleva enormemente e questo dolore, come nel suo suicidio immaginario, lo costringeva a rifiatare, a divorare il respiro successivo. Come ogni sera in quegli ultimi mesi la sua casa era ora un inferno, lo cacciava per strada alla ricerca di una bellezza cui non credeva e che comunque gli sarebbe sfuggita. Raccolse le sigarette, la giacca e uscì di corsa, quasi che quel vuoto alle sue spalle cercasse di afferrarlo e, come Lot, una sola condizione gli avrebbe permesso di allontanarsi. L'uscio, le scale, il portone, la calle, i muri, i pozzi chiusi, l'acqua quieta e finalmente il cielo! Lontano, tra le stelle, sarebbe stato benissimo, nel gelo e nella perfetta oscurità che non teme l'alba; ma tra i corpi caldi degli uomini e degli animali, nella tortura del sangue, nel ritmo della natura, delle cose che si distruggono, si divorano tra loro, si putrefanno, dove ogni odore è un'offesa e ogni colore è violento, quaggiù, nella terra maledetta dalla vita, si può soltanto morire. Respirava adagio ma già l'incontro dei primi passanti lo ferì. Cercò per qualche tempo rifugio nei pensieri, poi si aprì un varco nella gola e chiese a qualcuno un fiammifero.
© Paolo Melandri (21. 10. 2018)
*
Il cuore delle cose
L'estate scorsa ho ricevuto da te due o tre lettere. Se ricordo bene, nella scorsa lettera mi chiedevi di darti una mano per trovare un impiego. Ma ti devo confessare di non aver fatto nulla per te. Come sai, io vivo in una cerchia sociale molto limitata; anzi, sarebbe più esatto dire che sono un isolato. Quindi, come avrei potuto aiutarti?
Ma non è questo il problema. Quando mi è arrivata la tua lettera, stavo tentando di decidere che cosa fare di me stesso. Pensavo: “Dovrei continuare a vivere come ora, simile a una mummia lasciata in mezzo a gente viva, oppure dovrei?…” In quei giorni, ogni volta che meditavo su quell'alternativa, rabbrividivo di paura. Ero come un uomo che arriva di corsa sul ciglio di un precipizio, e guarda giù senza vederne il fondo. Ero un vigliacco. E come tutti i vigliacchi soffrivo nell'incertezza. Sfortunatamente, non è un'esagerazione dire che, in quel periodo, io mi rendevo conto a malapena della mia esistenza. Per di più, il problema dei tuoi mezzi di sussistenza per il futuro era per me quasi privo di significato, né mi curavo di quel che tu facevi. Dal mio punto di vista, l'argomento non meritava tutto quel rumore. Quindi misi la tua lettera nel portacarte, e continuai a tormentarmi con il mio problema. Tutto ciò che tu meritavi, secondo me, era una breve e sincera occhiata, niente altro. Del resto, mi chiedevo, perché mai una persona che ha alle spalle una famiglia con buone possibilità economiche deve darsi tanto da fare per trovare un posto subito dopo la laurea? Ti dico tutto questo perché sento di doverti qualche spiegazione per la mia condotta. Non vorrei suscitare la tua collera con espressioni rozze. Sono sicuro che tu capirai, quando avrai letto quel che ti sto scrivendo. Avrei dovuto almeno dirti di avere ricevuto la tua lettera. Per favore, perdona la mia negligenza.
In seguito ti ho mandato un messaggio nel quale, a dirti la verità, mi limitavo a chiedere se potevo vederti ancora. Avrei voluto raccontarti la storia del mio passato come tu una volta mi avevi chiesto. Quando ho visto il messaggio nel quale dicevi che per il momento ti era impossibile fare ritorno a Roma, ricordo che sono rimasto a fissarlo per un certo tempo, profondamente deluso. Anche tu devi avere intuito che un messaggio era troppo poco, tanto è vero che subito dopo mi hai scritto una lunga lettera nella quale mi spiegavi le ragioni per cui non potevi venire a Roma. Non ho motivo di risentirmi per il fatto che tu non abbia aderito alla mia richiesta. Come avresti potuto lasciare casa tua, con tuo padre gravemente malato? Piuttosto, sono io in colpa, che avrei dovuto ricordarmi delle condizioni di tuo padre. Quando avevo ricevuto il tuo messaggio, invece, me n'ero del tutto dimenticato, proprio io che ti avevo avvertito di occuparti seriamente di quella malattia… Vedi, io sono una persona incongruente. Forse ciò dipende più dalla mia esperienza che dal temperamento naturale. In ogni modo, sono ben consapevole dei miei difetti. Devi perdonarmi.
Quando ho letto la tua lettera – l'ultima – ho capito di avere agito male. Ho pensato che avrei dovuto scriverti. Ho preso in mano la penna, ma l'ho deposta sul tavolo prima ancora di avere tracciato una riga. Ti avrei scritto le stesse cose che ti scrivo ora, ma allora era troppo presto e vi ho rinunciato. Questo è il motivo per cui ti ho inviato quel semplice messaggio dicendoti che non era necessario il tuo arrivo.
2.
Allora ho cominciato a scrivere questa lettera. Io non sono abituato a scrivere, e mi è stato penoso scoprire come non fossi in grado di esprimere liberamente molti degli episodi e dei pensieri che mi riguardano. Ben presto sono stato tentato di abbandonare tutto, e rompere così la promessa che ti avevo fatto. Ma, pur volendo deporre la penna, non riuscivo a fermarmi, tanto che un'ora più tardi stavo ancora scrivendo. Puoi forse pensare che questa sia una manifestazione del mio senso del dovere, che per sua natura è molto forte. Non intendo contraddirti. Come sai, ho condotto una vita isolata, con scarsi contatti con il mondo esterno. Per quel che io posso giudicare, trovo che realmente io non ho obblighi, sia per le circostanze, sia per mia scelta. Ho vissuto in modo da essere libero da doveri, non perché io non abbia il senso del dovere verso gli altri, quanto perché io avverto in modo tanto acuto questo dovere da arrivare a condurre una vita tanto negativa. Io non sono abbastanza forte per sopportare le pene che il senso del dovere ci può infliggere. Capirai dunque che, se non avessi mantenuto la mia promessa, mi sarei sentito molto a disagio nei tuoi riguardi. Il desiderio di evitare un simile disagio è bastato per farmi riprendere in mano la penna.
Ma questa non è l'unica ragione per cui desideravo scriverti. Vedi, a parte ogni senso del dovere, c'è la semplice ragione che desidero raccontare il mio passato. Poiché soltanto io ho sperimentato il mio passato, potrei essere scusato se lo consideravo come mia proprietà esclusiva. E non è naturale che io possa desiderare, prima di morire, di dare a qualcuno questa cosa che è mia? Almeno, io la penso così. D'altra parte, preferirei vedere il mio passato annullato con la mia vita, piuttosto che offrirlo a qualcuno che non lo desidera. In verità, se non ci fosse stata una persona come te, il mio passato non sarebbe mai stato conosciuto da nessuno, nemmeno indirettamente. Solo a te, dunque, fra milioni di italiani, intendo raccontare il mio passato, perché tu sei sincero, e perché una volta hai detto, in tutta sincerità, di voler imparare dalla vita stessa.
Senza esitazione, ora sto per costringerti dentro le ombre di questo nostro oscuro mondo. Ma non devi aver paura. Guarda attentamente dentro quelle ombre, e afferra ciò che potrà servirti nella vita. Ti parlo di oscurità morale, perché io sono nato come creatura etica, e sono stato educato come persona etica. I criteri della mia morale sono forse diversi da quelli dei giovani d'oggi. Comunque appartengono a me. Non sono abiti presi a prestito per un certo periodo di tempo. Per questo motivo io penso che tu, in fase di maturazione, possa imparare qualcosa dalla mia esperienza.
Ricorderai come hai discusso con me di problemi legati al pensiero moderno. Ricorderai anche il mio atteggiamento. Non ho mai disprezzato le tue idee, né le ho mai prese in troppa considerazione. Non avevano solide fondamenta, perché eri troppo giovane per avere una tua esperienza. A volte ridevo, e tu ti mostravi spesso insoddisfatto. In quei momenti chiedevi che io dispiegassi davanti a te il mio passato, come un rotolo dipinto. Fu allora che cominciai a rispettarti, perché tu avevi deciso di afferrare, sia pure con una certa brutalità, qualcosa che era vissuto nella mia anima, volevi aprirmi il cuore e vedere il sangue scorrere. Io allora vivevo ancora. Non pensavo alla morte, e rimandavo la tua richiesta a qualche altro giorno. Ora, aperto il mio cuore con le mie stesse mani, voglio che il mio sangue bagni il tuo viso. E sarò soddisfatto se, quando il mio cuore avrà finito di battere, una vita nuova avrà trovato posto dentro di te.
3.
Non avevo ancora vent'anni quando persi i genitori. Mi ricordo che mia moglie te ne aveva parlato: entrambi morirono della stessa malattia. Se ricordo bene, mia moglie ti aveva detto che erano morti uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ne fosti sorpreso. La verità è che mio padre aveva contratto una forma letale di tifo intestinale; mia madre, che lo curava, ne fu contagiata.
Ero l'unico figlio maschio. Poiché la mia famiglia era abbastanza ricca, fui allevato lontano dalle preoccupazioni della vita. Considerando ora il mio passato, se i miei genitori non fossero morti allora, o se almeno uno di loro avesse continuato a vivere, avrei mantenuto fino ad ora la mia naturale generosità.
Mi lasciarono da solo, senza protezione come un bambino abbandonato. Non sapevo nulla, non avevo esperienza del mondo. Quando morì mio padre, mia madre non poté essermi vicino. E mia madre morì senza sapere che mio padre era già morto. Non so se l'avesse capito o se, come mi avevano detto, credesse che mio padre stava per riprendersi. Tutto quel che so è che lei chiese a mio zio di prendersi cura di ogni cosa. Io ero presente: lei fece un cenno verso di me, e disse a mio zio: “Ti prego, occupati di mio figlio”. Sembrava volesse aggiungere qualcos'altro, ma disse soltanto: “A Roma…” Lo zio rispose rapidamente: “Benissimo. Non preoccuparti”. Forse perché la costituzione fisica di mia madre le consentiva di sopportare la febbre alta, più tardi mio zio mi disse, con tono elogiativo: “È una donna coraggiosa”. Io non so se quelle poche parole di mia madre siano state le ultime oppure no. Certamente lei conosceva la terribile natura della sua malattia, e sapeva di esserne stata contagiata da mio padre. Ma non sono sicuro che lei pensasse di poterne morire. E per quanto fossero lucidi i discorsi che mia madre faceva quando aveva la febbre alta, spesso non lasciavano traccia nella sua memoria quando la febbre scendeva. Questo perché io… ma non importa. Sto solo tentando di dirti che io, già allora, cominciavo a rivelare la mia natura profondamente sospettosa, per cui non accettavo nulla senza prima averla attentamente esaminata. Per quanto possa essere irrilevante all'essenza del racconto, io penso che tutto ciò ti aiuterà a capire un lato del mio carattere. Ti prego di leggere tutti quei passaggi, quindi, sotto questa luce. La mia indole mi ha portato non soltanto a sospettare della moralità delle singole persone, ma a dubitare dell'integrità di tutta l'umanità. E vedrai tu stesso a quale grado arrivasse la mia capacità di sofferenza.
Ma sono uscito fin troppo dal seminato. Considerata la mia situazione, sono davvero molto tranquillo. Anche il rumore dei tram, che sembra diventare udibile solo quando il resto del mondo è andato a dormire, è ormai cessato. Fuori dalla finestra, il malinconico ronzio degli insetti comincia a farsi sentire e mi rammenta la rugiada dell'imminente autunno. Mia moglie, all'oscuro di tutto, dorme serena nella stanza accanto. La punta della mia penna stride mentre compongo le parole sul foglio di carta. La penna, a cui non sono abituato, mi scivola di lato, ma se usassi la tastiera mi sembrerebbe di correre confusamente dietro le angosce della mia mente.
© Paolo Melandri (17. 10. 2018)
*
Fino a dopo capodanno
Mio padre è morto prematuramente. È mancato all'improvviso quando io ero ancora un bambino incapace di comprendere la profondità dei sentimenti che legano i genitori ai figli. Forse perché ancora non sono padre, l'amore che nutro verso chi mi ha messo al mondo si è considerevolmente rafforzato nel corso degli anni. Come vorrei aver provato allora per i miei genitori gli stessi sentimenti che provo oggi! Da bambino ero molto freddo nei confronti di mio padre, anche se neanche lui era troppo espansivo con me. L'immagine di lui che oggi serbo nel cuore è quella di un uomo scostante e dall'espressione austera, con zigomi alti e l'incarnato pallido. Ogni volta che mi guardo allo specchio rimango sgradevolmente sorpreso di quanto io gli somigli. L'idea di poter risultare sgradevole come lui mi fa soffrire, e allo stesso tempo mi dispiace di non averlo conosciuto meglio. Come figlio, mi vergogno di ricordare di lui solo il lato più brutto e superficiale. Anche perché forse, così come nelle mie vene scorre molto più amore di quanto le mie tetre fattezze lascino supporre, non è escluso che in fondo al cuore mio padre nascondesse lacrime più calde delle mie! Due o tre giorni prima di morire, mi ha chiamato al suo capezzale per dirmi: “Flavio, quando sarò morto, dipenderai in tutto e per tutto da tua madre. Te ne rendi conto, vero?” Da quando ero nato era sempre stata mia madre a prendersi cura di me, per cui trovai strano che mio padre avesse sentito la necessità di rivolgermi quelle parole. Rimasi seduto in silenzio e poco dopo lui, movendo a fatica i muscoli del viso emaciato, proseguì: “Se continuerai a essere così disobbediente, le renderai la vita impossibile. Sforzati di essere più buono!” Fino a quel momento, mia madre non aveva avuto difficoltà a prendersi cura di me, quindi non riuscivo a capire perché dovessi modificare il mio comportamento. Lasciai la stanza certo che quella raccomandazione fosse del tutto inutile.
Quando morì, mia madre si abbandonò a un pianto irrefrenabile. Poco prima che il corteo funebre lasciasse la casa io, non sapendo cosa fare, uscii sulla veranda per ammirare il cielo azzurro. Poco dopo lei mi raggiunse. Indossava la veste nera del lutto. Riccardo, Lorenzo e gli altri uomini che avrebbero scortato il feretro erano tutti indaffarati dalla parte opposta della casa, cosicché sulla veranda c'eravamo solo noi due. A un tratto mi accarezzò i capelli tagliati a spazzola e, fissandomi con gli occhi gonfi per il pianto, mi sussurrò: “Non preoccuparti. Anche se tuo padre è morto, io continuerò a prendermi cura di te come ho sempre fatto!” Io non dissi nulla, e non versai una sola lacrima. Quei giorni sono ormai lontani, ma negli anni si è rafforzata in me la certezza che furono proprio le parole pronunciate allora dai miei genitori a gettare un'ombra sui ricordi che oggi ho di loro. Non sono mai riuscito a spiegarmi il motivo per cui ho sempre nutrito un così forte sospetto nei confronti di parole che non dovevano necessariamente avere chissà quale significato. Quante volte avrei voluto parlarne con mia madre, ma mi bastava guardarla in viso perché il coraggio mi venisse meno. Una vocina nascosta nei recessi del mio cuore mi sussurrava che, se mi fossi confidato con lei, avrei distrutto l'armonia del nostro rapporto; che se le avessi detto quello che realmente pensavo, non sarei più stato in grado di riguadagnarmi la sua confidenza. Anche senza arrivare a tanto, mia madre avrebbe potuto guardarmi dritto in faccia e, per togliersi dall'imbarazzo, con una risata avrebbe potuto chiedermi: “Ma davvero le nostre parole ti hanno turbato così tanto?” Immaginando il risultato crudele che un simile momento di sincerità avrebbe prodotto, ho giurato a me stesso che per nessuna ragione al mondo le avrei mai palesato i miei dubbi.
Non sono mai stato un figlio obbediente. Fin da piccolo mi sono sempre ribellato all'autorità di mia madre, il che spiega perché mio padre abbia sentito la necessità di convocarmi al suo capezzale poco prima di morire. Crescendo ho poi capito che dovevo essere più gentile, visto che dopotutto era mia madre. Eppure non sono mai riuscito a seguire i suoi consigli. Soprattutto negli ultimi due o tre anni sono stato per lei fonte di svariate preoccupazioni. Per quanto elevato sia il grado di confidenza tra una madre e un figlio, credo che il loro rapporto debba sempre mantenersi entro certi limiti. Tra noi non è mai successo nulla che abbia in qualche modo danneggiato la preziosità del nostro legame, e per questo sono convinto che, se le avessi confidato i miei dubbi, saremmo entrambi rimasti marchiati per sempre dalle ferite del rimorso. Ho sempre sospettato che a generare questa paura sia la mia indole irrequieta, anche se spesso ho l'impressione che questa apprensione sia più chiaramente rivolta al futuro che non al presente. Ecco perché sono tuttora molto addolorato di non essere riuscito a dimenticare le parole pronunciate dai miei genitori.
© Paolo Melandri (14. 10. 2018)
*
Non capisco
La mia è stata una vita di grande vergogna.
Non riesco lontanamente a immaginarmi cosa significhi vivere la vita di un essere umano. Nacqui in un paesino del nord-est, e soltanto quando fui grandicello vidi per la prima volta un treno. Mi arrampicavo su e giù dal ponte della stazione, totalmente ignaro che avesse la funzione di permettere alla gente di attraversare i binari. Ero convinto che quel ponte fosse adibito a impartire ai dintorni un tocco d'esotismo, e a rendere la zona della stazione un luogo d'ameno diversivo, simile ai giardini d'infanzia delle grandi città. Rimasi in questo abbaglio moltissimo tempo, e arrampicarmi su e giù dal ponte fu per me uno svago veramente squisito. Lo giudicavo uno dei servizi più eleganti messi a disposizione dalle ferrovie. Quando più tardi scoprii che il ponte era un espediente utilitario e nulla più, persi ogni interesse.
E ancora, quando da bimbo vedevo i treni della metropolitana riprodotti nei libri illustrati, non mi sognavo neppure che fossero stati inventati per soddisfare a una necessità di carattere pratico; potevo soltanto immaginarmi che correre nel sottosuolo invece che alla superficie della terra, dovesse essere un passatempo inusitato e stupendo.
Fin da piccolo sono sempre stato malaticcio, e costretto a letto di frequente. Quante volte, mentre ero disteso, mi avvenne di osservare quali squallidi elementi decorativi formassero federe e lenzuola. Non prima dei vent'anni mi resi conto che effettivamente servivano a un fine pratico, e questa rivelazione dell'insulsaggine umana provocò in me un cupo avvilimento.
E poi, non ho mai saputo cosa significhi aver fame. Con questa affermazione non intendo dire di essere cresciuto in una famiglia benestante – non ho ambizioni così banali. Intendo che non ho avuto la più pallida idea della natura di questa sensazione. A dirsi fa un effetto strano, ma non mi sono mai accorto una volta sola di avere lo stomaco vuoto. Quando da ragazzo uscivo da scuola e ritornavo a casa, i miei si davano un gran daffare per me. “Devi aver fame. Me lo ricordo io come si sta, la fame da morire che si prova quando si arriva a casa dalla scuola. Ti vanno le pastiglie di gelatina? Ci sono anche i biscotti e la torta.” Sforzandomi di compiacerli, come solevo invariabilmente, borbottavo qualche monosillabo per confermare che ero affamato, e mi cacciavo in bocca una manciata di pastiglie di gelatina, ma quello che loro intendevano per fame, mi sfuggiva completamente.
Si capisce che mangio moltissimo lo stesso, ma non serbo memoria, si può dire, di averlo mai fatto per fame. I cibi insoliti o complicati mi tentano, e quando vado a casa di qualcun altro, mangio quasi tutto quello che mi trovo davanti, anche se ciò richiede un certo sforzo. Da bimbo, il momento più penoso della giornata era senza dubbio l'ora dei pasti, specialmente tra le pareti domestiche.
Nella nostra casa di campagna tutti i membri della famiglia – eravamo una decina di persone – mangiavano insieme, allineati in due file, gli uni dirimpetto agli altri. Essendo il figlio minore, naturalmente avevo l'ultimo posto. La stanza da pranzo era buia e la vista dei dieci o più commensali che consumavano la colazione o qualunque altro pasto in tetro silenzio, bastava a mettermi i brividi addosso. Per giunta, si osservava un tenore di vita campagnolo e all'antica, in cui le vivande erano più o meno obbligate, e si sapeva che era vano perfino sperare in qualche pietanza insolita o complicata. Paventavo l'ora dei pasti ogni giorno di più. Me ne stavo seduto in fondo alla tavola nella stanza scarsamente illuminata, e, tremando da capo a piedi come se avessi freddo, mi portavo alla bocca pochi pezzetti di cibo e li cacciavo giù. “Perché gli esseri umani debbono consumare tre pasti ogni giorno che passa? Che facce strane, solenni, fanno tutti questi mentre mangiano! Sembra una specie di rito. Tre volte al giorno, all'ora fissata, la famiglia si raduna in questa malinconica stanza. I posti sono apparecchiati nell'ordine giusto e non conta che si abbia o non si abbia appetito, si mastica il cibo in silenzio, ad occhi bassi. Chissà mai? Potrebbe essere un atto di preghiera per propiziarci gli spiriti che forse si acquattano intorno alla casa...” A volte arrivavo al punto di formulare pensieri del genere.
In altre parole, si può dire che ancora non mi intendo per niente di come funzionano gli esseri umani. Quando scoprii che il mio concetto della felicità sembrava in pieno contrasto con quello di ogni altra persona, fu tale l'angoscia che mi dibattei gemendo insonne nel mio letto per notti e notti di seguito. L'ansia mi spinse addirittura sull'orlo della pazzia. Mi domando se sono mai stato veramente felice. Fin dalla mia prima infanzia, mi hanno detto e ripetuto non so quante volte che ero fortunatissimo, mentre ho sempre sentito di soffrire le pene dell'inferno. Anzi, mi è parso che chiunque mi chiamava fortunato fosse senza confronto più favorito dalla sorte di me.
Ogni tanto ho pensato che mi è stata imposta una soma di dieci disgrazie, ognuna delle quali, se la reggesse il mio simile, sarebbe sufficiente a fare di lui un assassino.
Insomma, non capisco. Mi manca l'indizio più remoto per comprendere la natura o la portata dei guai che possono affliggere il mio simile.
© Paolo Melandri (12. 10. 2018)
*
La nipote di Augusto
La nipote di Augusto
Mi sono sposato giovane, con l'approvazione dei miei genitori; io e mia moglie abbiamo avuto due figli maschi. Ero ambizioso e progettavo di diventare senatore; quindi mi davo molto da fare per coltivare le giuste amicizie, e mi restava pochissimo tempo da dedicare alla mia consorte, e ancora meno ai ragazzi. Lei era una madre ammirevole; loro mostravano nei miei confronti un rispettoso distacco. Mi adoperai in tutti i modi per avviarli alla carriera militare, che abbracciarono con successo, fin quando non caddero in battaglia, combattendo contro le popolazioni germaniche. Alla loro morte mi accorsi con rammarico di non conoscere quasi per niente quei due giovani di cui tutti tessevano le lodi. Credo sia abbastanza frequente, per un uomo alla seconda esperienza matrimoniale, rimpiangere le negligenze commesse durante la prima. Da quando era diventato perfettamente inutile, mi capitava di pensare spesso a loro. La mia prima moglie morì, e per anni rimasi solo. Mi ammalai, e impiegai molto a ristabilirmi. Gli amici che venivano a farmi visita mi consigliavano di risposarmi. Io ricordavo la mia consorte, giungendo alla conclusione che la nostra sarebbe stata un'unione d'amore, se le avessi dedicato il tempo necessario.
Durante la convalescenza venne ad accudirmi una lontana parente, una giovane di nome Giulia. Conoscevo bene il motivo di tanto interesse: la madre evidentemente sperava che il loro ricco congiunto 'facesse qualcosa' per lei e per gli altri figli. Ma erano troppi. Sapevo per esperienza che, quando si prende a cuore una persona che appartiene a una famiglia molto numerosa, nel giro di poco ci si deve accollare l'intera tribù. Giulia era una ragazza amabile, graziosa, sollecita, e non tirava mai in ballo i fratelli bisognosi. Mi piaceva, ne apprezzavo la genuina semplicità, le ingenue osservazioni da piccola provinciale dalla mente acuta, che osservava quanto accadeva intorno a lei in modo da adeguare il proprio comportamento allo stile di vita dell'élite. Posso affermare senza tema di smentita che mi considerava attraente, benché non ignorassi – e in questo mantenevo un atteggiamento cauto – che un uomo di una certa età non dovrebbe aspettarsi troppo da una bella donna con un terzo dei suoi anni. All'improvviso mi ritrovai la casa piena di giovani, parenti o semplici conoscenti, che mi vedevano come un benefattore, e mi convinsi che prima o poi lei avrebbe finito per sposare uno di loro, procurandomi un dispiacere; infatti – che contraddizione – non facevo che pensare alla mia prima moglie e a ciò che avevo perso. E poi mi tornavano in mente i miei figli, quei ragazzi così in gamba, cresciuti senza quasi che me ne accorgessi.
Chiesi a Giulia di sposarmi, proponendole un patto. Mi avrebbe reso padre due volte, e io non avrei preteso altro, assicurando a lei e ai bambini la tranquillità economica. Accettò, non senza esitazione, ben sapendo che tra i suoi pretendenti c'erano un mucchio di giovani. Ma non erano altrettanto ricchi. E inoltre le piacevo. Mi considerava un amico. O magari un tutore? Mi disse che amava conversare con me e ascoltare i miei discorsi. 'Imparo tanto, sai'. La sua ignoranza era pressoché totale.
Poi accadde un evento inatteso. Ero sicuro che quella ragazza dalle morbide forme e dalla pelle fresca ('la mia piccola pernice') avrebbe messo al mondo dei figli senza troppa fatica; invece la prima gravidanza si rivelò difficile, e il parto ancor di più. Ne attribuì la causa al fatto che da piccola era stata colpita da diverse gravi malattie, e non di rado aveva patito la fame. Se mi avesse chiesto di esentarla dall'adempiere fino in fondo al nostro accordo – dandomi il secondo figlio – non avrei rifiutato. Non mi aveva certo fatto piacere assistere a quella gestazione così problematica, culminata con un parto complicato. Ma la mia 'pernice' era una ragazza onesta, e affrontò la seconda gravidanza, sebbene anche stavolta le sofferenze non le fossero risparmiate.
Appena nate, le creature vennero affidate alle cure delle nutrici, e non credo che lei se ne sia più interessata. Non avevo pensato a inserire nel patto la clausola che, oltre a darmi due figli, dovesse comportarsi da madre. Quando però l'accusai di indifferenza nei confronti dei piccoli, replicò: “È orribile essere bambina e doverne accudire altri”. Seppi allora che era la maggiore dei suoi fratelli, con una madre cagionevole di salute, ed era stata lei a tirarli su, grazie all'aiuto, assolutamente insufficiente, di una giovane schiava fuggita da un grande latifondo, dove veniva trattata in modo crudele. La domestica, che era greca, parlava a mala pena la nostra lingua. Giulia aveva giurato a sé stessa che, una volta adulta, avrebbe rifiutato di sposare un uomo che non le avesse messo a disposizione dei servi: promessa alquanto impegnativa per una poverissima ragazza di provincia. Ma questo era il motivo per cui aveva deciso, d'intesa con la madre, di venire a offrirmi i suoi servigi, e spiegava altresì perché avesse tanto indugiato ad accettare il patto che le avevo prospettato. La mia richiesta di mettere al mondo un figlio, figuriamoci poi due, era quanto di più gravoso potessi proporle.
Aggiunse inoltre che non aveva mai avuto istinto materno. Quando aveva domandato alla madre per quale ragione solo a lei spettasse l'incarico di preparare da mangiare e lavare i fratellini, lei si era limitata a rispondere che così andavano le cose. Non è dato sapere che ne pensasse la schiava greca; del resto della sua opinione poco importa.
Le disinvolte osservazioni di Giulia venivano considerate audaci e molto originali, ma lei non si capacitava che la gente le trovasse tanto divertenti e la ricoprisse di lodi. Sono certo che all'inizio il suo intento non fosse quello di scandalizzare, benché stesse acquistando una certa fama per la sua impudente arguzia. Ben presto cominciò a frequentare circoli la cui nota distintiva era una sorta di annoiato cinismo, al quale pian piano si adeguò: le sue battute spontanee e immediate divennero una posa; quell'ambiente non mi piaceva, e della ragazza di provincia con una sua personale visione del mondo finì per rimanere ben poco.
Le feci notare che, alle persone della mia età, la sua generazione appariva egoista, dissoluta e amorale se paragonata a donne come mia madre, virtuose e celebri per la loro devozione e forza d'animo. Giulia mostrava interesse per quelle critiche, ma non ne sembrava minimamente scalfita, quasi avessi detto: “Sai che in Britannia esistono delle popolazioni che si dipingono il corpo di blu?” “Davvero?” avrebbe risposto, mentre un alone di dubbio le attraversava il volto. Tuttavia, certa che non mentissi, si sarebbe decisa a credermi. “Di blu, eh? Devono essere proprio buffi”. Con l'espressione aperta e franca che le era propria, avrebbe sorriso in segno di apprezzamento per quel mondo meraviglioso. Di lì a poco divenne celebre per l'immoralità e l'eccessiva inclinazione verso i piaceri, come tutte le donne della sua cerchia; me la immaginavo, con quel suo viso onesto, lo sguardo che manifestava una cordiale partecipazione, durante una di quelle orge in cui di tanto in tanto si lasciava coinvolgere, ascoltare un compagno che le proponeva la tale o tal'altra cosa e replicare: “Ah, sì? Davvero fanno questo? Be', divertente. Proviamo”.
Se Giulia non andava nella stanza dei bambini, io in compenso non riuscivo a staccarmene. Non mi ero mai sentito così coinvolto, nemmeno in occasione di un importante affare di Stato.
Quando i miei figli erano neonati, li guardavo stupefatto; quando poi ebbero tre, quattro, cinque anni, ogni giorno si trasformava in una rivelazione. Non interferivo con l'operato delle schiave che si occupavano di loro, a meno che uno dei piccoli non reclamasse un abbraccio e un po' di attenzione. Mi capitò di sentire una nutrice che diceva all'altra: “La madre è assente, ma ci pensa il nonno”.
© Paolo Melandri (8. 10. 2018)
*
Alba di primavera
Non appena Eraldo ebbe fatto le ordinazioni, prese la scatoletta da una tasca interna e la posò davanti a Lucrezia. La principessa l'aperse e proruppe in un'esclamazione.
“Era fatale che questo anello tornasse a voi”, disse Eraldo. E sforzandosi di usare il frasario più che schematico ed elementare le raccontò la storia del gioiello. Il sorriso che le aleggiava sul volto mentre ascoltava il suo interlocutore non era sempre motivato dal senso delle parole di quest'ultimo, sicché Eraldo fu portato a concludere che non seguisse pienamente il suo pensiero.
I seni, visibili al disopra del piano della tavola, a differenza del viso infantile apparivano in pieno rigoglio come quelli di una polena sulla prua di una nave. Pur senza vederlo, egli sapeva che sotto la sobria camicetta della studentessa seduta di fronte a lui si nascondeva un corpo in tutto degno delle divinità femminili negli affreschi murali del tempio di Iside a Pompei.
Le carni, meno lievi di quanto si potesse credere, e al contrario solide e piene, sembravano possedere la morbida compattezza di un frutto scuro… E la massa quasi soffocante delle chiome corvine, e quei tratti del volto, sognanti e ambigui, che dalle narici leggermente svasate scendevano verso il labbro superiore… Sembrava dimentica del linguaggio del proprio corpo non meno di quanto ignorasse la narrazione di Eraldo. I suoi occhi immensi, di un nero di giaietto, trascendevano l'intelligenza, e in certo qual modo la facevano sembrare cieca. Quale mistero si celava in quelle forme! Il fatto che Lucrezia elargisse al suo sguardo un incantesimo operatosi nella foresta remota, e i cui effetti si esplicavano a enormi distanze, fino in Italia. Eraldo ebbe l'impressione che la cosiddetta ereditarietà del sangue fosse, chissà, una voce profonda, confusa, indefinita, che ci incalza e ci insegue per l'eternità. Talvolta sussurro appassionato, talaltra grido rauco e soffocato, essa si situa alle radici di ogni bellezza fisica, e all'origine del fascino che dalle stesse si sprigiona.
Nell'atto di infilare al dito di Lucrezia l'anello verde cupo, ebbe la sensazione di vivere l'istante in cui quella voce profonda e lontana e la sostanza fisica della principessa erano alfine perfettamente fuse.
“Grazie, grazie davvero,” disse Lucrezia con un sorriso accattivante che avrebbe potuto compromettere la sua dignità. Eraldo si rese conto che si trattava dell'atteggiamento cui ricorreva sempre quando era certa che i suoi sentimenti egoistici venissero compresi. Ma non appena ebbe posto in atto il tentativo di trattenerlo, quel sorriso si era già dissolto, come l'onda che tosto si ritira.
“Quando eravate bambina, voi affermavate di essere la reincarnazione di un ragazzo romano che ho conosciuto molto bene. Ossessionavate quanti si occupavano di voi pretendendo ad ogni costo che Roma fosse la vostra vera patria, e insistendo per farvi ritorno. Ebbene, ora ci siete, e dal momento che recate l'anello al dito, ecco che anche per voi un grande cerchio si è chiuso.”
“Non capisco esattamente ciò che intendete dire,” rispose Lucrezia senza palesare la minima emozione. “Non rammento nulla della mia infanzia. Proprio nulla, credetemi. Tutti si burlano di me, dicendo che ero un po' matta, e mi deridono raccontandomi esattamente ciò che dicevate poco fa. Quando è scoppiata la guerra sono andata in Svizzera e vi sono rimasta fino alla fine delle ostilità. L'unica cosa che mi ricordo dell'Italia è che avevo una bambola napoletana. E mi piaceva moltissimo, sapete? Me l'aveva regalata qualcuno…”
Eraldo fu tentato di dirle che era stato lui l'ignoto donatore, ma poi preferì astenersene.
“Mio padre mi ha detto che le scuole italiane sono ottime, cosicché ho deciso di venirvi a completare i miei studi. Ultimamente mi è venuto fatto di pensare che negli anni della mia infanzia fossi una sorta di specchio che rifletteva i pensieri altrui. Probabilmente non facevo che dire ad alta voce tutto ciò che mi passava per la testa. Ammettiamo, insomma, che voi pensaste a qualcosa: ebbene, quel pensiero si rifrangeva in me. Sì, credo proprio che non si possa spiegare diversamente il fatto. Voi cosa ne pensate?”
Lucrezia usava concludere una frase interrogativa con un'inflessione ascendente della voce, tipica di chi si esprima in lingua inglese. La sua ultima sillaba rammentò ad Eraldo le code vivacemente sollevate dei serpenti d'oro che adornavano lo spigolo dei tetti dei templi di Iside, svettanti nell'azzurro abbagliante del cielo.
All'improvviso Eraldo si accorse della presenza di un gruppo familiare che sedeva a una tavola vicina. Il padre – probabilmente un commerciante o un affarista –, la madre e tre figli ormai adulti stavano consumando il pasto. Nonostante l'abbigliamento di gran classe, qualcosa nelle fattezze rivelava il modesto livello della loro estrazione sociale. Presumibilmente, fu il pensiero di Eraldo, avevano lucrato durante la guerra. I figli, in particolare, avevano un'espressione particolarmente mogia, simile a quella dei cani destati di soprassalto. Le labbra e gli occhi rivelavano l'assenza di ogni istruzione. Tutti inghiottivano la minestra con un rumore schioccante delle labbra.
Di tanto in tanto i figli si davano di gomito e lanciavano un'occhiata sardonica e furtiva in direzione del tavolo di Eraldo. Un vecchio ganimede che cenava in compagnia di una concubina che si spacciava per una studentessa. A quanto pareva, i loro occhi non avevano modo di esprimere qualcosa di più valido. Eraldo non pareva esimersi dal rievocare mentalmente l'esasperante inadeguatezza sessuale di cui Luciano aveva dato prova in quell'ora notturna, a Trastevere, e di operare un raffronto con se stesso.
In quei momenti, sentiva che nella vita vengono imposte regole più severe di quelle prescritte dalla morale. La punizione che spettava agli amanti inetti consisteva nell'impossibilità perpetua di tramutarsi in una fonte di sogni, e al contrario di non suscitare che un sentimento di disgusto. All'epoca in cui il concetto di umanesimo era ancora del tutto ignorato, l'uomo era certamente più crudele nei confronti delle creature laide e meschine di quanto lo fosse oggigiorno.
Terminato il pasto, Lucrezia chiese scusa e si ritirò nella toilette. Eraldo rimase solo nell'atrio d'ingresso. Subito peraltro avvertì un senso di sollievo. La sua tensione venne meno, ed egli apprezzò senza remora alcuna i vantaggi che gli derivavano dall'assenza fisica della principessa.
Poi fu indotto a riflettere che ancora ignorava ove Lucrezia si trovasse, la sera in cui aveva inaugurato la villa.
Trascorse qualche tempo prima che lei ritornasse nell'atrio. Eraldo si ricordò di quando aveva chiesto di far pipì alle sue dame, nel giardino di Caserta, poi la rivide nuda nell'atto di bagnarsi nelle acque brune del Sarno, tra le radici aggrovigliate degli eucalipti. Per quanto si fosse ingegnato di scrutarne attentamente il corpo, non era riuscito a individuare i tre nei che si aspettava di scorgere sul costato sinistro della bimba.
Ciò che Eraldo desiderava era in realtà molto semplice, e sarebbe stato sicuramente errato applicare a quel sentimento l'etichetta “amore”. Avrebbe voluto contemplare le forme completamente ignude della principessa, cosciente com'era che i piccoli seni appena visibili di un tempo erano maturati, ed ora sporgevano come due passerotti neonati che facessero capolino dal nido. Desiderava che le punte di quei seni si mostrassero loro malgrado, come avessero tenuto il broncio. Voleva che le ascelle brune riposassero nell'ombra lieve, che gli fosse dato di osservare come la superficie inferiore delle braccia comportasse un susseguirsi di motivi dolcemente ondulati, come le increspature di una proda vibratile e sabbiosa, che gli fosse accordato di scoprire come ogni passo verso l'età matura progredisse nella luce confusa e decrescente, onde a quel punto lo percorresse un brivido raffrontando il corpo di Lucrezia a quello della bambina ch'era stata.
Ed era tutto. Nel suo ventre immerso in una dolce purezza, l'ombelico incavato sarebbe stato simile a un minuscolo atollo corallino. Protetto non più da fasce, ma da una spessa coltre di capelli, ciò che un tempo aveva presentato l'austera serietà di un silenzio totale ora si sarebbe tramutato in un susseguirsi di sorrisi umidi e incessanti. Avrebbe visto mirabilmente dischiudersi, una per una, le mirabili dita dei suoi piedi, avrebbe ammirato i riflessi delle cosce, le gambe adolescenti allungarsi per meglio sorreggere le norme e i sogni della danza esistenziale. Tutto questo voleva raffrontarlo alla sua figuretta infantile. Tutto questo significava avere la rivelazione del tempo, scoprire ciò che il tempo aveva plasmato e maturato. Se un'attenta ispezione corporea non avesse rivelato l'esistenza dei tre nei, si sarebbe innamorato di Lucrezia, senza ritegno, definitivamente. La trasmigrazione gli sbarrava la strada all'amore, mentre il samsara teneva a freno gli slanci della sua passione.
Il ritorno di Lucrezia pose fine ai suoi sogni, ed egli dette voce ai suoi pensieri. Nonostante tutto, le parole di Eraldo risuonarono contratte e inasprite da gelosa angoscia.
“Ho dimenticato di domandarvi una cosa. A quanto pare, la notte precedente il ricevimento a casa nostra, a Ostia, non siete rientrata alla Casa dello studente. Dove diamine avete dormito? Forse in casa di una famiglia ostiense?”
“Sì,” continuò Lucrezia senza esitare, mettendosi a sedere in una poltrona accanto a quella di lui, il dorso un tantino ricurvo e l'occhio rivolto alle sue belle gambe che teneva serrate l'una all'altra. “Vi abita una ragazza norvegese. Una mia compagna di corso. Tutti i familiari hanno insistito perché mi trattenessi a dormire, e ho finito per accettare.”
“Una famiglia con tanti giovani dev'essere divertente, immagino.”
“Be', non proprio… I due ragazzi, la ragazza e la mia amica abbiamo giocato alle sciarade. Il padre è direttore di una grossa impresa finanziaria che opera nel sud Italia. Per questo si mostrano estremamente cortesi con chiunque sia originario di quelle parti.”
“Avrei preferito che la vostra amica norvegese fosse stata di sesso maschile.”
“Di sesso maschile… E perché?”
Di nuovo Lucrezia conferì alla sua domanda un'inflessione particolarmente accentuata.
Al che Eraldo proseguì disapprovando il fatto che si fosse fatta ben pochi amici italiani. Vivere all'estero, l'ammonì, non ha nessuno scopo se non si stabiliscono rapporti con ogni specie di persone, indicative del paese nel quale abbiamo scelto di completare i nostri studi.
Dal momento che il consumare il pasto a tu per tu con lui poteva forse metterla a disagio, le propose, alla prossima occasione, di portare con lei l'uno o l'altro dei suoi giovani amici, provocando in tal modo – sia pure a livello inconscio – il pretesto per rivederla un'altra volta. Dopo di che la indusse a promettere che nello stesso giorno della settimana successiva lo avrebbe atteso nell'atrio dell'Hotel alle sette di sera precise. Il pensiero di sua moglie Costanza lo dissuase dall'ipotesi di invitarla a cena a casa sua.
© Paolo Melandri (4. 10. 2018)
*
Circoscrivere
È ormai tempo che mi dedichi al mio problema. Chi non ce l'ha, un problema – ciascuno ne ha uno e perfino più d'uno. Hanno valori diversi: il problema principale invade il centro dell'esistenza, rimuove gli altri. Senza sosta ci accompagna come un'ombra e incupisce la mente. È lì anche quando ci svegliamo di notte; ci balza addosso come un animale.
Un uomo di tanto in tanto ha mal di testa; non è piacevole, ma esistono rimedi. Il caso si fa serio se un giorno egli sospetta che ci sia sotto qualcosa – forse un piccolo tumore. Ora l'ansia fugace diventa permanente; diventa l'ansia principale.
2.
Eppure anche un'ansia principale come questa è cosa di tutti i giorni. Ce ne convinciamo pensando alla statistica – infatti, mentre il nostro uomo rimugina sul suo tumore, nello stesso momento un'ansia identica opprime sul pianeta molte migliaia d'altri. Egli dunque la divide con loro? Certamente, e tuttavia rimane il suo problema privato e indivisibile. È in gioco l'insieme – sotto il mal di testa si nascondeva il tumore, ma ancor più sotto forse c'è dell'altro, per esempio un carcinoma.
Va anche considerata l'eventualità che non ci sia sotto NIENTE – il problema si fonda sull'immaginazione. Anche l'angoscia ha le sue mode – oggi predilige la guerra atomica e il carcinoma, dunque la rovina collettiva e quella personale.
Un tempo, quando infieriva la paralisi, specie negli strati superiori e lì in particolare fra gli artisti, molti s'immaginavano di esser colpiti da questo male, e più d'uno per questo si uccise. Ma è proprio quando sotto non c'è niente che il problema diventa più inquietante. Il terrore non incombe più in una forma o nell'altra, ma con tutto il suo indiviso potere.
3.
A colazione, quando mescolo nella tazza e seguo la rotazione degli addensamenti, mi balza agli occhi la legge secondo cui si muove l'universo – nel gorgo delle nebulose, nel vortice delle galassie.
Dal che possono trarsi conseguenze intellettuali e anche pratiche. Lo spettacolo mi ricorda la mela di Newton, o il vapore che Watt fanciullo vide scaturire dalla teiera ben prima di inventare la sua macchina. «Questo dà da pensare» diciamo. A quanto sembra l'atto di pensare è preceduto dalla sintonia con la materia, a cui segue quello stato di fantasticheria che genera il pensiero e lo suscita.
Ma a che serve? Che l'universo ruoti o si disgreghi – sotto rimane il problema.
4.
Il problema è indivisibile; l'uomo è solo. In definitiva non ci si può affidare alla società. Benché il più delle volte sia nociva e spesso perfino distruttiva, la società può anche aiutare, ma non più di un bravo medico – fino al limite inevitabile dove tutta la sua arte vien meno.
Soprattutto niente malinconia. Il singolo può darsi conforto conoscendo la propria situazione. Un tempo le religioni gli facilitavano il compito. Il loro stretto legame con l'arte non è casuale, perché ne sono le invenzioni supreme.
Ora che gli dèi ci hanno abbandonati, siamo costretti a ricorrere alla loro origine, l'arte. Dobbiamo farci un'idea della cosa o della persona che raffiguriamo. Da qualche parte dev'esserci un laboratorio. Un vasaio produce anfore, brocche, comuni stoviglie. La sua materia prima è la creta; tutto nasce nel volgere dei tempi, quindi ricade in polvere e ridiventa materia prima, per noi.
La nostra posizione sociale o morale non ha alcun rilievo in tutto questo. Possiamo essere un principe o un bracciante, un pastore, una puttana, un tagliaborse – o, il più delle volte, come me, un uomo comune.
Ognuno ha il suo ufficio, il suo compito. Quale sia stato il pensiero che ha presieduto alla nostra creazione, quale lo scopo cui siamo chiamati – chi ce ne trasmette anche una vaga idea ci nobilita.
5.
Ora io non sono un poeta; debbo ammetterlo, benché sia capace di esprimere «ciò che soffro» – peraltro solo nella forma del soliloquio. «Esprimere»: è certo questa la parola giusta, quale che sia il risultato. Si tende insomma a una liberazione, a una sorta di confessione nella speranza di autoassolversi. Nessun altro giudice, nessun prete sopra di me.
Il mio tempo è limitato, ma chiunque può ritirarsi per un mese nel bosco o nel deserto. Laggiù può descrivere il suo problema, o piuttosto: circoscriverlo – almeno sarà definito, ancorché non risolto. Forse ne farà un poema, oppure troverà una caverna e lo confiderà alle pareti in tinte nere, gialle e rosse. Ivi potrà sonnecchiare finché un archeologo lo scopra e tenti di decifrarlo; ma è meglio che resti celato per sempre.
© Paolo Melandri (27. 9. 2018)
*
Linea bianca
Il cielo è nuvoloso, e avvolge me e l'ospedale addormentato come un morbido panno bianco. Ogni volta che il vento mi rinfresca le guance ancora avvampate di calore, sento il frusciare delle foglie degli alberi. Il vento, gonfio di umidità, porta con sé l'odore delle piante che nella notte respirano silenziose.
Nell'ospedale sono accese soltanto le luci di emergenza dell'ingresso e dell'accettazione, il resto è buio per i pazienti che dormono. Sulle tante finestre, ritagliate entro sottili telai di alluminio, si riflette il cielo che attende l'alba.
C'è una linea viola che corre rifrangendosi, credo che sia uno squarcio nelle nuvole.
I fari delle auto che passano di tanto in tanto illuminano i cespugli, simili a cappelli da bambino. La falena che avevo buttato non era arrivata fin là. Stava lì per terra in mezzo ai sassi e ai pezzetti di erba secca. Ho provato a raccoglierla; la peluria che avvolgeva il corpo era tutta impregnata di rugiada mattutina. Come se quell'insetto morto avesse i sudori freddi.
Mentre uscivo di casa di Lia avevo avuto l'impressione che solo il mio braccio sinistro, da cui usciva copioso il sangue, fosse in vita. Mi sono messo in tasca il sottile pezzo di vetro tutto sporco di sangue, e ho corso lungo la strada nebbiosa. Le porte e le finestre delle case erano sbarrate, non c'era nulla che si muovesse; ho pensato a me stesso come al protagonista di una fiaba che viene inghiottito da un essere gigantesco e sballottato continuamente dentro al suo stomaco.
Sono caduto non so quante volte, e ogni volta il pezzo di vetro che avevo in tasca si frantumava in pezzetti più piccoli.
Mentre stavo attraversando uno spazio aperto, sono crollato sull'erba. Allora mi sono messo a masticare dei fili d'erba bagnati. Un sapore amaro mi ha irritato la lingua, e mi è entrato in bocca un piccolo insetto che stava riposando sul prato.
L'insetto si dibatteva con delle sottili zampe frastagliate.
Mi sono infilato un dito in bocca, e allora l'insetto, rotondo con disegni sul dorso, è sgusciato fuori inzuppato della mia saliva. Scivolando sulle zampe bagnate, è ritornato sull'erba. Mentre passavo la lingua sulle gengive irritate dall'insetto, la rugiada sul prato mi rinfrescava il corpo. L'odore dell'erba mi avvolgeva completamente, e ho avuto la sensazione che il calore che mi aveva assalito defluisse pian piano nel terreno.
Avevo sempre toccato con mano qualcosa per me incomprensibile, ho pensato disteso sull'erba. Qualcosa che sicuramente non è cambiato neppure adesso, neanche adesso che sono qui nel giardino dell'ospedale, in questa notte carezzevole. Quell'enorme uccello nero sta volando anche adesso, e io sono rinchiuso nel suo ventre con l'erba amara e l'insetto rotondo. Non si può sfuggire a quell'uccello, a meno che non si renda il nostro corpo duro e secco come quello della falena, che è diventata come un sasso.
Ho estratto dalla tasca il frammento di vetro grande ormai quanto l'unghia di un pollice, e l'ho ripulito dal sangue. Il piccolo pezzo di vetro è incavato dolcemente, e riflette il cielo che ha iniziato a rischiararsi. Sotto il cielo si allunga orizzontalmente l'ospedale, e in lontananza si vede un viale alberato e la città.
La città, che si riflette come un'ombra, crea con il suo profilo una tenue linea ondulata. Una linea uguale a quella biancastra che mi si era impressa a fuoco negli occhi per un solo istante, insieme ai fulmini, in quell'aeroporto sotto la pioggia, quando stavo per uccidere Lia. Una delicata linea ondulata come l'orizzonte marino che si vede confuso quando il mare è in burrasca, come le braccia bianche di una donna.
Fino a oggi ero sempre stato avvolto, in qualsiasi momento, da quella linea ondulata biancastra.
Il frammento di vetro ha ancora del sangue sui bordi; irradiato dai vapori dell'alba, è quasi trasparente.
È di un blu senza contorni, quasi trasparente. Mi sono alzato in piedi, ho camminato in direzione di casa mia. Ho pensato di voler diventare come quel pezzo di vetro; di voler provare a riflettere io, allora, quella delicata linea ondulata. Di voler mostrare anche agli altri quella dolce linea ondulata riflessa su me stesso.
Un'estremità del cielo si è rischiarata, e il frammento di vetro si è subito offuscato. Quando si è sentito il cinguettio degli uccelli, sul vetro non c'era riflesso più niente.
Accanto al pioppo di fronte a casa c'è l'ananas che avevo buttato ieri. Dall'apertura umida si diffonde ancora quell'odore.
Mi sono accovacciato a terra, e ho aspettato gli uccelli.
Gli uccelli sono scesi volteggiando; se la luce calda arrivasse fin qui, la mia ombra allungata avvolgerebbe gli uccelli grigi e l'ananas.
© Paolo Melandri (26. 9. 2018)
*
Uno sciocco
In quei tempi ero combattuto da due opposti sentimenti; l'amavo follemente ma sentivo anche una grande delusione. Ero cosciente insomma d'aver fatto una scelta sbagliata. Beatrice non era così intelligente come avevo sperato; ne ero ormai certo anche a volerla considerare con i benevoli occhi di colui che ama. Compresi allora che era stato un bel sogno la speranza che lei potesse diventare una donna di valore. Non ci si può illudere su chi è cresciuto male, pensai. In fondo, per una ragazza del quartiere di Scampia il mestiere di cameriera in un locale pubblico era più che adatto. Era inutile quindi tentare di darle un'educazione non confacente alla sua natura. Cominciai a rassegnarmi con tristezza, e d'altra parte ero fortemente preso dal suo corpo. Sì, adopero la parola “corpo”. Perché ciò che mi affascinava in lei era la bellezza della pelle, dei denti, degli occhi, insomma, di tutta la sua forma, e in tutto questo non vi era nulla di spirituale. Mentre dal punto di vista dell'intelligenza Beatrice aveva mancato alle mie aspettative, la sua bellezza fisica aumentava sempre più verso il mio ideale, superandolo addirittura. Più pensavo che era stupida e incorreggibile, più mi sentivo attratto dalla sua bellezza in maniera quasi perfida. Col passare del tempo dimenticai il mio proposito iniziale di renderla una donna di valore. Anzi, cominciavo a farmi trascinare da lei. E quando mi accorsi di aver sbagliato era troppo tardi e non potevo più farci nulla.
In questo mondo non tutte le cose vanno come si vorrebbe. Avevo sperato che Beatrice diventasse bella sia nel corpo sia nello spirito. E se avevo fallito nel campo spirituale, non avevo avuto successo forse nel senso fisico? A pensarci bene, non avevo sperato che il suo corpo diventasse bello fino a questo punto. Il successo non era più grande del fallimento?
“Giovanni, da diverso tempo non mi chiami più stupida durante la lezione di inglese,” disse Beatrice che aveva già intuito il cambiamento nel mio cuore. Pur essendo tarda nello studio, era molto acuta nel leggermi in viso.
“Se ti sgrido troppo diventi ostinata e ottengo solo un risultato negativo. Ho pensato quindi di trattarti in modo diverso.”
“Uhm…” rispose ridendo impertinente, e aggiunse: “È naturale. Se mi dai sempre della stupida, senza nemmeno un giusto motivo non ti obbedirò mai. A dirti il vero sapevo rispondere a gran parte delle tue domande. Ma per dispetto facevo finta di non farcela. Tu però non te ne sei accorto, vero?”
“Davvero?” rispondevo fingendo di meravigliarmi, pur sapendo benissimo che era tutto un bluff per non riconoscere i propri difetti.
“Certo. Uno qualsiasi avrebbe capito un problema del genere. Stupido sei tu se pensavi sul serio che non sapevo la risposta. Ogni volta che ti arrabbiavi mi trattenevo a stento dal ridere.”
“Oh, che tipo sei! Allora mi imbrogliavi completamente!”
“Capito? Ammetti ora che sono più intelligente di te?”
“Sì. Sei molto furba. Non c'è nulla da fare.” A queste parole, Beatrice rideva a crepapelle, tutta orgogliosa.
Cari lettori: non ridete se a questo punto vi racconto un episodio avvenuto molti anni prima. Quando ero ancora ragazzo e frequentavo la scuola media, durante una lezione di storia, studiammo la vicenda di Antonio e Cleopatra. Sapete anche voi la storia. Antonio attende la flotta di Ottaviano nelle acque del Nilo e ha luogo una battaglia navale. Quando appena cominciò a delinearsi la possibilità di una sconfitta di Antonio, Cleopatra, che l'aveva seguito fin lì, subito ordinò di voltare la sua nave e di mettersi in fuga. Non appena Antonio s'avvide della diserzione della perfida regina, sebbene il momento fosse disperatamente critico e decisivo, dimenticò completamente la battaglia per inseguire Cleopatra. “Ragazzi,” disse l'insegnante di storia, “quest'uomo di nome Antonio finì col perdere la vita per rincorrere un didietro di donna. Non c'è mai stato nella storia uno che abbia messo in mostra la propria stupidaggine in modo così evidente. Già, è un vergognoso esempio, un oggetto di derisione nell'intera storia dell'umanità… Un eroe ridotto in quello stato…”
Poiché la sua maniera di spiegare l'episodio era molto divertente, tutti scoppiarono a ridere guardando il volto dell'insegnante. Anche io, naturalmente, risi con gli altri.
Il punto importante è però qui: non riuscivo allora a capire come mai un uomo tanto degno come Antonio avesse perso la testa per una donna così perfida. Non è stato poi il solo. Subito prima di lui, anche il grande Giulio Cesare, preso nei lacci di Cleopatra, non fece in verità una bella figura. Né questi sono gli unici esempi. Se indaghiamo su vari episodi delle lotte di successione tra le potenti famiglie dell'epoca rinascimentale, vi sarà sempre qualche donna fatale e terribile. È vero poi che queste insidie sono fatte in modo così abile e malizioso, che appena uno ne rimane coinvolto viene ingannato senza scampo? A me non sembra. Infatti, pur ammettendo che Cleopatra fosse una donna molto furba, non posso credere che la sua intelligenza superasse quella d'un Cesare o di un Antonio. Non occorre essere un eroe per capire, solo che si stia un poco attenti, se le parole di una donna sono vere o false. Perciò, se uno si lascia ingannare pur sapendo che la situazione può condurlo alla rovina, è segno di troppa debolezza, di troppa impotenza. Se le cose stanno proprio come raccontano, può darsi che questi eroi dopo tutto non fossero dei grandi personaggi.
Accettai quanto asserito dal mio insegnante: cioè che Antonio era un oggetto di derisione e nessuno come lui aveva messo in mostra così generosamente la propria stupidaggine.
Ancora oggi mi tornano in mente le frasi dell'insegnante insieme all'immagine di me stesso, nei banchi di scuola, che ridevo da matto con i compagni. Ma ora sento nel profondo dell'animo che non sono più degno di disprezzare il comportamento di Antonio. Perché oggi penso di comprendere perfettamente – non solo, ma ne sento una profonda compassione – come l'eroe romano si fosse ridotto a tanto strazio e come fu possibile per un grand'uomo quale Antonio lasciarsi sedurre senza nessuna resistenza.
In genere si dice che la donna inganna l'uomo. Invece, secondo la mia esperienza, non è che la donna abbia all'inizio l'intenzione di ingannare. L'uomo piuttosto è contento di essere ingannato. Quando si è innamorati di una donna, tutto di lei piace all'uomo, sia quando gli dice la verità che quando mente. A volte, quando una donna, con finte lacrime, si abbandona su di lui, l'uomo pensa: “Ho capito, vuole vincere con questi trucchetti. Però sei proprio buffa, sai. Come mi piaci. Leggo bene nel fondo del tuo cuore, ma voglio lasciarmi ingannare solo per riconoscere se ce la metti tutta. Inganna, inganna quanto vuoi…” Così, considerandolo un gesto di magnanimità, l'uomo volontariamente si lascia prendere nelle mene di lei, quasi come si fa per accontentare i bambini. Ma ride in cuor suo raccontando a se stesso che è lui che la inganna.
La dimostrazione eravamo io e Beatrice.
“Sono più intelligente di te, Giovanni.” Con queste parole, Beatrice pensava di avermela fatta. Io fingevo di essere il tonto e di farmi ingannare. Invece di svelare la sua sciocca falsità, preferivo vederla contenta e orgogliosa. Per di più, avevo trovato perfino una scusa per soddisfare la mia coscienza. Mi dicevo: pur ammettendo che Beatrice non sia intelligente, non c'è nulla di male nel farle avere fiducia in se stessa. Il più grande difetto di una donna italiana è la mancanza di fiducia. Appunto per questo appaiono impacciate se vengono paragonate e a una francese o a una tedesca. Una donna moderna viene definita bella non tanto per le fattezze del volto ma principalmente per le espressioni e per gli atteggiamenti pronti e intelligenti. Anche quando non si tratta di una vera e propria fiducia in se stessa, se riusciamo a convincerla per pura vanità che è bella e intelligente, in effetti lo diventa davvero. Convinto di ciò, io non soltanto incoraggiavo la presunzione di Beatrice di essere intelligente, ma volevo inculcargliela sempre più.
Per esempio, a quei tempi giocavamo spesso a carte o a scacchi. Bastava che giocassi sul serio per vincere facilmente. Ma giocavo male di proposito per farla vincere. Ciò servì tuttavia solo a dare una sbagliata presunzione a Beatrice, che in seguito si mise in testa di essere molto più abile di me in qualsiasi gioco di azzardo.
“Su, Giovanni, facciamo una partita? Ho voglia di annientarti,” diceva sfidandomi in tono altezzoso.
“Va bene. Ma questa volta mi prenderò la rivincita. Se mi metto d'impegno non vincerai mai. Se perdo è perché non riesco a prendere sul serio una partita con una bambina.”
“D'accordo. Ma ti consiglio di cantare dopo la vittoria.”
“Va bene. Ma sappi che questa volta perderai.”
E con tutto ciò, facevo volutamente delle mosse sbagliate e come sempre le cedevo la vittoria.
“Che ne dici, Giovanni? Non ti vergogni di essere sconfitto da una bambina?… Non c'è nulla da fare, sai. Ormai avresti dovuto capire che non puoi competere con me. Mah, che roba! Quando un uomo di trent'anni perde con una ragazzina di appena vent'anni, vuol dire che non sa nulla di come si deve giocare.”
Ma la cosa terribile fu quanto inevitabilmente ne conseguì. All'inizio dicevo e facevo queste cose per darle allegria. Quando poi questo mio comportamento diventò abituale, Beatrice cominciò ad avere una tale fiducia nelle proprie capacità che io non riuscivo più a dominarla con tutte le mie forze.
In genere, le vittorie tra uomo e uomo non vengono conseguite con la sola intelligenza, ma sono importanti anche la forza di volontà e il carattere dei singoli. In altre parole entra in gioco l'elettricità animale. Ciò si verificava soprattutto nei giochi di azzardo. E quando mi mettevo a combattere Beatrice, lei vi si dedicava sin dall'inizio convinta della propria vittoria. Così mi spingeva piano piano e mi sopraffaceva completamente.
“Non c'è alcun gusto a giocare per niente. Perché non scommettiamo qualcosa?” E gustato una volta il sapore della scommessa, non voleva più giocare senza scommettere. E quanto più si scommetteva tanto più le mie perdite diventavano alte. Beatrice cominciava il gioco senza avere danaro, ma stabiliva di sua iniziativa una posta di cento o duecento euro, guadagnando quanto le occorreva per le piccole spese.
“Se avessi trecento euro comprerei subito quel vestito… Ma posso sempre vincerli a carte,” diceva, e veniva subito a sfidarmi. Raramente accadeva che Beatrice perdesse, ma anche in tal caso aveva pronto qualche trucco. Se voleva ottenere a ogni costo del danaro, nulla le impediva di vincerlo.
Quando si giocava, Beatrice indossava spesso una larga vestaglia in modo che in qualsiasi momento poteva mettere in atto la sua strategia preferita. Quando notava che una partita volgeva in mio favore, apriva un po' la vestaglia, o si scopriva le gambe e, se ciò non bastava, si appoggiava ai miei ginocchi per carezzarmi le gote o mi dava qualche pizzicotto in angolo della bocca; insomma, qualsiasi tentazione era buona. Quando poi ricorreva all'ultimo trucco – che non posso descrivere – la mia testa cominciava ad annuvolarsi e un buio improvviso calava davanti ai miei occhi.
“Beatrice, tu imbrogli. Non si fa così!”
“No, non imbroglio affatto. Anche questa è una mossa.”
Così, col cervello che si annebbiava lentamente e senza capire più nulla, vedevo solo vagamente il volto di Beatrice colmo di seduzione. Il suo volto sogghignava stranamente…
“È un imbroglio. Tu bari. La tua mossa non è nelle regole del gioco!”
“Come no! Esiste di sicuro. Quando una donna gioca con un uomo usa tutte le specie di fatture. L'ho visto fare altrove. Da bambina, sedevo spesso vicino a mia sorella maggiore quando a casa giocava a carte con un uomo. Vedevo che aveva sempre pronta qualche fattura.”
Considerando tutto ciò debbo pensare che Antonio fu conquistato da Cleopatra proprio in questo modo. E così, a poco a poco, gli venne a mancare la forza di resistere e la sua volontà fu totalmente annullata. È bene agire in modo che la donna acquisti la fiducia in sé, ma come inevitabile conseguenza l'uomo finisce col perdere fiducia nelle proprie capacità. A questo punto non si riesce più a controllare la superiorità femminile e da ciò, inaspettatamente, sorgono mali peggiori.
© Paolo Melandri (23. 9. 2018)
*
Scarpe
Ho fatto un sogno orribile.
Ero un uccello nero, enorme, che volava verso ovest sopra la giungla. Avevo una profonda ferita, le ali imbrattate di sangue. Il cielo a occidente andava coprendosi di uno strato di nuvole scure di pessimo auspicio, si sentiva odore di pioggia.
Per accorgermi che stavo sognando – erano secoli che non mi accadeva – ci misi parecchio tempo.
Mi alzai, lavai via il sudore sotto la doccia, poi feci colazione con un toast e del succo di mela. Sigarette e birra mi avevano lasciato in gola un gusto sgradevole, come di stracci vecchi. Gettai i piatti sporchi nel lavello, poi misi una camicia di cotone verde oliva più o meno stirata, e con la cravatta in mano – ne scelsi una di maglia nera – andai a sedermi in soggiorno davanti al condizionatore.
Alla tele, il tipo del telegiornale stava dicendo in tono convinto che quel giorno sarebbe stato probabilmente il più caldo dell'estate. Spensi l'apparecchio, entrai nella stanza accanto, che era quella di mio fratello, dalla montagna dei suoi libri ne scelsi un certo numero e tornai nel soggiorno, a sfogliarli sdraiato sul divano.
Due anni prima mio fratello se n'era andato in America senza dare uno straccio di spiegazione, abbandonando la sua stanza piena di libri e la sua ragazza. Ogni tanto pranzavo con lei. Una volta mi disse che mio fratello e io ci assomigliavamo molto.
– In che cosa? – le chiesi.
– In tutto, – mi rispose.
Può darsi che sia vero. Forse perché per più di dieci anni ci siamo dati il cambio a lucidare le stesse scarpe.
© Paolo Melandri (20. 9. 2018)
*
Una donna forte
Quella sera i nervi tesi di Barbara cedettero.
S'infilò a letto: voleva addormentarsi senza aspettarlo. Tuttavia, sempre più sveglia, non riuscì a trovare pace. Indossò la vestaglia da camera e accese la radio per ascoltare le trasmissioni notturne. Non poteva sopportare il profondo silenzio dell'appartamento in piena notte.
Non c'era più traccia neanche del piacere che invadeva la stanza quando viveva da sola, innamorata di Vincenzo. La sua ricca solitudine non esisteva più. Al suo posto, soltanto una sensazione di terribile vacuità, una lunga notte in cui anche le ombre degli angoli della casa sembravano in attesa, tremanti d'angoscia.
“Non doveva andare così!”
Nel profondo del proprio cuore Barbara pronunciò parole che mai avrebbe voluto dire.
Le era sempre piaciuto dormire da sola nel suo grande letto, lo spazio superfluo le garantiva un buon sonno. Adesso, però, tutto quello spazio le impediva di dormire.
Vincenzo per abitudine dormiva nudo, con un semplice tessuto di cotone sull'addome. Mentre si girava nel letto, il suo corpo sfiorava quello di Barbara, e lei era vittima di quell'onda calda che irrompeva su di lei a intervalli regolari. Era bastato un mese perché si abituasse ad avere una presenza al suo fianco, ormai indispensabile a farla addormentare.
Ormai qualcosa aveva fatto il nido da qualche parte nella sua vita e nel suo spirito. Era qualcosa di più brutale dell'amore, qualcosa che non era facile esprimere e che aveva messo radici. Barbara doveva suo malgrado ammetterne l'evidenza.
“No, non è possibile che io sia gelosa!” continuava a ripetere dentro di sé.
Essere gelosa avrebbe significato che una malattia si era impossessata di lei nel giro di un mese. Quindi no, non era gelosia.
E se fosse stato un dolore da provare prima o poi nella vita, a quanto pare non si era accontentato di annunciarsi a distanza e restare lì. No, era qualcosa di folle e di vicino a lei, ma cosa?
“E se rinunciassimo alla convivenza, tornando ognuno a vivere per conto proprio?”
Per la prima volta il pensiero la attraversò. Tuttavia, non era possibile che due persone, dopo aver vissuto insieme, tornassero allo stadio precedente. Avrebbe significato la fine del loro amore.
Non era una sera particolarmente calda, eppure Barbara aprì il congelatore e iniziò a mangiare cubetti di ghiaccio. Avrebbe voluto infilare la testa lì dentro e tenercela un'oretta. Che sollievo sarebbe stato: staccare la testa dal collo e lasciarla al fresco come un'anguria!
La tristezza e l'angoscia divennero insopportabili. Aveva acceso tutte le luci della casa, in soggiorno, in sala da pranzo, in camera da letto. Stava camminando su e giù per le stanze illuminate quando sentì una presenza dietro di sé. Ma non era altro che la sua stessa immagine, riflessa nello specchio dell'armadio.
Si sedette su un tappeto.
“Lo lascio! Lo lascio! Lo lascio!”
Lo ripeté centinaia di volte, pur sapendo che si trattava solo di un inutile mantra. Stupita di quanto fosse lunga la notte, tirò fuori il servizio da manicure e, sul pavimento, si fece le unghie delle mani e dei piedi, una a una, il più lentamente possibile. Lo smalto, sotto la forte luce elettrica, sembrava assurdamente vistoso con quel rosso scarlatto; si consolò immaginandosi come una donna vergognosamente dissoluta. In verità, dissoluto era il suo amante, lei era soltanto innamorata.
Alle otto del mattino, quando sentì la chiave girare delicatamente nella serratura, non poteva più credere che quello fosse il rumore tanto atteso.
Decise di accoglierlo con un'espressione fredda e ingenua.
“Ah, sei già sveglia?” le chiese Vincenzo.
A vederlo nel chiarore del mattino, con i suoi occhi ammiccanti illuminati da ogni dove, Barbara, senza neanche rendersene conto, si gettò in lacrime tra le sue braccia.
Vincenzo la sollevò e la portò singhiozzante in camera da letto.
“Sei una sciocca! Tu… Tu… Ti credi troppo forte e poi finisci per disperarti. Ecco cosa succede a fare i duri! Se proprio devi piangere, non sarebbe meglio se lo facessi a piccole dosi ogni volta che ne hai voglia? Non so cosa fare con te! Perché non riesci a vivere senza la tua ostinazione? Sei pazza!”
“Dove hai dormito stanotte?”
La domanda di questa “pazza” era luminosa come un piccolo miracolo sgorgato dalle sue labbra altere. Era così stanca da non riuscire a stupirsi più di nulla.
“Vedi? Se sei schietta e mi fai una domanda, io ti rispondo. Ieri sera sono uscito a bere con un amico e, alla fine, mi sono addormentato a casa sua. Potevo anche non fermarmi, ma volevo vederti piangere. Fra l'altro quest'amico si è appena sposato e vive con la sua donna in un appartamento minuscolo. È stato imbarazzante!”
“Davvero?!” rispose Barbara quasi ridendo.
“Senti, devo chiederti due favori.”
“Dimmi.”
“Il primo è promettermi che faremo un viaggio insieme.”
“Certo, perché no?”
“E l'altro…”
“Sì?”
“Avvicina un po' la guancia…”
Barbara lo colpì rumorosamente con il palmo della mano e poi, approfittando di quell'attimo di smarrimento, premette le sue labbra bagnate di lacrime contro quelle di lui.
© Paolo Melandri (20. 9. 2018)
*
La gente evolve
Andammo in un ristorantino vicino al porto, e dopo una cena leggera ordinammo un Bloody Mary e un bourbon.
– Vuoi sapere la verità? – mi chiese.
– L'anno scorso ho dissezionato una mucca.
– Cosa?
– Quando le ho aperto la pancia, nello stomaco le ho trovato solo una matassa d'erba. L'ho messa in una busta di plastica e l'ho portata a casa. La tengo sulla scrivania. Quando mi succede qualcosa di sgradevole, la osservo e penso: perché le mucche masticano e rimasticano scrupolosamente questa schifezza, la rigurgitano e la ingoiano?
Lei ridacchiò, poi strinse un po' le labbra e mi guardò in viso.
– D'accordo, ho capito. Non ti racconto nulla.
Annuii.
– Però c'è una cosa che ti vorrei chiedere. Posso?
– Prego.
– Perché la gente muore?
– Perché evolve. L'individuo singolo non ha l'energia necessaria all'evoluzione, quindi le generazioni devono susseguirsi e passarsi il testimone. Questa è solo una delle spiegazioni, naturalmente.
– Anche adesso stiamo evolvendo?
– Sì, a poco a poco.
– E perché la gente evolve?
– Be', su questo punto ci sono varie opinioni. Ma la sola cosa certa è l'universo evolve. Anche senza entrare nel merito della questione se tutto questo abbia una direzione o un significato, l'universo evolve, e noi siamo solo una minima parte di esso –. Posai il bicchiere e mi accesi una sigaretta. – Da dove venga tutta quest'energia, nessuno lo sa.
– Veramente?
– Veramente.
Lo sguardo fisso sulla tovaglia bianca, lei fece girare col dito il ghiaccio nel bicchiere.
– Quando sarò morta, passato un centinaio d'anni nessuno si ricorderà della mia esistenza.
– Forse no, – dissi.
Usciti dal ristorante, facemmo un giro lungo una strada tranquilla fra i magazzini del porto, nella luce di un tramonto smagliante. Camminando di fianco a lei, potevo sentire il lieve aroma del balsamo che usava per i capelli. La brezza di fine estate faceva tremare le foglie dei salici. Con la mano che aveva tutte e cinque le dita, prese la mia.
© Paolo Melandri (18. 9. 2018)
*
Carlo e Sara 2
“Carlo, ho la strana sensazione che il mio cuore sia pieno di grandi rose bianche. Anche se faccio il più piccolo movimento, i fiori si urtano fra di loro e si sente il loro fruscio. Carlo, ultimamente in tutti i miei sogni sento il profumo delle rose.
… Il profumo è molto intenso, di certo sono fiori che cominciano ad appassire.”
A queste parole, Carlo ebbe la sensazione che la morte interiore di Sara si rivolgesse alla morte che risiedeva nella sua anima. Dal pavimento di pietra fino al muricciolo, l'edera cresceva imperturbabile, anche nei pomeriggi in cui non vi era nessuno a osservarla. Con la stessa tranquillità e la stessa costanza, le sofferenze crescevano nel suo cuore ed egli ne avvertiva la presenza, come se ascoltasse una triste melodia lontana. Si sentì soffocare dall'angoscia.
“Sara! Quei fiori non stanno appassendo. … Forse non appassiranno mai. Perché…”
Carlo balbettava; in questi momenti, dentro di lui, le nuvole che nascondevano il sole si aprivano come uno splendido ventaglio.
“Perché… forse quel fruscio nel tuo cuore è un battito d'ali.”
Ma Carlo non ebbe il coraggio di pronunciare queste parole. Fissava intensamente Sara, come se volesse comunicarle i suoi pensieri e leggere nel suo volto un cenno di approvazione.
© Paolo Melandri (17. 9. 2018)
*
Fontane sotto la pioggia 4
Nella grande fontana centrale il getto d'acqua, agitando la criniera bianca in ogni direzione, superava con un balzo la base di granito nero e continuava a buttarsi con impeto nello specchio del lago. Sembrava che nell'osservare quella corsa instancabile dell'acqua che si volgeva in tutte le direzioni, il suo cuore ne venisse travolto. Il suo cuore, che fino a quell'attimo era stato presente, in un momento imprecisato veniva stregato, gettato in quella corsa e trascinato via. Lo stesso avveniva guardando le colonne d'acqua. A prima vista, il getto principale sembrava restare immobile, come una figura plastica modellata dall'acqua, perfettamente composta. Ma bastava fissarlo con attenzione per scorgere all'interno della colonna un'energia animata da un movimento trasparente, che incessantemente correva dal basso verso l'alto. Essa riempiva con una velocità straordinaria lo spazio cilindrico proteso verso l'alto e, attimo dopo attimo, colmava ciò che veniva a mancare, mantenendo senza sosta una stessa pienezza. In definitiva, altro non era che la distruzione nel punto di massima altezza, ma la persistenza della forza che sosteneva quella distruzione continua era meravigliosa. Mentre era intento a osservare la fontana – la stessa che in realtà avrebbe dovuto mostrare alla ragazza che aveva trascinato con sé – e si diceva che era meravigliosa, il suo sguardo, trascinato ancora più in alto, si volse verso la distesa del cielo da cui si riversava la pioggia. Gocce d'acqua si fermarono sulle sue ciglia.
Il cielo, chiuso da pesanti nuvole, incombeva sulla sua testa, e la pioggia seguitava a cadere, abbondante, compatta. Tutto intorno, ovunque arrivava la vista, era soltanto pioggia. La pioggia che gli bagnava il viso era esattamente la stessa che cadeva sulle terrazze dell'albergo e dei lontani edifici dai mattoni rossi, e sia il suo volto liscio, appena velato da una barba ancora rada, sia il pavimento di cemento percorso da sottili fenditure di una qualunque terrazza deserta di un edificio, altro non erano se non superfici inermi, esposte alla pioggia. Per questa pioggia, le sue guance e il sudicio pavimento di cemento erano esattamente la stessa cosa.
L'immagine della fontana che si trovava davanti ai suoi occhi si cancellò dalla mente di Carlo. Poté solo pensare che quelle fontane immerse nella pioggia continuavano a ripetere uno stesso inutile, stupido movimento. Dimenticando sia il buffo gioco di associazioni di poco prima sia lo scatto d'ira che ad esso era seguito, il ragazzo avvertì che il vuoto si faceva rapidamente strada nel suo cuore. E in quel cuore vuoto c'era soltanto pioggia che cadeva.
Riprese a camminare, incerto. “Dove vai?” chiese la ragazza, ancora aggrappata al manico dell'ombrello, imprimendo il movimento ai suoi stivaletti bianchi.
“Sono fatti miei. Te l'ho detto poco fa, no?”
“Che cosa mi hai detto?” A questa domanda, Carlo ebbe un brivido e fissò il volto di lei, ma quel viso bagnato dalla pioggia aveva lavato via ogni traccia di lacrime e, anche se negli occhi arrossati restava qualche sospetto di pianto, la voce non tremava più.
“Come sarebbe? Poco fa te l'ho detto… che ci saremmo lasciati.”
In quel momento, all'ombra del profilo della ragazza che si spostava nella pioggia, Carlo scorse piccole azalee primaverili sfumate di carminio sbocciate qua e là nel prato, come esitanti. “Davvero mi hai detto questo? Non ti ho sentito” disse lei, con voce tranquilla.
La sorpresa fu tale che il ragazzo fu sul punto di cadere: avanzò a fatica due o tre passi poi, balbettando, tentò una protesta: “Ma come?… e allora, perché piangevi? È assurdo!”. La ragazza non rispose subito. Le sue piccole dita bagnate restavano strette attorno al manico dell'ombrello.
“Non lo so perché. Non c'era nessuna ragione. Mi è successo così.”
Sopraffatto dall'ira, il ragazzo fu sul punto di esplodere in un grido di rabbia, ma la sua voce si trasformò in un grande starnuto. “Forse mi verrà il raffreddore” si disse.
© Paolo Melandri (16. 9. 2018)
*
Mezza estate
Lidia era sulla spiaggia. Indossava un elegante costume da bagno verde. Era l'unica cosa che non aveva ricevuto in regalo ma che aveva comprato in un grande magazzino. Molto orgogliosa della sua pelle chiara tipica della gente del nord, non aveva quasi nessuna traccia di abbronzatura. Faceva sempre il percorso dall'acqua all'ombrellone nel minor tempo possibile. I bambini erano sul bordo dell'acqua intenti a costruire un castello di sabbia, mentre Lidia si divertiva a lasciar cadere l'acqua mista a sabbia sulle gambe bianche. La sabbia asciugava immediatamente, formando un disegno scuro, rilucente di minuscoli frammenti di conchiglie. Lidia la puliva via frettolosamente, come se avesse improvvisamente temuto di non poterla più lavare. Dalla sabbia balzò fuori un insetto semitrasparente che si allontanò rapido.
Lidia raddrizzò le gambe e si appoggiò all'indietro sulle mani, guardando verso il mare. All'orizzonte ribolliva un enorme ammasso di nuvole, immenso nella sua tranquilla maestà. Sembrava che le nuvole assorbissero ogni rumore, persino quello del mare.
Si era nel pieno dell'estate e i raggi del sole picchiavano rabbiosi.
I bambini si erano stancati del loro castello di sabbia.
Corsero via scalciando nell'acqua poco profonda. Lidia uscì di soprassalto dal piccolo mondo privato nel quale era scivolata, e prese a rincorrerli.
Ma i bambini non facevano nulla di pericoloso. Avevano paura del rombo delle onde. Al di qua della linea dove si frangevano le onde c'era un leggero risucchio. Carlo e Valentina, mano nella mano, erano in piedi nell'acqua che arrivava all'altezza del torace, gli occhi brillanti mentre si opponevano alla corrente e sentivano la sabbia scorrere sotto la pianta dei piedi.
“Come se qualcuno spingesse,” disse Carlo alla sorella.
Dietro di loro arrivò Lidia e li ammonì di non andare oltre. Indicò Enrico. Non avrebbero dovuto lasciarlo solo, dovevano uscire dall'acqua e andare a giocare con lui. Ma i bambini non le prestarono attenzione. Se ne stavano nell'acqua, mano nella mano, sorridendo. Avevano un segreto tutto loro, la sensazione della sabbia che scivolava via sotto i piedi.
Il sole dava fastidio a Lidia. Si guardò le spalle e il petto e ripensò alla neve della Maiella. Si pizzicò leggermente sopra il seno. Sorrise avvertendo una sensazione di calore. Aveva le unghie leggermente lunghe che trattenevano sotto l'orlo un poco di sabbia scura. Avrebbe dovuto tagliarle quando fosse ritornata in albergo. Carlo e Valentina non si vedevano più. Dovevano essere ritornati sulla spiaggia.
Ma Enrico era solo. Aveva un'espressione stranamente alterata, e faceva cenni nella sua direzione.
Sentì il cuore batterle violentemente. Guardò nell'acqua ai suoi piedi. L'acqua si stava ritirando, e nella schiuma a pochi metri di distanza si vedeva un piccolo corpo bruno che rotolava continuamente. Colse per un attimo il colore blu scuro del costumino da bagno di Carlo.
Il cuore le batteva ancora più forte. Si diresse verso il corpo, guardinga come se dovesse affrontare un pericolo. Arrivò un'onda più alta del solito che si ruppe sotto i suoi occhi. La colpì proprio nel mezzo del petto. Cadde all'indietro nell'acqua. Era stata colpita da un attacco di cuore.
Enrico cominciò a piangere e un giovane che stava lì vicino lo raggiunse correndo. Arrivarono altri, correndo nell'acqua bassa. L'acqua schizzava attorno ai corpi nudi abbronzati. Due o tre videro la donna caduta, senza farci però troppo caso. Si sarebbe rialzata. Ma in simili occasioni c'è come una sorta di premonizione e, mentre correvano, erano a metà convinti che ci fosse qualcosa di tragico in quella caduta. Lidia venne trascinata fin sulla sabbia ardente. Aveva gli occhi aperti e i denti serrati. Pareva che guardasse con espressione inorridita qualcosa piantato saldamente di fronte a lei. Uno degli uomini le tastò il polso. Nulla.
Qualcuno la riconobbe. “Sta all'Hotel Savio.”
Bisognava chiamare il direttore dell'albergo. Un ragazzo del villaggio, deciso a non permettere a nessuno di rubargli questo compito, corse via a grande velocità sulla sabbia calda.
Arrivò il direttore. Era un uomo sulla quarantina. Indossava calzoncini corti, una maglietta spiegazzata e, attorno alla vita, una fascia di lana consunta in vari punti. Decise che i primi soccorsi dovevano esserle prestati all'albergo. Qualcuno obiettò. Senza attendere che venisse raggiunto un accordo, due giovani sollevarono Lidia e cominciarono a portarla in direzione dell'albergo. Sulla sabbia umida dove era stata sdraiata rimase l'impronta di un corpo umano.
Enrico li seguì singhiozzando. Qualcuno se ne accorse e lo prese in braccio.
Azzurra venne svegliata dal suo sonnellino. Il direttore, che sapeva fare bene il suo mestiere, la scosse gentilmente. Azzurra sollevò il capo e chiese che cosa non andava.
“La signora Lidia...”
“Le è successo qualcosa?”
“Le abbiamo prestato i primi soccorsi, e il dottore arriverà immediatamente.”
Azzurra balzò dal letto e uscì in fretta dalla stanza con il direttore. Lidia era sdraiata sull'erba vicino all'altalena. Un uomo seminudo, inginocchiato a cavalcioni sopra di lei, le stava praticando la respirazione artificiale. Al suo fianco due uomini facevano del loro meglio per accendere un fuoco con paglia e rottami di una cassetta di arance. Le fiamme si spegnevano immediatamente lasciando il fumo. Il legno era ancora bagnato per il temporale della sera precedente. Un terzo uomo allontanava il fumo quando questo avvolgeva il viso di Lidia.
Il capo rovesciato all'indietro, pareva a tutti che Lidia stesse respirando. Il sole che filtrava attraverso gli alberi faceva luccicare il sudore sulla schiena scura dell'uomo a cavalcioni sopra di lei. Le gambe bianche, allungate sull'erba, erano paffute e di un colore gessoso. Sembravano apatiche, come indifferenti alla lotta ingaggiata sopra di esse.
Azzurra si inginocchiò nell'erba.
“Lidia! Lidia!”
Sarebbero riusciti a salvare Lidia? Perché era successo? Che cosa ne avrebbe detto il marito? Piangendo, saltava incoerentemente da una domanda all'altra. Di colpo si voltò decisamente verso gli uomini che le stavano attorno. Dov'erano i bambini?
“Guarda. La mamma è qui.” Un pescatore di mezza età teneva fra le braccia Enrico spaventato. Azzurra guardò il ragazzo e fece un cenno di ringraziamento al pescatore.
Arrivò il dottore e proseguì la respirazione artificiale. Con le guance che scottavano alla luce del fuoco, Azzurra quasi non riusciva a rendersi conto dei suoi pensieri. Una formica salì sulla faccia di Lidia. Azzurra la schiacciò e la gettò via. Un'altra si arrampicò dai capelli vicino all'orecchio. Azzurra schiacciò anche quella. Lo schiacciare formiche divenne il suo compito.
La respirazione artificiale proseguì per quattro ore. Alla fine ci si accorse che stava sopravvenendo il rigor mortis, e il direttore rinunciò. Il corpo venne coperto con un lenzuolo e portato al terzo piano. La stanza era buia. Un uomo lasciò il corpo e corse ad accendere la luce.
Esausta, Azzurra si sentì pervadere da una specie di dolce sensazione di vuoto. Non era triste. Le vennero in mente i bambini.
“I bambini?”
“Sono nella stanza da gioco con Lorenzo.”
“Tutti e tre?”
“Tutti e tre?” Gli uomini si guardarono l'un l'altro.
Azzurra li spinse da parte e scese di corsa le scale. Lorenzo, il pescatore, con una vestaglia di cotone addosso, era seduto sul divano e scorreva un libro illustrato con Enrico che indossava una camicia da adulto sul costume da bagno. La mente di Enrico era presa da qualcos'altro. Non prestava attenzione al libro.
All'ingresso di Azzurra, gli ospiti dell'albergo che sapevano della tragedia smisero di farsi vento e la guardarono.
Azzurra quasi si gettò su Enrico.
“Carlo e Valentina?” chiese con voce tesa.
Enrico alzò timidamente lo sguardo su di lei. “Carlo … Valentina… tante bolle.” Cominciò a singhiozzare.
Azzurra scese di corsa alla spiaggia a piedi nudi. Gli aghi di pino la pungevano mentre attraversava il boschetto. Era sopraggiunta l'alta marea e per giungere alla spiaggia dove si facevano i bagni fu costretta a scalare la roccia. Sotto di lei si stendeva la sabbia candida. Vedeva lontano nell'oscurità. Un ombrellone a strisce bianche e gialle era rimasto sulla spiaggia. Era il suo.
Gli altri raggiunsero la spiaggia. Stava correndo tra i frangenti senza far caso al pericolo. Quando tentarono di fermarla, li respinse irritata.
“Non capite? Ci sono i miei due bambini là fuori, nel mare.”
Molti non avevano sentito che cosa aveva da dire Lorenzo. Pensarono che Azzurra fosse impazzita.
Sembrava impossibile che per tutte le quattro ore che era durato il tentativo di rianimare Lidia, nessuno avesse pensato ai bambini. Gli ospiti dell'albergo erano abituati a vedere i due bambini insieme. E, per quanto potesse essere sconvolta la loro madre, pareva strano che nessuno l'avesse avvertita della morte dei suoi due figli.
A volte, tuttavia, simili incidenti fanno nascere un atteggiamento psicologico collettivo per cui ciascuno pensa solo alle cose semplici. È difficile non rimanerne presi. È difficile notare discrepanze. Svegliata all'improvviso dal pisolino pomeridiano, Azzurra aveva recepito solamente ciò che gli altri le comunicavano, e non si era posta nessun problema.
A poca distanza dall'albergo e alla spiaggia, per tutta la notte si tennero accesi dei falò. A intervalli di mezz'ora, i giovani si tuffavano alla ricerca dei corpi. Azzurra era con loro alla spiaggia. Non riusciva a dormire, anche perché aveva dormito troppo al pomeriggio.
Per ordine del gendarme locale, il mattino seguente le reti non vennero posate.
Il sole sorse dietro il promontorio alla sinistra della spiaggia e la brezza del mattino colpì Azzurra in pieno viso. Azzurra temeva l'arrivo della luce. Le sembrava che la luce del giorno le avrebbe rivelato tutta la verità, e che per la prima volta la tragedia sarebbe divenuta un fatto reale.
“Non crede che dovrebbe riposare un poco?” disse uno degli uomini più anziani. “Se ci saranno novità, la chiameremo. Faremo tutto noi.”
“La prego, gli dia retta, la prego,” disse il direttore dell'albergo, gli occhi rossi per la mancanza di sonno. “Ha già avuto abbastanza sfortuna. Che farà suo marito se si ammalerà anche lei?”
Azzurra temeva l'incontro con il marito. Vederlo sarebbe stato come affrontare un processo. Ma avrebbe dovuto vederlo, comunque. Il momento si avvicinava e quasi le sembrava che si avvicinasse un'altra disgrazia. Di colpo, raccolse tutto il suo coraggio e inviò un messaggio. Questo le forniva una scusa per allontanarsi dalla spiaggia. Aveva cominciato a pensare che tutta l'attenzione dei giovani che si tuffavano si fosse rivolta verso di lei.
Mentre si allontanava si voltò a guardare. Il mare era calmo. Vicino alla spiaggia brillava un riflesso d'argento. I pesci balzavano fuori dall'acqua. Era spiacevole che Azzurra dovesse sentirsi così infelice.
© Paolo Melandri (15. 9. 2018)
*
Terra sconosciuta
Nell'oscurità affiorò una luminescenza, una sagoma vaga che dispiegò due grandi ali. Forse una farfalla notturna? La forma indistinta a poco a poco si definì, divenne una vestaglia di seta. Un fiume di sette colori scorreva smagliante sullo sfondo di un fresco azzurro chiaro, un arcobaleno sul bordo di un cielo dov'era rimasta un po' di luce. Le ricordava un uccello di un altro mondo che aprisse la splendida coda. Le maniche e l'orlo si allungarono dolcemente nell'aria, poi si riunirono e, sempre fluttuando, la seta disegnò un arco magnifico.
Lucrezia protese di colpo le braccia e, cercando di afferrare l'estremità dell'arcobaleno, lo tirò a sé. Il tessuto freddo e morbido le toccò il petto nudo e le spalle, cadde a coprirla tutta, più pesante di quanto si aspettasse. La sensazione di venire schiacciata da un arcobaleno era simile a quella di essere sepolta dalla neve, pensò Lucrezia. Di colpo il cuore si mise a batterle più forte.
Quando per la seconda volta si svegliò dal sogno, aveva ancora il battito accelerato. Sulle braccia e sul petto sentiva vividi il peso e la morbidezza della seta che si era tirata addosso.
Al di là delle imposte, il sibilo del vento carico di neve sferzava il bosco. Improvvisamente le tenebre si lamentarono e la notte levò una sorta di gemito. Il fischio e il rumore delle ruote di un treno merci, sulla ferrovia che attraversava la zona di Errano ai piedi delle colline, vibrarono nel cuscino di Lucrezia che aprì gli occhi; il sonno si era dileguato, ma avrebbe voluto tenere stretta ancora una volta, toccare con mano quella cosa che aveva appena visto con gli occhi e sentito sulla pelle con una tale sensazione di realtà. Si alzò a sedere e accese la luce.
Così, seduta sul letto nel bel mezzo della stanza, le parve di essere rimpicciolita. Un'altra se stessa la stava osservando, e in quello sguardo sia lei che la stanza diventavano sempre più piccole, come se venissero guardate attraverso un occhio magico.
Ricordò la piccola lente di vetro dell'occhio magico nella porta del suo studio, un appartamento nel centro di Roma. Dall'altra parte della lente, non più grande dell'unghia del mignolo, vedeva le pesone ridotte alle dimensioni di una penna stilografica. Questo le procurava ancora adesso, dopo tanti anni, un senso di malessere – non ci si era mai abituata.
Dietro la porta, il pianerottolo largo tre metri sembrava una scatola magica di vetro di un prestigiatore. Le persone che venivano a trovarla, anche se vicinissime alla porta, davano l'impressione di trovarsi a una distanza irreale, come nani rinchiusi nella scatola sempre immersa in una penombra azzurrina. In piedi al centro, il nano appariva bisognoso e sconsolato. Come toccato da una bacchetta magica, anche l'uomo più gioviale, o a lei più intimo, assumeva le sembianze di un nano miserabile. La sua faccia esprimeva una grande tristezza, come se fosse stato colpito da una gravissima disgrazia. Chiunque fosse, il visitatore se ne stava lì in piedi con aria infelice, sembrava il portatore di una notizia infausta, le spalle curve, un'ombra scura tutt'intorno. Quale terribile tradimento aveva subito, quale profonda ferita portava nel cuore colui che aveva inventato quel sinistro buco attraverso il quale guardare il mondo?
Qualche volta le era successo di appoggiarsi contro il lato interno della porta e restare immobile, trattenendo il respiro, a osservare la figura del nano rinchiuso nella penombra della scatola.
Il campanello continuava a suonare, tanto da far pensare che l'altro avesse indovinato la presenza di lei che al di qua del battente tratteneva il respiro. Benché l'occhio magico funzionasse soltanto in una direzione, per il timore di essere vista anche lei finiva per irrigidirsi tutta. Veniva presa da un senso di vertigine, come se il suo corpo in un istante rimpicciolisse, alla velocità con cui l'immagine sullo schermo di un televisore si restringe. La presenza del nano che non fiatava, non muoveva un muscolo, sempre in piedi nel bel mezzo della scatola, a poco a poco le faceva superare il senso di malessere ma diventava opprimente, incuteva quasi paura. Le sembrava di svenire, come se la forza di continuare a respingere quella persona le venisse meno, pur dicendosi che ognuno è libero di rifiutare chi vuole.
A un certo punto la piccola figura umana, triste come un cavalluccio marino chiuso in una bolla di plastica, all'improvviso scivolava all'indietro come tirata da un filo e veniva risucchiata fino all'ascensore. Un'invisibile lama affilata tagliava in due la porta azzurra, ridotta alle dimensioni di un mazzo di fiori, e la figura in completo grigio spariva all'interno della cabina con la leggerezza di un fiammifero. Da destra a sinistra le porte si slanciavano l'una verso l'altra e, quando erano perfettamente chiuse come i labbri di una ferita cicatrizzata, improvvisamente lei sentiva le forze abbandonare il suo corpo pietrificato e in silenzio si lasciava scivolare seduta accanto alla porta.
Lucrezia non riusciva a ricordare chiaramente la ragione per cui il suo rifiuto di una persona dovesse manifestarsi in quel modo. Ciò che sentiva ancora con estrema intensità era solo la tensione sgradevole dei momenti in cui continuava a respingere l'altro con tutta se stessa.
Dall'altra parte dell'occhio magico le facce delle persone, delle dimensioni di un fagiolo, apparivano stranamente invecchiate e intristite, senza età, come quelle dei nani. Chissà perché i nani avevano sempre quelle facce così dolenti e funeree? La tristezza, per qualche ragione, non abbandonava mai il volto di un nano, anche quando ballava o rideva.
© Paolo Melandri (12. 9. 2018)
*
Cristallo lucente
Cristallo lucente
“Piuttosto, che mi dici di te? Ti sei rimesso del tutto, sei diventato molto più loquace e d'un tratto vieni a dirmi che sei in partenza per il Messico. D'ora in poi dovrò fare attenzione, perché non potrò più permettermi di mostrare senza riserbo la mia curiosità, ma è l'ultima sera e credo di potermi concedere delle domande. L'estate scorsa avevo sentito che ti eri immerso in pensieri mistici, e poi cosa ti è successo? Perché non me lo racconti?”
“Vuoi sapere di me?” sorrise Lorenzo senza alcuna soggezione. In realtà, fin dall'inizio era andato da lei con il desiderio di raccontarle tutto. Si allungò un attimo sul divano, poi si piegò in avanti, e tenendo con entrambe le mani il bicchiere di cognac iniziò a parlare.
“Sono uscito dalla crisi mistica, però non so con esattezza se sono davvero guarito, se sono solo stato abbandonato dai fenomeni esoterici, oppure se fin dall'inizio non c'è stata comunicazione tra me e tali misteri.
Sia gli esercizi di concentrazione con la pietra, sia le astinenze fisiche non hanno avuto l'effetto di farmi ottenere il controllo dell'anima. Semplicemente, il mio cuore era invaso nel profondo da un senso di morte e di buio e non riuscivo a vedere con chiarezza le forme del mondo reale.
Il fascino dell'esoterismo è molto difficile da spiegare, di sicuro è più semplice far capire a chi è astemio l'attrattiva del vino. Il primo punto della seduzione del mistico è farti abbracciare la convinzione di essere ai margini della terra, e questa è la sola emozione che prova chi si impegna in una spedizione polare o chi conquista una vetta vergine, vale a dire camminare fino ad allontanarsi il più possibile dal mondo abitato e collegarsi da soli ad un altro universo. Se si viene sedotti dal misticismo, si va avanti in un sol fiato fino ai confini del mondo e della mente umana. La visione individuale si lascia alle spalle tutto ciò che costituisce la realtà umana, e guarda davanti a sé un cristallo luccicante, compatto, che sembra il panorama di una città in lontananza; in pratica, davanti ai propri occhi si erge un vuoto che fa girare la testa.
Come pittore credevo di sconoscere bene questo tipo di panorama della mente, però un artista sta lì fermo e, quando ha terminato la sua creazione, ripone la tela e ritorna tra la folla dei suoi simili. Per i mistici tale comportamento non è soddisfacente, per loro il lavoro principale è entrare in comunicazione con l'altro mondo, creare un contatto tra la sostanza e il nulla.
Una volta che si giunge all'estremità della terra, nella zona più remota della mente – di sicuro sarà così anche per gli esploratori e per gli scalatori – ci si sente molto naturalmente i rappresentanti del genere umano; anche la convinzione degli esoterici somiglia a qualcosa di questo tipo, proprio perché nel luogo che si è raggiunto non si vedono esseri viventi a parte se stesso.
Dato che sono un pittore, non chiamavo tale regione anima, ma margine dell'umanità. Se esistono l'anima e lo spirito, essi non sono nascosti nel profondo e nell'interno delle persone, ma devono essere l'estremità delle braccia stese dall'uomo, la parte più esterna di esso, devono rimanere esattamente sulla linea di confine. Se si oltrepassa tale perimetro, tale bordo, non si è più esseri umani.
Io avevo occhi solo per la vita al di fuori di me, ero un individuo che subiva il fascino solo della bellezza di foreste, cieli al tramonto, fiori, nature morte, e non prestavo mai la minima attenzione a quello che c'era dentro di me; ciò nonostante sono stato conquistato dall'esoterismo. A furia di camminare mi sono ritrovato ai confini dell'umanità.
È lì che gli esoterici e gli intellettuali si trovano spalla a spalla. I secondi arrivano fin lì e poi ritornano in fretta verso gli altri, ai quali guardano come se fossero dei modellini e delle espressioni matematiche di facile risoluzione. Per loro gli orientamenti politici, gli esiti economici, gli scontenti e le insoddisfazioni dei giovani, le crisi artistiche, insomma, tutto ciò che riguarda la psicologia umana, può essere risolto come una semplice formula matematica e le parole hanno un'immediata chiarezza che non dà adito a enigmi strani… Gli esoterici invece volgono con decisione le spalle al mondo, rinunciano alla comprensione di esso e riempiono le frasi di disordinati misteri.
Tuttavia, a pensarci adesso, in definitiva io non appartenevo a nessuna delle due categorie, ero un pittore; non mi si addicevano né l'immediata chiarezza né gli scuri enigmi. Una volta giunto al limite della terra, non sono stato capace né di lasciarmi il mondo alle spalle, né di ritornarvi con un sorriso cinico, freddo, d'intimità, né di sentirmi superiore: sono rimasto sospeso nel costante sentimento di perdita del mondo.
Non sono stato in grado neanche di concentrarmi sulla pietra per raggiungere il controllo dell'anima e mi guardavo con timore intorno nelle tenebre. A un certo punto, tra la morte e l'oscurità, mi sono apparsi numerosi volti di giovani che fluttuavano, sconfitti come me dal senso di perdita del mondo; non ero il solo ad aver camminato fin lì, c'erano affascinanti visi macchiati di sangue, feriti, gli occhi spalancati, pronti alla morte.
Pur arrendendomi ogni tanto, per tutto l'inverno mi sono aggrappato all'esoterismo. Ho fatto visita molte volte al maestro Sergio d'Endrigo; sono deperito, ma non ho avuto nessuna malattia seria, mi sosteneva una misteriosa energia vitale, cioè in realtà non ho avuto problemi di salute perché sono giovane.
Dopo essere diventato un adepto del misticismo, avevo proibito di mettere dei fiori nel mio studio perché i loro colori e i loro profumi sensuali mi davano l'impressione che potessero ostacolare il mio percorso verso di esso.
Nonostante mi fossi abituato durante l'inverno a limitare molto le ore di sonno, all'inizio della primavera mi capitò di dormire una mattina fino a tardi, forse perché quel caldo inaspettato mi aveva rilassato. Mi misi a sedere sulle lenzuola bianche del divano-letto, posto in un angolo del mio atelier, e mi accorsi che accanto al cuscino bianco c'era per terra un narciso.
Stavo per arrabbiarmi, ma mi fermò la sensazione che quel fiore si fosse poggiato lì, accanto al guanciale, naturalmente, ad aspettare il mio risveglio.
So che ascoltando il mio racconto non comprenderai la mia particolare situazione psicologica e di sicuro ti verrà da ridere; anche io adesso la penso così, e forse come te credo che mettere quel narciso nel mio studio sia stato uno scherzo o un gesto affettuoso di qualche mio familiare, però allora ero di un altro parere.
Nella luce della mattina che filtrava dalla finestra, rimasi per metà disteso sul letto a osservare immobile il narciso accanto al guanciale. Nello studio, isolato acusticamente, non c'erano rumori, per cui era possibile rimanere nel silenzio più assoluto, nel chiarore mattutino, soltanto il fiore ed io.
Mi venne da pensare che fosse un regalo mandato dal mondo delle anime, una mattina d'inizio primavera, alla fine di una devozione che durava fin dall'estate precedente; il dono consisteva in questo fresco narciso, come se l'energia invisibile dei fiori fosse stata congelata e avesse preso forma di quell'esemplare così bianco e netto!
Per un po' di tempo ero stato dimenticato dalla felicità esaltante, ma la mia lunga dedizione non era stata inutile. Raccolsi lo stelo protetto dalle foglie rigide e lo avvicinai agli occhi per fissare il fiore aperto.
La corolla aveva una forma regolare e senza alcuna macchia; ognuno dei petali odorava come se fosse appena sbocciato e aveva una linea chiaramente disegnata, appena ondulata, che indicava che i petali erano stati fino a poco prima piegati stretti nel bocciolo, fin quando si erano aperti illuminati dal sole: insomma, una struttura perfetta.
Continuai senza stancarmi a osservare il fiore e di pari passo penetravo sempre più nel mio cuore; quella forma essenziale e dal contorno netto faceva vibrare il mio animo come se fosse stato uno strumento a corde.
Presto sopraggiunse la sensazione di aver tradito me stesso. Avevo finalmente ricevuto un dono dal mondo spirituale? Ma quello che proveniva dalla spiritualità, poteva mai apparirmi davanti agli occhi con una forma così completa e riconoscibile? Se tutti i fenomeni che appartengono al nulla possono essere percepiti in più modi, non compaiono forse nel mondo in movimento, senza fare affidamento su una forma specifica? Di sicuro vedevo un narciso, ne ero certo, e sentivo che sia io che guardavo, sia il fiore che veniva osservato, appartenevamo allo stesso solido mondo. Quindi esso poteva rappresentare un aspetto della realtà? Non era forse sicuro che fosse un fiore vero?
Mentre facevo queste riflessioni fui colto a un tratto da uno stato di malessere indescrivibile e fui tentato di gettare il fiore sul letto. Ebbi l'impressione all'improvviso che quel fiore fosse vivo. Ebbi l'impressione d'un tratto che il narciso fosse vivo.
© Paolo Melandri (11. 9. 2018)
*
La dama dal cagnolino
Quando ridiscese dai suoi padroni di casa, trovò la giovane Zustina in vivace discussione con un ometto di mezz'età. Un naso quasi a mezzaluna dava al suo viso un'aria singolare e alquanto arrogante; dal fazzoletto di cotone che portava in mano si spandeva per la stanza un odore di pesce.
– No, no, così non va; se dà retta alla gente quella le appiccica ciò che vuole – sentì che diceva. – Fosse un altro giorno, ne risponderei di fronte alla mamma. Ma oggi bisogna proprio che mi faccia il piacere di ritornare giù. E non dimentichi il tappezziere. Contratti con lui punto per punto, esattamente come ho detto. I tappezzieri sono gente furba e senza coscienza, ma un uomo capace di esprimersi come lei deve poter stare a petto con chicchessia. L'estrazione cade giusto una settimana dopo la Natività della Madonna, perciò tutto deve essere consegnato la sera prima. Se manca la più piccola cosa, gli verrà detratto mezzo ducato d'argento. Lo voglio proprio come un altare del Corpusdomini, sul davanti un drappeggio con ghirlande, e nel centro, in mezzo a una decorazione di fiori freschi, ci va l'urna da cui verranno estratti i biglietti. Per montarlo non deve mettere niente in conto a parte. Tutto va consegnato a casa, a metterlo su e a decorarlo aiuterà Zorzi. Ora vada e regoli tutto in modo da meritare dei complimenti, e mi lasci il suo libretto delle spese, voglio rivederlo.
Il vecchio si allontanava quando Andrea entrò.
– Ah, eccola – disse Zustina. – Il suo bagaglio è già in basso. Zorzi lo farà portare di sopra. Poi le indicherà un buon caffè e l'accompagnerà, se vuole, da mia sorella, che sarà molto lieta di fare la sua conoscenza. – Per servizi di questo genere è quel che ci vuole, – aggiunse – per il resto non è affatto necessario che lei ne faccia subito il suo confidente. Del resto è affar suo, a questo mondo c'è gente d'ogni razza, e ognuno deve sapersi sbrigare. Voglio dire, il mondo bisogna prenderlo com'è. – Corse al focolare, gettò un'occhiata al fornello, bagnò l'arrosto; alcuni capi di vestiario, che dovevano appartenere alla madre e al fratello, scomparvero in un grande armadio. Cacciò il gatto dalla tavola e governò un uccello, che era appeso alla finestra. – Un'altra cosa volevo dirle, – soggiunse, e si fermò un attimo davanti ad Andrea – io non so se lei abbia con sé una somma importante di denaro o una lettera per un banchiere. Nel primo caso lo dia a custodire a persona con la quale lei sia in relazione d'affari o chi altri conosca in città. Non che ci sia gente poco onesta in casa, ma responsabilità non ne voglio. Ho abbastanza da fare per tenere in ordine la casa, istruire i miei due fratelli e pensare a mio padre; mia madre è quasi sempre occupata fuori casa. E poi lei stesso può immaginare se i preparativi per la lotteria non mi diano abbastanza pensieri. Si fa così presto a offendere qualcuno … Deve scusare se non ci è possibile offrirle un biglietto, anche se abita da noi, ma lei è uno straniero, e su questo punto i nostri protettori sono molto rigorosi. Anche il secondo premio è molto grazioso, è una tabacchiera d'oro smaltata; gliela mostrerò appena il gioielliere la consegna.
Tra una cosa e l'altra sempre senza sedersi rivedeva i conti del libretto delle spese, servendosi di una matita minuscola che doveva tenere nascosta in un ricciolo del suo tuppè; era infatti pettinata come se dovesse andare a un ballo, con un tuppè molto alto, e portava pantofoline di panno, e una gonna di taffetà con trine d'argento, ma, sopra, una giacchettina da casa a quadri, che era troppo larga per lei e lasciava tutto scoperto un collo incantevole, snello ma per nulla infantile. Tra i piccoli gridi e le esclamazioni con cui interrompeva il suo discorso, i suoi occhi correvano ora ad Andrea, ora al focolare, ora al gatto. A un tratto le passò per la mente qualcosa, volò alla finestra, si sporse tutta e gridò giù con voce squillante:
– Conte Gasparo! Conte Gasparo! Mi stia a sentire! Ho ancora una cosa da dirle.
– Son qui – disse il signore dal naso a uncino e dai pesci, ed entrò inaspettato nella stanza. – Che mi gridi dietro dalla finestra?… sono qui – e si volse ad Andrea: – Solo ora in basso ho appreso che lei è il distinto giovane forestiero che ho l'onore di salutare mio ospite. Auguro a lei e a noi che la felicità le sorrida sotto il nostro umile tetto. Lei abita le stanze della mia figlia Nina. Lei non la conosce ancora, e così non può ancora apprezzare al giusto valore la prova di stima e di fiducia che le diamo, mettendo a sua disposizione quell'appartamento. La stanza di una tale creatura è simile alla veste di un santo, che conserva forze miracolose. Quali che siano i casi che le occorreranno in questa città – e lei è venuto per raccogliere avventure ed esperienze – tra quelle mura torneranno a lei la pace del cuore e l'equilibrio dello spirito. L'aria stessa di quella stanza respira, se così posso dire, una virtù invincibile. Meglio morire che sacrificare tale virtù, fu il ferreo proposito della mia bambina. Io, signor mio, – e toccò Andrea con la mano, che era bianca e straordinariamente ben fatta, ma troppo piccola per un uomo e perciò sgradevole – non sono stato in condizione di confermare la mia figliola in tale proponimento, né di rimeritarla per questo. Io sono un'esistenza fallita, che i colpi della fortuna hanno precipitato dalle altezze della mia famiglia. – Fece un passo indietro e lasciò cadere la mano con gesto inimitabile. Con un inchino lasciò la stanza.
Il viso di Zustina era raggiante di ammirazione per il discorso del conte. E veramente il modo con cui aveva pronunziato quelle poche frasi era un capolavoro di grazia e di sfumature: la dignità si univa all'umanità, l'esperienza e la gravità erano temperate dalla confidenza. Il più vecchio parlava al più giovane, il padrone di casa al suo ospite, il vegliardo provato dalla vita paternamente al giovane inesperto, e un gentiluomo veneziano a un altro gentiluomo: – c'era tutto questo.
– Che ne dice, come si sa esprimere mio padre? – domandò la ragazza. Dal piacere candido e puerile sembrava non ricordare che aveva richiamato il padre per dirgli qualche cosa. – E così in ogni situazione – esclamò con occhi scintillanti – trova la parola giusta. Ha avuta molta sfortuna e molti nemici, ma le sue grandi doti nessuno le può contestare. – Se prima era volubile come l'argento vivo e piena di zelo, ma nello stesso tempo asciutta, ora sì che era tutta animata dall'interno, gli occhi le brillavano e la bocca si muoveva con un indescrivibile fervore di bambina. Qualcosa in lei faceva pensare a uno scoiattolo, ma era una piccola donna energica e coraggiosa.
– Così conosce anche mio padre, e prima che passi un'ora conoscerà mia sorella e certamente alcuni dei suoi amici. Il più distinto tra loro è il duca di Camposguardo, l'ambasciatore spagnolo. È così gran signore che quando il Re di Spagna parla con lui, lui si mette in testa il cappello. Non si spaventi quando lo vedrà, sembra una bestia feroce, ma è un gran signore. Tra i suoi amici Nina ne ha poi uno che piacerebbe anche a me – ma a che parlare di me? È un capitano austriaco, uno schiavone, o per meglio dire ha un brevetto di capitano austriaco e ha delle patenti, l'importazione dei buoi ungheresi e stiriani attraverso Trieste, un buon affare, ed è anche un bell'uomo e innamorato morto di Nina. Pensi, non si alza mai da tavola senza bere alla sua salute e poi ogni volta getta il suo bicchiere nel canale attraverso i vetri, o contro il muro, ma se poi è un giorno particolare, fracassa allo stesso modo tutti i cristalli della tavola, e tutto in onore di Nina. Naturalmente poi paga i bicchieri. Non è una grande bestialità? – ma nel suo paese non c'è cortesia più grande. È un gran giocatore, – e del resto lo conoscerà lei stesso e vivrà anche lei come gli altri. Se fosse mio marito gli leverei io questa abitudine. Una cosa, – proseguì, e lo guardò con gravità e importanza e con una espressione incantevole – se dovessero capitarle malintesi, liti, discussioni e diverbi, veda di spuntarla. Non si lasci intenerire da lacrime, né di donne né di uomini. È una vergognosa debolezza, che non posso soffrire. Non parlo delle lacrime di Nina. Le lacrime di Nina sono schiette come l'oro. Quando piange è come un bimbo piccino. Non si ha cuore di negarle quello che desidera, perché è dieci volte più buona di me, sebbene abbia già ventun anni e io non ancora sedici. Ma che può interessarla – aggiunse con uno sguardo malizioso, mentre governava l'uccello alla finestra, – sentirmi parlare di me – non è per questo che lei è venuto a Venezia. Scenda. Zorzi sarà giù che l'aspetta. Andrea era già sulla scala, quando gli corse dietro.
– Una cosa ancora – mi è frullata così per la testa. Lei ha una faccia di buono, e una persona buona bisogna metterla in guardia al primo passo. Non si lasci mai persuadere ad eccettare cambiali da alcuno, anche se le offre in copertura altre cambiali che scadono prima delle sue – mai, capito? – Per un attimo posò leggermente la mano sul braccio di Andrea – era il medesimo gesto del padre poc'anzi, ma, come dice il proverbio, se due fanno la stessa cosa, la cosa non è la stessa. Era una manina deliziosa e l'atto materno, donnesco, incantevole. – Ma era già di nuovo in casa, e mentre scendeva le scale Andrea la sentì dall'altra parte che chiamava Zorzi dalla finestra.
– Non è una gran cara donnina? – disse Zorzi, che l'attendeva in basso, come se avesse indovinato a che cosa stava pensando Andrea.
– Ma che cos'è questa lotteria? – chiese Andrea dopo pochi passi – chi è che dà i premi, e che c'entra la famiglia? Sembra che siano loro stessi ad allestirla.
Il pittore non rispose subito.
– Infatti – disse poi, rallentando il passo presso l'angolo di una strada e facendosi venire accosto Andrea. – Perché non dovrei dirglielo? La lotteria si svolge in una piccola cerchia di persone ricche e ragguardevoli, e il primo premio è la piccina stessa.
– Come, lei stessa?
– Insomma, la sua verginità, se vuole un'altra parola. È una buona creatura e si è messa in testa di sollevare i suoi dalla miseria. Dovrebbe sentire con che garbo parla di questa cosa, e che pena si è data per la sottoscrizione. Perché quando si tratta di lei, tutto deve essere fatto a modo. Un gran signore, che è un antico patrono della famiglia, ha preso la cosa sotto la sua protezione – qui abbassò la voce – … è il patrizio signor Sacramoso, che ultimamente è stato governatore di Corfù. Un biglietto non costa meno di ventiquattro zecchini, e non un nome è stato messo sulla lista dei sottoscrittori senza che prima il signor Sacramoso l'approvasse.
Andrea s'era fatto rosso di colpo, tanto che un bagliore gli tolse quasi la vista, e stava per scivolare sopra un pomodoro spiaccicato per terra davanti ai suoi piedi. L'altro camminando lo guardava con la coda dell'occhio.
– Una cosa di questo genere – continuò – può svolgersi in una cerchia di gente distinta e che ha la prudenza di non farne trapelare nulla; altrimenti le autorità si metterebbero di mezzo. Perciò i signori di qui non introducono volentieri uno straniero in una combinazione di questo genere. Ma se la cosa le preme molto, mi darò da fare, e forse posso procurarle un biglietto indirettamente, voglio dire in modo che uno dei sottoscrittori, contro un indennizzo, che non sarà piccolo, le ceda le sue probabilità, senza che sia fatto il suo nome.
Andrea non sapeva che rispondere, e passò rapidamente ad altro, esprimendo la sua meraviglia che la figliola maggiore non trovasse altra via per aiutare la sua famiglia e lasciasse sacrificare la sorella minore in questo modo inconsueto.
– Be', non è poi tanto inconsueto quello che fa, – rispose l'altro – e da Nina non c'è molto da aspettarsi, la piccina lo sa meglio di tutti. Nina ha le mani bucate, e ciò che lei le regala oggi, domani è bell'e sfumato. È una bellezza, ma quanto a cervello non si può mettere con Zustina. Stia a sentire com'è: una volta le voglio presentare un ricco e distinto signore di Vienna, il conte Grassalkowicz – il nome non le sarà ignoto. E lei saprà che significhi fare la conoscenza di questo signore, che, come lei sa, ha due palazzi a Vienna e uno a Praga, e beni in Croazia grandi come tutto il territorio della Repubblica. “Come si chiama costui?” dice, e si fa ripetere il nome, e intanto arriccia il naso; quando fa così non c'è nulla da fare, proprio come un cavallo bizzoso. “Il nome” dice “pare una brutta bestemmia, e come il nome sarà chi lo porta. Conducilo dove credi, io non ne voglio sapere”. Qui c'è tutta Nina.
Andrea pensò che non era una distinzione particolare, come aveva creduto finora, essere presentato a madamigella Nina, ma tenne per sé le sue riflessioni.
Erano giunti in una piazza: all'aperto, davanti a una piccola bottega di caffè, c'erano tavolini di legno e seggiole di paglia; a uno dei tavolini un signore tutto vestito di nero scriveva lettere. A un altro sedeva un uomo di mezza età, goffo e pesante, le guance rase ombrate d'azzurro, che indossava una lunga tunica ad alamari di foggia straniera; e seduto molto comodamente ascoltava senza battere ciglio un giovane, che gli andava parlando affannoso, ma senza aver il coraggio di accostare la sua seggiola al tavolino, anzi, senza osare nemmeno di sedere veramente, tanto che Andrea non poteva guardarlo senza provare pena e fastidio.
© Paolo Melandri (8. 9. 2018)
*
Carlo e Sara
Carlo vide Sara. Da quel giorno ne fu innamorato.
Le loro anime volarono l'una incontro all'altra, danzando e mormorando come uccellini che si scambiano messaggi festosi. Quel timido amore era giunto come una stagione incerta, solo a tratti serena e luminosa…
Come avverrà l'incontro di due destini in una strada deserta e silenziosa?
Quel mattino le case erano adorne di vividi stendardi che sventolavano vigorosamente, la città sarebbe stata in festa tutto il giorno. Il cielo azzurro sembrava una carta lucida; innumerevoli nuvole delicate, come quelle dipinte nelle raffigurazioni dei santi nel Medioevo, fluttuavano abbaglianti. Sulla strada riverberava una debole luce che presto si sarebbe dileguata. Fu qui che le loro sorti si incontrarono.
Ancor prima che i due giovani si accorgessero l'uno dell'altro, i loro destini avvertirono le reciproche presenze. Una debole risonanza che arrivava superando il mare dove ondeggiano le anime. Sembrava il suono di un'accetta che taglia dei rami, sgorgava a precipizio come una piccola sorgente al di là di un boschetto morto. Un cuore non innamorato non può sentire quel suono.
Carlo distolse lo sguardo da Sara, si sedette alle radici di una quercia ricoperte di muschio e nascose il viso fra le mani. Lei si sedette al suo fianco e guardò tranquillamente il cielo. Dalle cime dei vecchi alberi allineati esso appariva simile a piccole conchiglie azzurre…
Nei giorni in cui c'era un bel cielo sereno, sul viso di lei non apparivano mai i colori della sofferenza, neppure come l'ombra di una nuvola che passa furtiva su un lago ghiacciato. In quei giorni luminosi neanche il più terribile dolore di questo mondo avrebbe potuto disegnarsi sul suo volto. In lei si scorgevano i tratti delle principesse medievali. Quelle dame che i pittori non sapevano raffigurare che con uno stile molto semplice, anche se dovevano ritrarre una vita di lunghe sofferenze. Uno stile rozzo e primitivo, ma forse il solo possibile per rappresentare la verità. Oggi è impossibile vedere un volto femminile così semplice ed elegante, carico di quel fascino antico, un volto che non si rattrista mai.
“Sara!” esclamò Carlo rimanendo voltato e con il viso nascosto fra le mani.
“Sara.”
“Cosa c'è, Carlo?”
“Sei davvero lì? Non so perché ma ho la sensazione che tu non ci sia.”
Sara stava in silenzio, esprimeva così tutta la sua sicurezza interiore. Carlo si voltò bruscamente verso la fanciulla e colse per un attimo l'immagine della sofferenza che la assaliva. I suoi occhi fissi su di lei si riempirono di lacrime. Ma a poco a poco quel silenzio così pacificante e sereno riportò la calma nel suo cuore.
“Oh, Carlo, devi imparare a essere più fiducioso,” sembravano dire gli occhi di Sara; il suo sguardo nobile e intelligente come quello di un cervo si rifletteva negli occhi del giovane simile a un raggio di luce penetrato da un'alta finestra sul pavimento di un salone.
Nel cuore di Carlo i dubbi continuavano ad agitarsi, come foglie cadenti che all'approssimarsi dell'inverno volano e si disperdono all'ombra dei rami secchi.
Esisteva davvero a questo mondo una “realtà autentica”? Esisteva una ragione per cui trascorreva la sua vita fra l'insicurezza e la paura? Era terribile constatarlo, ma forse quella realtà che cercava nell'“esistenza” non l'avrebbe mai trovata, perché essa non era altro che un aspetto della non esistenza, una configurazione dell'“assenza”. L'“assenza” è un angelo. L'“esistenza” è un angelo disceso dal cielo, cui hanno tarpato le ali. Non vi è nulla di più triste della sua immagine: non può fare il minimo movimento all'interno degli angusti confini della terra. Non può cantare, non può parlare. È soltanto una commiserevole figura plastica, cui non è permesso altro che farsi toccare. Immobile e silenzioso, non spiccherà mai più il volo col suo abbagliante batter d'ali, simile al polline di pino che si libera come polvere d'oro verso il cielo sereno e luminoso.
In quel luogo c'era troppa luce, sembrava mezzanotte. Le api volavano nelle tenebre del pieno giorno facendo luccicare la pelle dorata come insetti dell'India, come tanti microscopici animaletti fosforescenti.
Carlo camminò a lungo, inciampando nei cespugli di fiori luccicanti che sembravano un mare quieto e coperto di spuma…
Provava una vertigine pari a una meravigliosa fiamma celeste. L'ebbrezza lo faceva tremare, si sentiva come l'albero di una nave che oscillava e scricchiolava. A un certo punto fermò lo sguardo sul monastero al di là del giardino: sembrava una piccola basilica di foglie verdi su cui la rosa selvatica stendeva i rami ormai quasi spogli. Il suo cuore trasalì, fu assalito da un misterioso timore. Per un po' restò immobile in mezzo ai fiori bianchissimi.
“Sara!” gridò all'improvviso volgendosi verso il monastero.
“Sara!” chiamò ripetutamente due, tre volte.
Non vi fu risposta, ma sul suo volto crebbe l'ombra del sollievo e della felicità, simile alla sagoma della foresta che, giunta la sera, si faceva sempre più scura sulla superficie del laghetto. Nondimeno in fondo a quell'ombra scorreva il vuoto, lo stesso vuoto di un cielo dove si incrociano solo due piccole nuvole.
Carlo rifletteva: Sara non era al monastero: quella dolce e nobile assenza verificava meravigliosamente il suo esistere più di ogni altra realtà. E il fatto che lui si sentisse così felice era la prova inconfutabile di tutto ciò.
Sara non c'era, ma al monastero, al solito posto dove la fanciulla aspettava sempre il suo arrivo, fluttuava una delicata essenza. A Carlo quel luogo sembrava inavvicinabile, inviolabile, proprio come se lei ci fosse stata realmente. In quel momento, un raggio di sole calante penetrò all'interno del monastero. Le poche rose selvatiche che lo ricoprivano accese da quel bagliore cominciarono a risplendere a una a una come se bruciassero.
© Paolo Melandri (7. 9. 2018)
*
Fontane sotto la pioggia 3
Inclinando un po' l'ombrello, resi più tranquilli dal fatto che potevano evitare di incrociare i loro sguardi, i due seguitarono a guardare le tre fontane, quella al centro più imponente, le due ai lati più piccole, quasi fossero i due santi che nei trittici affiancano il Cristo. Il continuo brusio degli zampilli e del laghetto rendeva impossibile distinguere il suono delle gocce di pioggia che cadevano sull'acqua. Da quel punto, l'unico rumore che talvolta si percepiva era il rombo irregolare di automobili lontane e tutt'intorno la voce delle fontane era così strettamente intrecciata con l'aria che sembrava di essere chiusi in un perfetto silenzio, a meno che non si tendesse l'orecchio.
L'acqua rimbalzava in gocce minuscole sulla massiccia base di granito nero e parte di essa seguitava a cadere percorrendo il bordo nero e trasformandosi in un disegno irregolare. Il grande getto principale torreggiava al centro della vasca, protetto da sei colonne d'acqua che venivano lanciate lontano irraggiandosi in tutte le direzioni e disegnando linee ricurve.
A ben guardare, il getto non manteneva sempre un'altezza costante. Non soffiava quasi vento e quindi l'acqua, indisturbata, poteva salire in perpendicolare verso il cielo color cenere, ma la sommità verso cui si protendeva non era necessariamente sempre la stessa. In alcuni momenti l'acqua, non più compatta, veniva lanciata ad un'altezza inaspettata e, qui giunta, ricadeva in gocce. La porzione più vicina alla cima rifletteva il cielo carico di pioggia, assorbendone le ombre e, assumendo un colore grigio cosparso di venature di biacca che le davano un'apparenza quasi polverosa, spargeva tutt'intorno un pulviscolo impalpabile. Attorno al getto principale gli spruzzi danzavano simili a larghi fiocchi bianchi, dando l'impressione di neve mista a pioggia. Tuttavia Alberto, più che dai getti principali, era affascinato dalla forma dell'acqua che si irraggiava disegnando linee ricurve.
© Paolo Melandri (6. 9. 2018)
*
L’ombrello
L'ombrello
Una pioggerella primaverile che pareva più una nebbia, che non bagnava davvero ma lasciava sulla pelle una vaga umidità. La ragazzina, che si era precipitata in strada, solo quando vide l'ombrello del ragazzo se ne accorse:
“Ehi, ma piove!”.
L'ombrello, più che per la pioggia, il ragazzo l'aveva aperto per nascondere l'imbarazzo di passare davanti al negozio dove sedeva la ragazzina.
Però senza dire una parola la prese sotto l'ombrello. Lei vi entrò solo con una spalla. Il ragazzo si bagnava ma non osava avvicinarsi e dirle «vieni vicino». La ragazzina avrebbe voluto mettercela anche lei una mano sul manico dell'ombrello, invece pareva sempre sul punto di sgusciar fuori.
Insieme entrarono da un fotografo. Il padre del ragazzo, che era un magistrato di sorveglianza, veniva trasferito lontano. Era una foto d'addio.
«Mettetevi qui, uno di fianco all'altro» e il fotografo fece cenno al divano, ma il ragazzo non osava sedersi accanto alla ragazzina. Rimase in piedi dietro di lei, e per poter pensare che i loro corpi fossero in qualche punto allacciati, allungò le dita che teneva attorno al divano fino a sfiorare appena appena la giacca di lei. Era la prima volta che la toccava. Alle sue dita si trasmetteva un impercettibile tepore, ma lui sentì lo stesso calore che se l'avesse stretta nuda fra le braccia.
Per tutta la vita, ogni volta che avesse guardato quella foto, gli sarebbe tornato in mente quel calore.
«Ne facciamo ancora una? Se vi mettete fianco a fianco facciamo un primo piano.»
Il ragazzo si limitò ad annuire. Si volse alla ragazzina e sottovoce le disse: «I capelli!». Lei levò la testa di scatto, lo guardò e avvampò, e con gli occhi che le brillavano di gioia, come una bimba trotterellò ubbidiente allo stanzino del trucco.
Quando aveva visto il ragazzo passare davanti al negozio si era lanciata fuori senza nemmeno il tempo di aggiustarsi i capelli. Quei capelli, sempre per aria come si fosse appena sfilata una cuffia da bagno, erano il suo eterno cruccio. Ma lei davanti a un uomo si sarebbe vergognata anche solo di accennare a ravviarsi una ciocca. Il ragazzo, a sua volta, pensava di metterla in imbarazzo a dirle di pettinarsi.
L'allegria con cui andò allo stanzino del trucco mise allegria anche al ragazzo. E dopo riuscirono a sedere con naturalezza sul divano, vicini.
Quando furono pronti per uscire dal fotografo, il ragazzo cercò l'ombrello. Gli scappò l'occhio e vide la ragazzina che era già uscita e lo aspettava in strada con l'ombrello in mano. Quando la guardò, solo allora, lei si rese conto di essere uscita con l'ombrello del ragazzo. E sbalordì. Con quel gesto involontario non aveva forse dimostrato di sentirsi sua?
Il ragazzo non riuscì a dirle di tenere l'ombrello. Né la ragazzina ebbe il coraggio di porgerglielo. Ma di colpo erano diventati adulti e, ben diversamente dall'andata, il ritorno lo fecero da coppia. Solo per via di un ombrello…
© Paolo Melandri (3. 9. 2018)
*
Animali in gabbia
Si riposarono tutti e tre seduti su una larga e piatta roccia accanto al bacino della cascata. Qualcosa era cambiato in Elena dal momento in cui aveva udito il rombo dell'acqua. Rideva allegramente, ammutoliva all'improvviso, si mostrava capricciosa ed egoista; i suoi occhi, in cui si rifletteva la cascata, erano umidi e appassionati, le labbra truccate con scuro rossetto s'increspavano di tanto in tanto senza però sorridere.
Lo spettacolo della cascata era superbo. Sulla cima rocciosa con neri riflessi, ad un'altezza di circa sessanta metri, tra lo scintillio di nubi sconvolte e la luce che filtrava attraverso alberi sparsi, l'acqua pareva trotterellare per poi precipitare. Al culmine si scorgeva, per un terzo della superficie, nient'altro che bianchi spruzzi, non si vedeva la roccia; l'acqua precipitando si divideva in due e improvvisamente si gettava in avanti come ad assalire lo spettatore, formava una decina o una ventina di balze e cadeva scuotendo la sua bianca criniera. Nelle rocce che provocavano la sua furia crescevano solo poche erbe fradicie fin sugli steli. La direzione del vento cambiava di continuo e con essa mutava l'incerta posizione della nebbia che volava qua e là. Ma la luce del sole che attraversava gli alti alberi della riva destra sembrava la quiete personificata e gettava sull'acqua che precipitava le linee dei suoi raggi regolari e parallele. Lì intorno tutto era dominato dal fragore della cascata e dal frinire delle cicale, questi due suoni lottavano tra di loro, sembravano fondersi, oppure, a tratti, pareva di sentire solo il fragore della cascata o l'intenso frinire delle cicale.
Stavano sdraiati sulla roccia, ognuno nella posizione preferita. Filippo prese il giglio che giaceva accanto ad Elena e se lo appoggiò sul volto rimanendo supino. I gesti di Filippo avevano qualcosa di incomprensibile perché erano sempre o esagerati oppure interrotti. Non si capiva se in quel momento volesse fiutare il profumo del giglio oppure mangiarlo. Comunque fosse rimase a lungo con il bel naso e la bocca sepolti dal giglio. Elena e Bruno, assordati dal fragore della cascata, finsero di non vedere. D'un tratto Filippo parve soffocare e respinse il fiore; stupito sollevò il volto, macchiato di polline color mattone sulla punta del naso e sulle guance. Aveva forse tentato di suicidarsi con il giglio?
Elena si rialzò. Fu la prima volta che Bruno vide nel suo sguardo una simile mancanza di rispetto verso il marito. Elena prese il giglio un po' sgualcito e tenendolo per il gambo avvolto nella carta argentata lo fece girare più volte leggermente tra le dita dalle unghie laccate di rosso, con un'espressione meditabonda.
“Senti, capisci la parola 'sacrificio'!”
Domandò con un tono irriverente scrutando il volto di Filippo che si era di nuovo coricato supino. Filippo si stupì per il tono, chiaramente diverso dal solito, con cui la moglie lo interrogava.
“Sa...ficio?”
“Ma no. Non capisci, 'sacrificio'!”
“Non può capire.”
Intervenne Bruno, perché gli era sembrato che il tono di Elena fosse troppo crudele.
“È impossibile, che capisca una parola così astratta.”
“Stai zitto. Lo sto mettendo alla prova.”
Così dicendo Elena si era voltata verso Bruno e nel suo viso non appariva affatto l'espressione pungente ch'egli aveva immaginato, sorrideva con un sorriso languido, quasi dissoluto. Bruno vide che il vento della cascata faceva strisciare sulla fronte di Elena alcuni capelli scomposti e ricordò quel capello che galleggiava nella penombra della vasca.
“Non capisci proprio, vero? Stupido. Significa questo.”
Improvvisamente Elena gettò nel bacino della cascata il giglio che aveva in mano. Cadde disegnando davanti ai loro occhi un luminoso cerchio bianco. Sul viso di Filippo trapelò un'espressione cupa e torbida. Bruno non l'aveva mai veduta; era apparsa chiaramente in lui l'ansia del suo spirito solitario, a cui era impedita ogni comprensione, che tremava di paura.
Elena assunse un'aria gioiosa. Era tanto allegra da non riuscire più a controllarsi. Rise inarcando il corpo, fin quasi a soffocare e poi domandò bruscamente:
“E 'bacio', lo capisci?”
“Ba…”
“Prova a dire 'bacio'.”
“Ba…”
“Che stupido! Non capisci, eh? Allora te lo insegno. Si fa così.” Elena si girò su se stessa e improvvisamente abbracciò il collo di Bruno seduto accanto a lei. La roccia era scivolosa e il giovane non ebbe il tempo di difendersi da quell'attacco improvviso. Le labbra di Elena premettero selvaggiamente le sue, i loro denti si scontrarono. Dopo quell'urto le loro labbra si fusero. Elena fece scivolare la lingua nella bocca di lui, Bruno, in un tepore umido, molle e stagnante bevve la saliva di Elena. Il suo udito era pervaso dall'eco ininterrotta della cascata ed egli non si accorse di quanto tempo stesse passando.
Quando scostò le sue labbra si sentì invadere dalla collera. Aveva l'impressione che quel bacio gli fosse stato dato solo a causa di Filippo.
“Smettila. Smettila di tormentarlo per scherzo.”
“Ma non soffre!”
“Come fai a capirlo? Ad ogni modo a me non va d'essere usato come un oggetto.”
Elena levò verso Bruno uno sguardo ironico.
“Ma che dici? E sì che sei sempre stato usato, fin dal principio. A te piace, vero?”
Bruno istintivamente colpì la guancia di Elena. E, invece di guardarla, rivolse lo sguardo a Filippo.
In quel momento sul viso di Filippo aleggiava un inconfondibile sorriso. Era assolutamente uguale a quello che Bruno aveva veduto per la prima volta dopo la scarcerazione, e finalmente gli parve di capire che cosa significasse quella nuova caratteristica espressione. Si sentì respinto ed estromesso da quel sorriso. C'era in esso qualcosa che gli ricodava la limpida clessidra che appariva e dispariva tra le volute turbinose di vapore durante quei luridi bagni nel carcere.
In preda al terrore, questa volta fu Bruno ad abbracciare Elena. Aveva fra le braccia il volto docile e freddo di lei, che teneva gli occhi chiusi. Bruno le baciò le labbra e si sforzò inutilmente di scuotersi da ogni angolo della mente il sorriso di Filippo, più in fretta che potesse. Perciò quel bacio era completamente privo del gusto meraviglioso dell'altro.
Infine si accorsero che il cielo era coperto di nuvole. Non avevano portato di che ripararsi dalla pioggia, tutti e tre in silenzio radunarono le loro cose, si alzarono aiutandosi a vicenda e pensarono al fastidio di dover incontrare la pioggia durante il lungo cammino di ritorno. Fu Elena a portare il cesto vuoto.
© Paolo Melandri (3. 9. 2018)
*
Tramonto nuvoloso
Quel pomeriggio, lasciato Claudio e ritornata a Settignano, Laura ebbe timore che l'euforia si prolungasse nelle ore di lavoro. Soprattutto era contenta che qualcuno le avesse dimostrato un interesse particolare. Questa felicità le faceva capire per la prima volta quanto era stata sola.
In compagnia di Claudio non si era sentita emozionata in modo speciale, ma appena lo ebbe salutato, un vortice di emozioni varie si svegliò dentro di lei. Anzitutto non si arrese a visioni di se stessa in atto di preparare per Claudio camicie candide e fresche di bucato e abiti nuovi e alla moda. Tuttavia questo ruolo domestico dipendeva dai sentimenti di Claudio verso di lei. Finché non ne fosse sicura, non era il caso di pensare a soccorrevoli interventi. Laura si stupiva che ancora una volta il dubbio potesse irrompere nella sua vita, che dovesse riproporlesi il problema di non sapere quali fossero i pensieri di un'altra persona. Non era soltanto strano ma preoccupante.
Laura cercò di spiegarsi perché Claudio portava abiti così brutti anche se di buona qualità, e questo pensiero sollevò a sua volta angosciate congetture sul suo reddito. Doveva senza dubbio vivere di una pensione, che forse gli era a malapena sufficiente. Per un uomo che era stato membro del governo, il suo era certamente un tenore di vita molto ridotto. Quella notte, anche mentre si affacendava a intrattenere gli ospiti, Laura seguitò a rimuginare questi pensieri. Si domandava se non esisteva un modo per venire a sapere senza offesa l'effettivo ammontare della sua pensione.
Quella sera, sola nella sua cameretta, Laura non riusciva a prendere sonno, la testa gremita di fantasie di ogni sorta. Il quartierino privato di Laura era, rispetto al resto dell'appartamento, straordinariamente severo e spoglio. Vicino al capezzale c'era il telefono su un tavolino basso, e intorno stavano pile disordinate di vecchie riviste. La stanza non conteneva nessun oggetto che somigliasse lontanamente a un'opera d'arte; perfino il caminetto era tutto coperto di biancheria gettata alla rinfusa. Ma quando Laura si infilava nel letto, un lettone che occupava tutta la stanza, si sentiva finalmente padrona di sé.
© Paolo Melandri (2. 9. 2018)
*
Sete di amore
Per certe persone vivere è estremamente semplice, per altre è assai difficile. Angela non provava alcun senso di ribellione verso simili ingiustizie, molto più profonde della discriminazione razziale.
È naturale che sia molto meglio riuscire a vivere con facilità. Infatti la gente per cui è facile vivere non ha bisogno di giustificarsi. Invece dire che la vita è difficile è un pretesto per continuare a vivere. In realtà non è il caso di vantarsi se si trova difficile vivere. La capacità di scoprire quanto sia arduo vivere ci rende in un certo senso la vita facile come quella degli altri. Infatti se ne fossimo sprovvisti, la vita sarebbe per noi una sfera vuota, scivolosa, senza alcuna asperità su cui poggiare i piedi. Questa capacità impedisce di vedere la vita sotto un aspetto del genere e sebbene appartenga a gente che non avrebbe assolutamente la possibilità di considerare la vita in quella forma, non è una capacità speciale, ma soltanto un bene indispensabile alla vita quotidiana. Chi trucca la bilancia della vita, facendo apparire un peso superiore, sarà punito nell'inferno. Non vi è necessità di ricorrere a trucchi, perché la vita ha un peso di cui non siamo coscienti, come quello di un cappotto: soltanto i malati hanno le spalle indolenzite dopo averlo indossato. Io sono costretta a coprirmi con un indumento più pesante di quello degli altri esseri umani perché, per pura combinazione, il mio spirito è nato in un gelido paese delle nevi. La difficoltà a vivere non è in me che un'armatura per difendermi.
Quel motivo per vivere non le faceva più sembrare un peso l'indomani, e neppure l'intero suo futuro. Continuava a essere sostanzialmente un peso, e tuttavia quella minima variazione di baricentro aveva dato agio ad Angela di volgersi agevolmente al futuro. Non con la speranza. Per nulla. Ormai Angela spiava di continuo il comportamento di Matteo e di Elisa. Non si baciavano forse all'ombra di un albero? Un misterioso filo non univa forse a notte fonda le loro camere lontane?… Una simile scoperta sarebbe servita soltanto a tormentarla, e tuttavia l'angoscia dell'incertezza le pareva più atroce, perciò decise che avrebbe osato agire anche con i metodi più vili pur di trovare la prova del loro amore. A giudicare soltanto dal risultato, la sua passione mostrava con esattezza quasi sinistra quanto smisurato sia l'ardore che l'essere umano riversa nel torturare se stesso. Forse tutta quella passione profusa al solo scopo di perdere le proprie speranze era un modello fedele delle forme manifeste dell'esistenza umana, profilate o arcuate che fossero. La passione è già di per se stessa una forma, un medium che mostra completamente le potenzialità della vita umana.
Nessuno si accorse di come Angela spiasse ovunque i due giovani. D'altronde ella pareva impegnarsi nella sua attività con più serenità del solito.
© Paolo Melandri (2. 9. 2018)
*
Fontane sotto la pioggia 2
Oltre il parco passavano di continuo i teloni bagnati dei camion e i tetti gialli, bianchi e rossi degli autobus; la luce rossa dei semafori all'incrocio si distingueva chiaramente ma, quando scattava il verde, il colore diventava impercettibile, confondendosi con la nebbia sollevata dalle fontane. Il ragazzo restava seduto in silenzio e questo lo riempiva di un'indicibile irritazione. Anche la buffa associazione di idee di poco prima era scomparsa. Non sapeva bene verso cosa fosse diretta quella sua collera. Poco prima aveva assaporato l'emozione di procedere libero da ogni freno, ma ora avvertiva un peso doloroso. L'impossibilità di risolvere il problema di Francesca che seguitava a piangere non era l'unica ragione di quel peso.
“Potrei buttarla nel laghetto della fontana e scappare via. Sarebbe tutto risolto” pensò, con una certa soddisfazione. Ciononostante avvertiva un disagio assoluto per quella pioggia che lo avvolgeva, per quelle lacrime, per quel cielo plumbeo. Un disagio pesante che lo opprimeva e trasformava la sua libertà in una specie di straccio bagnato. L'irritazione si trasformò in puro dispetto. Non sarebbe stato tranquillo fino a quando Francesca non fosse stata fradicia di pioggia, fino a quando gli occhi della ragazza non si fossero riempiti della vista delle fontane.
© Paolo Melandri (31. 8. 2018)
*
Fontane sotto la pioggia
Il ragazzo era stanco di camminare sotto la pioggia trascinando, come un pesante sacco di sabbia, la ragazza che continuava a piangere.
Poco prima, in un caffè del Quartiere Spagnolo, le aveva detto che si sarebbero lasciati. Era stato il primo discorso d'addio della sua vita!
Un avvenimento che aveva spesso sognato, e che finalmente era diventato realtà. Solo per questo si era innamorato, o aveva fatto finta di innamorarsi, della ragazza, solo per questo le aveva fatto la corte, solo per questo aveva cercato in tutti i modi di portarsela a letto, solo per questo aveva fatto l'amore con lei… ed ora che tutti i preliminari erano conclusi, gli era stato possibile dire la parola che da tanto tempo aveva desiderato pronunciare, almeno una volta, con tutti i crismi, proprio come il decreto emesso da un re: “Lasciamoci”.
Una parola tale che, se solo fosse stata pronunciata, per via della sua forza anche il cielo si sarebbe incrinato. Una parola che, per quanto egli fosse rassegnato a non vedere mai l'attesa trasformata in realtà, aveva seguitato a sognare, nella speranza che prima o poi si sarebbe presentato il momento. Una parola che era la più luminosa, la più eroica al mondo, che, come una freccia scoccata dall'arco, attraversa il cielo in linea retta, dirigendosi verso il bersaglio. Una parola che solo al più umano degli esseri umani, al più uomo degli uomini è permesso pronunciare: “Lasciamoci”.
Ciononostante, Carlo si sarebbe per sempre rammaricato per il modo confuso con cui l'aveva pronunciata, con voce strozzata, proprio come un malato d'asma che ha la gola invasa dal catarro (e non era servito a nulla il sorso di soda che aveva sorbito dalla cannuccia un attimo prima). In quel momento Carlo aveva temuto più di ogni altra cosa che la ragazza non avesse capito quello che aveva detto. E se Francesca glielo avesse chiesto e lui avesse dovuto ripetere la stessa parola una seconda volta? Sarebbe stato meglio morire. Era come se un'oca avesse sognato per anni e anni di produrre un uovo d'oro e poi quest'uovo, non appena comparso, si fosse rotto prima ancora che gli altri lo vedessero. Come avrebbe potuto l'oca produrne subito un altro uguale?
Ma per fortuna lo aveva sentito. Certo non si poteva dire altro se non questo: era stata una fortuna straordinaria che lo avesse sentito bene e non gli avesse chiesto nulla. Finalmente Carlo aveva superato con le proprie gambe la barriera che per lungo tempo si era innalzata davanti a lui, lontana, come sulla cima di un monte. La prova che lei lo aveva sentito gli era giunta in un istante. Proprio come quando la gomma da masticare esce di scatto dal distributore automatico.
A causa delle finestre chiuse ermeticamente per via della pioggia, le voci degli altri clienti, l'acciottolio dei piatti, lo squillo del registratore di cassa rimbalzavano urtandosi e, chiusi all'interno della stanza, si riverberavano stranamente nelle gocce tiepide sui vetri e producevano un suono che annebbiava la mente. Non appena le confuse parole di Carlo, attraversando quel suono, erano giunte fino all'orecchio di Francesca, la ragazza aveva spalancato gli occhi, che erano già troppo grandi, come se volessero eliminare, respingere ogni cosa in quel suo viso dai lineamenti esili e poco appariscenti. Più che occhi erano sembrati una sola unica fenditura incontrollabile. E da essa erano sgorgate tutte in una volta le lacrime. Francesca piangeva senza un singhiozzo, senza un lamento. Le lacrime sgorgavano inespressive, a fiotti, come spinte dalla pressione idrica. Naturalmente Carlo non aveva dato molto peso a quelle lacrime: erano troppo forti, troppo intense, sarebbero presto finite. Era estasiato dalla fresca sensazione, simile a quella della menta, che invadeva il suo cuore mentre, immobile, la fissava. Era proprio ciò che aveva progettato, costruito, tradotto in realtà, e forse vi era un che di meccanico, ma la conclusione era sublime. “Proprio per arrivare a questo ho fatto l'amore con Francesca” si ripeté. “Ero libero da ogni desiderio...”
Ora il volto rigato di lacrime della ragazza era una realtà. Questa, proprio questa, per Carlo, era l'immagine di una vera e propria “donna abbandonata”.
Francesca seguitava a piangere e non dava segno di voler smettere sicché il ragazzo cominciò a preoccuparsi di quello che gli altri potevano pensare.
Francesca, con il suo impermeabile bianco, era seduta composta sulla sedia. Dal bavero dell'impermeabile si scorgeva il colletto della camicetta rossa, scozzese. Con le mani stette con forza sui bordi del tavolino, sembrava irrigidita in quella posizione. Guardando fisso davanti a sé, lasciava che le lacrime scorressero a volontà. Non accennava neppure a prendere un fazzoletto per asciugarle. Il respiro affannoso che urgeva nella gola sottile produceva a intervalli regolari un gemito strozzato, simile al rumore di scarpe nuove, e le sue labbra senza rossetto, infantilmente ostinate, tremavano contratte in una smorfia di scontento.
I clienti adulti li stavano guardando con curiosità. E sebbene Carlo si sentisse ormai parte della categoria degli adulti, i loro sguardi erano sufficienti a distruggere quella sensazione. Davvero non gli restava che meravigliarsi per l'abbondanza di quelle lacrime che non accennavano a diminuire di intensità e di frequenza.
Stanco, abbassò gli occhi e guardò la punta dell'ombrello che aveva appoggiato alla sedia. Sul pavimento di antiquate piastrelle a mosaico, gocce d'acqua nerastra avevano formato una piccola pozzanghera. Agli occhi di Carlo sembrò che anch'essa fosse nata dalle lacrime di Francesca. Si alzò all'improvviso, stringendo il conto fra le mani.
Erano ormai tre giorni che la pioggia seguitava a cadere. Uscito dal ristorante, aprì l'ombrello e la ragazza lo seguì in silenzio. Francesca era senza ombrello e a Carlo non restò altra scelta se non quella di farle posto sotto il proprio. Scopriva in quel momento le abitudini degli adulti che tendono a rispettare le forme, a mente fredda, ed ebbe l'impressione che questa abitudine fosse ormai divenuta parte di sé. Convincersi che, dopo essersi detti addio, camminare in due sotto lo stesso ombrello era solo una questione di forma. Essere razionali… In qualche modo confuso, la razionalità si addiceva al carattere di Carlo.
Mentre si avviavano verso il Palazzo reale sull'ampio marciapiede, tutto ciò a cui pensava era solo a come liberarsi da quel fardello di lacrime. “Chissà se le fontane zampillano anche quando piove” pensò, senza quasi rendersene conto. Per quale motivo gli erano venute in mente le fontane? Fatti altri due o tre passi si rese conto della buffa relazione meccanica che si era creata fra i suoi pensieri.
Nell'esiguo spazio sotto la tesa dell'ombrello, sopportando a fatica il contatto dell'impermeabile umido della ragazza che lo sfiorava, simile a un rettile, la mente di Carlo seguì con forzata vivacità il percorso di quel gioco di associazioni. “Certo, una fontana nella pioggia. Facciamo una gara con le lacrime di Francesca. Per quanto possa piangere, Francesca perderà. Prima di tutto, quella è ad alimentazione continua, mentre le lacrime vanno tutte perdute e non possono reggere al confronto. È impossibile gareggiare con l'acqua che si autoalimenta e lei a questo punto si rassegnerà e smetterà di piangere. Così anche questa seccatura si risolverà in qualche modo. L'importante è sapere se le fontane buttano acqua anche quando piove.”
Carlo procedeva in silenzio. Francesca, sempre piangendo, lo seguiva ostinata. Era un problema liberarsi di lei, ma in compenso era facile trascinarla dove lui voleva. Carlo sentiva che tutto il suo corpo si stava bagnando di lacrime e di pioggia. Francesca, che indossava stivali bianchi, non aveva problemi, ma lui, con i suoi mocassini, aveva l'impressione di avere ai piedi alghe bagnate al posto dei calzini.
C'era ancora tempo prima della chiusura degli uffici e sul marciapiede non passava quasi nessuno. I due attraversarono le strisce pedonali e si avviarono verso i Giardini Carlo Felice. Dall'estremità del ponte, che conservava i parapetti di legno e le decorazioni metalliche di tipo tradizionale, si vedevano sulla destra i cigni che galleggiavano sull'acqua del fossato immerso nella pioggia: sulla sinistra, al di là del fossato, si scorgevano confusamente, attraverso i vetri appannati, le tovaglie bianche e le file di sedie rosse del ristorante annesso all'Hotel P.
Attraversarono il ponte. Superarono l'alta recinzione di pietra e, svoltando a sinistra, arrivarono al parco delle fontane. Francesca continuava a piangere, senza una parola.
All'ingresso del parco vi era un grande pergolato: sotto il tetto di canne, una panchina era in parte riparata dalla pioggia e Carlo vi si sedette senza neppure chiudere l'ombrello, mentre Francesca, sempre piangendo, si sistemava al suo fianco, un po' obliquamente, cosicché di lei poteva veder soltanto i capelli bagnati e le spalle coperte dall'impermeabile bianco. Anche le stille di pioggia, respinte dalla brillantina profumata cosparsa sui capelli, parevano minuscole gocce bianche. Francesca, che continuava a piangere con gli occhi spalancati, sembrava caduta in uno stato di trance, sicché Carlo provò il desederio di farla tornare in sé strattonandola per i capelli.
Forse la ragazza sarebbe rimasta in silenzio in eterno, sempre piangendo. Era evidente che si aspettava che lui le rivolgesse la parola e ciò bastava a irritarlo e a impedirgli di dire alcunché. A pensarci bene, da quando aveva pronunciato quell'unica parola di addio, Carlo non aveva più aggiunto nulla. Le fontane in lontananza seguitavano a mandare in alto i loro zampilli vigorosi, ma Francesca nemmeno li guardava. Dal punto dove si trovavano, le tre fontane, una grande e due piccole, sembravano allineate su una sola linea orizzontale; il suono dell'acqua arrivava flebile, come annullato dalla pioggia, ma i getti che si disperdevano in tutte le direzioni, per via della lontananza che ne cancellava gli spruzzi, apparivano nitidi come tubi di vetro ricurvi. All'intorno, fin dove lo sguardo poteva arrivare, non vi era anima viva. Il verde del prato che si stendeva davanti alle fontane e le siepi di rododendri immerse nella pioggia avevano riflessi splendenti.
© Paolo Melandri (30. 8. 2018)
*
Le unghie la mattina
Una fanciulla povera viveva in un povero appartamento in affitto al primo piano. E attendeva di sposarsi col fidanzato. Però ogni sera a casa sua c'era un andirivieni di uomini sempre diversi. Era una casa dove non batteva il sole del mattino. Sovente la fanciulla, coi suoi logori jeans da uomo, faceva il bucato presso l'entrata di servizio.
La notte gli uomini, tutti senza eccezione, dicevano:
“Che roba! Non c'è nemmeno la zanzariera?”
“Mi spiace, mi scusi tanto. Sto sveglia io tutta la notte, mi alzo io a mandarle via, le zanzare.”
La fanciulla tutta zelante accendeva lo zampirone verde. Poi spegneva la luce e fissava la fiammella dello zampirone, e non c'era volta che non le sovvenisse di quand'era bambina. Poi, per ore infinite faceva vento al corpo dell'uomo. E anche in sogno continuava a sventagliare.
È ormai autunno.
Cosa insolita, a questo povero primo piano salì un vecchio.
“Non metti la zanzariera?”
“Mi spiace, mi scusi tanto. Sto sveglia io tutta la notte, mi alzo io a mandarle via, le zanzare.”
“Sì? Aspetta un attimo” disse il vecchio alzandosi in piedi, ma la fanciulla tentò di trattenerlo:
“Ma le mando via io fino alla mattina! Non dormo neanche un secondo!”
“Sì, sì. Torno subito.”
Il vecchio prese le scale e sparì. La fanciulla accese lo zampirone ma non spense la luce. Da sola al chiaro i ricordi di infanzia non le venivano.
Nel giro di un'ora il vecchio fu di ritorno. La fanciulla si alzò, di scatto.
“Oh, meno male che ci sono almeno i ganci!”
Nella povera stanza il vecchio appese una zanzariera bianca nuova fiammante. La fanciulla vi entrò, e mentre camminava stendendone l'orlo, il fresco contatto la faceva palpitare.
“Ero sicura che sarebbe tornato, perciò l'ho aspettata con la lampada accesa. Voglio guardarmela ancora un po' alla luce, questa zanzariera bianca.”
Invece cadde in un sonno profondo, come non le accadeva da molti mesi. La mattina neppure si accorse quando il vecchio se ne andò.
“Ehi, ehi, ehi, ehi!”
A svegliarla fu la voce del fidanzato.
“Finalmente domani possiamo sposarci! Però, che bella zanzariera! Solo a vederla, ci si sente già meglio”, e detto ciò tolse via tutti i ganci. Poi trascinò fuori la fanciulla e ve la gettò sopra.
“Mettiti sulla zanzariera. Sembra un grande fiore di loto bianco. Ora anche la stanza è immacolata come te.”
La fanciulla al tocco di quel lino nuovo si sentì una bianca sposa.
“Mi taglio le unghie dei piedi.”
Seduta sulla bianca zanzariera grande quanto la stanza, si mise, tutta assorta, a tagliarsi le unghie lunghe che aveva trascurato.
© Paolo Melandri (29. 8. 2018)
*
Il fiore bianco
I matrimoni tra consanguinei si erano succeduti generazione dopo generazione. La sua famiglia era andata man mano estinguendosi per la tubercolosi.
Anche lei ha spalle troppo strette. Un uomo che le abbracciasse avrebbe un moto di stupore.
Una donna premurosa le aveva detto:
“Poni attenzione al matrimonio. Non deve essere una persona robusta. Che sia una persona di carnagione chiara, anche debole all'apparenza, ma senza malattie, e che con la tubercolosi almeno, non abbia niente da spartire. Una persona che stia sempre composta, che non beva, e col sorriso sulle labbra...”
A lei, invece, piace fantasticare di forti braccia maschili. Forti da farle scricchiolare le costole quando la stringe.
Nonostante il volto trasparente poi, ha modi di un fatalismo disperato. Di chi si abbandona a occhi chiusi, leggera nel mare della vita. È questo che la fa seducente.
Le giunse una lettera da un cugino: “Infine mi sono ammalato di petto. È semplicemente arrivato il fatale momento che mi attendeva dall'infanzia. Sono sereno. Però c'è una cosa, una sola cosa, che rimpiango: perché quand'ero sano mai una volta ti ho pregato di lasciarti baciare? Che almeno le tue labbra non siano contaminate dal bacillo della tubercolosi!”.
Lei volò dal cugino. Subito dopo fu mandata in un sanatorio sulla costa.
Un giovane medico se ne prese cura quasi fosse l'unica degente. Le portava ogni giorno fin sulla punta del promontorio una sdraio di tela simile a una culla. Un bosco di cipressi lontano scintillava sempre dei riverberi del sole.
Sorge il sole:
“Ah, ti sei ormai rimessa alla perfezione. Proprio alla perfezione. Quanto ho atteso questo giorno.”
Detto ciò, il medico la sollevò senza sforzo dalla sdraio sugli scogli.
“Come il sole, anche la tua vita è sorta di nuovo. Perché tutte le navi del mare non dispiegano per noi le loro vele rosa? Mi perdonerai vero, se ho atteso questo giorno con due cuori. Come medico che ti guariva e poi con un altro “io” ancora. Con quanta trepidazione ho atteso questo giorno. Quanto è stato duro non accantonare la coscienza professionale. Tu ormai sei perfettamente a posto. Così perfettamente a posto da poterti lasciare andare al sentimento. Perché il mare non si tinge di rosa per noi?”
Lei levò al medico occhi pieni di gratitudine, poi volse lo sguardo al mare e attese.
Ma in quell'istante fu folgorata, suo malgrado, dall'assenza di ogni pensiero di castità. Dall'infanzia ha davanti agli occhi la propria morte. Perciò non crede al tempo. E dunque neppure può esserci castità.
“Con quanto trasporto osservavo il tuo corpo. Ma con quanta razionalità anche ne studiavo ogni centimetro. Per un medico, il tuo corpo è stato un laboratorio.”
“Come?”
“Un così bel laboratorio… Non avessi avuto la vocazione del medico, la mia passione a quest'ora ti avrebbe uccisa.”
E così questo medico le divenne antipatico. Si rassettò gli abiti in modo da scansare il suo sguardo.
Un giovane romanziere che era nella stessa clinica le disse:
“Auguri a noi! Facciamoci dimettere lo stesso giorno.”
Al cancello i due salirono sulla stessa auto e corsero per pinete.
Il romanziere fece come per posare un trepido braccio sulle sue piccole spalle. Lei si abbandonò all'uomo come un oggetto debole e leggero che franasse.
I due si misero in viaggio.
“È l'alba rosa della vita. Quale meraviglia che nel mondo spuntino assieme due mattini, il tuo mattino e il mio. Ecco, questo è bello. Scriverò un romanzo intitolato I due mattini.”
Lei levò al romanziere occhi pieni di gioia.
“Guarda questo. È un tuo ritratto al tempo dell'ospedale. Anche se tu fossi morta e io fossi morto, tutti e due forse saremmo vissuti dentro questo romanzo. Ma ora siamo due mattini: bellezza trasparente di caratteri senza carattere. Come polline che olezza nei campi a primavera, tu fai fluttuare sul mondo una bellezza simile a un profumo, invisibile all'occhio. Il mio romanzo ha scoperto un'anima bella. Come potrò scriverne? Mettimi la tua anima sul palmo della mano. Come un grano di quarzo. Io ne farò un ritratto a parole.”
“Come?”
“Un così bell'ingrediente… Non fossi stato uno scrittore, neppure la mia passione avrebbe potuto tenerti in vita fino a un lontano futuro.”
E così questo romanziere le divenne antipatico. Si drizzò sulla sedia in modo da scansare il suo sguardo.
Ora è seduta in camera sua. Il cugino è morto tempo fa.
“Rosa, rosa.”
Spia la sua pelle bianca che si fa pian piano trasparente e intanto sorride ripensando alla parola “rosa”. Sorride pensando di assentire quando qualche uomo la desidererà.
© Paolo Melandri (29. 8. 2018)
*
La luce della carne
Irene suonò il campanello e comparve una donna, probabilmente una domestica. Appena sentito il nome, fu condotta in una stanza al secondo piano. Una stanza di medie dimensioni che, così come si presentò una volta accesa la luce, mandò in frantumi le fantasie di Irene. Dalle tende al mobilio, tutto là dentro era assolutamente inadatto allo stile dell'edificio: un'accozzaglia di oggetti a buon mercato e, in un angolo, perfino uno sgargiante angolo cottura in acciaio inossidabile.
“La sala da bagno è da questa parte,” disse la donna, mostrandole con fierezza una vasca piastrellata di mattonelle della grandezza di una pattumiera che formavano un motivo a scacchi rosa e bianchi.
Senza tener conto delle diverse qualità degli uomini che frequentava, non si può certo dire che la circostanza, per Irene, fosse rara. La cosa che temeva di più era la possibilità di restare incinta, dunque invitava sempre i suoi partner a prendere le precauzioni del caso. Era un momento delicato, e lo diventava sempre più a mano a mano che pensava a come dirlo. Stufa di tutto questo, aveva deciso di dichiararlo il prima possibile, senza tanti giri di parole. La replica di Eraldo fu del tutto inaspettata.
“Eh?! Io quella roba non ce l'ho!”
Una leggera collera fece sì che Irene si lasciasse andare a un commento che avrebbe fatto meglio a evitare.
“Ma allora, a dispetto delle apparenze, sei un dilettante!”
Eraldo ammutolì e Irene percepì il pericolo di quel silenzio. Quindi si armò di coraggio per andare oltre con un gesto volgare e farla finita.
“Bene, prendi questo!”
Eraldo, senza alcuna fretta, raccolse quel che Irene aveva tirato fuori dalla borsa e scagliato sul letto.
“Avevi calcolato tutto, eh?! Che sorpresa! Una vera sgualdrina!”
E così, fin dal principio, i due iniziarono a ferirsi a vicenda. Ma l'animo umano è complesso: più si facevano male, più il loro legame diventava autentico. Ecco perché Irene, benché provasse terrore, rabbia e disgusto a ogni battuta, allo stesso tempo sentiva che dietro quelle parole c'era una dolcezza che mai nessuno al mondo avrebbe scalfito.
Così come accade quando si ascolta una musica popolare, quelle repliche le davano una frustata che le procurava una bruciante eccitazione. Il ricordo di essere stata scambiata per una donna di strada davanti alla sala giochi la inebriò: nell'istante in cui stava comprando un uomo si figurò se stessa come una prostituta.
I due, svestiti, scambiarono sguardi furenti.
Irene lo osservava bene. Che delusione se Eraldo avesse appeso con cura la sua giacca elegante all'attaccapanni, se fosse stato attento nello sfilarsi uno a uno gli strati di indumenti! Invece, fortunatamente, con estrema virilità si sbarazzò della cravatta, gettò per terra i calzini e sistemò senza cura giacca e pantaloni sullo schienale di una sedia.
Era nudo. Il suo corpo abbronzato era giovane e puro, i suoi muscoli pieni e dolcemente arrotondati: era infinitamente più bello che vestito.
Ancora in piedi, Irene si lasciò stringere da quel corpo nudo. Eraldo, con le sue mani fredde e ruvide, le fece scivolare le bretelle della sottoveste. Si sentì pervasa da un piacere terrificante, come se tutto il suo corpo rabbrividisse.
“Non dire niente! Ti prego, non dire niente!”
Lo implorava con il palmo della mano premuto sulle labbra di lui. Con il carattere del ragazzo, non era una cosa di cui preoccuparsi, in ogni caso lei non voleva sentirsi rivolgere complimenti affettati.
Le mani ruvide del ragazzo la accarezzavano dalle spalle fino ai fianchi. Irene desiderava un bacio, e lui la baciò.
“Quest'uomo è un depravato! Quest'uomo è un depravato!” Irene continuava a ripetere dentro di sé, quasi un esorcismo. E più ripeteva quelle parole, più la pelle dell'uomo diventava pura e più si radicava in lei la sensazione di non aver mai incontrato tanta purezza.
Stretti l'uno all'altra, i due si lasciarono cadere sul letto.
Fu a quel punto che accadde una cosa di rara eleganza, una cosa che non si riscontra neanche nei giovani delle migliori famiglie: la carne di Eraldo prese a trasudare grazia. Se all'inizio Irene, come per mantenere un certo distacco, aveva ripreso il vizio di fare paragoni con le esperienze passate, ben presto tutto fu dimenticato e, nel momento decisivo, non fu più possibile alcun genere di confronto.
© Paolo Melandri (28. 8. 2018)
*
La stella del tramonto
La luce del sole era sempre più intensa, l'osservammo in silenzio.
Il fragore delle onde era sempre più forte. Tornava, e tornava, come un incantesimo sulle nostre menti inebriate.
Una luce trasparente avvolse il mondo intero. Il sole del tramonto riversava la sua grazia su tutti senza distinzioni. Le nuvole assumevano gradazioni di colore che cambiavano in continuazione e promettevano una serata splendida. Sui volti di tutti affiorò un sentimento di gratitudine incondizionata. Non importava come fossero andate le cose durante il giorno. Si poteva mettere un punto e andare a capo, del resto stavamo assistendo a uno spettacolo incantevole: oggi era stato oggi, domani sarebbe stato domani e le persone tristi, al pari di chi non lo era, quelle intelligenti e quelle meno, gli esibizionisti e quelli più riservati stavano tutti vivendo quel momento così speciale, erano tutti meravigliati.
Qualcuno era irritato, qualche coppia aveva litigato, ma stavano tutti guardando il tramonto. E questo cambiava le cose, anche se per poco. Socchiudevamo gli occhi di fronte a quel color arancio così intenso e l'istinto selvatico che ci portavamo dentro si annullava di colpo. Tutti ricevevamo lo scintillio di quelle nubi come un dono del cielo, senza starci a pensare.
Nell'istante in cui il sole svanì completamente sotto la linea dell'orizzonte, tutti tirammo un sospiro e ritornammo alle rispettive vite. Chi controllava il bicchiere, chi ne chiedeva un altro, chi si rimetteva a chiacchierare.
Ma i ricordi dei tramonti si facevano strada nella mia mente, intricati come il dedalo di vicoli che attraversava l'isola.
© Paolo Melandri (25. 8. 2018)
*
Prima luce
Se ne stavano adagiati l'uno accanto all'altra sul letto, gli occhi rivolti al soffitto. La pioggia, di nuovo torrenziale, crepitava sul tetto. Il battito concitato dei loro cuori non si era placato. Rodolfo era in preda a uno stato di esaltazione che superava non soltanto il suo senso momentaneo di prostrazione, ma altresì l'intuita certezza che qualcosa fosse giunto alla fine. Persisteva peraltro, aleggiante sopra di loro, il sentimento di un comune dolore, tangibile come le ombre che ora lentamente dileguavano dentro la stanza. Gli parve di udire il leggero rumore di una vecchia che si schiariva la gola al di là della parete. Rodolfo si apprestava ad alzarsi, quando Sara tese una mano e lo trattenne, afferrandolo dolcemente per una spalla.
Allora lei, senza una parola, dissipò ogni vestigia di rimpianto. Lui, estasiato, si lasciò guidare. E a partire da quel momento non ci fu più nulla che non fosse disposto a perdonarle.
Era giovane. Il suo desiderio non tardò a riaccendersi. Ora lei gli si offriva interamente e tutto si svolse nel modo più naturale. Sotto la sua guida sicura, femminile, sentì che per la prima volta ogni ostacolo era stato rimosso e che si trovava in un mondo affatto nuovo, traboccante di ricchi doni. Nel calore della stanza si era ormai liberato dell'ultimo suo indumento, e ora provava il senso immediato d'intimità derivante dal diretto contatto della carne con la carne, salda e tuttavia cedevole, come il flutto o l'alga all'avanzare della prua della nave. Vide che sul volto di lei non sopravviveva la minima traccia di contrarietà. Anzi, sorrideva di un pallido sorriso, ma ora non gli causava nessuna irritazione. Il cuore di Rodolfo era a riposo.
Più tardi la prese tra le braccia, arruffata com'era, e premendo la guancia contro quella di lei, avvertì l'umidore di altre lacrime. Erano, lo sapeva, lacrime di gioia; e tuttavia niente aveva il potere di far comprendere ad entrambi, meglio di quelle lacrime che scorrevano silenziose sulle loro guance, di aver commesso un peccato imperdonabile. Nondimeno, in Rodolfo il sentimento del peccato valse a incrementare il coraggio che lentamente nasceva in lui.
“Suvvia”, disse Sara, raccogliendo la sua camicia, “non devi prender freddo”.
Rodolfo stava per afferrarla, ma lei lo trattenne un istante e si portò la camicia al viso emettendo un profondo sospiro. Poi, quando gliela tese, era tutta bagnata di pianto.
© Paolo Melandri (25. 8. 2018)
*
Luce di gemma
Roberto e Sara percorsero la spiaggia, cercando di scansare l'intenso quanto improvvido chiarore della luna. Ora, nel cuore della notte, sulla spiaggia deserta non sopravviveva traccia alcuna della presenza umana, ad eccezione di una barca da pesca in secca che proiettava sulla sabbia l'ombra nera della prua prominente. Grazie all'irraggiare del plenilunio che si diffondeva all'intorno, quella barca sembrava offrire un oscuro, rassicurante ricetto. Le tavole dell'imbarcazione, bagnate dal raggio lunare, lucevano come ossa sbianchite dal tempo. Un istante Roberto posò la mano sullo scafo e sotto la luna la sua mano parve traslucida.
Subito, nell'ombra protettrice della barca, si allacciarono in un abbraccio, mentre attorno a loro turbinava la brezza marina. Raramente indossava completi, e in quel momento il bianco così crudo della veste le riuscì odioso. Incurante del biancore della sua pelle, Sara non pensava che una cosa: liberarsi dell'abito il più in fretta possibile e dissimularsi nelle tenebre.
Era affatto impossibile che qualcuno potesse vederli, e tuttavia il chiarore lunare, frantumato in particelle infinite sulla superficie dei flutti, era come migliaia, come milioni d'occhi. Il suo sguardo si portò verso le nubi sospese nel cielo, verso le stelle che sembravano roderne i contorni. Percepiva il contatto dei capezzoli di Roberto, minuti e fermi, che aderivano ai suoi, il loro voluttuoso strisciare, e alla fine quel premere su di essi, mentre lui affondava nella ricca opulenza dei suoi seni. Era un contatto assai più intimo del bacio, qualcosa di simile alla carezza gioiosa elargita da un giovane animale. Una dolcezza profonda errava ai confini della sua coscienza. E quando i limiti, i punti estremi dei loro corpi si toccavano, quella familiarità inaspettata li faceva pensare, nonostante le loro palpebre abbassate, alle stelle scintillanti fra le nubi.
A partire da quel momento, si abbandonarono a un'allegrezza intensa, profonda come le acque del mare. Ma sebbene lentamente si sentisse inghiottita da quell'oscurità, pure Sara era indotta a temere che si trattasse soltanto di un'ombra, la quale dipendesse a sua volta dalla barca da pesca presso la quale si erano adagiati. Non erano protetti da una solida struttura o da un crinale roccioso, ma da un corpo fortuito, un'entità transeunte che forse di lì a poco, nel breve lasso di poche ore, sarebbe stata lontano, al largo. Se la barca in quel momento non fosse stata in secca in quel luogo preciso, la sua ombra cupa non sarebbe stata più reale e concreta di un fantasma. Sara temeva che all'improvviso quel vecchio, massiccio burchiello prendesse a scivolare silenzioso sulla sabbia per poi prendere il mare e allontanarsi a vele spiegate. Per seguirlo nel cerchio della sua ombra, e dimorarvi per sempre, occorreva che lei stessa diventasse parte del mare. E in quell'attimo lo diventò, trasportata da un'unica, immensa ondata.
Tutto ciò che li circodava – il cielo ravvivato dalla luna, l'acqua sfavillante, la brezza che soffiava dalla spiaggia e agitava i pini al suo limite estremo – tutto era presagio di calamità. Appena oltre il malcerto lucore del tempo, echeggiava mostruosamente l'eco agghiacciante della Negazione. E quel messaggio risuonava tra i pini. Sara sapeva che lei e Roberto erano accerchiati, osservati, sorvegliati, guardati a vista da uno spirito implacabile, che non conosceva il perdono, così come una singola goccia d'olio balsamico caduta in una conca d'acqua non ha nulla che valga a sorreggerla se non la consistenza dell'acqua stessa. E quest'acqua era nera, vasta, silenziosa, e la goccia isolata di balsamo fluttuava in un mondo di totale, cieco isolamento.
Quel “No!” abbracciava ogni cosa. Era una creatura della notte oppure l'alba che si approssimava? Per loro era insondabile mistero. Ma ancorché ad ogni istante che passava planasse minaccioso sopra il loro capo, ancora non li aveva colpiti.
Si risollevarono. Le loro teste emergevano appena dall'ombra e la luna calante illuminò in pieno i loro volti. A Sara pareva che in qualche modo fosse l'emblema della loro trasgressione, appesa com'era lassù, così piena, così luminosa, così netta e visibile nel cielo.
La spiaggia era ancora deserta. Si alzarono in piedi per prendere gli indumenti che avevano deposto in fondo all'imbarcazione. L'uno guardava l'altra, e quel residuo di tenebra che era la zona d'ombra dei loro corpi al di sotto dei loro ventri bianchi vividamente rischiarati dalla luna. Ivi si concentrò il loro sguardo, sia pure per un fuggevole istante.
Quando si furono rivestiti, Roberto sedette sul bordo della barca, le gambe penzolanti nel vuoto.
“Sai una cosa?” disse “Se avessimo la benedizione di tutti, probabilmente non oseremmo fare quello che abbiamo fatto”.
“Sei un mostro, Ro-. Dunque è questo ciò che desideri realmente!” replicò lei, fingendosi scherzosamente offesa. Scherzavano fra loro, con una tenerezza che nondimeno recava in sé un mesto, indefinibile aroma di cenere. Sentivano che la loro felicità era ormai prossima a una fine irrevocabile. Sara era tornata a sedersi sulla sabbia, celata dall'ombra della barca. Davanti a lei, illuminato dalla luna, spiccava nell'aria il piede di Roberto. Protese un braccio, lo afferrò e vi depose un bacio, sulle dita.
© Paolo Melandri (23. 8. 2018)
*
Koimathi Hotel
Sono quasi due mesi che soggiorno al Koimathi Hotel, e la mattina, nel ristorante sul terrazzo che dà sulla spiaggia, ho ammirato non so quante volte la bellezza dei bicchieri di vetro che brillano al sole, disposti su un lungo tavolo in un angolo. Non ho mai visto, in nessun altro luogo, bicchieri che brillassero con lo stesso splendore. Non li ho visti nel sud della Francia, lungo la costa, a Nizza e a Cannes, né in Italia meridionale, sulla penisola sorrentina, dove pure la luce del sole è brillante e il colore del mare intenso. Credo che la luce dei bicchieri di vetro al mattino nel ristorante sulla terrazza del Koimathi Hotel resterà in me per tutta la vita come l'immagine inconfondibile della Grecia, paradiso di un'estate senza fine, e di Itaca, per il fulgore del sole, la luce del cielo, il colore del mare, il verde degli alberi. Tutti quei bicchieri sono disposti in file ordinate, come soldati pronti per una spedizione, capovolti, quindi con il fondo in alto; alcuni sovrapposti in modo da formare due o tre piani: grandi e piccoli, ma tutti accostati in un insieme compatto, con le superfici che si toccano. Non è l'intero corpo del bicchiere a brillare al sole del mattino, ma solo il bordo circolare del fondo, che emana scintille di luce bianca, fulgide come diamanti. Non ho idea di quale possa essere il numero dei bicchieri, forse duecento o trecento, e naturalmente non è che la luce li faccia risplendere in maniera uniforme e tutti sul bordo, eppure una notevole quantità dei bicchieri concentra il riflesso proprio in quel punto, quasi che su ognuno di essi brillasse una stella.
Mentre mi accorgevo di questo scintillio sul bordo, ho cominciato a notare che la luce del mattino colpiva anche un altro punto, nel corpo dei bicchieri. Qui lo scintillio non era altrettanto forte: era un riflesso più morbido e sfumato.
© Paolo Melandri (23. 8. 2018)
*
La fontana di sangue 2
L'essere umano riconosce volentieri l'universalità e la comune appartenenza a questioni che non gli fanno né caldo né freddo come gli slogan politici o le ideologie. Cose che non sono né utili né nocive, come antiquate architetture e oggetti d'arte, diventano facilmente un patrimonio culturale comune a tutta l'umanità. Ma questo non accade con la sofferenza. Sarebbe imbarazzante, infatti, se il dolore a un molare provato da un leader politico durante una conferenza si propagasse alle decine di migliaia di persone che lo ascoltano. Gli esseri umani non si stancano mai di parlare, di vedere e di ascoltare altri esseri umani perché questi atti sono una sorta di indennizzo per le condizioni della propria esistenza: gli umani accettano l'esistenza degli eroi perché sanno che qualsiasi eroe possiede funzioni escretorie non diverse dalle loro.
L'uomo cerca freneticamente gli altri uomini per concludere: “in fondo siamo uguali” e per pensare nello stesso tempo: “ma bene o male io sono diverso”.
© Paolo Melandri (22. 8. 2018)
*
La fontana di sangue
L'interesse degli esseri umani per gli oggetti indica una necessità di salvare sé stessi dalla irreversibilità del tempo. Il dominio dell'uomo sulla materia presuppone inconsciamente la vittoria finale della materia stessa. Altrimenti perché rimarrebbero sulla terra tanti volgari monumenti, costruzioni e tombe di pietra, di bronzo e di ferro? Studiando a fondo, in un certo qual modo, l'essenza della materia, l'essere umano è giunto a scoprire l'energia atomica. La bomba all'idrogeno è l'oggetto più paradossale raggiunto dagli esseri umani (potrei darvi molti esempi: al giorno d'oggi non esiste amicizia più bella di quella dell'uomo con il suo cane, perché tra gli esseri umani la vera amicizia non esiste più ed essi si incontrano solo per motivi di interesse). La bomba all'idrogeno è comparsa, appunto, come una specie di ultima espressione umana.
Essa è solitaria, eroica, gigantesca, possiede una forza senza limiti, è modernissima e intellettuale, ha un unico e semplice obiettivo (la distruzione), e inoltre vive soltanto l'attimo presente, non appartiene né al passato né al futuro e, qualità ancor più essenziale, è bella ed effimera come un fuoco d'artificio. Non c'è immagine dell'“uomo” più ideale di questa. Il suo obiettivo è l'annientamento di sé e dell'altro… L'annientamento di sé e dell'altro: ah, non sembra il ritornello di una meravigliosa canzone? Prima o poi gli esseri umani dovranno baciare questa loro immagine. Per ora si accontentano di ballarvi intorno perché sanno che il loro atto susciterebbe un esito irreversibile, ma un giorno o l'altro, necessariamente, ineluttabilmente, l'uomo si chinerà ai piedi di quell'immagine e la bacerà. Le sue labbra premeranno un piccolo bottone, e il cielo all'alba sarà attraversato da un missile a testata nucleare. Solo un piccolo bottone. Quell'immagine non è infatti soltanto un essere umano, è anche un bottone. Che esistenza ideale! Un piccolo bottone, come quelli che a volte cadono ai bambini e che i bambini raccolgono con cura. Alcuni sentimentali umanisti si ostinano a considerare la bomba all'idrogeno una semplice “cosa”. Ma si sa, gli esseri umani hanno una testa confusa, è possibile che reputino una cosa persino l'“ultimo uomo”. È nel loro stile. Sussiste tuttavia un problema, la bomba all'idrogeno è qualcosa di non ancora perfezionato. Per garantire la loro felicità, gli esseri umani devono vivere circondati dalla perfezione delle cose. Soprattutto gli umanisti, che prediligono le pipe e i vestiti da passeggio con toppe di pelle sui gomiti, non amano compromessi su questo argomento. Perciò devono anch'essi conferire un senso alla bomba all'idrogeno… e come riuscire nell'intento? Premendo semplicemente un bottone.
Rodolfo ascoltava in silenzio a testa bassa, nascondendo il suo malumore, ma il parrucchiere applaudì rumorosamente con le sue morbide mani sudaticce.
«Ha proprio ragione, professore. Io amo mia moglie e i miei figli, e nutro un meraviglioso senso di affetto per la famiglia proprio perché sono un extraterrestre. Se fossi un essere umano sarebbe differente. Soprattutto le persone ricche e famose si comportano in realtà con freddezza verso la famiglia, e gli uomini affascinanti si comportano da seduttori, e considerano le donne un oggetto. Si può immaginare la decadenza in cui è sprofondato l'essere umano considerando quanto facilmente le donne cadono nelle loro trappole. Insomma, anche per sedurre le donne bisogna comportarsi con onestà e con sincerità, rispettarle come esseri umani e circondarle di tenero amore. Ovviamente io non ho tempo per far questo perché mi occupo soltanto di mia moglie e dei miei figli».
«La seconda malattia», continuò il professore ignorando la reazione dei suoi compagni, «è l'interesse dell'uomo per gli altri esseri umani. La sua più evidente manifestazione è forse l'istinto sessuale, che tuttavia non è un vero e proprio interesse umano. È soltanto l'atto di spiare il crepuscolo del mondo da una fessura tra la riproduzione e l'annientamento.
A prescindere tuttavia, dall'istinto sessuale è davvero incomprensibile perché l'essere umano continui a interessarsi agli altri dal mattino alla sera! Il giornale del mattino non parla che di fatti accaduti agli esseri umani, e alla televisione non si fa che vedere uomini. Se qualche volta compaiono immagini di animali, sono animali umanizzati, in modo che siano gradevoli. E i discorsi umani? Parlano sempre di problemi umani. Se talvolta si accenna a fenomeni naturali quali i terremoti, i maremoti, la fioritura dei ciliegi, se ne discute sempre dal punto di vista del danno o del giovamento che rappresentano per l'uomo: gli umani amano, del resto, le storie di morti e di omicidi.
Pertanto, il loro interesse universale e popolare verte costantemente sui problemi umani. L'astronomia, la matematica, la fisica e la chimica sono affidate a un nugolo di esperti, non godono assolutamente del favore delle masse. E anche ciò che viene chiamato “politica”, che infervora il popolo per quanto teorizzata e strutturata sia, è dal principio alla fine una questione che riguarda uomini, uomini e ancora uomini.
Consideriamo per esempio un banchetto, durante il quale gli esseri umani godono dell'interesse che nutrono per gli altri esseri umani. Si scambiano parole e sentimenti, tutti sono allegri, si sentono amici gli uni agli altri come se lo fossero dalla creazione della terra, tutto si fonde, tutto sembra in comune. Eppure, cibi presi dallo stesso piatto e vino versato dalla stessa bottiglia attraversano l'oscuro esofago di ciascuno e si dirigono verso il buio stomaco di ciascuno. Là inizia il processo della digestione, completamente staccato dagli stomaci altrui, insomma, se al banchetto partecipano otto persone, esistono, sotto le sfavillanti luci della sala, otto canali nascosti, solitari, tenebrosi, con condotti diversi l'uno dall'altro.
Immaginiamo ora un incidente stradale, con una ragazza riversa sull'asfalto: ha le cosce scoperte, da cui sgorga sangue che si mescola con la pioggia notturna, e sembra indossare una fresca calzamaglia a rete rossa che lascia trasparire le gambe».
«Esatto! Gli esseri umani sono tutti delle fontane di sangue, e una fontana che non zampilla sangue durante la vita è soltanto una fontana secca o rotta. Le colombe si avvicinano agli esseri umani per abbeverarsi a quella fontana, poi volano via deluse. Quelle bianche, gentili colombe non riescono a colorarsi le ali di spruzzi di sangue!» interruppe con tono lirico il giovane impiegato in banca in preda all'eccitazione.
«E i curiosi che le si radunano intorno», continuò freddamente il professore, «osservano attentamente la donna agonizzante rapiti dalla gioia. Tutti sanno che le sofferenze non si trasmettono e che nello stesso tempo ciascuno di loro porta il peso di una “condizione” che lo assoggetterà prima o poi a simili tormenti.
L'interesse dell'uomo per un altro essere umano assume sempre questa forma. La sicurezza che, pur avendo ricevuto in sorte il peso di uguali condizioni di esistenza, non esista una sofferenza comune all'umanità, un unico stomaco per tutti gli esseri umani… Anche voi saprete che le donne dimenticano velocemente le sofferenze del parto e credono che il loro sia stato il più doloroso. Sebbene siamo tutti destinati a invecchiare, ad ammalarci e a morire, la sofferenza individuale non ammette assolutamente una malattia e una morte comune a tutta l'umanità.
© Paolo Melandri (21. 8. 2018)
*
La società
La società. Avevo l'impressione di cominciare finalmente anch'io a formarmi qualche vago concetto del suo significato. È la lotta tra un individuo e un altro, una lotta sul posto e sul momento, in cui il trionfo immediato è tutto quello che conta. Gli esseri umani non soggiacciono mai agli esseri umani. Perfino gli schiavi praticano le loro meschine rappresaglie. Gli esseri umani non riescono a concepire alcun mezzo di sopravvivenza fuorché in termini di un corpo a corpo, sul posto e sul momento. Parlano di dovere verso la patria e roba simile, ma l'oggetto dei loro sforzi è invariabilmente l'individuo, e anche quando sono stati soddisfatti i bisogni dell'individuo, ecco che l'individuo torna in ballo. L'incomprensibilità della società è l'incomprensibilità dell'indivuduo. L'oceano non è società: è individui. Così fu che riuscii a raggranellare un'oncia di affrancamento dal terrore che provavo dinanzi a quell'illusione d'oceano che si chiama mondo. Imparai ad assumere un contegno aggressivo, senza gli incessanti, ansiosi tormenti che conoscevo prima, adeguandomi, si può dire, ai bisogni del momento.
© Paolo Melandri (1. 8. 2018)
*
Non più umano
Si può dire che ancora non mi intendo per niente di come funzionano gli esseri umani. Quando scoprii che il mio concetto di felicità sembrava in pieno contrasto con quello di ogni altra persona, fu tale l'angoscia che mi dibattei gemendo insonne nel mio letto per notti e notti di seguito. L'ansia mi spinse addirittura sull'orlo della pazzia. Mi domando se sono mai stato veramente felice. Fin dalla prima infanzia, mi hanno detto e ripetuto non so quante volte che ero fortunatissimo, mentre ho sempre sentito di soffrire le pene dell'inferno. Anzi mi è parso che chiunque mi chiamava fortunato fosse senza confronto più favorito dalla sorte di me.
Ogni tanto ho pensato che mi è stata imposta una soma di dieci disgrazie, ognuna delle quali, se la reggesse un mio simile, sarebbe sufficiente a far di lui un assassino.
Insomma, non capisco. Mi manca l'indizio più remoto per comprendere la natura o la portata dei guai che possono affliggere il mio simile. Dispiaceri di carattere materiale, dolori ch'è possibile lenire purché solo ci sia da mangiare abbastanza – saranno anche le torture dell'inferno più strazianti di tutte, sufficientemente tremende per mandare in frantumi le mie dieci disgrazie, ma è proprio questo che non capisco: se i miei simili riescono a sopravvivere senza uccidersi, senza impazzire, conservando il loro interesse per i partiti politici, non cadendo in balìa dello sconforto, perseguendo con animo risoluto la lotta per l'esistenza, posson essere realmente genuine le loro pene? Sbaglio se penso che questi individui sono divenuti degli egoisti così inveterati, e talmente convinti dalla normalità del loro tenor di vita, che non hanno dubitato di sé un solo istante? Se tale è il caso, le loro sofferenze dovrebbero esser facili da sopportare: sono la sorte comune degli esseri umani, e forse la migliore che ci si possa augurare. Io non lo so… Se la notte hai dormito profondamente, il mattino sarà giocondo, m'immagino. Quale specie di sogni faranno, quelli lì? A che pensano camminando per strada? Al denaro? Improbabile… non dovrebb'essere soltanto questo. Ho udito sostenere, se non erro, la teoria che gli esseri umani vivono solo per mangiare, ma non ho mai udito dire da nessuno che vivano allo scopo di far soldi. No. E tuttavia, in date circostanze… No, non so neanche questo… Quanto più ci vado pensando, tanto meno comprendo. Tutto ciò che io sento, sono gli attacchi di apprensione e terrore all'idea di essere l'unico individuo assolutamente diverso dagli altri. Mi è quasi impossibile conversare col prossimo. Di che cosa dovrei parlare, in che modo dovrei dirlo? Lo ignoro. Così avvenne che inventai le mie pagliacciate. Era l'ultima richiesta d'amore che avrei rivolto agli esseri umani. Quantunque degli esseri umani avessi un terrore mortale, sembravo assolutamente incapace di rinunciare alla loro compagnia. M'ingegnai di mantenere a fior di pelle un sorriso che non abbandonò le mie labbra un istante; fu questo l'accomodamento che offrivo alla gente, un'impresa, precaria quanto mai, da me compiuta soltanto a prezzo di esulceranti sforzi interiori.
© Paolo Melandri (31. 7. 2018)
*
Onde di dolore
Sensazione di impotenza, come se non fosse più possibile continuare a vivere. Onde di dolore battono incessanti sul mio cuore, come dopo una tempesta le nuvole bianche fuggono impazzite per il cielo. Una emozione terribile – apprensione dovrei forse dire – mi comprime il cuore, mi altera il polso, mi mozza il respiro. A volte dinanzi ai miei occhi ogni cosa diventa nebbia e oscurità, e sento che la forza di tutto il mio corpo mi scivola via tra le dita. Da qualche tempo cade incessante una pioggia tetra. Tutto quel che faccio mi estenua. Oggi ho portato una sedia di vimini nel terrazzo.
© Paolo Melandri (31. 7. 2018)
*
Fedra
Si era all'inizio dell'inverno, ormai il crudele Orione saliva lentamente nel cielo nero e duro, e il vento gelido e roco che scendeva dai boscosi monti della Calabria entrava in mare come in una selva, con uno strepito di rami schiantati. Ero giunto da poco a Lipari, e passavo gran parte delle mie giornate camminando lungo il mare o contemplando dall'alto del Castello d'Eolo le rive lontane della Sicilia, o, il più delle volte, sedendo all'ombra di un carrubo in un prato presso il convento dei Cappuccini. C'era lì accanto, legata per una zampa al tronco di un fico selvatico, una capra di pelo chiaro, dagli occhi di un tenero e vivo azzurro, intenta ad allattare un capretto dalle gambe stecchite, dal muso informe e bianchiccio. Il capretto mi pareva malato, non aveva neppur la forza di succhiare il latte, rimaneva lunghe ore appeso alla mammella materna, quasi dormendo, e vomitava ogni tanto gialli grumi di latte. Una mattina lo trovai morto. La madre s'era scostata per quanto le permetteva la lunghezza della corda, lo guardava da lontano come se ne avesse orrore, e volgeva di quando in quando il muso dalla mia parte, con un lamento triste che mi stringeva il cuore.
© Paolo Melandri (31. 7. 2018)
*
Il vento nero
Il vento nero cominciò a soffiare verso l'alba, e io mi destai, madido di sudore. Avevo riconosciuto nel sonno la sua voce triste, la sua voce nera. Mi affacciai alla finestra, cercai sui muri, sui tetti, sul lastrico della strada, nelle foglie degli alberi, nel cielo su Posillipo, i segni della sua presenza. Come un uomo cieco, che cammina a tentoni, accarezzando l'aria e sfiorando gli oggetti con le mani protese, così fa il vento nero: che è cieco, e non vede dove va, e ora tocca quel muro, ora quel ramo, ora quel viso umano, e ora la riva ora il monte, lasciando nell'aria e sulle cose la nera impronta della sua lieve carezza.
Non era la prima volta che udivo la voce del vento nero, e subito la riconobbi. Mi destai, madido di sudore, e affacciatomi alla finestra scrutai le case, il mare, il cielo, le nuvole alte sul mare.
© Paolo Melandri (30. 7. 2018)
*
Il popolo di Oblomow
È cosa prudente non fidarsi troppo della bontà dei Russi. È propria dell'umanità di questo popolo la curiosità inquieta, mista di sospetto e di timore, particolare alla natura femminile. Il bene e il male nell'umanità pravoslavni, ovvero sia ortodossa, formano quel che i Greci chiamano ermafroditismo: ove i sensi sono distinti, ma si confondono in una sensibilità contaminata da quel sospetto e da quella simpatia che ha un sesso per l'altro. Sensibilità che il desiderio virile del possesso rende acuta e turbano le inquietudini periodiche della donna. La storia di questo popolo brulica di errori e follie, di candori spaventosi, di un sanguinario amore per il prossimo che ogni aspetto umano innalza sino al sacrificio. Uomini e donne, dramatis personae della storia di Russia si aggirano su questo sfondo di umanità angelica e bestiale, come Candido in mezzo ai guerrieri o Pamela tra le cortigiane: angeli vestiti alla moscovita e capaci di tutto, persino di una buona azione. Ma nessuna cosa potrebbe dire quel che si nasconde in quegli occhi glauchi, sotto quelle fronti bianche, nel suono remoto di quelle dolci voci. A guardarli, gli zar, le zarine, i carnefici, i «falsi Dimitri», i potenti di quella terra hanno più l'aria delle vittime che dei despoti, degli usurpatori e degli oppressori. Non è mai stato in Russia gran principe o spietato tiranno che non piatisse altamente i peccati degli altri, le brutalità del popolo, quella fatalità che lo condannava a sopportare il peso di tutti i misfatti dei sudditi e a diventare, in qualche maniera, il San Cristoforo del popolo russo, a versare il sangue degli uomini per la salvezza della loro anima, a fare il male per natural bontà. Si conoscono le lamentazioni di Pietro il grande, questo povero Pietro sentimentale per natura, sull'ingratitudine del popolo russo curvo e sanguinante sotto il peso della sua terribile volontà. Lo Tzarevitch Alessio, figlio di Pietro il Grande, questo Alessio candido e liberale, che si querela contro il feroce dispotismo del padre e tratta a calci nel ventre la moglie incinta, è il modello del comportamento, dei costumi, dello spirito e soprattutto del buon cuore dei potenti della terra. Un giudice al corrente degli affari di famiglia alla Corte di Russia, l'assennato Voltaire, ha scritto sulla morte violenta di Pietro III e sulla astuta innocenza di Caterina: «Non ignoro che si vada rimproverando a Caterina qualche inezia a proposito del marito, ma questi sono affari di famiglia nei quali io non mi mischio mai». Alessandro I era chiamato blagoslovenni, come dire «benedetto da Dio». «È un'anima nobile, diceva di lui Napoleone, un'anima nobile che ha fatto strangolare il padre».
In Russia sono tutti buoni, tutti innocenti, tutti hanno timore di Dio, e sono, ohimè, peccatori pentiti, spiriti generosi: tanto gli umili che i potenti, tanto i principi che il popolo. Che clima! «Il clima sono io» proclamava Nicola I. Ma in questo mondo oscuro ove cento forze contrarie facevano esplodere dal loro urto strane passioni, follie favolose, candori mostruosi, mancava una legge, una regola, una costante misura, una logica, fosse anche quella di Machiavelli. Persino l'egoismo era disinteressato. L'innumerevole popolo dei mugichi, degli artigiani, dei mercanti, dei pastori, dei vagabondi, dei mendicanti, dei monaci, dei soldati, degli stregoni, nei quali rivolta e fanatismo, e tutti gli isterismi sessuali e religiosi, andavano fermentando ad ogni ritorno di stagione; nei quali l'istinto del bene e del male rimontava confusamente col variare dei venti, questo popolo immenso, pronto sempre ai sacrifici più nobili e alle ignominie più stravaganti, crudele e misericordioso, violento e servile, pigro, molle e fanatico, era apparso sulla soglia della storia moderna quasi all'improvviso, trascinato a viva forza e spinto in avanti a gran pedate da quel terribile Pietro, di cui le scarpe che si possono ammirare al Cremlino, nel Palazzo delle Armi, basterebbero a raccontare la poltica, la ferrea volontà e la barbara ferocia. Dalla finestra che Pietro il grande aveva spalancato sull'Occidente, sul misterioso Occidente, ecco era penetrato in Russia il vento liberale di Candido, il soffio leggero e tiepido dell'Europa del secolo XVIII, corrotto già dalla filosofia e rischiarato dal presentimento della libertà. Questa rivelazione brusca di un nuovo mondo, di una civiltà regolata da una logica, che agli occhi dei Russi appariva un gioco facile, elegante e perverso, il cui senso rimaneva loro incomprensibile, non aveva fatto che risvegliare in quel popolo i più morbosi istinti e le illusioni più pericolose. Una inquietudine nuova lievitava a poco a poco dalla dolorosa coscienza della sua miseria e dalla sua impotenza a resistere al male. Dal fondo delle pianure di Russia, come dal fondo della storia, quel popolo fino ad allora senza rimorsi e senza speranze, vedeva per la prima volta sorgere davanti ai suoi occhi, di là dall'orizzonte della sua bontà pourrie e dalla sua barbara e feroce ingenuità, la terra dei popoli ricchi, degli uomini felici, dei Re sorridenti, l'Europa, regno proibito, paradiso senza mougiki. Impotente a dare al suo popolo la logica delle nazioni ricche, degli uomini felici e dei Re sorridenti, è con quella specie di rivelazione dell'aldilà che Pietro il Grande aveva riscattato la sua anima di barbaro e il fallimento della sua opera. Come tutti gli altri zar che, prima di lui, avevano tentato di imporre una logica, al popolo russo, Pietro il Grande, alla sua morte, era stato coricato nel letto di Oblomow, quell'eroe immortale, quel testimonio muto della storia di Russia. Non poteva essere un russo, un vero russo, colui che poteva dare una logica al popolo di Oblomow.
© Paolo Melandri (29. 7. 2018)
*
Come una specie di presente
C'era una volta una madre che se la passava proprio male, da un punto di vista emotivo, interiore.
A quanto ricordava, se l'era sempre passata male, anche da bambina. Ricordava pochi particolari della sua infanzia, ma quelli che ricordava erano sentimenti di odio verso se stessa, terrore e disperazione che sembravano averla sempre accompagnata.
Da una prospettiva oggettiva, non sarebbe inesatto dire che a questa futura madre da bambina avevano fatto mangiare un bel po' di merda psichica, e che parte di questa merda andava sotto la voce di maltrattamenti familiari. Non era stata proprio un'infanzia delle peggiori, ma nemmeno una passeggiata. Tutto ciò, per quanto esatto, non era il punto.
Il punto è che, a partire dall'età della ragione, questa futura madre odiava se stessa. Nella vita prendeva tutto con apprensione, come se ogni occasione o opportunità fossero una specie di esame tremendamente importante che lei era stata troppo pigra o stupida per preparare come si deve. Era come se fosse necessario ottenere il massimo dei voti a ciascuno di questi esami per evitare una punizione catastrofica. (I suoi genitori, per altro, non la picchiavano e in realtà nemmeno la castigavano, né facevano pressione su di lei.) Tutto la terrorizzava, e la terrorizzava darlo a vedere.
La futura madre sapeva benissimo, fin da piccola, che quella orribile costante pressione che sentiva veniva da dentro. Che non era colpa di nessun altro. Perciò si odiava ancora di più. Da se stessa pretendeva la perfezione assoluta, e ogni volta che non si dimostrava all'altezza piombava in una disperazione insostenibile che minacciava di madarla in frantumi come uno specchio da quattro soldi. Queste pretese smodate coprivano ogni settore della vita della futura madre, in particolare quei settori che implicavano l'approvazione o la disapprovazione degli altri. Perciò, durante l'infanzia e l'adolescenza, veniva considerata brillante, attraente, popolare, di spicco; era encomiata e approvata. I suoi coetanei sembravano invidiarle energie, spirito d'iniziativa, aspetto, intelligenza, carattere e l'inesauribile sollecitudine verso i bisogni e i sentimenti degli altri; aveva pochi amici intimi. Sviluppò una specie di orgoglio abietto per la spietatezza che aveva nei propri confronti. (In effetti, una spiegazione che i genitori della futura madre davano per il fatto di averla castigata così poco era che la figlia sembrava così spietata nel rimproverarsi da sola ogni manchevolezza o trasgressione che castigarla sarebbe stato, testualmente: «un po' come prendere a calci un cane».) Una volta diventata grande, sarebbe stato esatto dire che la futura madre interiormente se la passava davvero malissimo.
Quando diventò madre, le cose si misero anche peggio. Venne fuori che anche le pretese che la madre aveva nei confronti del figlioletto erano impossibilmente esagerate. E ogni volta che il bambino non si dimostrava all'altezza, lei aveva la naturale tendenza a odiarlo. In altre parole, ogni volta che lui (il bambino) minacciava di compromettere gli alti parametri che erano tutto quanto la madre in realtà sentiva di avere, interiormente, l'odio istintivo della madre nei confronti di se stessa tendeva a proiettarsi all'esterno e verso il basso sul bambino. Una tendenza resa tanto più grave dal fatto che nella mente della madre la differenza fra la propria identità e quella del piccolo era infinitesimale e indefinita. In un certo senso il bambino appariva come il riflesso della madre in uno specchio rimpicciolente e profondamente incrinato. Perciò ogni volta che il bambino era maleducato, ingordo, sudicio, stupido, egoista, crudele, disubbidiente, pigro, idiota, cocciuto o infantile, la tendenza più profonda e naturale della madre era di odiarlo.
© Paolo Melandri (28. 7. 2018)
*
Scirocco
Da qualche giorno un odore di uovo marcio, d'alga e di ginestra vagava nell'isola. La primavera era scoppiata all'improvviso come un tumore maturo. Dalla finestra aperta sul mare, Paolo guardava lontano incidersi a poco a poco nel vetro opaco dell'orizzonte l'orlo delle montagne, quel vetro intenerirsi, fondersi, sciogliersi in un'alba color perla, in un presagio lunare dalle trasparenze verdognole. Un vento caldo e umido soffiava dalla terraferma, sollevando dai fianchi del monte (un vulcano spento, ormai quasi senza fiato, che respira a fatica per le cento bocche delle sue fumarole) un'acre polvere gialla che ricadeva con un lieve fruscio di pioggia sulle ginestre fiorite di corolle di zolfo. La lettera di Camilla era lì, dietro di lui, aperta sul tavolo. Si passò la mano sul viso velato di sudore, chiuse gli occhi, rimase in ascolto. Il mare ansava sotto la finestra come una mucca davanti alla porta chiusa di una stalla.
© Paolo Melandri (26. 7. 2018)
*
Primo taccuino 1
Quando da bimbo vedevo i treni della metropolitana nei libri illustrati, non mi sognavo neppure che fossero stati inventati per soddisfare a una necessità di carattere pratico; potevo soltanto immaginarmi che correre nel sottosuolo invece che alla superficie della terra dovesse essere un passatempo inusitato e stupendo.
Fin da piccolo sono sempre stato malaticcio, e costretto a letto di frequente. Quante volte, mentre ero lì disteso, mi avvenne di osservare quali squallidi elementi decorativi formassero federe e lenzuola. Non prima dei vent'anni mi resi conto che effettivamente servivano a un fine pratico, e questa rivelazione dell'insulsaggine umana provocò in me un cupo avvilimento.
© Paolo Melandri (26. 7. 2018)
*
Punto panoramico
Da quando sono venuto in questa terra, ho sentito il mio cuore invecchiare misteriosamente e nutrire la sensazione di un profondo isolamento. Questo luogo non ha mai avuto alcun rapporto né con me né con i miei antenati, ma chissà che un giorno non nasca fra noi uno stretto legame, un legame che si manterrà vivo per tutta la mia discendenza. Pensavo a ciò mentre salivo gli stretti scalini di pietra ricoperti di muschio sul retro della casa. Quella scalinata conduceva a uno spiazzo di circa sedici metri quadrati che non poteva essere sfruttato in altra maniera se non come punto panoramico. Ogni volta che venivo qui in cerca di solitudine, il silenzio a poco a poco mi penetrava nell'anima, liberava la mia mente da ogni pensiero, lasciando spazio solo alla bruciante nostalgia del passato.
Di lassù era possibile cogliere con un solo sguardo la baia stretta dalla catena di montagne che accoglieva nel suo seno il villaggio sottostante. Al mattino e alla sera, dal molo situato ai margini partiva un piroscafo che collegava il paese con una grande città, l'irritante fischio del vapore si sentiva distintamente anche da qui. La sera il battello illuminato, piccolo quanto un ditale, puntava tenacemente al mare aperto. Osservando il tremolio delle sue luci, minuscole come la punta accesa di una bacchetta d'incenso, non potevo fare a meno di innervosirmi per la sua lentezza.
© Paolo Melandri (25. 7. 2018)
*
Notte
Alcune pietre pesantemente si sforzano di uscir fuori dalla sabbia alla luce, come grossi paguri color ardesia al rifluire della marea, e par che vogliano far di tutto per attirare il mio sguardo e dirmi cose di indicibile importanza.
Altre, esaurite, ricadono senza forze nei loro buchi e rinunciano a prendere la parola.
A tratti mi riscuoto dalla nebbia di questi mezzi sogni e per un istante torno a vedere la luce della luna posare sui rigonfi della mia coperta ai piedi del letto come una grossa, piatta pietra luminosa, per poi brancolare di nuovo dietro l'intermittente schermo della coscienza, senza requie in cerca di quella pietra che mi tormenta, che da qualche parte dev'esser nascosta sotto le macerie della mia memoria, la pietra d'aspetto simile a un pezzo di grasso.
Accanto a questa pietra una volta doveva terminare un tubo di grondaia, così mi raffiguro, un tubo ripiegato ad angolo ottuso, gli orli smangiati dalla ruggine, e caparbiamente voglio imporre al mio spirito una tale immagine, per ingannare cullandoli nel sonno i miei pensieri impauriti.
Non ci riesco.
Sempre di nuovo, sempre di nuovo con stolida insistenza una voce dentro di me, caparbia, instancabile come una persiana che il vento a regolari intervalli sbatta contro il muro, mi dice che è tutta diversa, che non si tratta affatto della pietra con l'aspetto di un pezzo di grasso.
E da questa voce non riesco a liberarmi.
Quando per la centesima volta obietto che tutto ciò non ha alcuna importanza, essa per un tratto tace, ma impercettibilmente torna a destarsi e di nuovo riattacca pertinace: sì, sì, giusto, tutto quello che vuoi, ma non è la pietra con l'aspetto di un pezzo di grasso.
Un sentimento di impotenza e di abbandono a poco a poco s'impadronisce di me.
Che cosa sia successo poi, ignoro. Ho volutamente rinunciato a ogni resistenza, o i miei pensieri mi hanno sopraffatto e imbavagliato?
So solo che il mio corpo giace addormentato nel letto, e i miei sensi sono sciolti e non più legati al mio corpo.
Chi è adesso “io”, questo vorrei chiedere a un tratto; poi mi prende la paura che la stolida voce si ridesti di nuovo e di nuovo cominci l'interrogatorio senza fine sulla pietra.
E do un altro corso ai miei pensieri.
© Paolo Melandri (21. 7. 2018)
*
Sonno
La luce della luna batte sul fondo del mio letto e vi si posa come una grossa, piatta pietra luminosa.
Quando la luna prende a raggrinzirsi e il suo lato destro comincia a sfaldarsi, come una faccia che va incontro alla vecchiaia da prima smagrisce e si solca di rughe su una sola guancia, verso quell'ora della notte si impossessa di me una inquietudine torbida, tormentosa.
Non dormo e non veglio, e nel dormiveglia si vengon mescolando nella mia anima cose vissute con cose lette e udite, al modo che correnti varie per colore e trasparenza confluiscono insieme.
Avevo letto prima di coricarmi alcune pagine sulla vita del Buddha Gotama, e in mille forme, sempre daccapo riproponendosi, questa frase mi attraversava la mente: “Una cornacchia volò a una roccia che aveva l'espetto di un pezzo di grasso, e pensò: è probabile che qui ci sia da mangiare qualcosa di gustoso. Ma non avendo trovato quel che sperava, la cornacchia se ne volò via. Come la cornacchia che si avvicinava alla pietra, così noi tentatori lasciamo l'asceta Gotama, poiché non sappiamo più godere di lui”.
E l'immagine della pietra che pareva un pezzo di grasso cresce, cresce mostruosamente nel mio cervello. Sto attraversando il letto di un fiume in secca e raccolgo ciottoli piatti.
Sono blu e grigi, cosparsi di un pulviscolo scintillante, e su questi ciottoli mi metto ad almanaccare, almanaccare, ma non so cosa farne – sono neri maculati di giallo zolfo, simili a pietrificati tentativi di un bambino di dar forma a salamandre macchiettate.
E li voglio gettar lontani da me, questi ciottoli, ma ogni volta mi cadon di mano e non riesco a bandirli dal mio campo visivo.
Tutte le pietre che hanno avuto una parte nella mia vita emergono tutt'attorno e mi circondano.
© Paolo Melandri (19. 7. 2018)
*
La conquista della città
Volevo conquistare una città, e ora mi sfiora una palma.
Uscendo dall'impotenza di lunghi mesi e di incessanti ripulse –: Voglio occupare questa terra, pensò, e i suoi occhi strapparono il velo bianco della strada, lo palparono e lo confrontarono con gli strati più vicini al cielo e con il chiarore dei muri di una casa, e subito si perse di felicità nella sera, nel netto prolungarsi della luce, in questa fresca fine di un giorno che era stato pieno di primavera.
Tutto ciò che avviene, avviene per la prima volta. Una lingua straniera, tutto è carico d'odio e avanza incerto sopra un abisso. Qui voglio procedere passo per passo. E se in un luogo dovrà riuscirmi, sarà qui.
Andò avanti; gli fioriva già intorno la città. Ondeggiava verso di lui, si sollevava sulle colline, gettava ponti sopra le isole, la sua cima stormiva. Superando piazze abbandonate da secoli e mai toccate da piede alcuno, tutte le strade premevano giù verso una valle; la città scendeva, si lasciava sprofondare nella pianura, squarciava le proprie mura e le offriva a un vigneto.
Si fermò su una piazza, si lasciò andare su un muro, chiuse gli occhi, con le mani tastava l'aria come fosse acqua, e supplicò: Cara città, lasciati occupare! Dammi una casa! Accoglimi nella tua comunità! Tu non cresci, né ti gonfi verso l'alto, tutto questo è estenuante. Tu sei così meridionale; la tua chiesa prega nella sera, la tua pietra è bianca, azzurro il cielo. Tu vaghi sulla riva della lontananza, sentirai pietà e già mi avviluppi.
Si sentì più saldo. Si gettò per i boulevards; era un fluttuare in ogni direzione. Andava di slancio, le donne le portava tra le pieghe come polvere; deposte dal trono; ma che avevano, in fondo: cavità minute e un ciuffo di terra sotto l'ascella. A una bionda ondeggiava nel respiro una rosa. Il suo profumo insieme al calore del seno saliva verso un qualche uomo.
Le andò dietro in un caffè. Si sedette e respirò profondamente: sì, qui è la comunità. Si guardò attorno: un uomo immergeva parole dolci in una ragazza, lei pensò che venissero da Dio e si lisciò la gonna. La mascella inferiore di un minorato manovrava una tazza con l'aiuto di due mani deformi, i genitori gli sedevano accanto e prendevano le distanze. Su tutti i tavoli stavano oggetti d'uso, alcuni per la fame, altri per la sete. Un signore faceva una proposta; la fedeltà apparve nel suo occhio, donna e bambino conferivano gravità ai suoi tratti. Uno valutava sobriamente un colloquio. Uno masticava un paesaggio, ornamento delle pareti. Sì, qui è la felicità, disse a se stesso e gonfiava le narici, come se affondasse. – Accoglietemi nella comunità!
Già alzava lo sguardo, come verso propri simili. I suoi occhi già vagavano come quelli dell'uomo che masticava. Non era più possibile negare che la luce della strada si oscurava e che, profondamente china, una ragazza cantava. In piena chiarezza appariva la voglia tra gli uomini e le donne, e il cameriere guadagnava in autorità. E lui si sentiva crescere e farsi silenzioso, così freddamente circondato da cose che accadevano.
Ora si era fatto più audace; si rilassò sulle sedie, ed ecco – erano lì. Distribuì ciò che portava sotto la fronte attorno al velluto delle colonne. I pannelli di marmo si espandevano, le maniglie spiccavano isolate dal resto. Si lasciò andare a un'intima dissipazione: sui ripiani, sulle mensole accumulava pesi su pesi, da tutte le cavità, da tutte le pieghe.
Ora c'era perfino un quadro appeso alla parete: una mucca su un prato. Una mucca su un prato, pensò; una mucca rotonda, marrone, il cielo e un campo. No, quale indicibile felicità da questo quadro! Eccola là, con le sue quattro zampe, con una, due, tre, quattro zampe, è innegabile; sta con quattro zampe su un prato, e guarda tre pecore – il numero, come amo i numeri, sono così duri, non si lasciano toccare da nessuna parte, irrigiditi nell'inafferrabilità, sono assolutamente univoci, sarebbe ridicolo trovare da ridire qualcosa su di loro; se mai una volta sarò triste, mi ripeterò i numeri; rise allegramente e se ne andò.
© Paolo Melandri (15. 7. 2018)
*
Fenomeni analitici
Sentì improvvisamente una profonda spossatezza e un veleno nelle membra. Si accostò a una finestra che dava sul giardino. C'era una fioritura bianca senz'ombre, la siepe piena di minimi giochi; su ogni filo d'erba stava sospeso qualcosa che fremeva; dentro la sera si scioglievano profumi dai cespugli, che brillavano senza fine e per sempre.
Per un attimo qualcosa gli sfiorò la testa: un allentamento, una vibrazione leggera di scoppio e nell'occhio arrivò un'immagine: terra chiara, ondeggiante nell'azzurro e nell'ardore e frastagliata di rose, in lontananza una colonna con folto fogliame alla base; lì lui e la donna, animaleschi e perduti, in silenzio colavano umori e respiro.
Ma subito scomparve. Si passò la mano sugli occhi. E già il cerchio tornava a stringergli la fronte e una sensazione di freddo alle tempie: che cosa era? Aveva vissuto con una donna e una volta l'aveva vista ammucchiare in un angolo petali sfioriti di rosa su un tavolo di pietra colorata; poi tornare a sedersi assorta nel chiarore di un cespuglio. Questo era proprio tutto quanto sapeva di lei: il resto era che lui era sottratto a se stesso, qualcosa ferveva e lui sanguinava – – – ma dove l'avrebbe condotto tutto questo?
Il suo sguardo si fece duro. Con determinazione entrò nel giardino, ordinò i cespugli, misurò il sentiero. E allora fu sopraffatto: si trovava alla fine di molti millenni, ma la donna era sempre; lui era debitore della propria evoluzione a un'epoca che aveva creato il sistema, e qualunque cosa potesse accadere, questo era lui!
Gettò uno sguardo di sfida nella sera, ed ecco, fioriva azzurra l'essenza del giacinto in curve odorose di pure formule, unità conchiuse, nello spazio del giardino; e una vecchia battona scendeva dai gradini di un penitenziario colando in verticale nella terra sotto l'abbraccio ardente dei raggi calcolabili di un sole al tramonto.
© Paolo Melandri (14. 7. 2018)
*
Sotto la stella del tramonto
Il mare si stendeva scintillante come uno specchio ieri e si stende scintillante come uno specchio oggi. È l'estate di San Martino e sull'isola fa caldo – e che dolcezza, che tepore! – ma non c'è sole.
Sono passati tanti anni da quando ho provato una simile pace, forse venti, o trenta, o forse è stato in una vita precedente. Ma una volta, penso, questa pace devo averla già assaporata, visto che sono qui a passeggiare canticchiando estasiato, e ogni sasso, ogni filo d'erba attira la mia attenzione e sembra ricambiarmi con uguale interesse. Siamo vecchi amici.
Mentre, seguendo il sentiero mezzo nascosto dall'erba, penetro nel bosco, il mio cuore freme di una gioia ultraterrena. Ricordo un luogo sulla costa orientale del mar Ionio dove sono stato una volta. Era come qui, e il mare era calmo e greve e color grigio ferro come ora. Mi addentravo nel bosco, mi sentivo commuovere fino alle lacrime, ero rapito, continuavo a ripetere: Dio del cielo, e pensare che sono tornato!
Come se fossi già stato lì!
Ma forse c'ero davvero arrivato una volta da un altro tempo e un'altra terra, dove il bosco e le stelle erano le stesse. Forse ero stato un fiore del bosco, o un coleottero che aveva per casa un'acacia.
E ora sono qui. Può essere che abbia volato per il lungo cammino, può essere che fossi un uccello. O forse il nocciolo di un frutto inviato da un mercante persiano…
Ecco, ora sono lontano dal chiasso della città e dalla ressa e dai giornali e dalla gente, sono fuggito da tutto perché ho sentito il richiamo della campagna e della solitudine da cui provengo. Vedrai, tutto andrà bene! penso, e sono pieno di speranza. Ah, sono già fuggito così e poi sono tornato in città. E sono fuggito di nuovo.
Ma ora è mia ferma intenzione trovare la pace a qualsiasi costo. Per il momento ho preso in affitto qui una stanza, e la vecchia Gilda è la mia padrona di casa.
I sorbi sono coperti di mature bacche di corallo tutt'intorno, nel bosco di conifere, e le lasciano cadere a terra in pesanti grappoli. Si vendemmiano e si riseminano da soli, ogni anno sprecano un'incredibile sovrabbondanza: su un solo albero conto oltre trecento grappoli. E qua e là sui pendii vi sono ancora fiori caparbi che si rifiutano di morire benché, in fin dei conti, il loro tempo sulla terra sia già finito.
Ma anche il tempo della vecchia Gilda è finito, e guarda un po' se muore! Si comporta esattamente come se la morte non la riguardasse. Quando i pescatori stanno sulla riva a sporcare dappertutto, incatramando le nasse o dipingendo le barche, la vecchia Gilda va da loro con gli occhi spenti, ma con il più scaltro spirito mercantile.
“Quanto costa oggi lo sgombro?” domanda.
“Quel che costava ieri”, è la risposta.
“Allora potete tenervelo.”
E Gilda se ne torna sui suoi passi.
Ma i pescatori sanno fin troppo bene che Gilda non è tipo da far solo finta di andarsene: è già capitato che se ne sia tornata a casa senza nemmeno voltarsi. “Ehilà!” E le gridano dietro che oggi avrà uno sgombro in più per ogni mezza dozzina, visto che è una vecchia cliente.
E Gilda compra il pesce…
Sulle corde dei panni sono appese sottane rosse, bluse azzurre e biancheria pesantissima: tutto filato e tessuto sull'isola dalle vecchie rimaste. Ma sono stese ad asciugare anche le eleganti sottovesti senza maniche tanto adatte a gelarci dentro, e le camiciole di lana che, tirandole, possono esser ridotte a una fune. Da dove vengono queste mostruosità? Ah, sono quelle delle figlie, le ragazze dei nostri tempi, che se le sono guadagnate in città. Se le si lava di rado e con attenzione durano giusto giusto un mese. E ci si ritrova così deliziosamente nude dentro quando i buchi cominciano a propagarsi nel tessuto.
Non sono un imbroglio, invece, le scarpe della vecchia Gilda. A intervalli ragionevoli va a trovare un pescatore della sua età che condivide il suo modo di pensare, e lui le unge tomaie e suole con un grasso forte, contro cui l'acqua è del tutto impotente. Vedo come il grasso viene bollito sulla riva: ci sono dentro sego, catrame e resina.
Ieri, mentre passeggiavo sulla spiaggia guardando i pezzi di legno portati dal mare, le conchiglie e i sassi, ho trovato un frammento di vetro da specchi. Non capisco come sia arrivato fin qui, ma ha tutta l'aria di un errore, una menzogna. Non è possibile che un pescatore l'abbia portato qui in barca, l'abbia posato e se ne sia ripartito! L'ho lasciato dov'era. Era grossolano, comune, semplice, forse era un pezzo di finestrino di un tram. Un tempo il vetro era raro e color verde bottiglia… Dio benedica quei bei tempi antichi in cui esistevano cose rare!
Sale ora il fumo dalle case dei pescatori all'estremità meridionale dell'isola. È sera, la farinata è sul fuoco. E quando il cibo sarà consumato, la gente a modo se ne andrà a letto per alzarsi di nuovo all'alba. Solo i giovani scapestrati continueranno a bighellonare di casa in casa, rimandando il tempo del rientro senza capire il proprio bene.
© Paolo Melandri (14. 7. 2018)
*
Irradiazione
Dopo lo scirocco ha piovuto quasi per tutto il giorno. Il pomeriggio è stato un po' più sereno. Spesso proprio quando il cielo è coperto l'irradiazione si fa più pungente, come se venisse riflessa dai bianchi nembi.
Di sera alla banchina, dove ho visto un ragazzo infilzare polpi con il tridente. Le lunghe braccia degli animali si avvolgevano morbidamente attorno al ferro che inchiodava i loro corpi. L'immagine mi ha riportato alla mente lo zoologo con cui mi trovavo anni fa in uno dei laboratori dell'acquario napoletano; il piccolo octopus De Filippi che avevo prelevato per lui dal fresco bottino si agganciò sotto il polsino distendendo uno dei suoi tentacoli costellati di ventose. Lo colse un terrore veramente poco scientifico, specie quando nel tentativo di strapparsi di dosso l'animale, il tentacolo si spezzò continuando a serpeggiare avvinghiato al suo polso.
Poi è sopraggiunta una barca, nella quale un pescatore seminudo e disteso sul ventre ispezionava il fondo con una specie di periscopio. Mentre manovrava così, con il piede flesso lasciava ondeggiare il remo imprimendogli lenti colpi d'anca. Appena mi vide si levò in piedi e con entrambe le mani mi ha offerto da comprare una magnifica orata. Il corpo di questo pesce regale splendeva al tramonto come un lingotto d'oro zecchino dallo smalto lampeggiante di puntini viola scuro. Le pinne recalcitravano convulsamente e sotto gli opercoli dorati, che si sollevavano ritmicamente, apparvero le branchie stillanti di sangue, simili a purpureo muschio marino o a velluto rosso.
Più tardi, in giardino, ho sostenuto con il signor Bosco una discussione di alta politica, nel corso della quale egli si è rivelato un liberale della vecchia scuola, che ha visto nascere molte idee e naufragarne altrettante. Ne traeva una calma malinconica e con essa segue le vicende del mondo.
© Paolo Melandri (13. 7. 2018)
*
Primo sguardo su terra e mare
Primo sguardo su terra e mare.
L'uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla solida terra. Questa è la sua collocazione e il suolo su cui poggia, e ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo. Dalla terra su cui nasce e si muove trae non solo il suo orizzonte, ma anche il modo di camminare e di muoversi e l'aspetto. Di conseguenza chiama «terra» l'astro su cui vive, sebbene, com'è noto, la sua superficie si componga per quasi tre quarti di acqua e solo per un quarto di terra, mentre anche i continenti più grandi non fanno che galleggiarvi come isole. Da quando sappiamo che la nostra terra ha la forma di una sfera parliamo con la massima naturalezza di «globo terrestre» e di «sfera terrestre», e troveresti strano doverti figurare un «globo marino» o una «sfera marina».
La nostra intera esistenza nel mondo – felicità e infelicità, gioia e dolore – è per noi la vita «terrena» e, a seconda dei casi, un Paradiso terrestre o una terrena valle di lacrime. Si spiega così il fatto che in molti miti e in molte leggende, in cui i popoli hanno conservato le loro esperienze e i loro ricordi più remoti e profondi, la terra appaia come la Grande Madre degli uomini. Essa è designata come la più antica di tutte le divinità. I testi sacri ci narrano che l'uomo viene dalla terra e alla terra deve fare ritorno. La terra è il suo fondamento materno, ed egli è quindi figlio della terra. Nei suoi simili vede fratelli terreni e abitanti della terra. Fra i quattro elementi tradizionali – terra, acqua, fuoco e aria –, la terra è l'elemento destinato all'uomo e quello che più lo determina. L'idea che un altro dei quattro elementi possa incidere sulla esistenza umana al pari della terra appare a prima vista solo una possibilità fantastica, giacché l'uomo non è un pesce né un uccello, e ancora meno una creatura di fuoco, sempre che ve ne siano.
© Paolo Melandri (12. 7. 2018)
*
La parificazione dei sessi
Considerata come un livellamento e valutata entro i termini del piano, la parificazione dei sessi viene a urtare contro limiti che è difficile infrangere. L'economia, con i suoi più sofisticati strumenti di normalizzazione tecnologica, incontra non soltanto una resistenza spirituale, ma anche l'ostacolo di una reale condizione fisiologica.
Quando si apre la porta di una fabbrica o di un ufficio e si osserva lo spettacolo del gruppo apparentemente asessuato dei dipendenti, a tale impressione contribuisce in buona parte il mimetismo. La ricostruzione avviata nei piani alti non raggiunge quelli inferiori. L'organizzazione coinvolge l'organismo solo in superficie.
Per effetto di una legge generale, le difficoltà dell'organizzazione sono tanto maggiori quanto più è elevato il livello di sviluppo degli organismi: la costruzione risulta tanto più facile, quanto più semplici sono le pietre con cui si costruisce. I popoli «non sviluppati» o privi di storia si prestano pertanto più facilmente a una rifusione tecnica e ideologica di quelli dotati di una grande e antica tradizione. Si tratta di una diversa plasmabilità. In accordo a questa legge, un piano di formazione di Stato potrebbe esercitare un effetto più profondo sulle forme meno sviluppate dell'albero genealogico.
Nell'ambito dell'umano stato del lavoro le trasformazioni sono limitate alle funzioni. Una donna può divenire minatore, soldato, fisico, presidente della Corte. Questo cambia il suo statuto sociale, ma non quello biologico. Non si distingue qui solitamente tra maschio e femmina, ma vi sono altri stati, che spesso si distinguono al punto tale che i ricercatori li assegnano, nella classificazione, ad altre specie. Ci addentriamo a scrutare un mondo avventuroso, in cui la professione e l'attività non si limitano a conferire una sfumatura di colore all'individuo, ma ne definiscono il profilo dell'impronta, ne determinano il modo di essere. Ciò appare con grande evidenza nello Stato delle api, in cui le cellette del favo, a seconda dei loro diversi standard, rappresentano appunto stampi diversi.
© Paolo Melandri (12. 7. 2018)
*
Elisabetta
La signora di Hautcastel appoggiò comodamente la bella testa allo schienale della poltrona; tutti fecero silenzio e il barone cominciò più o meno così: l'anno stesso in cui Federico Rothbanner uscì dall'accademia Militare per entrare nel corpo dei cavalleggeri, Elisabetta di Hermansburg lo notò e si interessò a lui. Fu un autentico «coup de théatre». La società elegante non era per nulla preparata ad un fatto così singolare e nei primi tempi i commenti e le chiacchiere si sprecarono.
Il robusto e corpulento Maëlstrom, da lunghi anni spasimante ufficiale della contessa e, più di lui, Bernstein di cui tutti conoscevano le follie che aveva fatto per lei, e che lei senza alcun dubbio aveva incoraggiato, buttarono fuoco e fiamme e non mancò chi prendesse le loro parti. Il granduca stesso non rimase estraneo all'indignazione generale e rivolse all'indirizzo della colpevole un epigramma così pungente che sarebbe bastato a trafiggerla. Ma la contessa rispose con tanta disinvoltura a Sua Altezza Reale, in una forma tuttavia così controllata e rispettosa che anche quelli che si preparavano a ridere alle sue spalle passarono dalla sua parte.
In conclusione: ciò che era rimase, e rimase del tutto immutato.
In capo a sei mesi tutti, ad eccezione dei due sconfitti e non rassegnati, ci avevano fatto l'abitudine e nessuno ne parlava più.
Eppure, almeno in apparenza, niente di più assurdo. Elisabetta aveva trentacinque anni ed era nel pieno splendore della sua bellezza, con in più la fama di donna di spirito, fama che andava crescendo ogni giorno e che era impossibile superare.
Per contro, Rothbanner, per rendere accettabile la propria conquista, non aveva da esibire che i suoi vent'anni e la sua bella persona, ma neppur l'ombra di quell'intrinseco valore che tutti gli avrebbero riconosciuto più tardi. Insomma: la perla stava ancora nascosta dentro la conchiglia.
A determinare quanto era accaduto c'erano volute la profondità di riflessione e la sagacia di egoismo che erano doti peculiari della contessa, in ogni cosa la più impeccabile delle creature, e soprattutto quella mondana e spregiudicata saggezza che conduce coloro che la possiedono a non aver certo rubato la dannazione eterna.
Elisabetta aveva pensato che, giunta ormai al sommo della gloria, era purtroppo molto vicina al pendio che ne avrebbe segnato la discesa. La salita era stata tutta tra i fiori; tra breve sarebbe stato inevitabile percorrere il cammino inverso tra i rovi.
Per sapere che cosa accade di solito ad una donna circondata di adoratori, le era bastato guardarsi attorno: i giardini di Armida, in cui lei mieteva trionfi, le avevano mostrato i loro prati verdeggianti popolati da vecchie cicale, le cui voci profetiche non erano capite da altri che da lei.
Prese ad esaminare ad uno ad uno il destino di quelle creature cadute in così tristi metamorfosi e credette di poter ritenere che la causa della loro sventura fosse da ricercare nell'imprevidenza con la quale ciascuna aveva legato la propria felicità ad un uomo che la dominava e che, di conseguenza, poteva rifuggire da lei non appena il cuore gli suggerisse la diserzione.
Disse a se stessa: io farò di un uomo un essere pienamente felice. Avrò così uno schiavo che mi dovrà tutto: il primo successo, la prima ebbrezza, la prima gloria, la prima esperienza. Mi adorerà; e se io, a mia volta, l'adorerò mi guarderò bene dal dirglielo nella misura in cui io lo sento. Lo dominerò, lo condurrò là dove mi piacerà che vada e lo conoscerò a fondo, testa e cuore, bene e male, vizi e virtù. Dei primi, asseconderò quelli che mi saranno utili, delle altre, soffocherò quelle che potrebbero ergersi contro di me. Lo avrò tutto mio, prima di tutto perché sarà molto giovane e si abbandonerà senza riserve, ed io approfitterò di questo tempo per plasmarlo e riplasmarlo in tale modo che non pensi mai a ribellarsi o a mettermisi contro, poiché non avrà più né nervi né muscoli per dar seguito ad un proposito del genere. In questo modo, tradurrò in realtà una delle più belle finzioni dei romanzi, avrò cioè dato vita ad uno di quegli ipotetici amori che durano per sempre; e fino all'ultimo respiro, se questo mi aggraderà, sarò servita, sarò amata. Tale almeno – ed è l'essenziale – la gente mi crederà. Infine, pur ammettendo che una siffatta catena possa un giorno diventare pesante, sarò io e non lui, sarà la mia volontà e non la sua, a decidere la rottura.
Quando per la prima volta vide Rothbanner, lui le piacque quanto bastava perché, mentalmente, imprimesse su di lui il marchio del possesso. Si concesse il tempo di convincersi che era un uomo capace di amore e tutto si svolse come lei stessa aveva deciso.
È ovvio che Rothbanner si ritenne tanto più fortunato quanto meno sospettò di aver perso la partita.
Le cose andarono così, alla perfezione, per cinque anni e tutti sono in grado, quanto me, di testimoniare che non una sola distrazione, non un solo sintomo di noia fu sorpreso nel giovane amante.
La signora Hermansburg aveva felicemente compiuto quarant'anni, e tutto procedeva a meraviglia quando il marito, altrettanto scioccamente e fuori proposito come tutto ciò che aveva fatto in vita, ebbe la bella pensata di morire, il che fu il segnale della catastrofe, perché vennero allora alla luce dei misteri che nessuno mai sarebbe stato in grado di immaginare.
© Paolo Melandri (12. 7. 2018)
*
Olga
Le prime luci del giorno filtravano dall'interstizio di pesanti tende doppie, con motivi scarlatti e gialli. Olga, al suo fianco, respirava con regolarità, con la corta camicia da notte rialzata fino alla vita. Giulio le accarezzò delicatamente le natiche, bianche e rotonde, senza svegliarla. Il suo corpo non era quasi cambiato in dieci anni, i seni però si erano un po' appesantiti. Quel magnifico fiore di carne aveva cominciato ad appassire; e il deterioramento, adesso, avrebbe accelerato. Aveva due anni più di lui; prese allora coscienza che avrebbe compiuto quarant'anni il mese successivo. Erano circa a metà della loro vita; le cose erano passate in fretta. Si alzò e raccolse i suoi indumenti disseminati sul pavimento. Non si ricordava di essersi spogliato, era stata lei probabilmente; aveva l'impressione di essersi addormentato subito dopo avere posato la testa sul cuscino. Avevano fatto l'amore? Forse no, e questo era già grave, perché dopo tanti anni di separazione avrebbero dovuto, avrebbero dovuto almeno tentare; la sua prevedibile assenza di erezione immediata sarebbe stata da imputare fin troppo facilmente all'assunzione eccessiva di alcolici, ma lei avrebbe potuto tentare di fargli un pompino; non si ricordava se era andata così, forse avrebbe dovuto chiederglielo? Anche tale esitazione sui suoi diritti sessuali, su ciò che pareva naturale e normale nell'ambito della loro relazione, era inquietante, e un probabile segno della fine. La sessualità è una cosa fragile, è difficile entrarvi, così facile uscirne.
© Paolo Melandri (10. 7. 2018)
*
Il sigaro di don Benito
Jaime Torrijos era un tenente del reggimento di cavalleria di Agreda, di stanza, in quel periodo, a Cochabamba. Era amato e ammirato da ufficiali e soldati, giacché tutto il suo corpo esprimeva un vigore e un'audacia straordinari. Per lo stesso motivo le donne lo amavano.
Quando lo conobbi la sua fama cominciava a diffondersi fuori dal reggimento e dalla città. E spensieratamente ne godeva. Suonavo la chitarra e mi legai a Jaime che mi voleva compagno delle sue orge. Era sempre privo di denaro a causa delle carte e dell'amore.
Ero chitarrista, ma ero stato anche seminarista; quando non strimpellavo la chitarra, leggevo libri di teologia. Osservavo uomini e donne di ogni tipo e mi rendevo conto di quanto fosse facile dominarli. Il potere che il corpo fiero di Jaime esercitava sugli uomini e sulle donne, immediatamente mi affascinò. Io che disprezzavo ogni forma di potere, mi chiedevo incuriosito come fosse possibile sfruttare quel dono anche al di fuori del suo ambito specifico. La chitarra, è vero, bastava a rendermi la vita incantevole, ma provavo il desiderio di introdurre forme rischiose nel cerchio intimo del mio essere.
Durante le orge, guardavo Jaime e improvvisavo canzoni che lodavano il suo coraggio e quello dei cavalleggeri di Agreda. Tutti le apprezzavano e si gonfiavano di orgoglio.
A quei tempi il Protettore dello Stato era Benito Ramirez, un uomo quanto mai energico e astuto, ma il suo potere era durato abbastanza, e amici e nemici se n'erano stancati.
Nelle mie canzoni cominciai a insinuare il disprezzo per il Protettore e a minacciarlo della disistima dei cavalleggeri di Agreda. Dapprima scherzavo soltanto, ma Jaime, che si annoiava e aveva bisogno di nuove avventure – da me aveva imparato chi egli fosse realmente – cominciò a decifrare il segreto significato delle canzoni.
Ubriaco, una sera esclamò:
«Benito Ramirez resta al potere soltanto perché sono io a volerlo.» Il giorno seguente mi recai a trovarlo nella camera di una donna e chiesi una spiegazione delle sue parole. Non se ne ricordava, ma ben presto ammise non solo di aver detto quelle cose, ma di conoscere anche l'idea che c'era dietro.
In quel periodo conobbe Conception. Conception era la più bella puttana della Bolivia e, quando giunse a Cochabamba, Jaime non ebbe occhi per lei. Nella capitale lei aveva avuto un gran numero di amanti distinti e disprezzava quel tenentino.
Lui non si sentiva così sicuro con lei come con le altre e richiese, con una certa umiltà, i favori del suo letto. Vi andò soltanto perché era forte e Conception non poteva negarsi a nessuno che fosse forte e, inoltre, nessuno del reggimento di Agreda avrebbe osato mettersi nel mezzo.
Lei si compiacque di quella forza.
Anch'io, come tutti, ero rimasto turbato dalla bellezza di Conception e, per un certo periodo, le sole canzoni che composi erano per lodare lo splendore dei suoi seni e dei suoi fianchi e per prometterli a Jaime. In seguito cantai l'imeneo, finché la tristezza non mi vinse e mi ributtai nella teologia.
Qualche tempo dopo, don Benito Ramirez, che da La Paz andava a Santa Cruz, si fermò a Cochabamba. Il reggimento di Agreda rese gli onori militari nella pianura antistante le porte della città, dando prova di un'innegabile bravura. Ero andato anch'io, a dorso di una mula, a godermi lo spettacolo, perché, nonostante la mia debole costituzione, mi piaceva la bellezza degli uomini e dei cavalli e il sobbalzare vigoroso dei loro pettorali liberava le note della chitarra quanto la vista dei seni delle belle donne e le incredibili idee dei teologi.
Ramirez si reggeva a stento in sella; era un uomo piccolo e curvo che si trascinava dietro la propria autorità con aria afflitta. Dopo le manovre si fermò davanti al reggimento schierato a battaglia e, da lontano, immaginai come muovesse lo sguardo profondo su quegli uomini di cui le spie gli avevano rivelato gli umori recenti. Un tempo era stato il reggimento di Agreda ad appoggiare il suo colpo di Stato.
Rapidamente smontò di cavallo e si sedette stancamente sotto un albero. Mi avvicinai e vidi il colonnello del reggimento che, venuto a mettersi a sua disposizione, si voltava e chiamava Jaime. Provai una certa emozione.
«Tenente Torrijos, mi si dice che non vi piaccio affatto», disse il Protettore con voce maschia e calma, sorprendente in una bocca tormentata dal dubbio. «Forse non ho fatto il mio dovere non scoprendo prima i vostri meriti. Vi nomino capitano dei dragoni a La Paz.»
Jaime parve dapprima sconcertato, ma, senza smettere di frugare negli occhi del Protettore, esclamò:
«Eccellenza, vi ringrazio per la nomina a capitano, ma vi prego di non concedermi promozioni se questo comporta il mio allontanamento dal reggimento di Agreda.
– Capitano, è un ordine. Potete ritirarvi.»
Ammirai con quale eleganza la bella voce del Protettore si librasse nell'aria. Sembrava la voce di un uomo grande e serenamente forte. Ero affascinato da quella voce e, quella sera, al club degli ufficiali, improvvisai una canzone accompagnandomi con la chitarra. Cantavo la tristezza di chi può solo dominare gli altri per placare la propria frenesia di disprezzo e si stupisce poi dell'odio che pure continua a ferirlo.
Jaime era di cattivo umore e beveva moltissimo; accanto a lui Conception lo osservava con ironica curiosità.
«Capitano», gridò, «finalmente conoscerai le belle donne di La Paz.»
Non provava più alcun piacere per il potere che esercitava sulle altre donne, da quando aveva capito che Conception gli resisteva. Si rendeva perfettamente conto che a La Paz sarebbe stato circondato da spie e certamente destinato a qualche attentato.
Gli ufficiali erano molto inquieti dopo aver appreso che il loro preferito se ne sarebbe andato e parlavano niente di meno che di marciare su La Paz durante l'assenza di Ramirez.
Allora, all'improvviso, cominciai un'altra canzone. Le prime parole stupirono i presenti.
Cantavano la forza e la gloria di Ramirez e la sua giustizia, perché aveva riconosciuto nel suo esercito il suo più grande capitano e aveva voluto mostrarlo come esempio a tutti i cavalleggeri. Agreda non avrebbe dimenticato Jaime Torrijos e presto i dragoni avrebbero amato Torrijos come l'aveva amato Agreda.
Chi mi ascoltava rimase sconcertato, ma poi finì col capire quello che intendevo dire e con l'ultima nota si scatenò il baccano degli applausi e delle risate.
Qualche giorno dopo il capitano raggiunse il nuovo posto ed io, alle calcagna, entrai a La Paz con Conception, che chiamavamo di preferenza Conchita, e con la vecchia mezzana che, secondo l'uso, amministrava i suoi disordini.
© Paolo Melandri (10. 7. 2018)
*
La valigia vuota
Attraverso una periferia – le periferie sono i confini del mondo –, poi una campagna autunnale color verdura cotta e oro pallido da stanza da letto, sotto una pioggia battente, con un autista che mi parlava del suo motore, sono arrivato in una di quelle terribili pensioni familiari dove malinconia e pazzia possono convivere bene con l'assoluta mediocrità.
Stava lì, sotto il tuo letto, la valigia aperta dove finalmente non potevi mettere che una cosa, la più preziosa che un uomo abbia: la sua morte. Grazie a Dio, avevi conservato il meglio e non te ne sei privato. Su questo punto, sei stato vigile e indefettibile: hai conservato la tua morte. Sono molto felice che tu ti sia ucciso. È la prova che eri rimasto un uomo e che sapevi bene che morire è l'arma più potente che un uomo abbia.
Sei morto per niente, ma dopotutto la tua morte dimostra che gli uomini non possono fare nient'altro al mondo che morire, che se c'è qualcosa che giustifica il loro orgoglio e il sentimento che hanno della loro dignità – e tu lo avevi questo sentimento, tu che sei stato continuamente umiliato, offeso – è che sono sempre pronti a gettare la loro vita, a giocarla in un colpo per un'idea, un sentimento. C'è solo una cosa nella loro vita, la passione, e la passione si può esprimere soltanto con l'omicidio – degli altri e di se stessi.
Avevi tutti i pregiudizi, tutto quel tessuto della vita sociale degli uomini che è la nostra stessa pelle, una pelle aderente come quella sessuale e animale – e che possiamo soltanto rivoltare su noi stessi con una lacerazione magnifica e assurda. Tu vivevi – il tempo che hai vissuto – con tutta la pelle dei pregiudizi rivoltata su di te. Scorticato!
Tu credevi a tutto: all'onore, alla verità, al decoro…
La tua camera era ordinata come tutti i posti in cui passavi. Sul tavolo, le carte, i piccoli oggetti, le scatole di fiammiferi in pila, le carte. O letteratura, sogno d'infanzia che sempre ti tornava e che era diventato un frutto secco e ridicolo che nascondevi in un cassetto. Una rivoltella graziosa come tutti gli oggetti con i quali giocavi. Tutto era mortale nelle tue mani: tutte quelle spazzole sulla toeletta. Pettinavi i tuoi bei capelli e uscivi: nei salotti, nei bar, il sentimento dell'amore impossibile, nefasto, contraeva il cuore di qualche donna.
Non di tutte. Tu non piacevi a tutte, né a tutti. Molte persone ti hanno disprezzato e rifiutato. Erano più limpide dei tuoi amici, che non ti accettavano mai incondizionatamente. Perché? Era anche colpa tua, non avevi talento. E avevi il torto di parlarne.
In ogni letterato c'è un bel becchino: non è la prima volta che verso inchiostro sulla tomba di un amico.
Ero tanto vile che una sera ti ho portato dei fiori. Non osavo più parlarti, urlarti la mia fede. La mia fede in tutto quello che tu odiavi, vomitavi, in tutto quello che tu hai ucciso con un colpo di rivoltella.
Non avendo passioni, avevi dei vizi. Essendo un bambino, i tuoi vizi erano l'ingordigia. E le tue ingordigie erano da bambino: eri avido di sonno e di gioco, di gioco e di sonno. Giocavi con i tuoi pezzi divini: foto curiose, ritagli di giornali, che ne so? E poi, chiacchierando, giocavi ancora con aneddoti… raccattati negli almanacchi, segni dell'impotenza umana da cui siamo crivellati ogni giorno. E poi arrivava la sera. Allora ti drogavi, ti bucavi, e ridevi, ridevi, ridevi. Avevi denti da sghignazzata indimenticabile: forti e stretti e solidi in una mascella energica, in una faccia dalla pelle spessa. Ridevi, sghignazzavi, e poi stramazzavi morto. Ma rinascevi, a quei tempi, ogni mattina. Come un fuoco fatuo o un folletto delle paludi, rinascevi da una bolla d'aria mefitica. Avevi il corpo di un tritone e l'anima di un folletto.
L'ho visto, rotolato nel vostro vomito di ubriachi, urlare alla morte in una tromba di scale calata giù dalla luna, davanti a una porta in cui non avevo potuto introdurre la chiave.
I pagani credono alla terra, i cristiani al cielo, e gli uni e gli altri al mondo. Io sono dei loro, appartengo a quei milioni di persone. Perché non mi hai sputato in faccia? Credevi soltanto agli uomini d'affari, alla gente di mondo, al successo con le donne. Eri volgare ma non all'altezza della tua volgarità. Perché non avevi un portamento elegante, anche se mi commuoveva fino alle lacrime; ti restava appiccicato addosso qualcosa di borghese che ti impediva di volare nelle alte sfere. Eri timido. Eri amato soltanto dalle donne che non amavi, o dalle donne perdute che amavano la propria rovina nella tua.
Sei morto con la certezza che la terra fosse popolata da gente di mondo, da domestici e artisti amici tra di loro. Avevi paura dei ladri e degli assassini, preferivi spillar denaro alla gente di mondo. Questo ti faceva male. Ne sei morto. La gente non sa dare. Ma sapremmo ricevere, se all'improvviso si sapesse dare?
© Paolo Melandri (9. 7. 2018)
*
Cleopatra
Cleopatra. L'autorità e l'audacia della donna egiziana si trovano nell'ultima e più famosa delle eroiche regine d'Egitto. E più precisamente quello spirito di iniziativa e quella sfrontatezza che la donna egiziana aveva acquistato alla fine dell'era tolemaica. Cleopatra è diventata una principessa da leggenda, il mito che l'ha fatta nascere l'ha trasformata nella nostra immaginazione. È necessario un certo sforzo per ritrovare, sotto le migliaia di sontuosi e barbari ornamenti che nascondono la sua vera fisionomia, la giovane donna che fu. Sposata a diciott'anni per condividere la tiara dei Tolomei con il fratello che ne ha nove di meno, Cleopatra incomincia col guidare un'armata per distruggere la fazione che le disputa il potere. Cesare si presenta come mediatore autoritario. Ed ecco apparire subito la donna calcolatrice. Il suo modo di chiedere un appuntamento è perfettamente orientale. Parte sola e in segreto, con uno dei suoi uomini più fidati. Avvolta in una coperta, proprio come una principessa cinese, si fa gettare nella stanza in cui dorme il conquistatore. Questa diplomazia diretta le riesce. Inutile precisare che il giovane fratello, nonché marito, morì accidentalmente poco tempo dopo, durante una passeggiata in barca. A Cleopatra venne dato come marito il fratello minore, assai meno ingombrante visto che aveva solo sei anni. Così potè fare la regina a suo talento, portò a spasso per tutto l'Egitto Cesare e lo seguì persino a Roma, dove egli pretendeva di ottenere dal Senato l'autorizzazione a sposarla. Le idi di marzo misero fine a questo sogno. Cleopatra tornò ad essere una regina d'Oriente. Il suo primo atto di governo fu quello di far avvelenare il suo piccolo marito che, avendo raggiunto i quattordici anni d'età, stava trasformandosi in un personaggio.
A questo punto compare Antonio. È giovane, è bello, è pazzo: figliol prodigo che non si rifiuta nulla, vero figlio di re che vive nella porpora, adorato dai suoi uomini per il suo coraggio. In suo onore Cleopatra fece il gran gioco: tutti gli splendori di Hollywood, galea dorata, nereidi nude fra le onde, feste meravigliose. Volle essere un idolo d'Oriente. Antonio scoprì quella California che la grande banca aveva fatto sorgere sulle rive del Nilo. I palazzi erano profumati da cespi di iris e di asfodeli. I bellimbusti di Alessandria si beffavano dei Romani, come se questi fossero ufficiali russi. Furono gli amori di una grande diva nella città più spirituale e più corrotta del mondo. Qualche volta, stanchi delle orge, Antonio e Cleopatra correvano nelle strade, mascherati, battendosi con i passanti. Allo spuntare del giorno, accarezzavano il gatto del lattaio, come nella Dolce vita. Quelle vacanze pazze durarono diciotto mesi. Dopodiché Antonio dovette tornare a Roma per sposare la dolce Ottavia, clausola inclusa nei patti per il triumvirato.
Tre anni dopo Antonio tornò dalla sua regina. Più pazzo di prima si vestiva da principe asiatico, satrapo ammaliato dall'Oriente, ma stanco, alcoolizzato, diffidente. Ad Azio il suo stato maggiore non ne voleva sapere dell'aiuto della flotta egiziana. Vi furono intrighi, malintesi. In piena battaglia Cleopatra abbandonò il combattimento per approfittare del vento che spingeva la galea regale verso l'Egitto. Antonio commise la pazzia di rincorrerla, perdendo in tal modo la battaglia per un colpo di testa. Vissero ancora qualche mese ad Alessandria, sempre stordendosi con orge e festini. Con i loro ultimi fedeli avevano fondato la società degli «Inseparabili nella Morte». Ma non era già più che una commedia. Ottaviano stava scendendo dalla strada della Siria. Cleopatra negoziava con lui, cercando di salvare la propria corona. Quando l'armata romana arrivò fin sotto le mura di Alessandria, fece spargere la voce della sua morte. Antonio vi credette e si pugnalò. Si dice che Antonio morente apprendesse la notizia che Cleopatra era ancora viva. Allora si fece issare con delle corde sino al mausoleo in cui lei si era rifugiata, per avere la gioia di morire fra le sue braccia. Cleopatra lo onorò con splendidi funerali, poi, visto che rimaneva pur sempre una donna calcolatrice, chiese di vedere Ottaviano, il quale fu perfetto. Non era questo che si aspettava. Si suicidò per non essere trascinata dietro il suo carro trionfale come prigioniera.
© Paolo Melandri (9. 7. 2018)
*
Una visita al porto
Una giornata nella casbah, da un mattino all'altro; e intanto, ho parlato poco di quanto riguarda il servizio.
La lunghezza di una giornata non è stabilita dall'orologio. Dipende dalla nostra fantasia, dal gioco dei nostri pensieri. Le immagini abbreviano il tempo, poiché esorcizzano la noia, moltiplicando nel contempo i contenuti. L'ideale sarebbe un attimo in cui il tempo si concentra, anzi si annulla, e tutto diventa possibile. La luce guadagna in forza, diventa assoluta.
Questa mattina viene anche il cambio di turno. Faccio le consegne di tutte le scorte al bar, deposito la mia divisa e la chiave dell'office. Lo studio rimane chiuso durante la mia assenza: il Grande Luminar è cosa segreta.
Posso adesso avviarmi in città; sull'altura della rocca vi è già un buon tepore. Il sentiero che ne discende taglia le anse dello stradale: indica come una freccia rossa la direzione del porto. Verdi lucertole lo attraversano furtive, scomparendo in mezzo alle euforbie. Le spine non le intralciano. Ho in tasca il salario e giocherello con le monete d'oro. Farò tappa al porto.
Latifah mi attende; l'ho fatta avvisare da Madame Posa. Latifah stessa non può ricevere ordini; possiede soltanto il fonoforo grigio, ch'è limitato a comunicazioni ufficiali dalla casbah e che consente solo di ascoltare ma non di trasmettere. Se, nell'ambito della nostra società atomizzata, si sono conservati residui di una gerarchia di classe o di casta, è in tal modo che si manifestano. I diritti sono di natura dinamica: si fondano sul potere e non sulla proprietà.
Latifah – detto tra noi – è stata la prima venuta che mi è capitata fra i piedi. L'avevo notata la prima volta ch'ebbi il cambio di turno. La sua zona di caccia si trova nella parte superiore del porto, in mezzo ai magazzini di forniture nautiche, agli uffici dei mediatori e a piccole osterie. È là che suole gironzolare su e giù; gli intervalli sono segnati dall'«Albergo» di Madame Posa – un misero hotel de passe dalle scale anguste, stretto fra due case, a molti piani; davanti al locale di mescita, sul selciato, vi sono due tavolini rotondi e delle sedie. Madame affitta a ore; è raro che qualcuno desideri pernottare.
Latifah non rivolge la parola, ma la rivelano il passo lento e lo sguardo interrogativo: attende di essere abbordata. E poi, il fonoforo grigio. Quassù, la clientela è gente bene – – – piloti, commissari di bordo, stewards scelti, anche un notaio magari, o un effendi, che abbia voglie improvvise: non perderà molto tempo.
Io mi sono abituato a lei. In fondo, mi vanno più a genio quelle del basso-porto – – – figure statuarie con seni impetuosi e meduse della zona fluviale, che dondolano le chiappe con sguardi sfrontati. Però, laggiù è raro poter evitare gli alterchi. Specialmente quando vi è all'àncora una grossa nave, le guardie hanno un gran daffare.
Ci sediamo a uno dei tavolini tondi: dentro la lamiera, è inserito un disegno geometrico. Quando si versa un bicchiere, non rimangono tracce. Madame serve l'aperitivo. Il sole è sopra i tetti, la luce è buona. Esamino Latifah come un mercante di schiavi prima dell'accettazione; vi è in questo qualcosa di arcaico, dell'antica Persepoli. Soprattutto la dentatura è importante: rivela la struttura ossea. A sinistra in alto un dente d'oro, che non dà alcun fastidio. Lo mostra un sorriso, che conferisce ai lineamenti una profondità misteriosa. È un errore inestirpabile degli uomini scorgervi un indizio di intelligenza.
Non mette rossetto, se non sulle labbra; questo fatto e i capelli neri, che ricadono sulla fronte, rendono il viso ancora più pallido; la pelle ha pori larghi.
Una volta, mentre stava di nuovo ritta contro il caminetto, l'atmosfera si fece sinistra. La luce cominciò a tremolare come prima di un cortocircuito, ma poi non venne il buio bensì una luce splendida, accecante. Tenevo il braccio davanti agli occhi: la luce trapassava radio e cùbito. Le mura pareva fossero state risucchiate dal vento, si distinguevano soltanto le strutture. Vidi presso il caminetto uno scheletro, una impalcatura di ossa col dente d'oro, accanto alle cosce le fibbie della giarrettiera e lo scudo, ch'ella aveva già riposto, la piccola spirale sotto la bocca dell'utero.
Un esperimento delle catacombe – o fallito, oppure progettato in sede dimostrativa. Talora interventi simili generano inquietudine in città, provocando una sorta di paralisi. Gli orologi si arrestano; segue un black-out, quasi che il tempo rimanga bloccato. Laggiù, sono in grado di provocare anche fenomeni sismici e tenebre. Una breve scossa alla potenza dei Khan, che viene dimenticata come un incubo.
© Paolo Melandri (7. 7. 2018)
*
La gioia che resta 1
Ora me ne sono andato nella foresta.
Non che qualcosa mi avesse offeso o la malignità degli uomini mi avesse particolarmente ferito; ma se i boschi non vengono a me, bisogna che io vada da loro. Così è.
Questa volta non sono partito come servo e vagabondo. Ho molto denaro e sono supernutrito, sono fiacco di tante mete raggiunte e di felicità, capisci? Ho lasciato il mondo come un sultano lascia il vitto esuberante, l'harem, i fiori, e indossa il cilicio.
Forse mi potrei anche dare più arie, perché qui andrò in giro, penserò e farò arroventare grandi ferri. Certamente Nietzsche avrebbe detto così: L'ultima parola che dissi agli uomini incontrò il loro consenso, gli uomini accennarono di sì; ma la mia parola ultima fu questa: io andai nella foresta. Compresi infatti di aver detto o qualche cosa di disonesto o alcunché di sciocco…
Io non mi sono espresso in questo senso; sono soltanto andato nella foresta.
Non credere che qui non avvenga nulla. I fiocchi di neve cadono qui come in città e uccelli e animali si occupano dei fatti loro dalla mattina alla sera e anche dalla sera alla mattina. Di qui potrei mandare storie molto significative ma non lo faccio. Ho cercato la foresta per amore della solitudine e dei miei grandi ferri: ho in me alcuni grossi ferri che si arroventano. Mi tratto perciò a questa stregua. Se un giorno incontro un cervo dirò forse: Dio del cielo, ecco un cervo ed è furibondo! Ma se questo mi farà troppa impressione, dirò che è un vitello o un volatile e mentirò a me stesso.
E qui non dovrebbe succedere nulla!
Un giorno ho visto due lapponi incontrarsi. Erano un giovanotto e una ragazza. Da principio si comportarono come fanno gli uomini. «Boris!» dissero l'uno e l'altra e sorrisero. Ma subito dopo caddero nella neve e per un po' furono invisibili ai miei sguardi. Bisogna che tu vada a vedere, pensai quand'era passato un quarto d'ora, potrebbero soffocare nella neve. In quella si alzarono e andarono via, ciascuno dalla sua parte.
Mai nella mia vita dilaniata ho visto un saluto simile.
© Paolo Melandri (6. 7. 2018)
*
La scarpata
Lo stesso sole, la stessa siccità. Faccio il mio solito giro per la campagna e osservo che tutto è inaridito. Un prodigio maligno. La foresta è rovinata e dovrà certo essere rimboschita almeno in parte, l'erica non ha fiori da offrire alle api. È mai successa una cosa simile? Le api si lanciano in volo sui soliti posti, si guardano intorno ronzando un po', e se ne tornano a casa.
Mi imbatto in un precipizio che si trova sul mio cammino. Cerco di evitare quella vista spiacevole tenendomi sul ciglio opposto della strada. In questo luogo per lungo tempo la gente è venuta a gettare pietrisco, pattume, stracci e rifiuti di ogni genere, nel punto peggiore perfino il paracarro è stato divelto. Bene. Ma al ritorno sono costretto a passare dal lato esterno, rischiando la vita. Poiché mi ha sempre irritato il fatto di esser nato codardo e buono a nulla, e di soffrire di vertigini, decido che oggi è la volta buona: ci si ferma e si guarda giù. Rabbrividisco, già incerto sulle gambe, ma mi sforzo di avvicinarmi ancor più e di guardare in basso.
Va bene, forse ho esagerato…
Non era stata una caduta pericolosa, per fortuna. Non sono rotolato giù: da vero pusillanime mi sono limitato a scivolare sulla schiena lungo tutta la scarpata. E lì mi sono fermato.
Non avevo corso un gran pericolo, riflettevo guardandomi intorno. Dal punto in cui mi trovavo non sembrava nemmeno così abissalmente profonda, quella scarpata. Osservando il lago che si trovava ancora più in basso potevo anche concedermi di ostentare superiorità, perfino un po' di disprezzo. Ero atterrato laggiù per un puro caso: ma potevo permettere a un caso di avere la meglio? Dunque mi detti a fingere di essere molto occupato a rovistare nel pattume. C'era un'infinità di roba interessante, come pezzi di fil di ferro, ossa, un gatto morto e scatole di latta. Se un carrettiere si fosse fermato in quel momento sulla strada, soprattutto non doveva pensare che ero rotolato giù. Gli avrei dimostrato che ero in cerca di qualcosa, sì: di alcuni fogli importanti che mi erano volati via.
© Paolo Melandri (5. 7. 2018)
*
La prova delle scarpe
Leggo, vado in giro e faccio solitari.
Per usare un po' le gambe, nel paesaggio, mi arrampico sul mio colle. È molto ripido, e a tratti ho bisogno di tenermi appoggiato a un bastone appuntito per non scivolare di nuovo a valle. E non è tutto: le mie vertigini sono talmente sfacciate da farmi venir voglia di vomitare, cosicché devo inghiottire con forza. Decisamente ho cominciato un po' tardi l'attività alpinistica. Ripeto la gita giorno dopo giorno e divento più esperto in materia, ma arrivo su tremando in tutto il corpo.
In cima al colle c'è una spianata. Al principio devo starmene seduto tranquillo e non oso alzarmi a fare il forte… ma il mio cervello intanto è in moto e lavora. Guardo l'orologio: caro mio, ho impiegato soltanto pochi miserabili minuti per l'ascesa, ed eccomi seduto sulla mia vetta, a godermela come se avessi fatto chissà cosa. Per cavarne una vera gita devo pensare a ridiscendere dall'altro lato del colle e rientrare furtivamente a casa senza che nessuno mi veda.
La cosa sembra andare, riesco a scendere abbastanza bene. Ma poi trovo una strada, e non oso prenderla per timore di incontrare qualcuno. Guardo l'orologio: ancora non c'è verso di parlare di una gita. Tutto quel che devo fare è girare i tacchi e tornarmene un'altra volta sul colle.
Anche quella fu una piccola cosa, benché a un certo punto sia caduto malamente con tutto il peso su un braccio. E la ripida discesa fino a casa venne risolta lasciandomi scivolare giù, seduto su uno strato di rami e foglie.
Sì, tutta la faccenda non era mal congegnata e realizzata, bisogna ammettere. E in seguito non ho apportato alcun cambiamento a quelle gite. L'unica cosa che potevo temere era che qualcuno venisse a cercarmi durante la mia assenza.
Ma quando dopo giorni e settimane tornai a riflettere sui vantaggi di quelle gite sul colle non mi sentii molto soddisfatto. Non quello era l'esercizio che ci voleva per i miei muscoli e le mie membra, mi costava uno sforzo eccessivo, mi fiaccava e mi faceva sudare senza che il mio corpo ne guadagnasse in agilità. Sotto di me i piedi parevano completamente avvizziti. Si aggiunga che le mie scarpe non avevano sopportato bene la prova e s'erano strappate di sopra e di sotto. E altre non ne avevo.
© Paolo Melandri (5. 7. 2018)
*
Per sentieri
Non ho l'abitudine di lamentarmi o di essere insoddisfatto della vita e del mondo. In fin dei conti non lo faccio neppure qui. Non sono un brontolone io, scherzo di frequente, rido volentieri e ho un animo allegro. L'ho ereditato da mio padre, che era conosciuto anche lui per le stesse cose. Se possiedo altri aspetti gradevoli, per quelli devo dir grazie a mia madre. Io sono il loro prodotto.
Non intendo scrivere un'autobiografia; vi sono cose più interessanti da raccontare: quello che vedo, ad esempio, talvolta quello che provo. Siamo tutti in viaggio verso un paese che di sicuro raggiungeremo. Fretta non ne abbiamo, e ci fermiamo a raccogliere le casualità che ci capita di trovare per la strada. Solo gli stolti ridono in faccia al cielo e battezzano quelle casualità con nomi altisonanti.
© Paolo Melandri (4. 7. 2018)
*
La forbice
La forbice è un esempio qualsiasi della potenza che riposa dentro agli oggetti o, si potrebbe anche dire, che è ad essi conferita. Essa agisce aprendosi e chiudendosi, prima ancora di tagliare. Tra «attività» e «azione» vi è la stessa differenza che tra taglio e cartamodello.
Il gesto di Mosè, mentre Aronne gli sostiene la mano, è sacrale; la forbice di Atropo è mantica; quella di uno stemma simbolico è allegorica; quella di una sarta, di un giardiniere, di un borsaiolo, è pratica nel senso della quotidianità. È perfettamente corretto che, quando sentiamo il nome di questo oggetto, pensiamo in primo luogo alla sua funzione.
© Paolo Melandri (1. 7. 2018)
*
Il visitatore
Giacevo nella mia piccola camera quasi riempita dal letto e due grandi armadi ed ero ancora completamente sveglio. La nonna era venuta a farci visita e sedeva con mia madre in una camera contigua, la cui porta era socchiusa. Dalla larga fessura vedevo il raggio smorzato della lampada coperta dal paralume di seta rossa increspata e ascoltavo i discorsi delle due donne a proposito di ogni sorta di preoccupazioni domestiche.
Mentre ero intento ad ascoltare, fui sorpreso da un rumore estraneo, e cioè da un lento tambureggiare, lieve e smorzato, che non risuonava nella camera accanto, bensì vicino al mio letto. Devo dire che la parola sorpresa non è del tutto pertinente, perché dapprima il rumore era tanto flebile da far pensare a granelli di sabbia che cadessero su una pelle di tamburo, ma il suono aumentò in un lento e penetrante crescendo. Ad ogni modo non fui affatto spaventato; quei suoni sembravano un preludio, tale da modificare l'animo dell'ascoltatore e predisporlo ad un avvenimento eccezionale.
Mi sollevai con cautela, mentre di là la conversazione procedeva tranquilla. Ora mi si rivelò anche l'origine di quegli insoliti suoni: provenivano da una figura seduta sulla sedia, che come sempre si trovava accanto al mio letto, e con stupore vidi che si era impossessata di una grande scatola per il tè decorata con ideogrammi cinesi, sul cui coperchio faceva tambureggiare la nocca di un dito. Questa scatola da tè mi era ben nota; mio padre l'aveva comperata da un soldato reduce dalla campagna di Cina che diceva di averla predata durante l'incendio del palazzo imperiale. Era vuota da tempo e in ricordo dell'impareggiabile tè, di cui serbava ancora il profumo, veniva conservata con altri oggetti in cima a uno degli armadi.
Il visitatore era alto, di mezza età e dalla corporatura pesante. Il suo volto era brutto e ricordava una di quelle zucche che i bimbi amano intagliare con un coltello spuntato. Eppure i tratti non erano ripugnanti; lo impediva un'espressione di bonaria malinconia. Più tardi, negli anni che seguirono, mi sovvenni talvolta di quel volto allorché in vecchi esemplari preziosi mi capitava di ammirare le incisioni di Tony Johannot.
Avevo appena fissato lo sguardo su quel compagno inatteso, vestito di un umile abito grigio e maltagliato, che subito avvertii una forte sensazione di superiorità. Era quella specie di superiorità che un marmocchio cittadino, a caccia di scoperte nelle stalle e nei fienili di una masseria durante le vacanze, potrebbe sentire verso un vecchio bracciante con cui ha attaccato discorso. Del resto il mio visitatore non pareva affatto risentito che durante il vivace dialogo, subito accesosi tra noi, io cercassi apertamente di prenderlo in giro; al contrario, il tratto bonario del suo volto si accentuava sempre più ed egli seguiva i miei lazzi come un contadino che osservi i salti di un puledro al pascolo. Per la prima volta nella mia vita mi accadeva di superare per intelligenza uno spirito diverso e i fondo più forte, che per di più se ne rallegrava; questo rapporto mi ha sempre commosso.
Il nostro colloquio fu senza dubbio strano e rimpiango di non poterlo ripetere, sebbene ne abbia chiaramente impressa l'intima configurazione. Durante il colloquio io bisbigliavo ed egli mormorava; probabilmente il contenuto potrà sembrare alquanto insignificante, poiché per lo più concerneva ogni genere di suppellettili domestiche. Ci intrattenemmo su oggetti quali si trovavano nel solaio, in cantina, nell'antibagno o in cucina, in breve, su tutto ciò che appartiene al piccolo mondo della casa.
Tutti quegli oggetti naturalmente li conoscevo bene, e mi accorsi presto che anche lo sconosciuto ne possedeva una precisa cognizione. Il vero succo del discorso consisteva nel fatto che il visitatore li interpretava in modo del tutto insolito, conferiva loro qualità straordinarie e remote, sforzandosi visibilmente di ascrivere loro una vita propria, mentre io dovevo correggerlo e spiegargli il loro vero significato.
© Paolo Melandri (1. 7. 2018)
*
La bilancia dorata
Sebbene la perfezione non possa essere raggiunta, essa conserva il valore di un modello. Così pure la retta, cui, tra le linee, assegnamo un rango di particolare importanza. La retta perfetta, cioè quella immaginaria, si nasconde in ogni asse e gli conferisce un orientamento. Se il carro traballa, possiamo dare la colpa al fabbro, che ha costruito la ruota senza la dovuta attenzione. Potremmo anche dire che egli è venuto meno a quanto l'idea della linea orizzontale gli prescriveva. Un'idea che è implicita anche nel rimoprovero al maestro, per quanto questi possa anche non esserne consapevole e dia maggiore importanza al lavoro compiuto dall'artigiano. Simili pretese si fanno valere anche sull'opera dell'architetto – e non solo su questa – ricorrendo al piombino e alla bilancia. La bilancia cui si ricorre per osservare un'opera d'arte è una bilancia dorata.
© Paolo Melandri (30. 6. 2018)
*
Filtri
La flora delle giungle si decompone, nei deserti si dissecca e si trasforma in polvere. Sul muro del tempo crescono sempre muschi e licheni, come già li vide Leonardo. Le loro figure danno da pensare, da sperare anche: l'acqua della vita deve esservi filtrata. Il compito che ci resta è quello di separarla dal mare, dalle nuvole, dalla rugiada.
© Paolo Melandri (30. 6. 2018)
*
Il giardino perduto
È un avvenimento bizzarro come la fantasia, simile a una febbre i cui germi sono apportati da lontano, prende possesso della nostra vita e si insedia in essa sempre più profondamente e ardentemente. Alla fine soltanto l'immaginazione ci pare l'unica realtà e la vita di tutti i giorni un sogno, nel quale ci muoviamo svogliati, come un attore turbato dal suo ruolo. È allora venuto il momento in cui il crescente disgusto fa appello alla ragione e le pone il compito di cercare una via d'uscita.
Questo era il motivo per cui la parola «fuggire» aveva per me una melodia particolare, giacché non si poteva dire che vi fosse un particolare pericolo che giustificasse la sua applicazione; a parte forse gli insegnanti, i quali mi trattavano come un sonnambulo e le cui lamentele si accumulavano, diventando piuttosto minacciose nelle ultime settimane.
«Berti, tu dormi, Berti, tu sogni, tu sei nelle nuvole», era un eterno ritornello. Anche i miei genitori, che vivevano in campagna, avevano già ricevuto qualcuna delle ben note lettere, il cui sgradito contenuto iniziava con le parole «Il Vostro figlio Alberto Berti...»
Queste lamentele erano però non tanto la causa quanto la conseguenza della mia decisione; o meglio, le due cose si trovavano in quel rapporto di interazione, che suole accelerare i movimenti scoscesi. Da mesi vivevo in una eccitazione segreta, che in quegli ambienti difficilmente può passare inosservata. Così ero già arrivato al punto di non partecipare affatto alle lezioni, sprofondandomi invece in descrizioni di viaggi in Africa che sfogliavo sotto il banco. Quando mi veniva rivolta una domanda, dovevo superare tutti quei mari e quei deserti prima di dare alcun segno di vita. In fondo ero presente solo come rappresentante di un lontano viaggiatore. Mi piaceva anche, simulando un improvviso malore, uscire dalla classe e passeggiare sotto gli alberi del cortile scolastico, lì riflettevo sui particolari del mio piano.
L'insegnante di classe aveva già adottato nei miei confronti il penultimo dei provvedimenti educativi, che vuole indicare la definitiva separazione; mi trattava come fossi aria, mi «puniva ignorandomi». Che anche questo castigo non avesse effetto era un brutto segno, un segno di quanto io fossi già assente. Questo isolamento attraverso il disprezzo mi era anzi gradito, perché mi circondava di un vuoto, nel quale mi dedicavo indisturbato ai miei preparativi.
Vi è un tempo in cui il mistero appare raggiungibile al cuore solo nello spazio, solo nelle bianche macchie della carta geografica, e in cui tutto ciò che è oscuro e sconosciuto ha una potente attrattiva. Luoghi, ebbri sogni ad occhi aperti durante le mie passeggiate notturne sui bastioni mi avevano tanto avvicinato a quei lontani Paesi, che pareva ormai sufficiente la sola decisione per penetrare in essi e godere dei loro piaceri. La parola giungla racchiudeva in sé tutta una vita, la cui prospettiva è irresistibile a sedici anni; una vita da dedicare alla caccia, alle ruberie e a straordinarie scoperte.
Un giorno ebbi la certezza che il giardino perduto era celato nel delta superiore del Nilo o del Congo. E poiché la nostalgia per quei luoghi è fra le più difficili cui resistere, cominciai a nutrire innumerevoli, pazzi progetti su come ci si potesse meglio avvicinare alle regioni delle grandi paludi, della malattia del sonno e del cannibalismo. Covavo pensieri quali tutti conoscono certo dai loro più lontani ricordi: volevo farmi strada come clandestino, mozzo o travestito da apprendista artigiano girovago.
© Paolo Melandri (28. 6. 2018)
*
Zone estranee
Affondò ancora di più la nuca nell'erba di maggio che odorava di tirso e di Valchiusa. Sciogliendosi nel meriggio ruscellava la testa sui ciottoli del greto.
Lui la offrì: la luce, il sole forte gli filtrava inarrestabile attraverso il cervello. Là giacque: appena un mucchietto di terra sollevata dalle talpe, friabile, con l'animale che ci scavava dentro.
L'elemento animale e il pensiero che si sublima sempre più nudo: c'è ancora per entrambi un principio comune? Per la vita e per la conoscenza, per la storia e per il pensiero, c'è nel mondo occidentale ancora un simile principio monistico? Per il movimento e per lo spirito, per le emozioni e per le profondità – c'è ancora un combaciare, un contatto, una felicità? Sì, risponde lui, ma remoto, niente di universale, zone estranee, dure da sostenere, estranee da vivere: La corrente scrosciava in sé. E se non era corrente, era un getto di forme, un gioco febbrile, assurdo, e la fine ovunque intorno all'orlo: sorge l'arte.
© Paolo Melandri (19. 6. 2018)
*
Fiori di ghiaccio
Tutti i caratteri del tardo nichilismo definivano l'essere di Brachemarti. Gli era propria la fredda intelligenza sradicata e incline all'utopia; la vita gli appariva, come sempre a questa specie di uomini, quale un meccanismo di orologio; ed egli vedeva nella violenza e nel terrore le ruote motrici di codesta orologeria. Allo stesso tempo riusciva al concetto di una seconda natura, artificiosa, per cui egli si poteva inebriare al profumo dei fiori dipinti o di una sensualità solamente recitata e falsa. Aveva ucciso nel proprio animo la creazione e l'aveva ricostruita come si fa del meccanismo di una suoneria: fiori di ghiaccio, come su di un cristallo, fiorivano sulla sua fronte, e chi lo vedeva era indotto a rammemorare il profondo motto del suo maestro «Il deserto si estende: guai a colui che in sé nasconde deserti».
© Paolo Melandri (19. 6. 2018)
*
La fiamma refrigerante
Una soave frescura si diffondeva dagli oscuri pergolati sopra lo spiazzo e i suoi gradini. Il maestro fece portare una di quelle singolari pietre luminose che chiamano carbonchi: e una chiara e viva luce rossa si diffuse sulle forme e sui vestiti diversi. Un'amichevole conversazione iniziò presto fra loro. Mentre di lontano giungevano gli accordi di una musica, ed una fiamma refrigerante vampeggiava dalle coppe di cristallo tra le labbra loro, i forestieri narravano strani ricordi dei loro lunghi viaggi.
© Paolo Melandri (17. 6. 2018)
*
In somnio
Il grido della civetta, con le sue ali ovattate, mi è più familiare del canto del gallo. Preferisco gli archi agli ottoni. L'intervallo è l'oscurità. Avverto la luce come una scalfittura; è più un disagio che un dolore. Volentieri torno ad immergermi.
Il sonno privo di sogni, dopo la mezzanotte, è il più profondo; è allora che lo spirito entra da padrone nel mondo dei sogni. Non soltanto egli vi orchestra i fatti, ma li inventa anche a suo piacere, liberamente, apprestando dalle sue risorse inesauribili personaggi e arredamenti.
È una proprietà vivente. Lo spirito si tramuta in torrente; inonda la propria messinscena. È in grado di aprire gli occhi dovunque – – – negli esseri umani, nelle cose, dentro animali e piante; dà respiro alle proprie creature e le fa parlare: ne diviene il suggeritore. Ma quel che dicono, lo ricolma di stupore, quasi che la sua parola si spiritualizzasse nell'eco. «Nel sogno siamo dèi», diceva a ragione un greco.
© Paolo Melandri (16. 6. 2018)
*
Il corso delle giornate
È tempo di abbozzare il corso delle mie giornate, nella misura pertinente all'argomento. Meglio sarebbe se cominciassi dalla notte, giacché la mia giornata non ne rappresenta che il riflesso. Lo deduco già dal fatto che mi sveglio malvolentieri: ogni giorno sono costretto a rivestire da capo la mia armatura.
La notte è buia, il giorno chiaro. Secondo Bruno, questa luce del giorno non è altro se non oscurità derivata, attenuata e filtrata. Vi sarà qualcosa di vero. Quando chiudo gli occhi, non si fa buio, ma chiaro, come se dai celletti scenici cominciasse a calare una luminosità mentre il sipario si leva. Appaiono fiori che lentamente discendono, ruote variopinte che girano, innumerevoli volti che anelano all'individuazione; e tra essi il mio. Tutto ciò prima che io mi addormenti. Poi, penetro più a fondo.
© Paolo Melandri (16. 6. 2018)
*
Metamorfosi
Oggi ho assistito a questa scena.
Quando, sul finire dell'estate, i carri tornano dalla campagna, carichi di vino, olio e frutta, a casa c'è aria di festa, e io vi prendo parte. Mi metto a sbirciare dalle finestre della mia stanza, come i domestici, ansioso di vedere i buoi che entrano in giardino, di udire il cigolio delle ruote. Oggi gli animali erano particolarmente agitati a causa del frastuono sulla strada che conduce a ovest, gremita di folla. Avevano gli occhi iniettati di sangue, rossi come la tunica dello schiavo Marco, e il vello ricoperto di terriccio. Le ragazze mossero incontro al carro, incuriosite, non solo per tutto quel ben degli dèi che si apprestavano a riporre nella dispensa, ma anche per la presenza di Marco, che nell'ultimo anno si era fatto un bel giovanotto. Aveva la gola troppo riarsa dalla polvere per ricambiare i loro saluti, e allora si precipitò alla fontana, riempì la brocca, bevendo a grandi sorsi, e versò l'acqua sul capo, riemergendo da quell'abluzione con la massa dei riccioli neri grondanti; quindi gettò frettolosamente la caraffa sulle mattonelle che lastricavano il suolo, mandandola in frantumi. A quel gesto Lolla – figlia di una schiava acquistata da mio padre durante un viaggio in Sicilia –, ragazza dal temperamento assai impulsivo, si scagliò contro il giovane, rimbrottandolo aspramente. Lui a sua volta iniziò a inveire, giustificandosi. Gli altri servi erano già tutti indaffarati a sollevare gli orci di vino e olio, insieme ai tini colmi di uva bianca e nera: insomma, c'era un gran tramestio. I buoi cominciarono a muggire e a quel punto, con aria visibilmente impaziente, Lolla afferrò un'altra brocca, la immerse nella vasca e riempì l'abbeveratoio mezzo vuoto. Era compito di Marco accertarsi, appena giunti a destinazione, che gli animali si dissetassero. I buoi abbassarono le grosse teste e si abbeverarono, mentre Lolla, ancora infuriata, si rivolse di nuovo al ragazzo per rimproverarlo. Marco è figlio di un domestico della fattoria, e i due si conoscono sin da piccoli. In alcuni periodi lui ha lavorato nella nostra residenza cittadina, in altri, durante l'estate, lei si è trasferita in campagna. Lolla ha notoriamente un carattere irascibile e, se Marco non fosse stato accaldato e sporco per l'interminabile viaggio compiuto, probabilmente le avrebbe riso in faccia, canzonandola per quella sfuriata. Ma non sono più dei bambini: bastava vederli insieme per capire che il malumore di lei e l'astio di lui non erano dovuti unicamente all'afa di quel pomeriggio.
Marco si avvicinò ai buoi, schivando le grandi corna, e prese ad accudirli. Li liberò del giogo e li condusse all'ombra del maestoso fico, appoggiando le tirelle su un ramo. Per qualche motivo, le cure che il giovane prestava agli animali irritarono ancora di più Lolla. Rimase in piedi a osservare la scena mentre le altre ragazze le sfilavano davanti con le vettovaglie, man mano che venivano scaricate; aveva le gote paonazze e gli occhi lanciavano sguardi accusatori verso Marco. Lui non le badava. Le passò di fronte come se nulla fosse, diretto sotto il portico; tirò fuori un'altra tunica dal suo fagotto e, dopo essersi tolto quella sudicia, si lavò di nuovo e senza nemmeno asciugarsi – con quel caldo non ce n'era bisogno – indossò quella pulita.
Lolla sembrava più calma, appoggiata con la mano alla parete della veranda, in atteggiamento contrito, o comunque remissivo. Lui continuava a ignorarla: se ne stava in piedi, all'estremità del portico, e osservava i buoi, affidati alla sua custodia. «Marco...» lo chiamò lei in tono tranquillo, ma il ragazzo scrollò le spalle, sprezzante. Ormai le ultime giare e le casse di frutta erano state riposte nei magazzini. Erano rimasti soli sulla veranda. «Marco» lo chiamò ancora Lolla, stavolta dolcemente. Lui si voltò a guardarla, con un'espressione che non mi piacque affatto. Sdegnosa, adirata, ben diversa da quell'aria gentile che lei sperava di cogliere. Il giovane andò a chiudere il cancello e si allontanò. Le abitazioni della servitù si trovavano in fondo al giardino. Raccolse il fagotto della sua roba e si incamminò di buon passo verso il luogo in cui avrebbe trascorso la notte. «Marco» supplicò lei, sul punto di scoppiare in lacrime. Il ragazzo stava per entrare nell'edificio riservato agli uomini quando Lolla attraversò il giardino e lo raggiunse: troppo tardi, aveva già varcato la soglia.
Sapevo come sarebbe finita. Lolla avrebbe trovato un pretesto per trattenersi nel cortile; magari si sarebbe messa ad accarezzare i buoi, avrebbe riempito di fichi la mangiatoia, o avrebbe finito di pulire la fontana. Lo avrebbe aspettato. Quella sera Marco aveva voglia di uscire con gli altri ragazzi per andarsi a divertire; non capitava spesso nella nostra residenza di campagna, e nemmeno a Roma. Eppure ero certo che avrebbero passato la notte assieme, benché lui avesse programmi diversi.
Trovo che questo quadretto costituisca un'esemplificazione dei rapporti tra uomini e donne.
© Paolo Melandri (14. 6. 2018)
*
Mezzogiorno di scherno
Dov'era finito il suo Sud? Le rocce di edera? L'eucalipto, dove stava il suo mare? Ponente, costa del tramonto, azzurrargentea l'onda che arriva!
Si precipitò in una bettola; si gettò su bevande, calde, brune. Si distese sulla panca per lasciar pendere più in basso la testa per la forza di gravità e il sangue. Aiuto, gridava, esaltazione!
Sedie, oggetti per signori che vogliono avere un punto di appoggio sotto il sedere e piegare in avanti le ginocchia, si stavano asciugando cupe e nordiche. Tavoli per conversazioni come queste: Be', come va, maliziose e maschili, contornando le cosce, attraversavano rispettabili il tempo. Mai la morte scaraventava la signorina cisposa fino alla soglia del nulla quando l'ora, ogni ora, batteva. Bottegai arraffavano; non c'era lava sulla ghiaia morta!
E lui? Cosa era lui? Sedeva là fra i suoi stimoli, la maramaglia avveniva con lui. Il suo mezzogiorno era scherno.
Di nuovo il cervello si mise a sgorgare, lo stesso corso cupo del primo giorno. Ancora tra le cosce di sua madre – ecco che lui avveniva. A una spinta del padre, lui rotolava giù. – Il vicolo lo aveva distrutto, indietro: la puttana gridò.
Già se ne voleva andare, quando avvenne un suono. Un flauto suonava nel vicolo grigio, tra le capanne una canzone azzurra. Doveva esserci un uomo che passava suonandola. Una bocca era attiva sul suono, che si levava e si perdeva. Ecco, ora ricominciava.
Per caso. Chi lo incitava a suonare? Nessuno lo avrebbe ringraziato. Chi avrebbe chiesto dove era finito il flauto? Ma come nubi avanzava: soffiando il suo bianco attimo e già spirando in tutte le forre dell'azzurro.
© Paolo Melandri (7. 6. 2018)
*
Il servizio alla casbah
I giorni di servizio alla casbah scorrono piuttosto uniformi. Tra un servizio e tempo libero non faccio quasi differenza. L'uno mi è gradito quanto l'altro. Ciò corrisponde al mio principio, secondo il quale non deve esistere tempo vuoto, nessun attimo privo di tensione e di vigilanza interiore. Colui che riesce a trascorrere la vita come un gioco, troverà dolcezza anche nella ortica e nella cicuta: persino seccature e pericoli gli procureranno godimento.
Da dove viene la sensazione di essere sempre in vacanza? Certo dal fatto che la persona intellettiva mette in libertà la parte corporea e ne osserva il gioco. Lungi da ogni gerarchia, essa gode la consonanza tra riposo e moto, tra invulnerabilità e sensibilità elevata – – – a tratti persino creatività. Essa scrive un testo sopra una pagina bianca e domina il destino: il mondo si trasforma attraverso la scrittura. È questa l'unità di danza e melodia.
D'altronde, mi trovo anche costantemente in servizio. Ciò sia detto non soltanto riguardo alla mia partecipazione intellettiva a tutto quanto avviene nella casbah e nel bar notturno, ma anche per le banalità della vita quotidiana, stabilite dalle norme. In sé e per sé non è cosa di gran rilievo: molte professioni obbligano a una disponibilità costante – in primo luogo, se collegate a rischi.
La disponibilità è calcolata in base al fatto che potrebbe accadere qualcosa – – – rappresenta quindi una forma di servizio, durante il quale nulla o assai poco accade. Ciò richiama alla mente le disposizioni per il caso di un incendio o di una catastrofe in alto mare. Un allarme di prova all'inizio del viaggio provvede a far conoscere a ciascuno il proprio compito e la propria scialuppa di salvataggio. Egli deve essere in grado di trovarla come un sonnambulo, quando la sirena lo desta.
Allo stesso modo, nella casbah, ogni trimestre vi è un'esercitazione destinata al caso di torbidi. Si tratta però di poco più che una passeggiata armata – per il resto ho a mia libera disposizione la giornata e abbastanza spesso anche la notte, perché non sempre garba al Condor di recarsi ancora al bar dopo la mensa. Inoltre, non sempre vi ha luogo una seduta prolungata, spesso si tratta soltanto di un caffè turco, una coppa di champagne, un digestivo. È appena il caso di rilevare che a me tornano utili, per contro, proprio quelle notti in cui si beve a lungo e forte.
Talvolta può passare una settimana prima che io mi calchi in testa la barchetta. Una vita di cuccagna dunque – almeno per i più, e per me rinvigorita ancora dal godimento intellettuale.
© Paolo Melandri (7. 6. 2018)
*
Broadways dei caprioli
Per un attimo cercò. Qualcosa di copto era salito, ma non fu capace di trarlo fuori. Alloro cantò di nuovo, molle nella felicità.
Giunge l'inverno e rinverdiscono i campi; cadono alcune foglie del melograno, ma il grano sprizza davanti ai suoi occhi. Cosa vuoi avere: narcisi e violette, durante tutto l'anno, sparsi al mattino nel tuo bagno, quando ti alzi tardi; forse vuoi aggirarti di notte nei piccoli villaggi del Nilo, quando la limpida luna del Sud lascia cadere grandi ombre chiare per strade tortuose? Aranceti, fiammeggianti di giallo, una nube di linfe e di effluvi posata sulla città a mezzogiorno; il fresco scolpito di un tempio tolemaico?
Si fermò. Era l'Egitto? Era l'Africa a cingere un corpo di donna, golfo e liana attorno al flutto delle spalle? Cercava qua e là. Aveva tralasciato qualcosa? C'era qualcosa da aggiungere? Era riuscito a creare: ardore, malinconia e sogno?
Ma quale strano alitare nel suo petto! Un'eccitazione, come se lui stesso fluisse via. Lasciò l'ambulatorio, attraversò la sala verso il parco. Si sentiva attratto verso la terra, verso l'erba tagliata irregolarmente.
Come mi ha spossato, pensò, con che forza! Lo colpì l'idea che il pallore fosse il frutto e la lacrima di dolore –: sovvertimenti! Lontananza spalancata!
Il parco ardeva, sontuoso. Un cespuglio sul prato aveva un fogliame come di felci, ogni lembo grande e carnoso come un capriolo. Attorno a ogni albero in fiore stava chiusa la terra, vaso che lo nutriva e a lui interamente abbandonata. Cielo e fioriture: morbidi, da occhi scendevano azzurro e neve.
© Paolo Melandri (3. 6. 2018)
*
La piazza era deserta come prima
La piazza era deserta come prima; sotto il ponte galleggiava immobile la barca vuota, e Andrea volle scorgere in questo un segno che gli dette coraggio. Andava come in un sogno ma non aveva dubbi, sapeva che avrebbe trovato seduta la donna dolente e, quando fosse entrato, quella avrebbe teso verso di lui le braccia angosciosamente, come supplicando. Poi sarebbe tornato indietro sapendo che dietro le sue spalle l'altra si levava dello stesso inginocchiatoio, per seguirlo. Questo mistero non era per lui niente di passato ma qualche cosa che si ripeteva come in cerchio, e stava solo in lui rientrare nel cerchio perché fosse di nuovo presente.
Entrò nella chiesa, non c'era nessuno. Ritornò sulla piazza, si fermò sopra il ponte, guardò in ogni casa e non trovò nessuno. Si allontanò, percorse alcuni vicoli, ritornò poco dopo nella piazza, entrò nella chiesa per una porta laterale, tornò indietro, passò di nuovo sotto l'arco, ma non trovò nessuno.
© Paolo Melandri (2. 6. 2018)
*
Il mostro di Bendoro
Piaccia al cielo che il lettore, reso ardito e fatto momentaneamente feroce come ciò che legge, trovi, senza disorientarsi, il suo cammino scosceso e selvaggio, attraverso le paludi desolate di queste pagine scure e piene di veleno; poiché, a meno che egli non introduca nella sua lettura una logica rigorosa e una tensione di spirito simile almeno alla sua diffidenza, le emanazioni mortali di questo libro gli imbeveranno l'anima come l'acqua lo zucchero. Non è bene che tutti leggano le pagine che seguono; pochi, soli, assaporeranno questo frutto senza pericolo. Di conseguenza, anima timorata, prima di penetrare oltre in simili lande inesplorate, dirigi i tuoi calcagni indietro, e non in avanti. Ascolta bene ciò che ti dico: dirigi i tuoi calcagni indietro e non in avanti, come gli occhi di un figlio che si sottrae rispettosamente dall'augusta contemplazione del volto materno; o, piuttosto, come l'angolo, a perdita d'occhio, di uno stormo di gru intirizzite e molto pensierose, che, nel corso dell'inverno, voli possentemente attraverso il silenzio, tutte le vele tese, verso un punto determinato dell'orizzonte, da cui, tutt'a un tratto, si alzi un vento strano e forte, precorritore della tempesta. La gru più vecchia, e che da sola forma l'avanguardia, vedendo ciò, scuote la testa come una persona ragionevole, e poi, seguitando, anche il suo becco, che fa schioccare, e non è contenta (io neppure lo sarei al posto suo), mentre il suo vecchio collo, sguernito di piume e coevo di tre generazioni di gru, si muove in ondulazioni irritate, che presagiscono la bufera, che sempre più si avvicina. Dopo aver guardato, a sangue freddo, numerose volte da tutte le parti, con occhi che racchiudono l'esperienza, prudentemente, la prima (poiché è lei che ha il privilegio di mostrare le piume della sua coda alle altre gru, inferiori per intelligenza), con il suo grido vigile di melanconica sentinella, e per respingere il nemico comune, vira con flessibilità la punta della figura geometrica (ed è forse un triangolo, ma non si vede il terzo lato che formano, nello spazio, questi curiosi uccelli migratori), e a babordo e a tribordo, come un provetto capitano; e, manovrando con ali che non paiono più grandi di quelle di un passero, perché non è scema, si mette per un cammino filosofico altro, e più sicuro.
Stabilirò in poche righe come Bendoro fu buono durante i suoi primi anni, in cui visse felice; ecco fatto. In seguito si accorse che era nato cattivo: straordinaria fatalità. Dissimulò il suo carattere finché lo poté, per un gran numero di anni; ma, alla fine, a causa di questa concentrazione, che non gli era naturale, ogni giorno il sangue gli montava alla testa; fino a quando, non potendo più sopportare una vita simile, si gettò risolutamente nella carriera del male, dolce atmosfera. Chi l'avrebbe detto. Quando baciava un bambino, dal viso rosa, avrebbe voluto staccargli le guance con un rasoio, e l'avrebbe fatto molto spesso se Giustizia, col suo lungo corteo di punizioni, non glielo avesse ogni volta impedito. Non era menzognero, confessava la verità e diceva di essere crudele. Umani, avete sentito. E osa ridirlo, con questa penna che trema. Così, dunque, esiste una potenza più forte della volontà. Maledizione. La pietra vuol per caso sottrarsi alle leggi di gravità? Impossibile. Impossibile che il male voglia allearsi al bene. È quel che dicevo più sopra.
© Paolo Melandri (31. 5. 2018)
*
Il rifugio
Scomparire è ancora meglio che tuffarsi sott'acqua: al costume dei ranocchi, preferisco quello dei topi. Non penso, però, a quelli neri e grigi delle case e dei giardini, ma al topo giallo-rosso della foresta tropicale, che somiglia ad un minuscolo scoiattolo. Si nutre di noci, di cui nel primo autunno reca una provvista nel suo nido invernale. Là, dorme ben nascosto per sei mesi o più, mentre le folglie cadono sul terreno boschivo e le ricopre poi la neve.
Io ho preso le mie precauzioni secondo il suo modello. Il moscardino, o topo di nocciole, è parente della marmotta: fin da bambino mi raffiguravo la vita di questo sognatore altamente comoda. Non è un caso che, dopo la morte del padre, io mi sia smarrito in questo mondo protettore. Nella mia solitudine, nel solaio di casa, io mi tramutavo in moscardino. Per anni, esso fu il mio animale totemico.
Mi sono cercato, ai margini della foresta, un posticino per la mia tana. Il foro d'ingresso non dovrebbe trovarsi al livello del suolo, è meglio una fessura nella roccia o dentro un tronco cavo. Di là iniziai a scavare il cunicolo, giorno per giorno, sempre più in fondo, raschiando fuori il terriccio, che poi sparpagliavo perché non ne rimanesse traccia.
Una volta giunto abbastanza in fondo, scavai un secondo cunicolo verso l'alto, come uscita di sicurezza. Per ogni ingresso bisogna provvedere alla sortita, per ogni via pensare al ritorno: questo mi risultava chiaro fin da allora. Il lavoro doveva avvenire in assoluto silenzio e con cautela; dall'alto vi era di giorno la minaccia dello sparviero, e di notte del gufo, al suolo animali ostili, in primo luogo la vipera – il moscardino è sempre minacciato. È il tributo che paga alla sua libertà.
Dopo aver scavato i cunicoli, si passava all'abitazione, una comoda cameretta, non troppo piccina, né troppo grande. Che vi potesse stare anche una femmina, non mi veniva ancora in mente. Nemmeno per la mamma c'era da provvedere: era presente ovunque, era la tana stessa.
Una volta apprestata la cameretta e levigato bene il suo ovale, scavai il cunicolo di approccio alla dispensa. Questo era più grande, con una curvatura a forma di focaccia: con un granaio simile non vi sarebbe stata penuria. Non bisognava dimenticare nemmeno quel certo posticino: il moscardino è celebrato per la sua pulizia. Non ha il sentore degli altri topi, soltanto in primavera emana un profumo di muschio. Il posticino nell'inverno si sarebbe riempito di grani neri: anche in questo, non pensavo solo alla bocca, ma anche allo scarico.
Dopo la costruzione, passai all'arredamento. Per un giaciglio in cui occorreva trascorrere, sognando, l'inverno, le piume più fini erano giusto quel che ci voleva. Conoscevo luoghi ove la scelta era già fatta: i nidi degli scriccioli e dei regoli. Ne andai in cerca, non appena udivo il «si-si-si» dei regoli: è il richiamo quando la covata ha preso il volo. Il moscardino si arrampica cauto fra i rami. Trovai lassù le piume ch'essi si erano strappati, le fibrille che vi avevano trasportato, e me ne presi la mia parte.
Ai margini della foresta, s'inerpica tra le ortiche e le scabiose la cùscuta trifoglina. Essa merita il suo appellativo perché forma cuscini di fili morbidi come seta, che nel primo autunno inaridiscono. Anche di questi feci raccolta: li intrecciai al mio giaciglio e vi aggiunsi rose canine e foglie di biancospino.
Lavoro volentieri: coi piedi trattenevo le fibre, con mani e bocca le intessevo. Vi riuscivo senza fatica, sebbene avvenisse al buio. Quando le materie sono gradevoli al tocco e al movimento, il lavoro può diventare un gioco: il godimento materiale si trasforma in piacere spirituale.
Tale era il mio umore nella tana, e si intensificò al cadere delle prime noci – con un suono che disinguevo fra tutti. Era come un bàttito, un annuncio. Così è la profezia che prediligo. Non vuote promesse, ma fenomeni, una piccola moneta spicciola, materiale. Io sono come Tommaso: mostra le tue piaghe! Allora mi convinco. Presto le noci caddero in gran copia; se il vento passava nel fogliame, era come se grandinasse.
© Paolo Melandri (31. 5. 2018)
*
I giardini di Amilcare
I mercenari punici nei giardini di Amilcare. L'orda ammutinata dei battuti che gozzovigliano sulle terrazze intorno al castello abbandonato del signore in fuga: tremiladuecento talenti euboici per il sangue che abbiamo versato per Cartagine, e le coppe, le coppe della legione sacra, e i pesci di Barca, le anguille primigenie che avevano covato l'uovo mistico in cui si nascondeva la dea –, dov'è Giscone, dov'è il consiglio supremo? Via! Vino, carne, oro! In pezzi i poggiapiedi d'avorio, i vasi tirii di vetro, le anfore della Campania – fuoco negli alberi, i leoni in libertà, guai a Cartagine!
O chi ha letto Plutarco? Chi ha tenuto a mente anche solo tutti gli imperi che uscirono dalla mano del solo Demetrio come acini da un grappolo, finché bastò a un siro o uno scita a gettarli nel tino? Chi aspetta ancora a sbadigliare, chi non si è messo ancora in salvo? Chi ancora non scorge la natura casuistica delle battaglie, il ritmo segreto delle catastrofi e la follia circolare, maniaco-depressiva, della storia delle guerre?
© Paolo Melandri (29. 5. 2018)
*
Narciso
È meriggio al di sopra dell'“Io” o dell'estate, è un silenzio di frutti, su tutti i colli, un silenzio di papaveri. C'è un richiamo, Eco chiama, non è una voce, non una voce di risposta, non felicità, non richiamo.
Ma ci sono campi sopra la terra che nulla producono se non fiori dell'ebbrezza – arrèstati, Narciso, le Moire son morte, con gli uomini parli come col vento –, dal largo del tuo sentire, dal largo del tuo sciabordare, a te è nata la tua immagine liea.
Narciso, Narciso, i boschi tacciono, tacciono i mari intorno all'ombra e all'albero: – tu, terra, nuvole, mare attorno alle tue spalle, grida che chiedono procreazione, Salvini aveva paura di Berlusconi, così dicono, fame nei pugni, per te pezzi da strappare al corpo del mondo, per dar loro forma e trovare oblio profondo in essi, via da tutta la miseria e vergogna della solitudine – e poi: sulle palpebre dell'albero un soffio; poi: un tubare, poi: in mezzo agli asfodeli rimiri te stesso nell'onda stigia.
© Paolo Melandri (20. 5. 2018)
*
La fiaccola della conciliazione
Era una sera dei primi di maggio. Sul Monte di Mosè, nella parte meridionale della città, il piccolo giardino non si era ancora aperto al pubblico, e nessuno ne aveva ancora lavorate le aiuole. Fra i cumuli delle foglie cadute l'anno prima i bucaneve si erano già aperta la via e stavano adesso conchiudendo la loro breve giornata per far largo ai fiori di croco che s'erano intanto rifugiati sotto uno sterile pero. I sambuchi aspettavano per fiorire il vento del sud, mentre i tigli già offrivano, nelle lor gemme ancor chiuse, filtri d'amore ai fringuelli che, tra tronco e ramo, avevano incominciato a costruire i loro nidi a treccia.
Sulla ghiaia dei sentieri non s'era ancora posato alcun piede umano da quando la neve dell'ultimo inverno si era sciolta, e così animali e fiori trascorrevano la loro vita senza affanni. I passeri si davano un gran da fare a racimolar del bottino che poi nascondevano sotto i tegoli della Scuola di Nautica. Trasportavano dei frammenti di cartucce degli ultimi fuochi artificiali, raccattavano fili di paglia fra gli alberelli che, l'anno innanzi, erano usciti dal vivaio di Roseto. Nulla sfuggiva ai loro occhietti! Scovavano minuscoli brandelli di tulle nelle pergole e, tra le schegge di un piede di panchina, riuscivano a trar fuori ciuffetti di peli di cani che s'erano abbuffati là presso nel San Giuseppe dell'anno prima. Era davvero un bel vivere, e anche un bel battagliare!
La parete, in quel punto, veniva aperta da una servetta che aveva giusto tolto le strisce incollate dalla doppia finestra. Un esecrando odore di rifritto, di feccia di birra, di ramaglia di abete e di trucioli ne uscì, e se lo portò via il vento che poi ghermì la cimosa della finestra, tutta cosparsa di pagliuzze, di crespini e di petali di rose e intraprese una danza in tondo verso le vie d'uscita, cui presero parte i passeri e i fringuelli, lieti di veder ormai cancellata ogni loro preoccupazione per la costruzione del nido.
La cuoca intanto continuava il suo lavoro intorno alle doppie vetrate. In pochi minuti venne aperta la porta del tinello verso la veranda e un giovane vestito con semplicità e distinzione uscì nel giardino.
Dal suo volto non traspariva nulla d'insolito, ma nei suoi sguardi si poteva notare una certa preoccupazione, che tuttavia subito scomparve quand'egli, uscito dall'angusta saletta di soggiorno, si trovò faccia a faccia col vasto orizzonte. Si voltò dalla parte del vento, si abbottonò il soprabito e respirò a pieni polmoni alcune volte. Parve che da ciò traessero soltanto sollievo il suo petto e il suo spirito. Poi prese a passeggiare avanti e indietro lungo la barriera che separa il giardino dal pendio scendente in direzione del mare.
© Paolo Melandri (27. 5. 2018)
*
Elena e Fiesco
Le tolse per prima cosa il reggipetto e i seni si drizzarono. Erano due superbe collinette con il capezzolo rosa. Le succhiò per un po', poi slacciò la gonna e gliela tolse, come pure la sottoveste e il resto. Elena restò in camiciola, Fiesco rialzò eccitatissimo la tela bianca che nascondeva i tesori incomparabili di due gambe perfette. Le calze salivano fino a metà coscia, e le cosce erano rotonde come torri d'avorio. Nel bassoventre si celava la grotta misteriosa di un bosco consacrato, fulvo come gli autunni. Il vello era spesso, e le labbra strette del fiore non lasciavano intravvedere che una riga simile ad una tacca mnemonica sui pali che servivano da calendario agli Incas.
Fiesco rispettò lo svenimento di Elena. Le tolse le calze e cominciò a succhiarle le dita dei piedi, che erano graziosi, paffuti come quelli di un bebè. La lingua del principe iniziò dalle dita del piede destro. Leccò coscienziosamente l'unghia dell'alluce poi passò tra le giunture. Si fermò lungamente sul mignolo che era piccolo piccolo. Si accorse che il piede destro sapeva di lampone. La lingua lecchina frugò poi tra le pieghe del piede sinistro nel quale Fiesco trovò un sapore che gli ricordava il prosciutto di Magonza.
In quel momento Elena aprì gli occhi e si mosse. Fiesco sospese i suoi esercizi di lecchinaggio e guardò la graziosa ragazza alta e formosa stirarsi in pandiculazione. La sua bocca aperta per uno sbadiglio mostrò una lingua rossa tra i denti corti ed eburnei. Poi sorrise.
© Paolo Melandri (25. 5. 2018)
*
Il cavaliere sconosciuto
Era primo pomeriggio, il sole raggiava in un cielo senza nubi e una gran quiete estiva si stendeva sopra la campagna, quando il cavaliere giunse al mulino abbandonato.
Non si muoveva un alito di vento, non si udiva un verso d'uccello, solo i grilli cantavano la loro canzone e le api ronzavano: il loro canto suonava come una sommessa musica d'organo. Una vanessa dei cardi brancolava stordita tra la veronica, la cardamine e il tarassaco. In gran lontananza, là dove si trovavano i forni e le ferriere del vescovo, era sospesa sopra le abetaie una nuvola di fumo nero.
Il cavaliere la vide, e una sorda sensazione di disagio e malumore si destò in lui, come se da quella parte lo minacciasse un pericolo. Ma con una crollata di capo egli scacciò questo pensiero ancor prima ch'esso prendesse forma. Poi smontò di sella e legò il suo cavallo a un ceppo di salice, così che potesse muoversi in tondo e pascolare.
La porta della casa del mugnaio era sprangata, dal comignolo non si levava nemmeno un filo di fumo, le gelosie eran serrate. Certo l'antico mugnaio, quell'uomo che una volta, in un'ora buia, lui aveva preso per un fantasma sorto dalla tomba, per una pover'anima del purgatorio, stava percorrendo la strada maestra tra schioccar di frusta e grida di arri arri, per portare al suo padrone, il vescovo, merci d'ogni parte del mondo. Ma se adesso egli dovesse risalir la collina col suo carro – a chi mai farebbe paura?
Il cavaliere si sedette nell'erba alta della proda e stese le gambe. Col dorso appoggiato sul muretto del pozzo a carrucola, rimase lì a sognare a occhi semiaperti.
Gli ritornò in mente il giorno in cui, povero e infelice e mezzo intirizzito, era salito al mulino in mezzo alla neve alta quanto un uomo, e come poi si era guadagnato l'arcanum, quello era stato l'inizio della sua fortuna. Doveva all'arcanum se ora poteva stare al mondo da signore, con le piume sul cappello e in tasca danari e lettere di cambio, e se poteva figurare e pavoneggiarsi al pari d'uno nobile di famiglia. Quanto al mugnaio morto, venisse pure, adesso, con quella sua bocca storta: il purgatorio non era una cosa reale, ma un'invenzione, esisteva solo nella testa dei preti biascicamesse, il purgatorio – glielo aveva detto il Brabantino, e quello era uno che aveva girato il mondo intero, era stato ovunque si frigga il lardo sopra i carboni accesi. Ma che cos'era quel mugghiare tutt'intorno a lui, un chiasso come se Venezia fosse caduta in mano al Gran Turco, che cosa vuole quella gente, che cosa grida? Il baccano proviene da ogni lato, da lontano e da vicino, son voci profonde e voci stridule, e tutte gridano la stessa cosa, sempre la stessa cosa: «Accorrete! Accorrete!».
Il cavaliere si riscosse di soprassalto. Che gente era mai quella, che cosa voleva? Si guardò attorno: non si vedeva anima viva, solo il suo cavallo che accanto a lui strappava da terra ciuffi d'erba; e non un suono s'udiva, né invocazioni né grida, solo le api che ronzavano tutt'intorno a lui.
© Paolo Melandri (23. 5. 2018)
*
La vita delle api
La prima volta che si apre un alveare, si avverte un po' dell'emozione che si proverebbe nel violare qualche cosa di sconosciuto dove possono celarsi spaventose sorprese: una tomba, per esempio. Vi è, intorno alle api, una leggenda di minacce e di pericoli. Vi è il ricordo irritante di quelle punture che provocano un dolore così particolare che non si sa a che cosa paragonarlo: si direbbe un'aridità folgorante, una specie di fiamma del deserto che si spande nella regione lesa; come se le nostre figlie del sole avessero estratto dai raggi irritati del padre loro un veleno prodigioso, per difendere più efficacemente i tesori di dolcezza che esse traggono dalle sue ore benefiche.
È vero che, aperto senza precauzioni da chi non conosce né rispetta il carattere e i costumi dei suoi abitanti, l'alveare si trasforma istantaneamente in un roveto ardente di collera e di eroismo. Ma si fa presto ad acquistare la piccola abilità che occorre per maneggiarlo impunemente. Basta un po' di fumo proiettato nel momento giusto, molto sangue freddo, molta dolcezza, e le operaie bene armate si lasciano allora spogliare, senza pensare a sfoderare il pungiglione. Non che riconoscano il loro padrone, come qualcuno ha sostenuto; non temono l'uomo, ma l'odore del fumo, i movimenti lenti che attraversano la loro casa senza minacciarle, fanno loro immaginare che non si tratti di un attacco o di un gran nemico contro il quale sia possibile difendersi, bensì di una forza o di una catastrofe naturale alla quale si debba sottomettersi. Invece di lottare invano, e piene di una previdenza che sbaglia perché guarda troppo lontano, esse vogliono almeno salvare l'avvenire e si gettano sulle riserve di miele per attingervi e nascondere in loro stesse di che fondare altrove, – non importa dove, e subito, – una nuova città, se la vecchia sia distrutta o se esse siano costrette ad abbandonarla.
© Paolo Melandri (22. 5. 2018)
*
I figli dei vicini
Due famiglie importanti, che abitavano vicine, avevano rispettivamente un figlio e una figlia, in età tale da poter diventare un giorno marito e moglie. In questa piacevole prospettiva si lasciò che i ragazzi crescessero insieme, e i genitori di entrambi si rallegravano all'idea della futura unione. Ci si accorse ben presto però che quel progetto minacciava di andare in fumo, in quanto tra i due caratteri, entrambi eccellenti, era nata una strana antipatia. Forse erano troppo simili: entrambi introversi, pienamente consapevoli di quello che volevano, saldi nei loro propositi; ciascuno dei due amato e rispettato dai compagni di giochi; sempre rivali quando erano insieme, sempre pronti a costruire per sé soltanto e a danneggiarsi a vicenda quando si incontravano, mai in gara per uno stesso fine, ma sempre in lotta per uno stesso scopo; buoni ed amabili con tutti, ma pieni d'odio, addirittura malvagi l'uno verso l'altro.
Questo strano atteggiamento, manifestatosi già nei giochi infantili, venne accentuandosi con il passare degli anni. Si sa che i ragazzi amano giocare alla guerra, dividersi in partiti e darsi battaglia: fu così che un giorno la fanciulla, fiera e coraggiosa, si mise alla testa di uno dei due eserciti e combatté con tale violenza e un tale accanimento, che l'esercito nemico sarebbe stato ignominiosamente costretto alla fuga se l'altro giovane, suo diretto avversario, non avesse valorosamente resitito, riuscendo infine a disarmare la sua rivale e a prenderla prigioniera. Ma anche allora lei si difese con tanta violenza che l'altro, per ripararsi gli occhi, senza però far del male alla nemica, fu costretto a strapparsi dal collo la propria sciarpa di seta, della quale si servì per legarle le mani dietro la schiena.
La fanciulla non glielo perdonò più, anzi, in segreto tentò in tutti i modi di fargli del male, al punto che i genitori, i quali già da tempo si erano accorti di questi strani sentimenti, decisero di comune accordo di separare i due nemici e di rinunciare a quelle care speranze.
Nel nuovo ambiente il ragazzo si distinse presto. Riusciva bene in ogni materia di studio. I suoi tutori e la sua personale inclinazione lo indirizzavano alla carriera militare. Ovunque si trovasse, era amato e rispettato. Pareva che la sua ottima indole promuovesse solo il bene e la soddisfazione altrui; e in cuor suo, pur senza averne piena coscienza, era ben contento di essersi liberato dell'unico avversario che la natura gli aveva destinato.
La ragazza invece subì un'improvvisa trasformazione. L'età, il raffinarsi dell'educazione e, più ancora, una certa sensibilità interiore la distolsero dai giochi violenti, cui fino ad allora era solita attendere in compagnia dei maschi. Nel complesso sembrava però che le mancasse qualcosa: intorno a lei non c'era nulla che meritasse il suo odio; e degno di amore non aveva ancora trovato nessuno.
© Paolo Melandri (20. 5. 2018)
*
Fernova
La malinconia, come avevo previsto, mi colse già in viaggio, sul treno che dalla città ci portava a Fernova, la nostra proprietà di campagna. Pioveva ininterrottamente, una pioggia sottile, che cadeva di traverso e sembrava voler smorzare l'estate. Nello scompartimento eravamo soli, mio padre ed io. Mio padre non parlava, sembrava ignorarmi. Teneva la testa leggermente appoggiata allo schienale, con gli occhi chiusi come se stesse dormendo. Di tanto in tanto alzava le palpebre pesanti, dalle lunghe ciglia ricurve, e mi fissava; ma subito inarcava le sopracciglia, cosa che in lui era segno di disprezzo. Io gli ero seduto di fronte, con le gambe allungate, e giocherellavo con la nappa della tendina. Mi sentivo piccolo piccolo e molto infelice. Per non so quale intrigo dei miei insegnanti ero stato bocciato all'esame di maturità. Era un bel guaio, a quasi diciotto anni. Ora mi si rimproverava di non avere studiato, e così, invece di trascorrere una bella vacanza al mare con la mamma e i miei fratelli, mi toccava andare a Fernova e starmene lì con mio padre per rimediare al malfatto, mentre lui verificava i conti e sorvegliava il raccolto. Non poter andare al mare con gli altri era duro; una vacanza buttata al vento. Ma ancora peggio era dover passare tutta l'estate a tu per tu con mio padre. Noi figli, nei suoi confronti, provavamo sempre un senso di disagio. Quando tornava, tutta la casa prendeva un altro aspetto. Sulla nostra vita calava un'atmosfera eccitata e solenne, come se fossimo ospiti. Per andare a tavola dovevamo vestirci con più cura, il pranzo era migliore del solito, i servitori più nervosi. Nelle stanze si spandevano l'aroma di sigarette egiziane e un forte profumo inglese. Le guance della mamma, solitamente così pallide, si coprivano di chiazze rosse. A tavola si parlava di cose lontane e sconosciute, risuonavano nomi di luoghi come Obermustafa e di famiglie come i Pallavicini. Per non farsi capire dalla servitù si usava molto il francese. Quando mio padre puntava su uno di noi i suoi occhi grigioazzurri, si diffondeva un senso di disagio. Sentivamo di non piacergli. D'abitudine distoglieva subito lo sguardo, inarcava le sopracciglia e diceva alla mamma: «Mais c'est impossible, comme il mange, ce garçon!». La mamma allora arrossiva per noi. E ora dovevo passare tutta l'estate da solo con questo signore sconosciuto, sedere da solo a tavola di fronte a lui, giorno dopo giorno! Difficile immaginare una situazione meno gradevole.
Mi misi a osservare mio padre. Era un bell'uomo, solo adesso me ne rendevo conto. Il viso aveva tratti regolari, netti e precisi. Le labbra, sotto i baffi, erano sottili e molto rosse. Sulla fronte, tra le sopracciglia, si disegnavano tre piccole rughe verticali, come incise da un coltello. I capelli, lucenti e ondulati, si ingrigivano un poco soltanto sulle tempie. E poi le mani, bianche e fini come quelle di una donna. Al polso gli tintinnava leggermente un braccialetto d'oro. Tutto bello; ma, mio Dio, com'era scostante! Mi passò la voglia di guardarlo. Chiusi gli occhi. Nemmeno un piccolo barlume di gioia, dunque, per tutta l'estate? C'erano le cugine di Verona, a neppure mezz'ora di distanza. Là si poteva respirare un po' d'aria di vacanze. A Verona era tutto così carezzevole e grazioso. La zia sulla sua couchette, con la sua vestaglia di velluto e la sua emicrania. E poi le ragazze. Ellita aveva qualche anno più di me ed era troppo altezzosa perché uno della mia età se ne potesse innamorare. Ma a volte, quando mi fissava con quei dolci occhi a mandorla, mi sentivo avvampare. In quei momenti provavo una strana sensazione, come se dovesse succedere qualcosa d'importante. Gerda aveva la mia età, e di lei ero innamorato – da non so quanto tempo. Ogni volta che pensavo alle sue trecce lucenti, al suo viso sottile, così delicato che gli occhi azzurri vi risaltavano scuri e quasi prepotenti, ogni volta che avevo davanti a me quella visione di azzurro, di rosa e d'oro, una strana specie di delizioso dolore si destava in fondo al cuore. Non potei trattenere un lungo sospiro.
© Paolo Melandri (18. 5. 2018)
*
Il soffiatore di vetro
Lì il mondo con la sua dissoluzione intellettuale e qui l'io con il suo fallimento storico. E poi la dottrina planetaria e l'alta estetica del soffiatore di vetro: il fluido incandescente e poi il colpo sul cannello, un respiro – e poi le fragili pareti, avvolte solo da una trama d'ombra e luce. Forse che tutto non è altro che suono su cui, giocando, andiamo in cerca di dèi? – giungeva la voce di un altro, di uno di quei grandi odierni su cui valeva la pena di gettare uno sguardo retrospettivo e la cui opera ci consentiva di credere che non tutti i destini hanno fine. Tu ti ritrai fra le ombre, ma qualcosa di te rimarrà ancora. E se anche nel tuo caso non si tratta di altro che di vasi e di vetri che il tuo soffio distacca, non dei profondi rilievi e delle fughe di figure, se anche nel tuo caso si tratta solo di pezzi minori, pure soffermati anche tu nel paese in cui ti traggono i tuoi sogni e in cui tu esisti per portare a perfezione, in silenzio, le cose che ti sono state affidate.
© Paolo Melandri (17. 5. 2018)
*
In un cervello
Un impulso verso la perfezione che porta al dolore; presagi, mai certezza. Se ci si rassegnasse al fatto che non ci si può saziare, che si ha sete, che le mani non sono sterilizzate anche se uno se le lava, che gli stati d'animo non si spengono su un accordo armonioso, che i sogni sprofondano senza realizzarsi, che l'amore si trasforma e la trasformazione non ha fine, fino all'oblio – se si insegnasse tutto ciò, questa seconda legge della termodinamica esistenziale, quest'apologia della decadenza, questi universali dell'anima – se piegassimo il capo, levato insensatamente verso l'alto –, allora questa dottrina ci sottrarrebbe al disfacimento – era questo che intendeva quello scrittore quando sosteneva che i pochi possono salvare il mondo?
© Paolo Melandri (17. 5. 2018)
*
Complesso del porto
Sopra le rocce cresce la luce, già si profilano ombre, rilucono ville e lo sfondo è carico di monti. Un pennacchio di fumo nero oscura il molo, mentre il minuscolo battello lotta con l'onda increspata. Sopra il pontile che oscilla si affretta il facchino indaffarato: hojo – tira – hoy, si sente; scorre nella piena il flusso della vita. Verso regioni tropicali e subtropicali, miniere di sale e fiumi di loto, carovane berbere, anzi verso gli antipodi stessi è puntato il ventre della nave; una pianura orlata di mimose scarica resina rossastra, un pendio tra marne calcaree l'argilla grassa. Europa, Asia, Africa: morsi, effetti mortali, vipere dal corno; il bordello accoglie sulla banchina il nuovo venuto, silenziosa nel deserto sta ritta la folaga.
© Paolo Melandri (17. 5. 2018)
*
Il prato azzurro
Era un posto stretto e io ero solo. Su un lato, oltre un margine di verde ondeggiante, c'era il mare azzurro, luminoso e mosso da cui si alzavano effluvi che mi intossicavano. I vapori, anzi, erano così abbondanti da darmi la strana impressione che il mare si fondesse con il cielo, perché anch'esso era azzurro e luminoso. Sull'altro lato era la foresta, antica quasi come il mare ed estesa all'infinito verso la terraferma. Era molto buio perché gli alberi erano grandi, rigogliosi fino al grottesco e numerosissimi. I tronchi giganti erano di un verde orribile che si fondeva in modo bizzarro con il tratto verde e angusto in cui mi trovavo. A una certa distanza, su entrambi i lati, la strana foresta raggiungeva l'orlo del mare, cancellava la spiaggia e circondava completamente il tratto angusto. Osservai che alcuni alberi si trovavano effettivamente nell'acqua, come incuranti di qualsiasi barriera che si frapponesse alla loro avanzata.
Non si vedevano esseri viventi e non c'era segno che fossero mai esistiti, tranne me stesso. Mare, cielo e foresta mi circondavano, estendendosi verso regioni che non potevo nemmeno immaginare. Il silenzio era completo, fatta eccezione per la vegetazione agitata dal vento e dal mare.
Me ne stavo in quel luogo silenzioso quando all'improvviso cominciai a tremare; sebbene non riuscissi a ricordare come c'ero arrivato e conoscessi a stento il mio nome e rango, mi resi conto che se avessi scoperto ciò che si nascondeva intorno a me sarei impazzito. Ricordai cose che avevo studiato, cose che avevo sognato, cose che avevo immaginato e desiderato in un'altra e remota esistenza. Pensai alle lunghe notti in cui avevo guardato le stelle maledicendo gli dèi perché la mia anima libera non poteva attraversare gli spazi inaccessibili al mio corpo. Riesumai antiche blasfemità, studi terribili che avevo effettuato nei papiri di Democrito, ma quando i ricordi affioravano la paura mi attanagliava in modo anche peggiore perché sapevo di essere solo, orribilmente solo. Solo, eppure vicino a forze senzienti di un genere vago e vasto; forze che pregavo di non comprendere e non incontrare mai. Nella voce dei rami che stormivano mi pareva di individuare una sorta di odio malefico, di trionfo demoniaco. A volte sembrava che conversassero con esseri mostruosi e inconcepibili che i corpi azzurri e scagliosi degli alberi nascondevano quasi (nascondevano alla vista, non alla coscienza). La più opprimente delle sensazioni era una sinistra consapevolezza della mia estraneità. Benché vedessi intorno a me una serie di oggetti che potevo nominare – alberi, erba, mare, cielo – sentivo che il loro rapporto con me non era lo stesso degli alberi, erba, mare e cielo che conoscevo da un'altra esistenza e che ricordavo vagamente. Non sapevo precisare la natura della differenza, ma nel provarla tremai di paura.
© Paolo Melandri (9. 5. 2018)
*
Il giardino sotto la luna
Detesto la luna, ne ho paura: anche quando brilla su oggetti familiari e amati, a volte li rende paurosi e irriconoscibili.
Era un'estate spettrale, la luna brillava sul vecchio giardino in cui vagabondavo; era un'estate di fiori narcotici e multicolori. Camminando lungo un basso torrente vidi bizzarre increspature tinte di giallo, come se quelle placide acque venissero risucchiate da correnti irresistibili verso oceani che non sono di questo mondo. Silenziose e scintillanti, malefiche e inargentate, le acque maledette della luna precipitavano non so dove, mentre, lungo le rive in ombra, bianchi petali di loto fluttuavano nel vento oppiaceo della notte e cadevano disperati nel torrente. Giravano, come impazziti, sotto il ponte ricurvo e scolpito, e guardavano verso di me con la sinistra rassegnazione di facce calme e morte.
Io me ne andavo per la riva, calpestando fiori addormentati con il piede incauto, ossessionato dalla paura dell'ignoto e dal richiamo delle facce morte, quando mi accorsi che il giardino sotto la luna non aveva fine: dove di giorno c'erano le mura ora si stendevano nuove visioni di alberi e sentieri, fiori e cespugli, idoli di pietra e pagode, e sotto la luce argentea il fiume curvava all'infinito, tra l'erba delle sponde e grotteschi ponti di marmo. Le morte facce di loto sussurravano tristezze, invitandomi a seguirle, e non arrestai i miei passi fino a quando il torrente diventò un fiume e tra paludi di canne ondeggianti e spiagge di sabbia lucente sfociò nella riva di un mare vasto e senza nome.
Sul mare brillava l'orribile luna; misteriosi profumi aleggiavano su onde mute. Le facce di loto scomparvero, desiderai avere una rete per catturarle e imparare i segreti che la luna aveva impartito alla notte. Ma quando la luna scese ad ovest e la marea si ritirò dalla riva addormentata, vidi anche guglie svelate dalle onde e bianche colonne festonate di alghe. Sapevo che in quel luogo inabissato si erano dati convegno tutti i morti e tremai, perché non volevo parlare più con le facce di loto.
Ma quando, da lontano, un nero condor scese dal cielo per riposarsi sulla grande scogliera, mi venne il desiderio di interrogarlo e di chiedergli notizia di quelli che avevo conosciuto da vivi. Questo gli avrei chiesto, ma era troppo lontano e nel momento che si posò sulla scogliera non riuscii più a vederlo.
© Paolo Melandri (6. 5. 2018)
*
Il calore in aumento
L'uomo giaceva sulla sommità erosa della parete di roccia e guardava a valle, in lontananza. Così disteso poteva vedere a gran distanza, ma nel panorama avvizzito non c'era nulla che si muovesse. Niente agitava la pianura sabbiosa, rena disintegrata di fiumi da molto tempo asciutti nel cui solco, un tempo, erano corse le acque della giovane terra. C'era ben poco verde in quel mondo arrivato alla fine, ultimo stadio della lunga presenza umana sul pianeta. Per innumerevoli cicli siccità e tempeste di sabbia avevano sconvolto le terre. Alberi e piante avevano ceduto il posto a piccoli arbusti contorti che erano riusciti a durare grazie alla loro resistenza; poi anch'essi erano periti davanti a una marea assassina di erbe selvatiche e vegetazione elastica, robusta, dall'evoluzione misteriosa.
Il calore in aumento, man mano che la Terra si avvicinava al sole, essicava e uccideva tutto con raggi spietati. Non era stato un cambiamento improvviso: secoli e secoli erano passati prima che si potesse avvertire la differenza. E in quelle prime età l'adattabile forma dell'uomo aveva seguito la lenta mutazione e si era plasmata in modo da resistere al surriscaldamento dell'atmosfera. Poi era venuto il giorno in cui gli uomini non avevano più potuto sopportare le città roventi, salvo che con grande malessere, ed era cominciato un esodo graduale, lento ma costante. Città e centri abitati vicini all'equatore, naturalmente, erano stati i primi ad essere lasciati, ma poi erano venute le altre. L'uomo, piegato ed esausto, non era più in grado di lottare con il calore che aumentava spietato. Ormai lo aveva ferito mortalmente, e l'evoluzione era troppo lenta per modellare il suo corpo e aiutarlo a resistere.
Ma le grandi città dell'equatore non vennero subito abbandonate al ragno e allo scorpione. Nei primi anni molti rimasero dove erano, inventando bizzarri scudi e tute protettive contro il caldo e la terribile secchezza dell'aria. Questi impavidi schermarono alcuni edifici contro il sole che bruciava ogni cosa e realizzarono rifugi che erano veri e propri mondi in miniatura, dove le tute protettive non erano necessarie. Inventarono soluzioni meravigliose e per un pezzo gli uomini resistettero nelle torri arrugginite, sperando di poter sopravvivere nelle antiche terre fino a quando il fuoco non si fosse estinto. Perché molti non credevano a quello che dicevano gli astronomi e aspettavano che il mondo più dolce di una volta riprendesse il sopravvento. Ma quando un gruppo di esploratori raggiunse la millenaria città di torri unite da ponti, trovò solo il silenzio. Non c'era nemmeno l'orrore della corruzione, perché i rettili che si nutrivano di carogne erano stati veloci.
© Paolo Melandri (3. 5. 2018)
*
Fortunato
Avevo sopportato come meglio potevo le mille offese di Fortunato; ma la volta che lui si lasciò andare ad insultarmi, giurai vendetta. Voi, che conoscete a fondo la natura della mia anima, non supporrete certo che gli abbia fatto qualche minaccia. Alla fine, avrei avuto vendetta: questo era un punto definitivamente fermo; ma lo stesso carattere definitivo della mia risoluzione escludeva ogni idea di rischio. Non soltanto dovevo punire, bisognava anche che punissi impunemente. Non si rimedia un torto se il castigo viene poi a ricadere su colui stesso che castiga. Così pure se il vendicatore manca di farsi conoscere da chi commise il torto.
Bisogna tenere per inteso che io, né con qualche parola né per qualche fatto, avevo dato a Fortunato ragione di dubitare della mia benevolenza. Secondo la mia abitudine continuai a sorridergli sulla faccia, e lui non indovinò che sorridevo, adesso, per il pensiero di immolarlo.
Aveva un punto debole – questo Fortunato – sebbene sotto ogni altro riguardo fosse un uomo da rispettarsi e anche – forse soprattutto – da temersi. Egli si vantava di essere un intenditore di vini. Ma di italiani che abbiano veramente la virtù dell'intenditore ce ne sono ben pochi. Per la maggior parte il loro entusiasmo è tagliato su misura in ragione del tempo e dell'occasione; tanto quanto basta a infinocchiare i milionari inglesi e russi. Così in materia di quadri e di gioielli Fortunato, come i suoi compatrioti, era un ciarlatano; ma a proposito di vini era invece sincero. In questo io non ero da meno di lui; la sapevo lunga in fatto di prodotti italiani, e ne acquistavo largamente tutte le volte che potevo.
Una sera, sull'imbrunire, proprio nei giorni che più infuriava il carnevale, incontrai il mio amico. Egli mi si avvicinò con eccessiva cordialità. Doveva aver bevuto parecchio. Ed era mascherato. Indossava un vestito aderente, a colori contrapposti, e portava in testa un cappello conico adorno di sonagli. Fui così felice di vederlo che non avrei più finito, ritengo, di storcergli la mano.
© Paolo Melandri (2. 5. 2018)
*
La scatolina
Fui introdotto nella stanza in soffitta di un uomo dall'aspetto serio e intelligente che indossava abiti poco vistosi e portava una barba grigio-ferro; costui mi parlò nei seguenti termini: “Sì, lui visse qui, ma le consiglio di non fare niente. La sua curiosità la espone a dei rischi. Non ci veniamo mai di notte, e in ciò rispettiamo la sua volontà. Lei sa cosa fece: alla fine l'abominevole congrega prese il sopravvento e non sappiamo nemmeno dove sia sepolto. Non c'è stato verso, per la legge o per altre forze, di mettersi in contatto con la congrega. Spero che non vorrà rimanere dopo il buio, e la prego di lasciar perdere l'oggetto sul tavolo… sì, quello che sembra una scatola di fiammiferi. Non sappiamo che cos'è, ma sospettiamo che abbia a che fare con le sue attività. Evitiamo persino di guardarlo troppo”.
Dopo un po' l'uomo mi lasciò solo nella soffitta. Era polverosa e squallida, ed ammobiliata in modo primitivo, ma nelle cose c'era un ordine che non faceva pensare all'appartamento di un povero diavolo. C'erano scaffali pieni di libri classici e di teologia, un altro conteneva trattati sulla magia di Paracelso, Alberto Magno, Tritemio, Ermete Trismegisto, Borello e altri testi in alfabeti che non ero in grado di decifrare. La mobilia era molto semplice. C'era una porta, ma dava in un armadio. L'unica via d'uscita era costituita dall'apertura nel pavimento da cui scendeva una scala rozza e ripida. Le finestre erano di tipo rotondo e le travi di quercia annerite parlavano di una incredibile antichità. Era una casa mediterranea, non c'è dubbio: mi pareva di sapere dove mi trovassi, ma non riesco a ricordare le informazioni di cui ero in possesso allora. Certo la città non era Roma, o Napoli, o Palermo. La mia impressione è che fosse un piccolo porto sul mare.
L'oggettino sul tavolo mi affascinava profondamente. Sembrava che sapessi come usarlo, perché tirai fuori una torcia tascabile (o qualcosa che le assomigliava) e la provai nervosamente. La luce non era bianca ma violetta, e più che luce vera e propria sembrava una specie di bombardamento radioattivo. Ricordo di non averla considerata una torcia normale, anche perché in un'altra tasca avevo una pila comune.
© Paolo Melandri (1. 5. 2018)
*
Il libro
I miei ricordi sono molto confusi. Dubito persino dove comincino, perché a volte ho la sensazione che alle mie spalle si snodi una processione di anni mostruosa, mentre, in altre occasioni, mi sembra che il presente sia un punto isolato in una grigia e informe infinità. Non sono neppure sicuro del modo in cui sto comunicando questo messaggio. Sono cosciente del fatto che sto parlando, ma ho la vaga impressione che per sopportare il carico delle mie parole e farle giungere dove voglio, sia necessaria una strana e forse tremenda mediazione. Anche la mia identità è incerta in modo sorprendente. A quanto pare ho sofferto uno shock violento, forse la mostruosa conseguenza di uno dei miei cicli di esperienze incredibili e straordinarie.
Esperienze che, naturalmente, hanno tutte origine in quel libro divorato dai parassiti. Ricordo quando lo trovai, in un posto fiocamente illuminato presso il fiume nero e oleoso dove sempre turbina la nebbia. Era un luogo molto antico, e gli scaffali pieni di volumi incartapecoriti che arrivavano fino al soffitto si succedevano all'infinito in una sequenza di alcove e stanze interne senza finestre. Inoltre, sul pavimento e in certi rozzi contenitori c'erano informi mucchi di libri: proprio in uno di quei mucchi trovai il mio. Non ne ho mai conosciuto il titolo, perché mancavano le prime pagine, ma cadendo si aprì verso la fine e mi permise di dare un'occhiata a qualcosa che fece vacillare i miei sensi. Era una formula, o meglio un elenco di cose da dire e da fare, che riconobbi come sacrilega e proibita; qualcosa di cui avevo già letto in passato nelle pagine furtive e colme di orrore, misto a fascinazione, di alcuni dei misteriosi e antichi esploratori dei segreti meglio custoditi dell'universo, nei cui tomi sgretolati amavo sprofondarmi. Era una chiave, una guida verso determinate porte e determinate transizioni di cui gli occultisti hanno sognato e sussurrato fin dagli albori della specie, e che avrebbero permesso di giungere all'affrancamento dalle tre dimensioni della vita e della materia che noi conosciamo, scoprendo realtà oltre di esse. Da secoli nessun uomo ricordava più il segreto essenziale di quel processo né sapeva dove trovare il libro, che era molto antico. Non era stampato, ma ricopiato a mano da un monaco semi-impazzito che aveva trascritto diligentemente e con esattezza puntuale le sinistre formule in latino in un corsivo di spaventosa antichità.
© Paolo Melandri (30. 4. 2018)
*
Vortici di luce
Quando il mondo invecchiò e lo stupore abbandonò le menti degli uomini; quando grigie città alzarono al cielo torri cupe e spaventose all'ombra delle quali nessuno poteva sognare il sole o i prati di primavera; quando la sapienza rubò alla terra il mantello della sua bellezza e i poeti non cantarono più, se non di fantasmi contorti e dagli occhi ciechi che guardavano solo dentro se stessi, quando avvennero queste cose e le speranze della fanciullezza si furono dissipate per sempre, un uomo fece un viaggio oltre la vita e compì una ricerca negli spazi da cui i sogni del mondo erano fuggiti.
Poco si sa del nome e della famiglia di quest'uomo, perché appartenevano solo al mondo della veglia, ma si dice che fossero entrambi oscuri. Sia sufficiente sapere che viveva in una città dalle alte mura dove regnava uno sterile e perenne crepuscolo, e che lavorava tutto il giorno fra le ombre e il frastuono, per tornare a casa la sera e chiudersi in una stanza le cui finestre non davano su prati e campi, ma su un tetro cortile dove altre finestre dividevano la sua disperazione. Dall'appartamento non si vedevano che mura e finestre di altri palazzoni, a meno di non sporgersi pericolosamente per cogliere qualche stella di passaggio. E siccome un panorama di infinite mura e finestre rende pazzo chi sogna o legge molto, l'inquilino della stanza si sporgeva ogni sera a guardare il cielo, per afferrare un frammento delle cose che stanno oltre il mondo e il folle grigiore dei grattacieli. Dopo alcuni anni imparò a chiamare per nome le stelle che passavano su di lui e a seguirle con la fantasia quando scomparivano dalla vista; finché, alla fine, la visione si estese e fu in grado di percepire cose che l'occhio comune non sospetta. E una notte il grande abisso fu superato, i cieli stregati dai sogni premettero alla finestra dell'osservatore solitario e si mescolarono con l'aria della stanza, facendo di lui una parte del meraviglioso.
Scesero nella stanza rivoli di luce purpurea a mezzanotte, misti a polvere d'oro: vortici di fuoco e luce che filtravano dagli ultimi spazi e portavano profumi al di là dei mondi. Mari oppiacei si riversarono dalle finistre, illuminati da soli che l'occhio umano non vedrà mai e che portavano nell'abbraccio delle onde strani delfini e ninfe di immemorabili profondità. L'infinito si stese silenzioso intorno al sognatore e lo portò via senza nemmeno sfiorare il corpo che penzolava, tutto irrigidito, dalla finestra solitaria; e in un tempo che il calendario degli uomini non sa contare le maree dell'infinito spinsero il visionario verso sogni che desiderava, quelli che gli uomini hanno perduto. E per molti cicli lo lasciarono a dormire teneramente su una spiaggia verde illuminata dal sole; una spiaggia verde che profumava di fiori di loto ed era punteggiata di fiori rossi.
© Paolo Melandri (29. 4. 2018)
*
La città
Dalla finestra settentrionale della mia camera brilla di luce arcana la Stella Polare. Brilla nelle lunghe ore d'incubo della notte, e in autunno, quando il vento del nord soffia minaccioso e gli alberi dalle foglie rosse accanto alla palude sussurrano sotto una falce di luna fino alle ore piccole, io siedo accanto alla finestra e fisso la stella. Con il passare delle ore la splendida Cassiopea si abbassa nel cielo, mentre il Gran Carro si alza dietro gli alberi ammantati di vapori che non smettono di agitarsi nel vento della notte. Poco prima dell'alba Arturo ammicca rossastra sul cimitero che sovrasta la collina e la Chioma di Berenice si accende fantastica, sognante, in lontananza, verso il misterioso oriente. Ma la Stella Polare ghigna sempre dallo stesso punto della volta nera, sinistra come un occhio folle che guardi in continuazione e tenti di trasmettere uno strano messaggio, senza riuscire a ricordare quale: sa soltanto che un tempo il messaggio c'era. A volte, quando il cielo è coperto, riesco a riposare.
Ricordo benissimo la notte della grande aurora, quando sulla palude giocavano i riflessi inquietanti della luce demoniaca: per fortuna dopo i bagliori vennero le nuvole e io mi addormentai.
Fu sotto una falce di luna bianca che vidi per la prima volta la città. Sorgeva, immobile e sonnolenta, su un misterioso altopiano in mezzo a una depressione circondata da montagne fantastiche. Mura, torri, pilastri, cupole e strade erano di marmo sepolcrale, e dalle strade si alzavano colonne che in cima avevano scolpite le immagini di uomini severi e barbuti. L'aria era calda e immobile e nel cielo, a dieci gradi scarsi dallo zenit, brillava l'occhio della Stella Polare. Guardai a lungo la città, ma il giorno non spuntava: e quando la rossa Cassiopea, che brillava nel cielo senza tramontare, ebbe percorso un quarto dell'orizzonte, mi accorsi che nelle strade e nelle case c'erano luce e movimento. Individui stranamente vestiti, ma di aspetto nobile e familiare, camminavano all'aperto e sotto la falce di luna discutevano la loro scienza in una lingua che io capivo, pur essendo diversa da tutte quelle che avevo conosciuto. E quando la rossa Cassiopea ebbe percorso più di metà dell'orizzonte, ci furono di nuovo oscurità e silenzio.
© Paolo Melandri (29. 4. 2018)
*
Una vecchia casa
Avevo dato per scontato – io stesso non so perché – che la casa fosse abbandonata, ma all'avvicinarmi non ne fui più tanto sicuro: i viottoli erano coperti di vegetazione, ma conservavano una traccia troppo evidente della loro funzione per far supporre che non venissero mai usati. Per questa ragione, e in preda a una trepidazione che posso a stento spiegare, bussai anziché tentare la porta. Mentre aspettavo sul rettangolo di pietra che fungeva da soglia, esaminai le finestre della lunetta sopra di me e vidi che, per quanto fossero vecchi, tremanti e opachi allo sporco, i vetri non erano rotti. Nonostante l'isolamento e il senso di generale abbandono, dunque, la casa doveva essere ancora abitata. Poiché ai miei colpi non rispondeva nessuno, bussai di nuovo e tentai il chiavistello arrugginito, che non era chiuso. All'interno c'era un piccolo vestibolo da cui l'intonaco si andava abbondantemente separando e dall'ingresso veniva un odore debole ma disgustoso. Entrai, portando la bicicletta con me, e richiusi la porta. Una scala piuttosto stretta mi si parava proprio davanti, fiancheggiata da una poltroncina, che con ogni probabilità portava alla cantina. A sinistra e a destra due porte chiuse immettevano nelle stanze del pianterreno.
Appoggiai la bicicletta al muro e aprii la porta di sinistra, che dava in una piccola stanza dal soffitto basso e illuminata a stento da due finestrelle: l'arredamento era il più spoglio e primitivo che si possa immaginare. Pareva che fosse una specie di soggiorno, perché c'erano un tavolo e diverse sedie, nonché un immenso camino su cui ticchettava un vecchio orologio. Di libri e carte ce n'erano pochi, e nella penombra non riuscii a leggere i titoli. Mi colpì l'atmosfera di totale arcaismo che trasudava dall'ambiente: molte case della regione, avevo scoperto, erano piene di reliquie del passato, ma qui l'antichità raggiungeva una misteriosa completezza; in tutta la stanza non c'era un solo oggetto di data post-anni-sessanta. Se l'arredamento fosse stato meno umile, quel posto sarebbe diventato il paradiso del collezionista.
© Paolo Melandri (25. 4. 2018)
*
Il lucchetto del cancello
Arrivato ai miei ultimi giorni, e spinto verso la follia dalle atroci banalità dell'esistenza che scavano come gocce d'acqua distillate dai torturatori sul corpo della vittima, cercai la salvezza nel meraviglioso rifugio del sonno. Nei sogni trovai un poco della bellezza che avevo invano cercato nella vita e mi immersi in antichi giardini e boschi incantati. Una volta che il vento era particolarmente dolce e profumato sentii il richiamo del sud e salpai languido, senza meta, sotto costellazioni ignote.
Un'altra volta cadeva la pioggia gentile e io mi imbarcai su una chiatta che percorreva un torrente senza sole, verso un mare senza sole, un fiume sotterraneo che sfociava in un altro mondo di crepuscoli purpurei, regno di pergolati multicolori e rose immobili. In un terzo sogno mi incamminai per una valle d'oro che conduceva a una serie di boschetti ombrosi e mucchi di rovine, per chiudersi con un muro possente coperto di rampicanti dove si apriva un piccolo cancello di bronzo.
Ho camminato in quella valle molte altre volte, indugiando sempre più a lungo nella penombra magica dove alberi giganteschi assumevano pose grottesche e parevano rannicchiati su se stessi; lì la terra incolore si stendeva umida fra gli alberi e a volte rivelava le pietre fangose di templi sepolti. Ma la meta delle mie fantasie era sempre la stessa: la muraglia di rampicanti in cui si apriva un piccolo cancello di bronzo. Poco a poco i momenti di veglia si fecero più rari e insopportabili, soffocati nel grigiore di un'immobilità stagnante; sempre più spesso mi abbandonavo alla pace drogata che solo poteva ricondurmi alla valle degli alberi d'ombra, chiedendomi come avrei fatto a non lasciarla più: non volevo essere costretto a strisciare di nuovo nel mondo spento, privo di interesse e di nuovi colori. E guardando il cancello nel muro coperto di verde sentivo che al di là si stendeva una terra di sogni da cui, una volta entrati, non ci sarebbe stato ritorno. Per questo, nel sonno, lottavo per trovare il lucchetto del cancello, ma il sistema di apertura mi era tenuto nascosto con grande abilità. Sapevo, tuttavia, che il paese al di là del muro sarebbe stato più autentico, più dolce e luminoso.
© Paolo Melandri (25. 4. 2018)
*
La conquista
Uscendo dall'impotenza di lunghi mesi e di incessanti ripulse –: Voglio occupare questa terra, pensò il Dottore, e i suoi occhi strapparono il velo bianco della strada, lo palparono e lo confrontarono con gli strati più vicini al cielo e con il chiarore dei muri di una casa, e subito si perse di felicità nella sera, nel netto prolungarsi della luce, in questa fresca fine di un giorno che era stato pieno di primavera.
L'assalto è finito, disse a se stesso; la posizione è sicura. Loro portano la loro impotenza ancora nei colori dei cappelli, nei nastri rossi e gialli e nelle mostrine sulle giacche; ma qui, per ora, non verremo scacciati. Anzi, tutto ciò che avviene, avviene per la prima volta. Una lingua straniera, tutto è carico d'odio e avanza incerto sopra un abisso. Qui voglio procedere passo per passo. E se in un luogo dovrà riuscirmi, sarà qui.
Andò avanti; gli fioriva intorno la città. Ondeggiava verso di lui, si sollevava sulle colline, gettava ponti sopra le isole, la sua cima stormiva. Superando piazze abbandonate da secoli e mai toccate da piede alcuno, tutte le strade premevano giù verso una valle; la città scendeva, si lasciava sprofondare nella pianura, squarciava le proprie mura e le offriva a un vigneto.
Si fermò su una piazza, si lasciò andare su un muro, chiuse gli occhi, con le mani tastava l'aria come fosse acqua, e supplicò: Cara città, lasciati occupare! Dammi una casa! Accoglimi nella tua comunità! Tu non cresci, né ti gonfi verso l'alto, tutto questo è estenuante. Tu sei così meridionale; la tua chiesa prega nella sera, la sua pietra è bianca, azzurro il cielo. Tu vaghi sulla riva della lontananza, sentirai pietà e già mi avviluppi.
Si sentì più saldo. Si gettò per le strade; era un fluttuare in ogni direzione. Andava di slancio, le donne le portava tra le pieghe come polvere; deposte dal trono; ma che avevano, in fondo; cavità minute e un ciuffo di terra sotto l'ascella. A una bionda ondeggiava nel respiro una rosa. Il suo profumo insieme al calore del seno saliva verso un qualche uomo.
Le andò dietro in un caffè. Si sedette e respirò profondamente: sì, qui è la comunità. Si guardò attorno: un uomo immergeva parole dolci in una ragazza, lei pensò che venissero da Dio e si lisciò la gonna. La mascella inferiore di un minorato manovrava una tazza con l'aiuto di due mani deformi, i genitori gli sedevano accanto e prendevano le distanze. Su tutti i tavoli stavano oggetti d'uso, alcuni per la fame, altri per la sete.
© Paolo Melandri (23. 4. 2018)
*
Tormentille
Non portano palandra né mantel fiamengo. Son femminette dalle gambe nude, come per guardare il Lete immemore. Han vesticciole color di fragola, maniche a sboffi di refe color d'avorio, capelli come i papaveri di Proserpina. Talune han lo scialletto nero a lunga frangia di lacciuoli, le calze nere che della magrezza e del pallore fan quasi un afrodisiaco trasparente, i tacchi alti come trampoli da passar fanghi di delizia o come trivelle da cavar pozzi di guadagno; e certi visini modellati da una certa febbre che si chiama «samara» e che non lavora col pollice ma con l'alito.
Questa danzatrice è forse una tanagrina travestita; che si è messa la gonnella a foggia di convolvolo riverso e l'ha tempestata di quelle rose azzurre introvabili come le belle bocche veritiere, ma ha dimenticato di togliersi i coturni.
Questa principessa posata sulla campana del guardinfante, come una farfalla che dalla cintola insù sia per volar via, ha i capelli di canapa di Lucrezia Borgia e di quella miserella coricata nella camera vuota della Casa Romei. Ne taglierò una boccola, e me la metterò sul cuore per ricordarmi di tutte e tre.
© Paolo Melandri (20. 4. 2018)
*
Verso la spiaggia
La spiaggia dista mezz'ora di cammino. Se si osservano piante e animali, più ci dilunghiamo nell'esame e più esso diventa appassionante. Già sui campi imbiondiscono i cereali; le foglie della fava maggiore sono inaridite. Queste colture sono rinserrate da alte siepi di opunzie, che meglio di qualsiasi recinto tengono lontano il bestiame al pascolo. Massicce piante sembrano parte integrante del paesaggio; è difficile immaginare che una volta non ci fossero. E invece sono state ambientate qui in tempi recenti. Vengono da terre ancor più calde e più secche. Lo stesso si dica di altri vegetali che noi diremmo tipicamente mediterranei: l'arancia, l'aloe, la nespola. Forse tutte le piante alimentari e voluttuarie sono state introdotte qui una volta da uomini venuti dall'esterno, e così la maggior parte degli animali domestici. Come per le razze, gli idiomi e gli stili architettonici, anche per questi doni della natura l'isola offre la cornice a una continua vicenda di mutamenti e di innesti.
In un terreno ininterrottamente percorso da greggi e mandrie è inestimabile una pianta capace di costruire impenetrabili recinti. Per giunta, essa offre in dono il fico d'India, un frutto succoso e nutriente. Viene raccolto in autunno; ora arde ancora tutta sola, sulla cima, una delle rosse candele.
© Paolo Melandri (19. 4. 2018)
*
La polvere del passato
Non so terrore più profondo di quello che mi occupa quando, nella pausa della mia propria volontà che mi crea, vedo accorrere all'infinito il vento senza nome e in esso agitarsi la polvere del passato e levarsi contro a me non come ombre delle cose che furono ma come aspetti di quelle che sono per essere: onde non riconosco più la successione della vita né la mutazione della sua sostanza, ma avverto entro me una specie di immobilità veggente.
Il giorno d'inverno è chiaro e senza soffio, ma fragile come un globo di vetro. Qualcosa pare serrarsi intorno a noi, par divenire angustia e pericolo. L'urlo è nella luce; ma si sussulta come quando all'improvviso una persiana sbatte mentre si scantona lungo una casa, per una via deserta, verso sera. Giù nella valle fischia il treno che va a Firenze. Il fischio si attenua, si fa dolce quasi come una parola modulata che dica: addio, addio, addio. Per un istante l'anima mi si parte, segue la parola già svanita.
© Paolo Melandri (18. 4. 2018)
*
Cristo deposto
Cristo deposto è un eroe stanco: il dolore è rimasto imprigionato in lui, e ha il medesimo peso delle ossa. Le braccia riposano lungo i fianchi di scarso nerbo come quelle che non solevano reggere né arnese né arme né fardello. Le mani son quelle che intinsero il pane nel piatto dell'ultima cena, per rendere la vita e per accettare la morte. Le dita in entrambe son riunite e composte; e in entrambe i pollici son nascosti, ripiegati entro la palma. Sembra che manchi a ciascuna il dito della forza, del lavoro, del prendimento; e ne viene a ciascuna una rassegnata stanchezza. Le costole sono rilevate quasi a simmetrico ornamento del torace. La gentilezza del sangue davidico sembra affinare le membra; senonché la rotella del ginocchio è prominente, grossa la nocella del polso, greve anche il malleolo. Si parte diritto il naso dalla radice ma con lieve declinazione presso la punta si avvalla: le nari certo in vita si dilatarono e palpitarono. I capelli sono come un pietoso origliere. Le labbra sottili della ferita nel costato son parallele alla linea profonda della bocca. V'è ancora qua e là qualche indizio di mollezza, non definibile. Così bellissimo mi apparve in mille immagini; insieme le conflài; sparve ombra labile riverso indietro nel morbido crepuscolo dei miti.
© Paolo Melandri (15. 4. 2018)
*
Nina o della felicità
Andrea ascoltava appena. La scala era stretta e buia, a ogni svolta credeva, sperava veder sbucare di non so dove la sconosciuta, ancora in cima davanti all'uscio di Nina si aspettava di vedersela guizzare davanti. Ora gli sembrava fuori di ogni dubbio che tra i due gesti c'era un misterioso rapporto: che anche il braccio della donna dolente levato quasi a scongiurare, a implorare, doveva essere rivolto a lui come l'invito della giovane. La smania, l'impazienza di scoprire chi fosse quella creatura incomprensibile, poteva a stento sopportarla; una cosa sola gli dava un poco di pace: per vederlo un istante ella aveva trovato la strada in modo incomprensibile, un alto muro, sotto il quale scorreva forse l'acqua, non le aveva impedito di compiere ciò che pareva negato ad ogni creatura, salvo a un gatto, e non aveva esitato a far correre il sangue dalle proprie dita. Ella avrebbe saputo ritrovarlo in ogni luogo, a ogni ora.
Trovarono madamigella Nina distesa sul canapè in un atteggiamento comodo e aggraziato. Era tutta chiara e tutta amabili curve tenere. Aveva i capelli biondo chiaro che parevano d'oro pallido e li portava senza cipria. Tre cose, tutt'e tre deliziosamente arcuate e l'una in accordo con l'altra, le sopracciglia, la bocca e la mano, si levarono con espressione di tranquilla curiosità e di grande amabilità incontro all'ospite che entrava.
Un quadro senza cornice era appoggiato al muro da rovescio, un taglio come di coltello correva attraverso la tela. Zorzi lo sollevò da terra, lo osservò e lo portò via scuotendo la testa, senz'altro aggiungere, uscì.
Nina guardava davanti a sé come distratta; sul suo labbro superiore, arcuato come le sue sopracciglia, e come abbandonato a qualcosa che doveva venire, era sospeso un sorriso, e sembrava attendere un bacio. Andrea si chinò senza saperlo e fissò incantato quelle labbra socchiuse. L'immagine di Romana affiorò per un attimo, per dissolversi subito nell'aria. Egli sentì qualche cosa di infinitamente dolce e di pauroso insieme scendere lento e sciogliersi nel suo cuore.
– Ora siamo soli, – disse – ma chi sa per quanto. – Fece per prendere la mano di lei e non la prese, ché gli parve di sentire la mano di Zorzi sulla maniglia della porta. Si alzò e si avvicinò alla finestra.
Andrea guardò dalla finestra e vide sotto di sé un grazioso giardinetto pensile. Sopra una terrazza c'erano piante di aranci in mastelli, in cassettine di legno fiorivano gigli e rose, e rose rampicanti formavano una galleria e una piccola pergola. Nel mezzo c'era persino un albero di fico con alcuni frutti maturi. Egli chiese: – Il giardino le appartiene?
– Non appartiene a me, lo prenderei tanto volentieri in affitto, – rispose Nina – ma non posso dare a quella gente avida quanto ne chiede. Fosse mio, ci farei una vasca e una piccola fontana – Zorzi dice che si può – e una lanterna dentro la pergola.
Andrea si vide entrare dai vicini, contare sul tavolo il denaro per l'affitto, e ritornare da madamigella Nina col contratto in mano. Nella fantasia dava già ordine di alzare il cancello intorno al giardino: rose rampicanti e convolvoli correvano su per aste leggere e facevano del piccolo spazio una stanza viva, in cui dall'alto si affacciavano le stelle. La brezza notturna vi passava scherzando, impediti gli sguardi indiscreti dei vicini. Su piccole tavole stavano coppe di frutta, tra lumi sotto campane di vetro. Nina giaceva sopra un divano in uno scialle leggero, quasi come ora dinanzi a lui. Ma in che modo diverso egli stava dinanzi a lei – come in un sogno sentiva quell'altro se stesso: non era una visita occasionale, che ogni scricchiolare di porta riscuote, cui è concesso un incerto e distratto quarto d'ora; egli era l'amico legittimo, il signore di questo giardino incantato e il signore della sua signora. Si perdette in un vago senso di felicità, come se vibrasse in lui il suono di un'arpa eolia. – Egli non sapeva quanto poco necessario fosse tutto questo, che anzi l'attimo seguente gli avrebbe forse donato quella felicità.
© Paolo Melandri (14. 4. 2018)
*
Il problema invisibile
È ormai tempo che mi dedichi al mio problema. Chi non ce l'ha, un problema – ciascuno ne ha uno e perfino più d'uno. Hanno valori diversi: il problema principale invade il centro dell'esistenza, rimuove gli altri. Senza sosta ci accompagna come un'ombra e incupisce la mente. È lì anche quando ci svegliamo di notte; ci balza addosso come un animale.
Un uomo di tanto in tanto ha mal di testa; non è piacevole, ma esistono dei rimedi. Il caso si fa serio se un giorno egli sospetta che ci sia sotto qualcosa – forse un piccolo tumore. Ora l'ansia fugace diventa permanente; diventa l'ansia principale.
2.
Eppure anche un'ansia principale come questa è cosa di tutti i giorni. Ce ne convinciamo pensando alla statistica – infatti, mentre il nostro uomo rimugina sul suo tumore, nello stesso momento un'ansia identica opprime sul pianeta migliaia d'altri. Egli dunque la divide con loro? Certamente, e tuttavia rimane il suo problema privato e indivisibile. È in gioco l'insieme – sotto il mal di testa si nascondeva il tumore, ma ancor più sotto forse c'è dell'altro, per esempio un carcinoma.
Va anche considerata l'eventualità che non ci sia sotto NIENTE – il problema si fonda sull'immaginazione. Anche l'angoscia ha le sue mode – oggi predilige la guerra atomica e il carcinoma, dunque la rovina collettiva e quella personale.
Un tempo, quando infieriva la paralisi, specie negli strati superiori e lì in particolare fra gli artisti, molti si immaginavano di esser colpiti da questo male, e più d'uno per questo si uccise. Ma è proprio quando sotto non c'è niente che il problema diventa più inquietante. Il terrore non incombe più in una forma o nell'altra, ma con tutto il suo indiviso potere.
3.
A colazione, quando mescolo nella tazza e seguo la rotazione degli addensamenti, mi balza agli occhi la legge secondo cui si muove l'universo – nel gorgo delle nebulose, nel vortice delle galassie.
Dal che possono trarsi conseguenze intellettuali e anche pratiche. Lo spettacolo mi ricorda la mela di Newton, o il vapore che Watt fanciullo vide scaturire dalla teiera ben prima d'inventare la sua macchina. «Questo dà da pensare» diciamo. A quanto sembra l'atto di pensare è preceduto dalla sintonia con la materia, a cui segue quello stato di fantasticheria che genera il pensiero e lo suscita.
Ma a che serve? Che l'universo ruoti o si disgreghi – sotto rimane il problema.
© Paolo Melandri (5. 4. 2018)
*
Il risveglio della personalità
Oltre le due ferite appena sanate, Lorenzo aveva ora questa nuova, non meno penosa delle altre. Aurelia non gli permise di rivolgersi ad un chirurgo. Volle fasciarlo lei stessa, fra strani discorsi di ogni fatta, cerimonie e sentenze; mettendolo con ciò in una situazione quanto mai penosa. Non soltanto lui, ma tutte le persone che le erano vicine soffrivano della sua irrequietezza e della sua originalità; nessuno, però, più del piccolo Felice. Il vivace bambino era insofferentissimo sotto tale oppressione, e tanto più sgarbato quanto più Aurelia lo rimproverava, cercando di correggerlo.
Il ragazzo si compiaceva di certe stranezze, o per dir meglio, sconvenienze, che ella non riusciva a perdonargli. Soleva bere, per esempio, più volentieri dalla bottiglia che dal bicchiere, e preferiva mangiare direttamente dal vassoio, anziché dal piatto. Tali sue sconvenienze non passavano certo inosservate. Bastava che aprisse o chiudesse la porta, o che non si allontanasse subito dal luogo dove si trovava, o corresse precipitosamente quando gli era comandata qualcosa, perché si beccasse una solenne sgridata. Ma purtroppo non lasciava scorgere alcun miglioramento. Pareva, anzi, che il suo affetto per Aurelia diminuisse sempre di più, e nulla di dolce vi era nel tono con cui la chiamava mamma. Era invece affezionatissimo alla vecchia governante, la quale lo assecondava, naturalmente, in ogni capriccio.
Anche la vecchia, però, da qualche tempo era talmente malata, che si era dovuto trasportarla dalla casa in un quartiere più quieto. Felice sarebbe rimasto proprio solo, se Cecilia non fosse apparsa anche a lui un amoroso spirito protettore. Graziosissima cosa era vedere come i due ragazzi si intrattenevano insieme. Cecilia gli insegnava delle canzoncine, e Felice, che aveva buona memoria, le recitava spesso con meraviglia di chi ascoltava. Ella voleva anche spiegargli le carte geografiche, alle quali si interessava molto; ma in ciò non procedeva con il migliore dei metodi. Perché sembrava, in verità, che per i paesi ella non avesse altro speciale interesse che quello di sapere se fossero caldi o freddi. Sapeva dire molto bene dei poli, del terribile freddo che faceva lassù, e del caldo tanto più piacevole quanto più ci si allontana da essi. Se qualcuno era in procinto di mettersi in viaggio, ella chiedeva soltanto se partiva per il nord o per il sud, e si studiava di cercarne la via sulle cartine. Cecilia stava molto attenta specialmente quando Lorenzo parlava di viaggi, e quando la conversazione verteva su un altro argomento, se ne rattristava. Mentre non si riusciva che a stento a indurla ad assumersi una parte, o anche soltanto a recarsi in teatro a qualche rappresentazione, ella imparava a mente con facilità e diligenza notevoli poesie e canzoni, suscitando in tutti notevole stupore quando (spesso inaspettatamente e quasi improvvisando) recitava una di tali poesie, per lo più di genere serio e solenne.
© Paolo Melandri (3. 4. 2018)
*
Nuovi avvistamenti nel giardino di Zapparoni
In tali casi di solito ricorriamo all'esperienza, ai raffronti. Cercai, dunque, quando il grigiofumo si muoveva nel mio campo di visione, di cogliere nello stesso momento un oggetto conosciuto da me che ne desse le dimensioni. Non fu difficile; da alcuni minuti infatti il grigiofumo si librava tra me e il più vicino fosso della palude. Questi minuti, mentre io, con gli occhi fissi su di lui, lentamente spostavo il capo, ebbero un effetto specialmente soporifero. Non sapevo dire se i mutamenti che credevo di riconoscere sulla superficie dell'automa fossero reali o no. Lo vedevo trascolorare come per segnali ottici, sbiadiva e poi bruscamente si illuminava di color di sangue. A poco a poco si fecero visibili due escrescenze nere, sporgenti come corna di lumache.
Intanto non dimenticavo di osservarne le dimensioni, quando il grigiofumo invertì il movimento del suo cammino e per la durata di un secondo si fermò sopra una pozza della palude. Gli sciami di automi se n'erano andati o non li vedevo più, perché ero rimasto incantato? Comunque il giardino era perfettamente silenzioso e senza ombre, come accade nei sogni.
«Una scheggia di quarzo, della grandezza di un uovo di anatra.» Arrivai a questa conclusione, confrontando il grigiofumo col fiore del giunco, che egli quasi sfiorò. I fiori del giunco li conoscevo bene sin da bambino; allora li chiamavamo «puliscicilindri» e ci eravamo rovinati il vestito nell'acquitrino tentando di coglierli. Bisognava aspettare che l'acqua gelasse, ma anche allora l'avvicinarsi era pericoloso, perché rasente ai giunchi il ghiaccio era fragile e crivellato dai buchi delle anatre.
Un perfetto termine di paragone era la zanzara, che ornava la foglia della drosera come incisa in un rubino. Anche la drosera era una mia antica conoscenza. Mio padre ed io l'avevamo presa con le radici durante le nostre incursioni nelle torbiere per trapiantarla in un terrario. I botanici la chiamano «pianta carnivora»: era stata questa barbarica esagerazione che ci aveva fatto desiderare la delicata pianticella. Quando il grigiofumo, che ora si librava più in basso, sfiorando quasi l'orlo della pozza nella palude, entava nel mio raggio visivo, potevo notare che, in verità, paragonato alle api, egli era di considerevole grandezza.
Nell'osservazione tesa e monotona si nasconde il pericolo delle allucinazioni, come sanno tutti quelli che viaggiano nella neve o sulla sabbia o hanno percorso strade interminabili e diritte come una fettuccia. Cominciamo a sognare; e le immagini prendono il sopravvento.
«La drosera, dunque, è una pianta carnivora, un'erba cannibalesca.»
Perché mi era venuto questo pensiero? Era come se avessi veduto le foglie rosse frangiate con le ventose appiccicaticce immensamente ingrandite. Un inserviente vi gettava da mangiare.
Mi strofinai gli occhi. Una figura di sogno mi aveva ingannato in questo giardino, dove le cose minuscole diventavano grandi. Però nel medesimo tempo sentii nel mio intimo un segnale stridulo, come il campanello di una vettura che si avvicinasse.
Dovevo aver veduto qualcosa di illecito, di vergognoso, che mi aveva spaventato.
© Paolo Melandri (2. 4. 2018)
*
Le api robotizzate
Zapparoni pensava piuttosto a enti di distribuzione, a laboratori, ad accumulatori e a posti di rifornimento. Dove consegnare e ricevere materiali, come qui nell'arnia delle api, dove non soltanto si portava il miele, ma palesemente si riceveva l'energia, infatti vedevo come le forme di vetro venivano letteralmente scagliate come proiettili quando erano state svuotate.
Oramai l'aria era piena di un sibilo chiaro, uguale, di un sibilo che non vorrei dire addormentava, ma intormentiva ipnoticamente l'attenzione. Dovevo fare uno sforzo per distinguere tra sogno e realtà, per non soggiacere ad allucinazioni che prolungavano spontaneamente il tema di Zapparoni.
Come ho detto, avevo notato diversi modelli delle api di vetro. Da un po' di tempo nella loro scia erano apparsi anche altri apparecchi. Differenti da esse in modo molteplice per grandezza, forma e colore, e palesemente estranei all'apicoltura. Queste nuove forme dovetti accettarle come si presentavano, non potevo seguirle con la mia interpretazione. La stessa cosa ci può accadere quando sulla spiaggia osserviamo gli animali marini: vediamo pesci e gamberi, riconosciamo anche le meduse, ma poi salgono dal fondo degli esseri che ci pongono enigmi insolubili, allarmanti. Qui ero come un uomo dell'era della cultura posto a un crocevia. Dopo un poco di stupore egli indovinerà facilmente che l'automobile è una specie di cocchio. Intanto viene sopraffatto da costruzioni alla maniera di Callot.
© Paolo Melandri (31. 3. 2018)
*
Le api di Zapparoni
Lo spettacolo sulle prime mi aveva divertito come gioco, e poi affascinato come combinazione. Ma ora ne afferravo il potente significato ed ero ebbro come un cercatore d'oro che è entrato nella terra di Ophir. Perché mai il vecchio mi aveva concesso di entrare in quel giardino?
«Fate attenzione alle api!» Come tutto quel che diceva, anche questa frase, aveva un senso diverso da quello palese. Forse voleva dirmi di serbare il mio sangue freddo, e in verità sentivo che lo spettacolo mi scardinava il cervello. Probabilmente il maestro me l'aveva preparato come una prova. Ecco il lato pratico. Voleva sapere se io ne avrei afferrato la vasta portata, se fossi pari al pensiero. Forse la mente di Caretti si era smarrita in questo giardino?
«Fate attenzione alle api!» Poteva anch'essere un ammonimento a non essere curioso. Forse voleva vedere come mi sarei comportato di fronte a quel segreto palesato. Però non mi ero ancora alzato dalla sedia.
Del resto ero troppo occupato per riflettere sul mio comportamento: quell'attività mi avvinceva completamente. Prima, quando si faceva una nuova invenzione, era quasi un colpo di fortuna: spesso l'inventore non vedeva chiaro fino in fondo al suo significato. Le costruzioni, i miseri scheletri nei musei suscitano il sorriso. Invece qui c'era un nuovo pensiero concepito non soltanto nelle sue conseguenze, ma eseguito nel medesimo tempo sopra una vasta superficie e in tutti i suoi particolari. Si era creato un modello che superava le esigenze pratiche. Questo lasciava supporre molti collaboratori, e molti complici, e faceva comprendere la preoccupazione di Zapparoni di conservare segreta la cosa.
Nel corso del pomeriggio il numero degli oggetti volanti crebbe notevolmente. Nello spazio di due, tre ore si compendiò un'evoluzione pari a quella che si era svolta da quando io ero nato, voglio dire la trasformazione di un fenomeno straordinario in cosa corrente. Come mi era accaduto per le automobili e per gli aeroplani.
Sulle prime ci si stupisce dell'oggetto che si presenta isolato, e alla fine lo si vede passare rombando a legioni in cortei lampeggianti. Nemmeno i cavalli voltano più la testa. Il secondo spettacolo è più sorprendente, però entriamo nella regola della serie, dell'abitudine.
Zapparoni doveva avere spinto molto avanti lo sviluppo di quegli automi, dovevano essere già allo stadio della produzione in serie, per quanto ciò fosse possibile nelle sue officine. Non pareva, però, che egli preparasse qui un nuovo articolo da mettere in commercio: una delle sorprese che annualmente serviva nei suoi cataloghi. Sarebbe avvenuto forse col tempo. Doveva essere un'impresa fine a se stessa: era chiaro, quando l'attività aumentò, in un modo che faceva pensare alla stagione in cui le api sciamano o all'ora di punta in una città. Adesso si diramava a schiere anche in altre parti del parco.
Contemplata dal punto di vista dell'organizzazione, quell'attività poteva essere interpretata in diversi modi. Era difficile credere che esistesse una fonte di energia centrale. Non era nello stile di Zapparoni. Per lui il valore di un automa dipendeva dalla sua autonomia. Il suo successo mondiale riposava su questo, che in casa, in giardino, nel minimo spazio egli aveva reso possibile una economia chiusa; aveva dichiarato guerra ai fili di ferro, alle condutture, ai tubi, ai binari, agli allacciamenti. Portandoci così ben lontani dal modo di lavoro del secolo ventesimo e dalla sua bruttezza.
© Paolo Melandri (30. 3. 2018)
*
Il cenacolo Mascetti
Lo straniero si commosse nel ritrovare tante splendide opere senza il loro proprietario, ma si rallegrò di risentire lo spirito dell'amico nelle parole dei suoi degni successori. Passarono in rivista le varie opere d'arte e provarono gran piacere di comprendersi. Mascetti e l'abate conducevano la conversazione; Natalia che si sentiva di nuovo in presenza dello zio, seppe adattarsi molto bene ai loro discorsi e alle loro idee; Guglielmo doveva tradursi tutto in termini teatrali, se voleva comprendere qualche cosa. A fatica riuscivano a frenare gli scherzi di Federico. Wolfgang era ben di rado presente.
All'osservazione che nel presente le opere d'arte eccellenti sono rare, Mascetti rispose: – Non è facile pensare e intendere chiaramente quale concorso di circostanze sia necessario per la formazione di un artista. Anche il genio più grande, il talento più sicuro devono esigere infinitamente da se stessi. Chi potrà dir mai quanta assiduità, quale diligenza si richiedono per la loro educazione? Quando le circostanze fanno poco per l'artista, quando egli nota che il mondo si contenta facilmente, e desidera solo una facile, piacevole, comoda apparenza, come potremmo meravigliarci se egli, per comodità e vanità, si tiene stretto al mediocre? Sarebbe strano se invece di offrire merci alla moda in cambio di lodi e denaro preferisse la via vera dell'arte che sempre, più o meno, conduce a un doloroso martirio. Per questo gli artisti del nostro tempo molto promettono e poco danno. Vogliono sempre stuzzicare la nostra sensibilità, e non mai soddisfarla: tutto è solo accennato, e non si trova né un solido fondamento né una compiuta esecuzione. Ma del resto basta aver la pazienza di fermarsi per un poco soltanto in una galleria d'arte e osservare quali opere attraggono la folla, quali essa loda, quali trascura per aver poca gioia del presente e poca speranza dell'avvenire.
»È vero, – rispose l'abate, – e così amatori e artisti si educano a vicenda; l'amatore cerca solo un godimento generale e indeterminato; l'opera d'arte gli deve dare su per giù lo stesso piacere di un'opera della natura e gli uomini credono che gli organi per godere un'opera d'arte si formino così spontaneamente come la lingua e il palato e che si giudichi di un'opera d'arte come di un cibo. Non comprendono che ben altra cultura è necessaria per elevarsi al godimento vero dell'arte. La cosa più difficile mi sembra quella specie di separazione fra i vari elementi che l'uomo deve attuare in se stesso se vuole realmente educarsi. Appunto per questo troviamo tante culture unilaterali, eppur ciascuna con pretesa di universalità.
» Quel che sta dicendo non mi è completamente chiaro, – disse Mozart che entrava di fretta in quel momento.
» Ed è anche difficile, – rispose l'abate, – spiegarsi in breve e con chiarezza sull'argomento. Dirò soltanto questo: appena l'uomo pretende a un'attività o a un godimento più vario e più multiforme deve anche essere in grado di sviluppare in sé degli organi vari, indipendenti, per così dire, gli uni dagli altri. Chi vuol fare tutto o godere tutto nella pienezza della sua umanità, chi a questa specie di godimento vuol partecipe tutto il mondo esteriore, chi vuole in tutto il tutto e l'universo nel particolare, consuma il suo tempo in un'aspirazione eternamente insoddisfatta. Come è difficile quel che invece sembra così naturale: contemplare una bella statua, un bel quadro in sé e per sé, ascoltare un canto solo in grazia del canto, veder nell'attore solo l'attore, rallegrarsi di un edificio solo in virtù della sua propria armonia e della sua durata. Ma invece vediamo la maggior parte degli uomini trattare opere d'arte ben definite e precise come se fossero molle argilla. Secondo i loro gusti, le loro opinioni, i loro grilli, il marmo già scolpito dovrebbe rimodellarsi o restringersi. Un quadro deve istruire, un'opera drammatica render migliori, e tutto deve trasformarsi in tutto quello che essi vogliono. Ma in verità poi, siccome i più degli uomini non hanno una loro forma, e non possono dar forma alcuna né al loro essere né a sé, si adoperano per togliere da ogni oggetto la forma sua propria, affinché tutto diventi quella materia molle e incerta, di cui essi stessi sono fatti. Tutto riducono in fine al così detto effetto, tutto proclamano relativo e tutto anche relativo diventa, fuorché la stoltezza e il cattivo gusto, che regnano sovrani.
» La comprendo, – rispose Mozart, – o meglio, comprendo bene e intendo come le sue parole si connettono con i princìpi a cui lei fermamente si tiene; io però non posso prendere con tanta serietà quei poveri diavoli che sono gli uomini. Ne conosco, è vero, abbastanza che dinanzi alle più grandi opere della natura e dell'arte si ricordano subito dei loro più miseri bisogni, che quando vanno al teatro si portan dietro la loro coscienza e la loro morale, che di fronte a un colonnato non riescono a deporre i loro odi e i loro amori. Nella loro immaginazione debbono, prima di tutto, rimpicciolire quanto più possono il bello e il grande che si presenti loro dal di fuori per poterlo così mettere in qualche rapporto con la meschinità del loro essere.
Capitolo VIII.
La sera l'abate invitò alle esequie di Emilia. La compagnia si recò nella Sala del Passato e la trovò stranamente illuminata e addobbata. Le pareti erano rivesite dall'alto fin quasi in basso di tappeti azzurro-cielo così che apparivano soltanto lo zoccolo e il fregio. Su quattro candelabri negli angoli ardevano quattro grandi candele di cera e altrettante in proporzione sui quattro più piccoli che circondavano il sarcofago posto nel mezzo. Vicino a questo stavano quattro fanciulli con vesti azzurre e argentee: sembravano ventilare dolcemente con larghi ventagli di struzzo una figura che giaceva nel sarcofago. Gli ospiti si sedettero e due cori invisibili cominciarono a chiedere con canto soave: – Chi portate nella nostra tacita cerchia? – I quattro fanciulli risposero con tenera voce: – Una compagna stanca di giochi vi portiamo, lasciatela riposare fra voi finché il giubilo non la risvegli di fraterni cori celesti.
E il coro invisibile rispose: – Primizia di giovinezza, sii benvenuta fra noi. Con tristezza la benvenuta. Ma nessun fanciullo ti segua, nessuna fanciulla. Vecchiezza soltanto, spontanea e rassegnata, si avvicini al tacito portico e qui nella raccolta dimora riposi la cara, la buona fanciulla. Fanciulli, ritornate alla vita. Nella pura veste della bellezza vi incontri l'amore con sguardo celeste e con la corona dell'immortalità.
I ragazzi si erano già allontanati, l'abate si alzò dalla sua sedia e andò dietro la bara. – È ordine, – disse, – dell'uomo che preparò questa tacita dimora, che ogni nuovo ospite vi venga accolto con rito solenne. Dopo di lui che costruì questa casa, istituì questo funebre ufficio abbiamo condotto qui per prima questa giovane straniera e così il breve spazio accoglie già due vittime diversissime della severa, capricciosa, implacabile dea della morte. Secondo leggi prescritte, noi entriamo nella vita: numerati sono i giorni che ci rendono atti a mirar la luce, ma per la durata della vita non c'è legge alcuna. Il filo più sottile si protrae in una lunghezza inaspettata e il più forte viene troncato violentemente dalle forbici di una parca che sembra compiacersi di contraddizioni. Della fanciulla che qui vien sepolta sappiamo dire ben poco. Ancora ci è ignoto donde venne, non conosciamo i suoi genitori e il numero dei suoi anni possiamo solo supporlo. Il suo cuore chiuso e profondo ci lasciò appena indovinare la sua intima vita. Nulla era in lei chiaro, e nulla ella manifestò all'infuori dell'amore per l'uomo che l'aveva salvata dalle mani di un aguzzino. Questo tenero affetto, questa ardente gratitudine parvero essere la fiamma che consumò l'olio della sua vita; l'abilità del medico non poté salvare questa bella vita, né le più tenere cure dell'amicizia riuscirono a prolungarla. Ma se l'arte non poté incatenare lo spirito che fuggiva, ha però usato tutti i suoi mezzi per conservare il corpo e per sottrarlo alla caducità. Una sostanza balsamica ha permeato tutto il suo corpo e colora adesso invece del sangue le gote così presto impallidite. Si avvicinino, amici miei, e guardino questo miracolo dell'arte e dell'amicizia.
Alzò il velo; e la fanciulla giaceva nelle sue vesti di angelo, come dormendo, nel più dolce atteggiamento. Tutti si avvicinarono e ammirarono quella parvenza di vita. Solo Federico restava seduto; non riusciva a dominarsi; non osava pensare a quel che sentiva e ogni pensiero sembrava voler distruggere il suo sentimento.
© Paolo Melandri (29. 3. 2018)
*
La saggia stoltezza
Noi guardiamo così volentieri nel futuro, perché con i nostri taciti desideri vorremmo volgere a nostro favore le incerte sorti che vagano in esso.
È difficile che, trovandoci in compagnia numerosa, noi non pensiamo: il caso, che riunisce tante persone, dovrà pur condurci un giorno anche i nostri amici.
L'uomo ha un bel vivere ritirato: prima che se lo aspetti egli diventa debitore o creditore.
Se incontriamo qualcuno che ci deve gratitudine, ce ne rammentiamo subito. Quante volte invece ci capita di incontrare persone cui dobbiamo noi gratitudine, senza pensarvi!
Comunicarsi è natura; saper accogliere ciò che vien comunicato, così come è dato, è cultura.
Nessuno parlerebbe molto in società, se avesse coscienza di come spesso egli fraintenda gli altri.
Si alterano tanto i discorsi altrui ripetendoli, semplicemente perché non si sono capiti.
Chi in presenza di altri parla a lungo da solo, senza lusingare gli ascoltatori, li disgusta.
Ogni parola espressa provoca l'idea contraria.
Contraddizione e adulazione rendono entrambe la conversazione spiacevole.
Le compagnie più simpatiche sono quelle in cui regna fra i loro membri un sereno rispetto reciproco.
Nulla designa meglio il carattere degli uomini di quello che essi giudicano ridicolo.
Il ridicolo scaturisce da un contrasto morale, i cui termini vengono, in un modo innocuo, accoppiati per i nostri sensi.
L'uomo in cui predomina il senso ride spesso dove non c'è nulla da ridere. Qualunque sia lo stimolo, mostra sempre il cuor contento.
L'uomo guidato dall'intelletto trova quasi tutto ridicolo, l'uomo guidato dalla ragione quasi nulla.
Un uomo d'età fu criticato, perché corteggiava una donna giovane. – È l'unico mezzo per ringiovanire – rispose – e questo è il desiderio di tutti.
Noi ci lasciamo rinfacciare i nostri difetti, ci lasciamo punire, per essi sopportiamo tante cose con pazienza; ma se dobbiamo rinunciare ad essi, allora diventiamo impazienti.
Certi difetti sono necessari all'esistenza dell'individuo. Ci spiacerebbe, se i nostri vecchi amici perdessero certe loro particolarità.
Si dice: – muore presto! – quando uno fa qualcosa di contrario alla sua natura.
Quali sono i difetti che possiamo conservare, anzi coltivare in noi? Quelli che non offendono, ma piuttosto lusingano gli altri.
Le passioni sono difetti o virtù, ma portati all'esaltazione.
Le nostre passioni sono vere fenici. Quando brucia l'antica, sorge subito dalla cenere la nuova.
Le grandi passioni sono malattie senza speranza. Ciò che potrebbe guarirle le rende più che mai pericolose.
La passione si accresce e si attenua con la confessione. In nulla forse sarebbe più desiderabile la via di mezzo, che nel confidarsi e nel tacere con le persone che amiamo.
© Paolo Melandri (28. 3. 2018)
*
Ora la barca scivolava
Ora la barca scivolava, illuminata dal fervido sole meridiano, lungo il fiume, brezze miti rinfrescavano l'aria calda, molli rive ai due lati lasciavano godere un paesaggio semplice, ma riposante. I campi di grano si avvicinavano fino alla corrente, e il terreno fertile era così prossimo alla riva, che in qualche punto le acque scroscianti, gettandosi oltre i margini, avevano assalito violentemente la terra friabile trascinandola con sé, così che si erano costituite delle rapide scarpate di una notevole altezza.
Su in alto, sull'orlo di una di queste, dove forse una volta era stato un ciglione, il nostro amico vide galoppare un giovanotto di bell'aspetto, dalla figura vigorosa. Lo si voleva osservare meglio, quando l'orlo erboso su cui cavalcava cede e l'infelice d'improvviso precipita con tutto il cavallo nel fiume, a capofitto. Non c'era da indugiare e da far domande, i barcaioli remano veloci come saetta verso il vortice, in un attimo hanno già ripescato la bella preda. L'amabile giovane, apparentemente esanime, giaceva nella barca, dopo breve riflessione gli abili barcaioli si spinsero verso una specie di isolotto ghiaioso che si era formato in mezzo al fiume. Approdare, portare il corpo a riva, spogliarlo, asciugarlo, fu tutt'uno. Ma ancora non si poteva notare alcun segno di vita, il tenero fiore posava lì immobile fra le loro braccia!
Guglielmo afferrò subito una lancetta per aprire una vena del giovane, il sangue sprizzò copioso e mescolandosi con l'onda che s'insinuava lì scherzosa, rifluì con essa nel fiume. La vita ritornò; il premuroso chirurgo ebbe appena il tempo di fermare la fasciatura, che il giovane era già di nuovo coraggiosamente in piedi. Guardò Guglielmo in volto ed esclamò: «Se io devo vivere, che io viva con te!». Con queste parole si gettò fra le braccia del suo salvatore che lo aveva riconosciuto, che era riconosciuto, e scoppiò in lacrime. Così stavano fortemente abbracciati, come Castore e Polluce, i fratelli, quando si incontrano nella luce, nel loro alterno cammino verso l'Ade.
Lo pregarono di calmarsi. I bravi compagni avevano già preparato un comodo giaciglio, metà al sole, metà nell'ombra, sotto rami e cespugli leggeri. Ora giaceva là, sul mantello del padre: la più attraente figura giovanile, i ricci bruni, già asciutti, tornavano a inanellarsi, sorrideva tranquillo, e si addormentò.
© Paolo Melandri (16. 3. 2018)
*
La caccia [1]
Una fitta nebbia autunnale avvolgeva ancora di primo mattino l'ampio cortile del castello; ed ecco che, al diradarsi del velo, si incominciò a vedere nel suo confuso movimento l'intera partita di cacciatori a cavallo e a piedi. Si riusciva a distinguere nettamente come i più vicini si affrettassero nei loro preparativi: chi allungava le staffe, chi le accorciava, chi porgeva schioppo e cartucciera, chi raddrizzava le biasacce, mentre i cani al guinzaglio minacciavano impazienti di trascinare con sé chi li tratteneva. Di quando in quando anche un cavallo si faceva irrequieto, spinto dalla sua natura focosa o eccitato dallo sperone del cavaliere che, perfino in quella mezza luce, non poteva rinunciare alla vanità di mettersi in mostra. Ma tutti aspettavano il principe che, nel prendere congedo dalla giovane sposa, indugiava più del consueto.
Sposati da poco, essi provavano già la felicità di due anime in perfetto accordo; erano entrambi di temperamento attivo e vivace, amavano prender parte l'uno alle inclinazioni e alle aspirazioni dell'altra. Il padre del principe aveva ancora vissuto e messo a frutto il momento in cui si era capito che tutti i cittadini avrebbero trascorso le loro giornate ugualmente operosi e che ciascuno, lavorando e producendo a modo suo, avrebbe dovuto prima guadagnare e poi godere i profitti del proprio lavoro.
Il successo di quest'idea era facile da verificare in quei giorni in cui appunto si riuniva il mercato grande, così grande che ormai lo si sarebbe potuto benissimo chiamare fiera. Il giorno prima il principe aveva condotto a cavallo la sua sposa in mezzo al brulichio delle merci ammucchiate, per farle notare come proprio lì montagna e pianura trovassero una felice occasione di scambio; e sempre in quella circostanza aveva saputo richiamarne l'attenzione sull'operosità che regnava nelle sue terre.
Se dunque in quei giorni il principe si era quasi esclusivamente trattenuto con i suoi collaboratori su quelle importanti questioni, lavorando senza tregua specialmente con il ministro delle finanze, per parte sua il capo dei cacciatori aveva ribadito anche lui i suoi diritti e, da come li aveva presentati, fu impossibile resistere alla tentazione di intraprendere in quelle belle giornate autunnali una battuta di caccia già più volte rimandata, e dedicare così a se stessi e ai molti forestieri appena giunti una festa rara e grandiosa.
La principessa restò malvolentieri al castello: da parte dei cacciatori ci si era ripromessi infatti di spingersi molto addentro fra le montagne per allarmare con un'inattesa spedizione guerresca i pacifici abitatori di quei boschi.
© Paolo Melandri (15. 3. 2018)
*
Padre e figlio
Era nella stagione che il vendemmiatore suol premere dalle uve mature il vino e che gli alberi si vedono in qualche luogo spogliati dei frutti, quando io, che in abito di sconosciuto pellegrino tra Novara e Vercelli a passi lenti e silenti me ne andavo, vedendo che già l'aria cominciava ad annerare e che tutto intorno era cinto di nuvole e quasi pregno di pioggia, cominciai a forzare più rapido il mio movimento e a darmi un tempo sostenuto di marcia. Ed ecco intanto mi percosse negli orecchi un latrato di cani confuso da gridi: e volgendomi indietro, vidi un capriolo che, seguito da due velocissimi veltri da lepre, già stanco e fiacco nel suo tardo andare, fu da loro sopraggiunto, così che quasi mi venne a morire innanzi ai piedi. E poco stante arrivò un giovinetto di età di diociotto o venti anni, alto di statura, di bell'aspetto, proporzionato di membra, asciutto e nerboruto, il quale, percuotendo i cani e sgridandoli, la fiera, che avevano scannato, tolse loro di bocca e la porse lietamente ad un villano, il quale, recatala in spalla, ad un cenno del giovinetto, innanzi, con veloce passo, si incamminò.
© Paolo Melandri (14. 3. 2018)
*
Lo sciame del mago
Il tempo passò a volo mentre mi dilettavo di quello spettacolo. Gradualmente penetrai nella costruzione, nel sistema dell'invenzione. Gli alveari erano disposti in lunga fila davanti al muro. In parte erano di forma tradizionale, in parte trasparenti, fatti, sembrava, della medesima sostanza delle api. I vecchi alveari erano abitati da api naturali. Probabilmente questi sciami erano lì soltanto per dimostrare la grandezza del trionfo sulla natura. Zapparoni aveva certamente fatto calcolare quanto nettare uno sciame può produrre al giorno, all'ora, al secondo. Ora lo collocava sul campo sperimentale accanto agli automi.
Ebbi l'impressione che egli avesse posto in imbarazzo gli animaletti dalla economia antidiluviana, infatti ne vidi spesso qualcuno volarsene via da un fiore che prima era stato toccato da un concorrente di vetro. Se invece il calice era stato visitato prima da un'ape vera, vi rimaneva sempre un piccolo dessert.
Da questo conclusi, senza alcuna difficoltà, che le creature di Zapparoni procedevano in modo più economico, cioè succhiavano in modo più esauriente. O forse, la forza vitale dei fiori si esauriva dopo che erano stati toccati da un pungiglione di vetro?
Comunque sia, l'evidenza insegnava che questa era un'altra delle fantastiche invenzioni di Zapparoni. Osservai poi il movimento davanti alle costruzioni di vetro che rivelava un metodo complesso. Credo che sia stato necessario l'intero corso dei secoli sino ai tempi nostri per indovinare il segreto delle api. Dell'invenzione di Zapparoni acquistai, dopo averla contemplata dalla mia poltrona soltanto forse un'ora, una concezione già precisa.
Gli alveari di vetro si distinguevano a prima vista dagli antichi per il grande numero di aperture. Non somigliavano tanto ad apiari quanto a centrali automatiche di telefoni. Non avevano poi autentiche aperture, infatti le api non vi entravano. Non vedevo dove si riposavano o venivano fermate o dove avevano la rimessa, infatti non saranno sempre state al lavoro. In ogni caso nell'arnia non avevano nulla da cercare.
Le aperture avevano piuttosto qui la funzione che hanno nei distributori automatici o quella dei fori di contatto in una presa elettrica. Le api vi si avvicinavano, attirate magneticamente, vi introducevano il pungiglione vuotandovi il nettare di cui avevano piena la piccola pancia. Poi ne venivano allontanate con forza quasi come proiettili. Era un prodigio che in questi viavai, nonostante la grande velocità del volo, non avvenissero urti. Sebbene la manovra fosse compiuta con un grande numero di unità, avveniva con perfetta precisione; doveva esservi un principio centrale che la dirigeva.
Evidentemente il procedimento naturale era stato semplificato. Così ad esempio era risparmiato tutto quanto riguardava la produzione della cera. Non c'erano né grandi né piccole celle e nulla che stabilisse la differenza tra i sessi, ogni cosa raggiava di uno splendore perfetto ma completamente privo di erotismo. Non c'erano né uova né larve, né fuchi né regine. Se ci si voleva attenere a una stretta analogia, Zapparoni aveva approvato e sviluppato soltanto un alveare di operaie neutre. Anche su questo punto aveva semplificato la natura, la quale già con l'uccisione dei pecchioni aveva osato una iniziativa economica. Sin dall'inizio egli aveva escluso maschi e femmine, madri e nutrici.
Se mi rammento bene, il nettare che le api succhiano dai fiori subisce diverse trasformazioni nel loro stomaco. Zapparoni aveva tolto anche questa fatica alle sue creature sostituendola con una chimica centrale. Vedevo come il nettare incolore iniettato attraverso i fori veniva raccolto in un sistema di tubi di vetro, nei quali gradualmente cambiava colore. Intorbidato sulle prime da una sfumatura di giallo, diveniva color paglia e arrivava al fondo con una stupenda tinta di miele.
La metà inferiore dell'apparecchio serviva da serbatoio o luogo di raccolta, che si riempiva a vista d'occhio della deliziosa sostanza. Potevo seguire l'aumento sulla misura incisa nel vetro. Se col binocolo osservavo i cespugli intorno e il fondo del prato, e poi riportavo lo sguardo sugli apparecchi, vedevo che il deposito del miele era salito di diverse linee.
Presumibilmente l'aumento e in genere il lavoro non venivano osservati soltanto da me. Distinsi un'altra specie di automi che oziavano davanti agli apparecchi o anche aspettavano come fanno i sorveglianti o gli ingegneri in una officina o in un cantiere di costruzione. Si distinguevano facilmente dagli altri perché erano color fumo.
Capitolo XIII.
Tutto preso da quello spettacolo, avevo completamente dimenticato che aspettavo Zapparoni. Però egli era presente come capo invisibile. Sentivo la potenza sulla quale lo spettacolo era fondato. Nel regno della tecnica, la tecnica diventava magia e non avvinceva tanto per il suo valore economico, e nemmeno per il suo significato politico, quanto per la parte di divertimento che vi si scopriva. In questi casi ci si accorge che siamo presi in un gioco, anzi in una danza dello spirito, che nessun'arte del calcolo può afferrare. Possiamo ricorrere soltanto all'intuizione, a un appello del destino.
I lineamenti del gioco sono più palesi nelle piccole che nelle forme gigantesche del nostro mondo. Agli occhi grossolani ha valore soltanto l'immenso, soprattutto quando è accompagnato dal moto. Eppure una zanzara ha tanti organi quanto il leviatano.
Era questo che mi avvinceva tanto al campo sperimentale di Zapparoni, così come dimenticai il luogo e il tempo come un bambino a scuola. Non pensai nemmeno che forse vi poteva essere pericolo: infatti spesso gli automi mi sibilavano accanto come proiettili. Si irradiavano fuori dagli alveari a fasci, per gettarsi sulla variopinta flora come un tessuto lampeggiante, e poi tornavano in rapido volo, frenavano, attendevano in fitto sciame che una raccoglitrice dopo l'altra venisse chiamata da impercettibili richiami, da invisibili segnali in rapido ritmo perché consegnasse il suo raccolto. Era uno spettacolo che affascinava e ipnotizzava insieme, e cullava la mente. Non sapevo che cosa mi stupisse di più, se la ingegnosa invenzione dei singoli corpi o il loro gioco combinato. Forse più di tutto mi deliziava la forza danzante dello spettacolo, potenza concentrata in ordine superiore.
Non vorrei trascurare una circostanza caratteristica di simili scoperte. Dopo avere osservato per un'ora intera con grande tensione tutte quelle evoluzioni, credetti di comprendere, non il segreto tecnico, ma il sistema dell'invenzione. Subito dopo, ne iniziai anche le critiche e meditai sui miglioramenti. Questa inquietudine, questa scontentezza è strana, sebbene conti fra le nostre caratteristiche. Supponiamo che in Australia ci capitasse di incontrare un genere di animali mai veduto, certo ci colpirebbe lo stupore, però non ci metteremmo subito a riflettere sul modo di perfezionarli. Questo indica la differenza dell'autorità creativa.
La critica è uno dei tratti fondamentali del nostro mondo; è in armonia col movimento. Entrambi sono indipendenti l'una dall'altro. Se la critica diminuisse, aumenterebbe la quiete dello spirito, e l'intelligenza diminuirebbe a beneficio dello sviluppo materiale. Intanto il processo non si lascia dirigere né in un senso né nell'altro: questo significa che sono in gioco potenze superiori.
Oggi ogni ragazzo al quale si regali una motocicletta fa della critica tecnica. Per l'invenzione di Zapparoni, dopo il primo stupore si presentava la questione del costo. Le creature di vetro davano l'impressione di automi di lusso: ciascuna doveva costare quanto una buona automobile, magari addirittura quanto un aeroplano. Certo dopo che fossero state perfezionate, Zapparoni le avrebbe prodotte in serie, come accadeva per tutte le sue invenzioni. Evidentemente con quello sciame, anzi forse con una sola ape di vetro, poteva in una giornata di primavera guadagnare più che con uno sciame naturale in un anno intero. Probabilmente potevano lavorare anche con la pioggia e di notte. Ma come gareggiare con la regina delle api, la Grande Madre, che ne partorisce a migliaia?
E inoltre le api non sono soltanto operaie in una fabbrica di miele. Senza pensare alla loro completa autonomia, il loro lavoro oltre all'utile manifesto ha una parte nei piani cosmici: comprende la loro funzione di messaggeri d'amore, che trasportano il polline, fecondano i fiori. Le vitree collettive di Zapparoni mi avevano dato l'impressione di succhiare i fiori senza riguardo e di usare loro violenza. Dove avessero scacciato i vecchi sciami, la conseguenza doveva per forza essere prima un cattivo raccolto, poi una misera fioritura e infine il deserto. Dopo alcune grandi incursioni non ci sarebbero più stati né fiori né miele, e anche le api si sarebbero spente, come si spengono balene e cavalli. E allora sarebbe stata ammazzata la gallina che aveva fatto le uova d'oro, abbattuto l'albero che dava le mele.
Bene, il miele era un cibo squisito, ma se si voleva accrescerne la produzione, non era faccenda che riguardava l'industria degli automi. Era piuttosto compito della chimica. Pensai ai laboratori, che avevo veduto nella Provenza, magari a Grasse, dove si estrae la sostanza profumata da milioni di fiori. Là c'erano foreste di aranci amari, campi pieni di violette e tuberose e azzurre piante di spigo che pendevano nella macchia. Con simili sistemi si poteva ottenere probabilmente anche il miele. Si potevano sfruttare i prati come i giacimenti di carbone, dai quali si trae non soltanto una sostanza combustibile, ma anche innumerevoli prodotti chimici, essenze, colori, medicine d'ogni specie, anche fibre tessili, conduttori elettrici ed elettronici. Mi sorprende che non vi avessero già pensato.
Naturalmente Zapparoni aveva meditato la questione delle spese già da molto tempo, altrimenti sarebbe stato il primo miliardario che non sapesse calcolare con la massima precisione. Già molti hanno imparato a proprio danno, quanto conosca bene il valore dei centesimi la gente ricchissima. Non sarebbero mai diventati così ricchi se fosse mancato loro quel dono.
C'era dunque da supporre che lo stabilimento avesse un significato, al di fuori della solita economia. Poteva essere il giocattolo di un nababbo, col quale si dilettava quando tornava dal campo da golf o dalla pesca. In un'èra della tecnica ci sono molti giocattoli tecnici. Addirittura dei milionari si sono già rovinati con simili giocattoli. Nel gioco non si stringono i cordoni della borsa.
Però la supposizione era troppo inverosimile, infatti se Zapparoni voleva sprecare tempo e danaro per i suoi menus plaisirs, il cinema gli offriva abbondanti occasioni. La Zapparoni Film era la sua grande passione personale. Là egli osava esperimenti che avrebbero portato ogni altro uomo all'asilo dei poveri. Così l'idea di far recitare degli automi, era naturalmente vecchia e nella storia del cinema era stata sperimentata molte volte. Però che fossero automi quelli così presentati, non era mai stato nascosto, quindi i tentativi si erano limitati al fiabesco o al grottesco, ad effetti consueti nel teatro delle marionette o della vecchia lanterna magica. Zapparoni invece voleva realizzare l'automa nel senso antico, l'automa di Alberto Magno o del Regiomontano. Voleva uomini artificiali in grandezza naturale, figure simili agli esseri umani. Tutti si erano divertiti a quell'idea, se n'erano sdegnati e l'avevano dichiarata la trovata di cattivo gusto di un uomo immensamente ricco.
Eppure tutti avevano sbagliato, infatti già la prima di quelle opere aveva fatto furore. Era una commedia di lusso per marionette senza marionettista e senza fili, la «prima» non soltanto di un nuovo lavoro ma di un nuovo genere d'arte. Certo le figure erano ancora un po' diverse dagli esseri umani, ma a loro vantaggio. Le facce erano più luminose, più immacolate, gli occhi avevano il taglio più grande, erano più simili a pietre preziose, i movimenti più lenti, più nobili e nel turbamento più rapidi, più violenti. E anche il brutto, l'anormale era interpretato in modo nuovo, piacevole o terrificante, ma sempre affascinante. Un Caliban, uno Shylock, un Quasimodo come Zapparoni lo presentava, non poteva esser stato generato in nessun letto, partorito da nessuna donna, per quanto strane fossero le strade in cui si fosse smarrita. E tra questi potevano esservi puri esseri magici, Golia, il nano Naso, l'archivista Lindhorst, l'Angelo dell'Annunciazione, trasparente, così che attraverso il suo corpo e le sue ali si vedevano gli oggetti.
Si poteva dunque dire che queste figure non imitavano semplicemente l'essere umano, ma lo conducevano oltre le sue possibilità, fuori delle sue dimensioni. Le voci giungevano a un'altezza che svergognava ogni usignolo, a una profondità che svergognava qualsiasi basso; movimenti ed espressioni rivelavano che la natura era stata studiata e superata.
L'impressione fu straordinaria. Si ammirava oramai con infatuazione ciò che alla vigilia si era deriso. Non voglio ripetere quel che affermavano i panegiristi. Vedevano nel nuovo teatro delle marionette una nuova opera d'arte che presentava tipi ideali. Certo bisognava tener conto dell'ingenuità dello spirito di allora, che afferrava le più audaci invenzioni come la bambina la sua bambola. I giornali compiangevano il destino di un giovane che si era gettato nel Tamigi. Aveva preso un'eroina di Zapparoni per una donna di carne e ossa e non aveva saputo sopravvivere al dolore. La direzione espresse il suo rammarico e lasciò trasparire che non sarebbe stato inconcepibile che la giovane robot avesse ascoltato il giovane. Egli aveva agito con troppa fretta, non aveva afferrato tutte le possibilità della tecnica. In ogni caso il successo fu tremendo e certamente coprì le spese. Zapparoni aveva la mano d'oro.
No, chi sapeva giocare con uomini artificiali, aveva un passatempo sufficiente. Non aveva bisogno di divertirsi con api di vetro. Quello in cui mi trovavo non era un cortile di ricreazione. Infatti vi sono altre regioni dove il danaro perde la sua importanza. Dovetti pensare alla conversazione col brasiliano che mi aveva detto una volta: «Non è ancora deciso chi sulla terra avrà il sopravvento, se l'uomo o la formica».
Certo, che quelle api di vetro raccogliessero miele, era un gioco. Era un compito assurdo per opere d'arte. Intanto con esseri capaci di questo, si poteva tentare quasi ogni cosa. Per quegli automi era più facile riportare granelli d'oro e diamanti che il nettare attinto dai fiori. Però anche per i migliori affari sarebbero costati troppo. Le assurdità economiche si compiono soltanto dove è in gioco la potenza.
E veramente il padrone di quegli sciami era un uomo potente. Era forse più potente di un altro che comandasse a un uguale numero di aeroplani. Davide era più forte, più intelligente di Golia.
© Paolo Melandri (8. 3. 2018) [Nota. L'opera nella sua interezza sarà partita in ventiquattro capitoli, più un epilogo.]
*
Le ombre della storia
Gli altri si misero ben presto a svolgere una attività straordinaria. Arrivavano notizie di loro dalle province baltiche, dalle Asturie e da molti luoghi, anche lontanissimi; non vi furono torbidi in cui non si facessero vivi. Compivano imprese prodigiose, ma non si poteva dire che il tempo li secondasse, o almeno lo faceva soltanto là dove insorgeva la reazione.
Cominciai allora a occuparmi di storia. Ero curioso di vedere se fatti simili fossero già accaduti in passato. Tra i personaggi storici mi attirava il giovane Catone, al quale non piacque la causa vincitrice, ma la vinta. Anche a me nel grande quadro mondiale le ombre parevano più significative e più profonde della luce; e il lutto la vera corona della contemplazione: Ettore e Annibale, indiani e boeri, Montezuma e Massimiliano del Messico. Certo anche questa era una delle ragioni del mio naufragio: la sfortuna è contagiosa.
© Paolo Melandri (3. 3. 2018)
*
Le ipotesi di Twinnings
Rimanevano i lavori rischiosi. Si viveva bene, con un ottimo trattamento, ma non si dormiva tranquilli. Twinnings ne esaminò alcuni, erano impieghi simili alla polizia. Chi non aveva oggi la propria polizia? I tempi erano incerti. Bisognava proteggere vita e proprietà; sorvegliare terreni e trasporti, difendersi da ricatti e da violenze. L'insolenza cresceva in rapporto diretto con la filantropia. Da un certo gradino della scala sociale in su, non ci si poteva più fidare della forza pubblica, ma bisognava avere un bastone in casa.
© Paolo Melandri (3. 3. 2018)
*
La vita scorreva calma
La vita scorreva calma, tranquilla, dolce e gentile, e benché di tanto in tanto fossi tentato di fare due chiacchiere con la padrona di casa, specialmente quando aveva l'aria preoccupata, riuscivo a vincere la tentazione in quanto, da una parte, temevo di impegolarmi nei problemi altrui, dall'altra volevo rispettare i segreti della sua vita. Volevo che i nostri rapporti fossero impersonali e trovavo più confacente al mio umore collocare il suo passato in una piacevole penombra. Se avessi conosciuto la sua storia, i mobili avrebbero assunto un carattere diverso da quello che io avevo deciso dovessero avere, e a quel punto la mia trama si sarebbe spezzata: sedie, tavolo, credenza e letto avrebbero costituito la scenografia dei suoi drammi, sarebbero potuti apparire dei fantasmi. No, ora queste cose erano diventate mie; le avevo ricoperte con la fodera del mio spirito e ora la scenografia doveva servire solo al mio dramma. Al mio!
© Paolo Melandri (2. 3. 2018)
*
Nuovi sintomi
A volte accade che siamo puniti per le nostre colpe da accadimenti che quelle stesse colpe non hanno affatto contribuito a causare: ed io ho sempre sentito questo come il più severo dei castighi. La ferita invero ha le stesse dimensioni; ma gli orli sono frastagliati, e c'è un cupo dolore di sottofondo che sopravvive a quello lancinante che esso ha contribuito ad aggravare. Perché si prova comunque un sentimento di consolazione nel cogliere una proporzione tra gli antecedenti e le conseguenze. A molti medici si è presentato il caso del paziente con sintomi strani e inusuali, più sconvolto e abbattuto per il fatto di riuscire inintellegibile a se stesso e agli altri, che non per il dolore e il pericolo della malattia; e addirittura anzi del paziente che riceve un sicuro conforto, e riacquista una feconda e duratura letizia al manifestarsi di qualche nuovo sintomo o effetto del male, che consenta di stabilire insieme il nome e la natura dell'affezione rendendola l'intelligibile effetto di un'intelligibile causa, pur se tale scoperta precluda all'istante ogni speranza di guarigione.
© Paolo Melandri (2. 3. 2018)
*
Lo Spirito di Diavolacci
Sia per gli Abiti che per la Legislazione, l'uomo non procede per semplice Casualità; egli è sempre guidato da atti misteriosi della mente. In tutte le Mode, in ogni foggia di Abiti, apparirà di continuo l'Idea Architettonica. Il Corpo e l'Abito rappresentano in luogo e la stoffa su cui e con cui dévesi costruire lo splendido Edifizio di tutto il suo Personaggio.
Che inceda con sandali leggeri e avvolto in mantello di drappo; che si dimeni graziosamente e che torreggi con alta acconciatura e con appuntati ornamenti sul capo; che si gonfi fra i ricami del colletto inamidato, fra imbottiture, bucheràmi e sbuffi mostruosi, o che si stringa ai fianchi, tanto da spezzarsi in due parti; o, vera Agglomerazione di quattro membra, sfidi ed affronti il mondo, egli dipenderà pur sempre dalla natura di quella tale Idea Architettonica; è indifferente che lo stile sia Greco, Gotico, del Rinascimento Italiano od affatto Moderno, di Zerbino Francese o Inglese.
Si pensi, inoltre, al significato racchiuso nel Colore. Dal più sobrio grigio borghese e calvinista allo scarlatto più vivace, nella scelta del Colore si spiegano le idiosincrasie spirituali: se il Taglio rivela l'Intelletto ed il Talento, nel Colore si rivelano l'Indole e il Cuore. In tutto ciò vi è un lavorìo incessante e infinitamente complesso di Cause ed Effetti, sia nelle nazioni che negl'individui. Ogni colpo di Forbici è determinato e regolato da influenze sempre attive, le quali non sono certamente invisibili, né inesplicabili ad una Intelligenza di ordine superiore.
Una Filosofia degli Abiti basata su Cause ed Effetti, come quella delle Leggi, formerebbe indubbiamente, per le Intelligenze Superiori, un piacevole passatempo, nelle lunghe serate d'inverno. Quanto alle Intelligenze Inferiori, come sono gli uomini, tali Filosofie mi sono sembrate sempre piuttosto inutili. Che cosa è infatti il grande Montesquieu se non un abile fanciullo che compili Lettere da un Libro Profetico geroglifico, il cui Lexicon giace nell'Eternità, nel Cielo? Che qualche Filosofo di Cause ed Effetti mi spieghi non perché io porti tale o tale altro Abbigliamento, perché obbedisca a questa o quella Legge; ma anche perché Io sono qui; perché porto qualche cosa ed ubbidisco a qualche cosa! Sopprimerò dunque molto, se non ogni parte, di questo Spirito degli Abiti, come cosa ipotetica, inefficace ed anche inopportuna; i Fatti nudi, le Deduzioni da ricavarne, con uno stile tutt'altro che profetico e onnisciente, ecco il mio umile e modesto compito.
Non ostante questa prudente restrizione, Diavolacci si è sforzato di occupare un campo abbastanza vasto e quasi illimitato, i cui confini oltrepassano, almeno spesso, il nostro orizzonte. Ahimè, povero, Diavolacci.
© Paolo Melandri (28. 2. 2018)
*
Adnotationes hebdomadariae
Ho sfogliato la Bibbia e mi è capitato Il libro di Giona dove il Profeta è costretto a vaticinare anche quando si nasconde.
Al mattino nevicata silenziosa.
Ho letto l'ultimo capitolo del Libro di Giobbe, dove Dio punisce Giobbe per la sua presunzione nel voler criticare la sua opera: Giobbe chiede perdono e viene perdonato.
Atmosfera tranquilla e grigia, fino alle 15.
Buio – Apatico, svagato, senza interesse. Non riesco a far nulla. Ho provato a scrivere sul sistema di Linneo ma ho perso l'interesse. Verso l'ora di pranzo ho sentito freddo, un brivido di morte. Ho mangiato controvoglia. Ho consultato la Bibbia e mi è capitato il libro di Giobbe; rimproveri per non aver creduto. Avrei voluto leggere il Libro dei Salmi ma ho sentito bussare alla parete.
© Paolo Melandri (21. 2. 2018)
*
La boa
Era come avere attorno a sé la propria atmosfera. Solo, si librava come in un altro corpo celeste, in un elemento che non era aria ma vapore acqueo, più piacevole e più fresco da inspirare dell'aria secca, con il suo inutile settantanove per cento di azoto, avanzato senza scopo apparente quando l'ordine della materia terrestre era emerso dai gas.
Non era una nebbia scura, color del fumo, ma un chiaro argento appena fuso dal quale filtrava la luce del sole. Calda come ovatta avvolse il suo io stanco, proteggendolo da urti e da pressioni. Godé per un po' di questo cosciente riposo dei sensi, senza suoni, senza odori, sentendo la sua mente tormentata rinfrescarsi nella sicurezza di non entrare in contatto con quella degli altri. Era sicuro di non ricevere domande: non avrebbe saputo rispondere, né parlare. Il meccanismo rimase immobile per un po', poiché tutti i cavi erano stati interrotti; poi ricominciò a pensare, con chiarezza, in maniera ordinata, a tutto quanto aveva vissuto. Ma quegli avvenimenti erano così subordinati, così meschini, che prima dové lasciar scorrere via l'acqua stagnante degli ultimi tempi perché poi sgorgasse pulita.
Da lontano sentiva suonare la boa a intervalli di diversi minuti. Seguendo il segnale, diresse la rotta diritta nella nebbia.
© Paolo Melandri (20. 2. 2018)
*
La gioia del giorno
La gioia del giorno, il giorno in fiore, un mattino d'agosto, con il suo umore e il suo rigoglio, tutto rilucente – e già, nell'aria troppo pesante, i tristi profumi dell'autunno – esplodeva a tutte le finestre dell'interminabile veranda dai vetri rossi e verdi. Era la gioia del giorno, e, per non so qual splendore perituro, era anche la gioia di un solo giorno, il giorno unico, così delicato, così fragile nella sua impeccabile serenità, in cui appariva per la prima volta, in cima all'ardente canicola, la bruma insidiosa che si trascinava ancora al di sopra dell'orizzonte, e che tra qualche settimana sarebbe discesa sulla terra esausta, sui prati dissodati, sull'acqua addormentata, con l'odore delle foglie secche.
© Paolo Melandri (19. 2. 2018)
*
Segni
Ma nessuno avrebbe mai pensato doversi adorare alla Marina le deità del lardo e del burro, che davano latte alle mammelle delle vacche; eppure ciò avveniva da parte di gente, che da tempo motteggiava la religione tradizionale e le sue cerimonie sacrificali. Quegli stessi spiriti che si erano ritenuti abbastanza forti per sottrarsi ai vincoli dell'antica religione degli avi furono soggiogati dalla magia di barbari idoli. E lo spettacolo offerto da simile traviamento era più ripugnante che non il vedere un ubriaco a mezzogiorno: costoro s'illudevano di alti voli e se ne gloriavano, mentre si avvoltolavano nel fango.
Un pessimo segno fu dato dall'estendersi della confusione profanatrice persino al culto dei morti. In ogni tempo la condizione di poeta era stata grandemente onorata alla Marina: i poeti vi erano ritenuti liberali dispensatori e il dono di foggiare versi era considerato come benefica sorgente di grazia. Se la vigna era florida e dava frutta, se l'uomo e l'animale prosperavano, se i venti malefici si disperdevano e serena concordia univa i cuori, tutto ciò era dono dell'armonia, che vive nei canti e nei poemi: anche l'ultimo vignaiolo n'era persuaso, ed egualmente che l'armonia contiene in sé una forza risanatrice.
Nessuno era alla Marina così povero da non inviare le prime frutta e le migliori del suo orto alle capanne dei pensatori e agli eremi dei poeti. E perciò chi si sentiva chiamato a servire allo spirito poteva vivere estraneamente alle faccende, in povertà, ma non bisognoso. Nella cordialità vicendevole tra coloro che lavoravano il campo e colui che coltivava la parola valeva quale comune ideale l'antico detto: gli dèi concedono a noi il meglio senza nostro merito.
L'influire visibile, già nel presente, della forza dello Spirito è il segno della bontà di un'epoca: e così avveniva alla Marina. Nel mutare delle stagioni e delle varie età dell'umana vita e nel consentaneo succedersi delle cerimonie religiose, ogni giorno festivo era celebrato dalla poesia. Ma specialmente spettava al poeta, nelle cerimonie funebri, dopo la benedizione del cadavere, l'ufficio di giudice dei morti, e a lui si addiceva di rivolgere alla vita ora compiutasi uno sguardo simile a quello degli dèi, e di celebrarla nel canto, come un palombaro toglie dalla conchiglia la perla.
© Paolo Melandri (18. 2. 2018)
*
Il Corno del Carnefice
Nella Campagna, all'incrocio tra i tratturi e i confini dei vari appezzamenti, si vedevano di solito le statue delle deità dei pastori. Queste deità, custodi dei confini, erano grossolanamente scolpite in pietre o in vecchia quercia, e già di lontano se ne indovinava la presenza dall'odore rancido, che se ne diffondeva. Infatti le tradizionali offerte votive consistevano in calde miscele di burro e di quel grasso di trippa che il coltello sacrificale poneva da parte. Sul verde prato, attorno alle immagini sacre, si vedevano quindi nere macchie di fuochi; e i pastori, compiuta l'offerta, toglievano dal fuoco votivo un ramo annerito, con il quale, la notte del solstizio, segnavano di un marchio il corpo così delle donne come delle bestie che speravano esser feconde.
Se noi incontravamo in questi luoghi le donne che venivano dalle mungiture, esse abbassavano sul viso il fazzoletto, che portavano in capo; e il fratello Ottone, amico e conoscitore delle deità campestri, non passava mai oltre senza consacrar loro una parola giocosa. Egli attribuiva loro una antichità immemoriale e le diceva compagne di Giove sin dall'infanzia del Dio.
Inoltre, e non lungi dal cosiddetto «Corno del Carnefice», si trovava un boschetto di salici piangenti, ov'era l'immagine di un toro con rosse narici, rossa lingua e il membro colorito in rosso: il luogo era malfamato e correvano voci che vi si compissero orribili orgie.
© Paolo Melandri (18. 2. 2018)
*
La ultima sera di Di Annunzio
L’ULTIMA SERA DI D’ANNUNZIO
Io non odo i miei passi. Io sono come
un’ombra; il mio dolore è come un’ombra;
è tutta la mia vita come un’ombra
vaga, incerta, indistinta, senza nome.
(G. D’Annunzio, “Un sogno”, vv. 13-16 [da
Poema paradisiaco])
Il primo marzo, verso sera, il ‘Comandante’ si trovava solo al tavolo di lavoro.
Di là, in biblioteca, stavano apparecchiando per la cena. Fra poco, sarebbe dovuto passare «di là» dove avrebbe avuto la sua porzione francescana di «asceta della parola». Ancora non aveva fame, ma era visitato da dolci ricordi, dolci e laceranti. Era da breve passato l’anniversario della «prima volta» con ‘Giusini’: «Giusini è come un fior di rosa bianca…». Oh ricordi! Cercò un foglio. Annotò qualche frase di perfezione indubitabile: «La carne non è se non uno spirito promesso alla Morte». Non l’aveva egli già scritta da qualche parte? Quante volte l’aveva egli scritta «con polso che non langue»? Non più gli sovveniva. Che gli importava? L’atto di scrivere era per lui ogni volta una creazione novella. Dallo spiraglio d’una finestra semichiusa entrava un soffio d’aria primaverile, che annunciava l’Eterno Ritorno e la Rinascita Certa:
«Marzo è giunto e febbraio
gito se n’è col ghiado.
Or lasceremo il vaio
per vesta di zendado».
Non così cantavano Biancofiore e Garsenda «per salutare il marzo» nella sua Francesca? Lo assalì il ricordo d’una pausa musicale nel tumulto di Fiume: l’opera di Zandonai interpretata da un tale Antonio Melandri di Faenza nel ruolo di Paolo1. Se ne ricordò con un sorriso appena percettibile tra i cascami delle guance sformate: il diavolo pareva aver impresso il proprio sigillo sulla figura di cera. Sorrise visibilmente: il taglio delle labbra conservava ancora qualcosa di arguto e di fresco. Rise d’un riso metallico come quello d’una mùcida salma. – La moglie di quel Melandri era donna gelosissima! – pensava. – Non fu lei che ad una prova fece una scenata al marito per via del bacio simulato alla fine dell’Atto Terzo? Oh il riso! – Si contorceva meccanicamente come il ranocchio morto attraversato dall’energia della pila di Galvani.
Non più rideva: altre impressioni si avvicendavano nella mente stanca per il duro esercizio mnemonico. Gli sovveniva di quando la sera della rappresentazione dell’opera aveva udite le parole di Francesca: «E la reìna vede il cavaliere…», e le lacrime gli eran piovute dall’occhio veggente e dall’occhio chiuso all’esterno, aperto all’«altro» suo mondo. Non era uno dei personaggi del suo dramma quel Malatestino dall’occhio leso che gli aveva suggerito alcune pagine tra le più crudeli della poesia? Si ricordava della pazienza dura della creazione. Aveva molto sofferto per Francesca. Molto, come Dante, avrebbe desiderato pregare per lei, se a qualcosa fosser valse le sue preghiere, se qualche dio avesse egli avuto da pregare per lei. «O figlio, e non v’è dio se tu non sei quello». Non aveva egli scritto così in calce al suo romanzo estremo? Non più gli sovveniva, non più voleva sovvenirsi delle parole precise. Ben gli tornava ne la memoria quanto avesse sofferto per la Riminese nella dimora ch’egli aveva avuta a Settignano del Desiderio tra cavalli e belli arredi: ogni sera, sul prato, veniva a trovare l’artefice, esausto dopo il lungo sfavillare diurno, una coniglia di bianco pelo dagli occhi luminosissimi in cui parevano specchiarsi le prime stelle; ed egli la careggiava, e in quel calice d’ebbrezza si sommergeva ogni suo pensiero amaro.
- O Settignano! – Il poeta non represse un sospiro. – O Rimpianto!2
«E l’Ellade è fra Luni
e Populonia».
Non aveva trovato là senza sforzo la vita e le abitudini d’un signore del Rinascimento? Non s’era egli presentato ad un ballo in casa Rucellai in costume di Enrico IV re di Francia? Era stato un ottimo lancio pubblicitario. Ora l’essere legato alle gesta ed al mito dell’uomo Gabriele d’Annunzio, del ‘Comandante’ Gabriele d’Annunzio, gli cagionava un intollerabile fastidio. Avrebbe dato le sue cose migliori: anche Alcyone, anche Maia, anche il Proemio alla Vita di Cola di Rienzo, ch’era tra la sue prose più ariose, e che pure la critica non ancora aveva riconosciuto, anche le Parabole del Bellissimo Nemico, ogni cosa, ogni cosa – pur di essere un prestante mozzo ventenne arso dal sole.
L’eroe di Alcyone ora si aggirava per le stanze del Vittoriale con passo malcerto. I disordini dello stomaco e dell’intestino non gli davano tregua. – Non potevo esser colpito più iniquamente, io digiunatore – pensò, e calcò mentalmente la parola. – L’aereo cantore di Alcyone s’è trasformato in bipede stercorario.
Si levò. Non più s’udivano dalla biblioteca i passi attutiti dei cauti servitori su i tappeti. L’effigie della Duse, lì sul tavolo, taceva, era muta. –Imbavagliata dalla morte – disse sottovoce. Accostò, non senza un fremito, le sue labbra gonfie alle labbra di gesso. Gli parve che le labbra di materia inerte vibrassero all’unisono con le sue irrequiete. Si scostò dal gesso, turbato: il cuore gli sfondava il torace angusto con l’insistenza del suo Corrado Brando esploratore munito di macete. Si appoggiò al malsicuro piedistallo ligneo: il gesso ebbe uno scrollo, ma non cadde né s’infranse. Egli l’avrebbe forse desiderato: «spezzate i flauti…» Stralunato nel volto tutto rughe, eppure gonfio, volgeva attorno con determinazione maniacale l’occhio veggente, sulla cui pàlpebra era un poco d’eczema, e quello non veggente, che lacrimando incrinava la purezza cerulea. – Spessate i phlauutii… - senza denti, con la lingua grossa tra le labbra rientrate, pronunciò a stento le parole del suo carme.
Aveva una terribile emicrania. La notte precedente aveva fino a tarda ora ‘ballato’ – o meglio ‘traballato’ – il tango in compagnia di una delle sue ben note ‘badesse di passaggio’. Le sue scarpe vecchie, male allacciate, tentarono qualche passo di danza sul tappeto impolverato. Anche la sua lindura, un tempo così esagerata ed ‘abruzzese’, aveva ceduto. I pantaloni e la giacca pesti apparvero in tutto il loro squallore mentre Gabriele li trascinava goffamente per la stanza illudendosi di volteggiare in un walzer. Si fermò. La testa girava orribilmente. Un vortice lo attirava sotterra. Vi si oppose. Si riprese.
E nuovamente si sedette alla scrivania. Regnava un eterno silenzio.
Udiva egli il tarlo clericato che «fa un cheto strepito rodendo piano».
Udiva il tarlo. O la tarma?3
Gli pareva che in una fessura della porta di quercia si fosse insinuato il mazzamurello di terra d’Abruzzi4. Ecco ora entrava. Gli piegava i libri, li sformava, li rifoggiava a guisa di leùti5.
Rise. I libri erano come tanti gatti spaventati che inarcassero la schiena irsuta.
Ecco il sogno svaniva: la stanza come prima. Da una magnolia del giardino cantava un assiolo.
Aperse un libro: esercitava la sua perizia di «maestro della parola» con il volgere mentalmente in «lingua di sì» le magistrali cadenze del suo ultimo libro di prosa, scritto in francese antico: lo faceva quotidianamente col suo Martyre de Saint Sébastien, con Baudelaire, con Rimbaud dal francese, con Erodoto e Tucidide dal greco, e con Seneca e Tacito dal latino. Ogni giorno si riservava una mezz’ora buona per dedicarsi ai ‘volgarizzamenti’, e alle ‘imitazioni’ (così si compiaceva di definire i suoi esercizi). Ars longa vita brevis! Solo adesso gli sembrava di saper scrivere, solo ora egli era certo di possedere l’arte difficile. Le sue prose di romanzi, esclusa forse l’ultima, gli recavano alla lettura un fastidio sordo ed un ineliminabile senso di sazietà. Leggeva:
‘Après quinze ans révolus, après la bonne guerre sans treves et ma trop longue aventure adriatique achevée dans le meurtre fraternel, je dédie cette sorte de fableau tour à tour choral dialogué dansable «aux bons chevaliers latins de France et d’Italie», pour opposer hardiment un lumineux témoignage d’amour à des ombres importunes.’
Volgeva senza sforzo:
‘Dopo quindici anni compiuti, dopo la buona guerra senza tregue e la mia troppo lunga avventura adriatica finita nell’uccisione fraterna, dedico questa sorta di canzon di gesta volta per volta corale dialogata danzereccia «ai buoni cavalieri latini di Francia e d’Italia», per opporre arditamente una luminosa testimonianza d’amore ad ombre importune.’
Il poeta proseguiva nella lettura delle pagine introduttive della sua colta opera, dove dichiarava di aver scritto «pour loiauté maintenir», ed evocava contro le nuove minacciose «ombres importunes» la memoria dei giovani Francesi morti tra Brenta e Piave, e dei giovani Italiani «ivres du sacrifice entier d’eux memes à défendre la montagne de Reims en vue des saintes tours», «ebbri del sacrifizio intero di sé medesimi per difendere il monte di Reims in vista delle torri sante».
Quel libro rivelava il suo mistero di poeta bilingue, affondava le radici nel suo amore per l’arte e per il mondo francesi (o, com’egli diceva con elegante allitterazione, «fraterni di Francia»): quell’amore che lo aveva condotto ad essere anche poeta di lingua e di ‘spirito’ francese, così come il suo «fratello maggiore» Giovanni Pascoli era stato anche (e forse soprattutto) poeta di lingua e di ‘spirito’ latino6.
Dopo una lunga dimestichezza con la letteratura francese in tutti i suoi aspetti, egli un giorno si era sentito ‘miracolato’ (come il protagonista del suo racconto in questione7), ed era d’incanto divenuto degno di cantare nel ritmo migliore di Francia, giungendo perfino a respirare l’atmosfera stessa delle canzoni di gesta e dei ‘fableaux’ arcaici. Non più aveva dovuto egli attendere che gli venissero la parola e il suono giusto con la pazienza lunga di un esperto ornitologo che attenda il richiamo prezioso dell’uccello da uccellare: ma le parole e le frasi gli eran venute ‘come vien l’acqua al cavo della mano’.
«Ecco la storia di San Giuliano l’Ospitaliero, come la si vede in una vetrata di chiesa del mio paese.» Non finiva così uno dei “Trois contes” di Gustave Flaubert? Non più se ne ricordava, non più voleva ricordarsi dell’esattezza.
A una grande vetrata di chiesa, divisa dai telai di piombo in infiniti scomparti, ciascuno dei quali, col trasparente mosaico delle lastre di vari colori, narra un differente episodio, e l’occhio, per discernerne i separati disegni e le leggende, deve un po’ alla volta abituarsi ai filtranti colorati chiarori, egli poteva paragonare la sua ultima e singolarissima opera.
Il poeta, ultimo fra gli spiriti di poesia capaci di dominare un mondo, mentre l’arte altrui si piegava all’episodio e non toccava più, se non a brevi istanti, i limiti dell’universalità, aveva tratto, da un itinerario entro i territori della memoria poetica, qualcosa che appunto doveva prender luce e colore come nei disegni di una smagliante vetrata fatta per sostenere, contro la luce, i gesti e le apparizioni di una leggenda inimitabile.
Non era la storia di San Giuliano. Se, della propria vita, Gabriele d’Annunzio aveva fatto un tempio, e ora lo ripercorreva, al centro della vetrata stava, e vi batteva in pieno, il raggio di sole, la figura di colui che ora amava chiamarsi “Guerri de Dampnes”. Il tempio, alla cui fabbrica, come nel malatestiano, avevano concorso, oltre che quelli di una fede, tutti i motivi di una vita e – per così dire – di una religione d’amore e di eroismo, splendeva del vario fiammeggiare di quei toni, sospesi laggiù, oltre al tenebrore delle navate, nella curva dell’àbside.
La vetrata celebrava il miracolo e i fatti memorabili del «sordo e muto che fu miracolato l’anno di grazia 1266». Trasformato volta a volta in baccelliere, in cavaliere, in giostratore, in beffatore di saracini, in nomade d’Oriente, in un inequivocabile presentimento di talune opere stupende di Italo Calvino e di Gianni Celati, il “Guerrin de Dampnes” andava, di scomparto in scomparto, tra le lamine dalle tinte smaglianti e il disegno tirato con morbido filo di piombo, narrando una canzone di gesta e di leggenda, così come gli si componeva musicalmente nella lùcida veglia del ricordo, assommando ore ed esperienze e sogni vari e lontanissimi, presenti ancora o dispersi nel tempo, fatti di un palpito dei nervi o di una meditazione erudita, di uno slancio canoro o di un ripiegarsi oltre la riva superata dell’oblìo.
«O souvenance…», gridava a un certo punto il poeta, svestendo le armi del miracolato dugentesco. Questo grido domina tutta la sua opera, umanissimo e profondo entro gli smalti e le porpore, entro i profumi e i suoni, dal labirinto donde Icaro non vuole uscire, assorto nelle magìe dello stile riflesse tra le cento e cento specchianti pareti delle pagine. «O souvenance…». E ci pare oggi che un’ebbrezza orgogliosa e malinconica lo avesse colto, riandando a questo che pure non era che un solo frammento della memoria di una vita senza eguali.
Anche Gabriele d’Annunzio, come già nelle Faville, ancora raccolte entro precisi schemi d’ordine, come già nel Notturno e nel Venturiero e nel Libro segreto, dove il disegno obbediva a ritmi sempre più segreti e modellati sui suggerimenti del ritmo creatore della lirica, faceva il viaggio «à la recherche du temps perdu», abbandonandosi ormai tutto all’impasto sinfonico di mille temi che sgorgavano in tumulto e si giovavano di accostamenti quasi sempre del tutto imprevedibili.
«O souvenance…». Un’armonìa incommensurabile gli saliva dalla sua vita. Ed egli l’ascoltava, lassù, chiuso nel silenzio della sua solitudine. Nasceva così “Le dit du sourd et muet”. Fui sordo e muto un giorno, diceva la finzione lirica. Vi dirò adesso come io abbia acquistato voce e udito. Il poeta scriveva il suo libro segreto. E la memoria voleva andare alle origini di quello che fu lo Stile.
Ora D’Annunzio non scopriva solamente un “segreto del mestiere”, ma ritrovava – nelle profondità della memoria china ad ascoltare gli echi anche più lievi che venivano dalle lontananze dell’anima, dalla zona dei sogni e da quella dove palpitano, ancora apparentemente informi, le nebulose che formeranno poi i mondi della nostra ispirazione – i segreti forse anche più rari del suo temperamento, il modular primo degli istinti, i riflessi più sommessi, quelli, come diceva a un certo punto nel suo libro, intrecciati coi fasci stessi delle vene e dei nervi. Di qui il motivo del viaggio, o dell’itinerario del “miracolato”, teso a riprendere, nota per nota, colore per colore, ritmo per ritmo, i motivi che avevano fatto di lui una sorta di figura bifronte delle due letterature, d’Italia e di Francia, non per pura maestrìa tecnica, ma per un’adesione che gli faceva riconoscere origini simili nell’animo dei due popoli, sotto l’insegna della buona Cavalleria e della primitiva poesia. Il “miracolato” valicava il tempo. Ritornava al Duecento. La finzione poetica era basata sulle fondamentali realtà spirituali dei due popoli. Non solamente egli vedeva simili le due lingue. Ma erano per lui eguagliate dall’«animo».
Il poeta poteva senza meraviglia, ricordando le rivelazioni della giovinezza, immaginarsi nella figura del sordomuto che aveva accompagnato Ser Brunetto, e preso le armi a fianco di Guglielmo d’Orange contro al Saracino per amore della bella gesta. Tornavano ora, una per una, le immagini di quell’itinerario che la fantasìa e il cuore avevano percorso. La luce le investiva. Il tempio della memoria ne era tutto colorato. Arcaiche figure camminavano accanto a quella del giovinetto che aveva acquistato la parola e l’udito sulla soglia della Santa Cappella, mirando i colori delle vetrate e udendo piangere il re Loys.
«Je ne sais. Les sublimes couleurs des vitraux me ravissaient comme des cantiques, me transportaient vers une indistincte annonciation du Chant que je n’entendais point, que je n’avais jamais ouï! Cependant je voyais les lèvres des chantres se remuer, les veines de la gorge s’enfler, les visages s’extasier. Et, comme ils chantaient au lutrin les antiennes dans la paradisiaque splendeur des vitraux frappées par le soleil, ils eurent pleine de l’éclat la bouche, ils en eurent jusqu’au fond du gosier, jusqu’au sommet du coeur. Ils entonnaient les rouges, ils modulaient les bleus élevaient les faunes diminuaient les violets. Et, sans ouir les voix, j’écoutais les couleurs chanter en des modes surnaturels, au delà de mes sens scellés, au delà de mon ame agrandie.»
In quel momento egli si sentiva un povero chierico errante, uno studente vagabondo tra il Tevere e la Senna, fra l’Ombrone e la Garonna. Ed ecco, fra le ombre della pineta della sua memoria, apparirgli le figure di due maestri della giovinezza, il francese Gaston Paris e l’italiano Ernesto Monaci, che aveva insegnato al poeta la filologia neolatina e aveva guidato i suoi studi per la tesi di laurea che comprendeva la Chanson de Roland, il Lai d’Eliduc, il Richeut e il Lai d’Aristote, il Roman de la Rose e Li livres dou Trésor di Brunetto Latini. Il demone della filologia riprendeva il grande innamorato e tiranno della parola.
Ed iniziava la giornata sibillina, fra le pinete di Arcachon. I pini, nella memoria, si trasformavano fino ad esser simili agli olivi, e Pallade veniva dal Mediterraneo alle Lande. Nell’inquietudine della memoria evocatrice il dolore e l’allegrezza prendevano la figura e il gesto di un’ultima “beneamata figlia di San Marco”, colei che «ne se plaisait à aucune ombre comme à l’ombre si humaine de l’olivier toscan».
Svanita questa, altre immagini percorrevano il crepuscolo della giornata sibillina, mentre il poeta tratteneva ancora fra le ciglia abbassate il miraggio della Grecia, della Toscana e della Siria. Si preparava al trapasso. Voleva forse rinunciare al genio. Voleva diventare il postumo di se stesso. Ed egli era stanco di essere “il padre putativo della fata Morgana”. Ma le Morgane lo seguivano. Eccolo sulle spiagge calabresi, e di Sicilia, riprendere al Normanno tutti i saraceni di Abu Abdalla Ased, riconducendoli sulla via dell’arcobaleno. L’odor d’Africa lo chiamava, quell’odore che «remonte du fond de je ne sais laquelle de nos jeunesses». Confessava: «Je suis comme une fable de là-bas, qu’on n’a pas encore narrée; et je crois que je ne oserais la raconter toute entière à ma tristesse».
L’ora del trapasso era vicina. E sarebbero stati chiamati, per aprir la fossa, i levrieri. Ed egli era pronto per la tumulazione. E voleva esser sepolto tra le radici di un ulivo.
E “Guerri de Dampnes” era, adesso, vagabondo per Parigi e per la Francia del Duecento, l’«escolier miraculé» fra tentazioni di trivio e taverne, tra brigate di ribaldi e di goliardi canori; memore appena dell’infanzia muta, e dei vigneti della sua terra prospera, quando, fanciullo, camminando tra i grappoli ancora acerbi gli pareva di vivere in una specie di favola incompresa.
«O souvenance…» La voce dell’onda aveva popolato i silenzi del fanciullo infelice.
Isole di madrepore circondate dai sogni eran le pagine che la memoria ricomponeva. E il poeta sfidava le leggi dell’equilibrio e della gravità. La parola diventava sospesa senz’ombra sulle immagini: «Je fus léger comme l’anémone de l’aube». Muoveva le fanciulle cariatidi dell’Acropoli, scopriva gli asfodeli di Palestina, si attardava accanto al sonno del gatto di Maometto, penetrava nei verzieri di Siracusa, in gara per riconoscere al profumo le fanciulle, guidato da immagini di lasciva incertezza, da larve di umido silenzio.
Il miracolato non temeva di morire.
Ed era ai limiti del sogno.
Aigiairn la straniera era vinta senza lotta, sotto il chiaro di luna, mentre lontano nitrivano in cerchio di magìa i destrieri. «De quel nom, douce, puis-je te nommer?»
Il ‘Comandante’ venne distratto dalle sue meditazioni dal gorgheggio squillante di un cardellino prigioniero in una gabbia nella stanza accanto. Egli aveva sempre amato quegli uccellini da molti ritenuti ‘insulsi’ e ‘stupidi’ e aveva sempre cercato d’intenderne il canto per trarne ispirazione alla sua poesia. Una volta s’era fatto perfino ritrarre fotograficamente davanti a una gabbia insieme al proprio traduttore Giorgio Hérelle: la fotografia era poi stata molto divulgata, ed ora dannunziani di tutt’Italia imitavano il suo gusto in questo caso un po’ piccolo-borghese.
Riprese a leggere:
‘Dans une page qui précède mon histoire de monseigneur Saint Sébastien, j’avouais candidement à mon faux frère Maurice Barrès mon émotion de bon ouvrier devant la qualité de la matière insolitement traitée, et mon ambition de mériter la parole voluptueuse de Francesco Francia dans l’acte de palper la statue de Jules II: «Questa è una bella materia».’
‘In una pagina che precede la mia istoria di messer Santo Sebastiano, confessai candidamente al mio fratellastro Maurizio Barrès la mia emozione di buon artiere dinanzi alla qualità della materia trattata in modo insolito, e la mia ambizione di meritare la parola voluttuosa di Francesco Francia nell’atto di palpare la statua di Giulio II: «Questa è una bella materia».’ Nel leggere, nel volgere queste parole di inequivocabile schiettezza il suo cuore paziente d’artista, avvezzo alla lunga fatica letteraria, ebbe un sussulto di autentico orgoglio. Egli era ben Francesco Francia, più Francese dei Francesi nella vita e nelle abitudini. Non aveva egli scritta la più bella lode della sua terra d’esilio?
Si ripeté interiormente le parole finali del suo Compagno dagli occhi senza cigli: - Nacqui alla gloria.
Cercò di ricordarsi il periodo completo:
«Ma l’anima ode lo schianto del pianto, e si torce indietro soffrendo nell’attimo e negli anni. Riode e rivede il compagno dagli occhi senza cigli, che singhiozzava a piè del letto, nel giorno delle rondini e del miracolo, nel giorno delle nubi e della bufera, nel giorno della ribellione e del coraggio e dell’orgoglio, quando senza di lui nacqui alla gloria.»
Quelle parole erano intensissime, le più intense forse che egli avesse mai scritte.
Alla faccia di quelli che mi tacciano di superficialità, alla faccia di abbaiatori e abbaiatorelli! – pensò. – Io me ne friego! – Poi, riflettendo:
Alla faccia del Dittatore che mi vuole svalorizzare (anzi, con pronuncia tribunizia, ‘sva-lo-riz-za-re’)!
Si ricordò della lontana sicurezza:
«Ei ciò non ode:
dedica l’opre al Tempo…»
O souvenance!
Addio, addio mio caro Dario!
Addio, amico! Addio, fratello!
E tornò a chinarsi sulle sue carte.
Aprì un libro su cui qualche anno addietro aveva annotato alcuni suoi versi improvvisati:
«Qui giacciono gli inutili miei cani,
stupidi ed impudichi,
novi sempre et antichi,
fedeli et infedeli
all’Ozio lor signore,
non a me uom da nulla.»
Sorrise. La poesia era datata 31 ottobre 1935. Si compiacque di continuarla: - Una bella matassa pei posteri! – rifletté beffardo. Gli era innata la passione per la burla. Continuò:
«Rosicchiano sotterra
nel buio senza fine
rodon gli ossi i lor ossi,
non cessano di rodere i lor ossi
vuotati di medulla»
Non sorrideva più. Non controllava la forte emozione. La mandibola inferiore gli era pervasa da un tremito che la scagliava violentemente contro la superiore, rendendo un suono d’ossa percosse e rosicchiate. Sussultò. Non vista la finestra s’era aperta e aveva lasciato entrare un fresco alito serale. Il fumo d’un incensiere appeso alla parete in prossimità dello spiffero s’agitava senza pace, e pareva cercare cercare la propria strada e non mai trovarla. Gli occhi del poeta si soffermarono distratti su di esso: ma non lo vedevano.
Si chinò sul foglio. Il chiurlo continuava a trar lai: - Chiù… chiù… - Rilesse l’improvviso e riprese a scrivere:
«Rosicchiano sotterra
nel buio senza fine
rodon gli ossi i lor ossi,
non cessano di rodere i lor ossi
vuotati di medulla
et io potrei farne
la fistola di Pan
come di sette canne
i’ potrei senza cera e senza lino
farne il flauto di Pan
se Pan è tutto e
se la morte è il tutto.»
Lo interruppe il suono lontano d’un pianoforte. Era Luisa8. Suonava una trascrizione della messa in do minore di Mozart. S’accompagnava col canto: - Christe eleison, eleison… La sua voce echeggiava limpida come quella di una cantante. Gabriele si sentì rinascere: – Non fe’ Volfando – così soleva egli appellare il sommo dei musici – non fe’ Volfando solfeggiare e gorgheggiare la consorte per prepararla al duro cimento? – si compiaceva (e da sempre, ma ora, nella “dolente sera”, maniacalmente, ché ogni suo vizio s’era accresciuto fino al grottesco) d’esser cruschevole – Io la mia compagna trovo apparecchiata al celeste concento senza prova alcuna di gorgheggi e di trémoli.
Il suono era ora svanito. La pianista verisimilmente si preparava alla cena. Fu lì lì per chiamarla a sé. Ma non lo fece: si sentiva ormai brutto e fastidioso. Nulla gli era rimasto della sua ben nota disinvoltura con le donne. Ora nel corteggiar le sue ‘badesse’ esperiva di nuovo la timidezza dell’adolescente. A che gli erano serviti i dolci anni di Roma? Ahimè!
Faceva freddo. Si alzò per chiudere la finestra.
Si fermò dietro i vetri socchiusi. Era in lui come un’attesa. Ed il suo fiato appannava il vetro e precludeva la vista dell’occhio veggente. Ma attraverso la nebbia del proprio fiato intravide egli la luna.
«O falce di luna calante…»9
Era la morte. Rabbrividì.
Chiuse con violenza i vetri. Non udì che bussavano alla porta per chiamarlo alla cena. I servitori si allontanarono silenziosi per non disturbare il lavoro del ‘Comandante’.
E tremava, tremava davanti a quelle imposte tarlate e sconnesse10.
Si ricordò di un verso omerico nella familiare traduzione del ‘suo’ Zvanì:
«Tu mi ricerchi il ritorno di miele…»11
Buttò l’occhio alla radice della magnolia illuminata solo dal mite lume della cheta luna: e Giovanni di San Mauro era lì, con la sua veste dei campi, la sua veste di contadino: il capo scoperto, il collo nudo. Lo guardava fisamente, lo guardava dentro il cuore; e sorrideva.
Gli risuonavano nella memoria i versi della “Canzone d’aprile” dell’amico:
«Fantasma tu giungi,
tu parti mistero.
Venisti, o di lungi?
ché lega già il pero,
fiorisce il cotogno
là giù»
L’uno chiamò il nome dell’altro. E dal fagotto informe dei panni stracchi del contadino si levò il braccio robusto che aveva brandito su per la balza12 la «piccozza d’acciar ceruleo»13. E dal corpo gracile del vecchio seduttore si levò un braccio tremante nell’estremo saluto.
Ed il vecchio s’accasciò su una sedia. Il suo cranio bellissimo, levigato dal pensiero e dall’ardimento, s’incrinò internamente. E in quello che seguì, nella vertigine d’ombra dove tutto ritorna per poi dileguarsi, l’amico gli apparve di nuovo. Ed egli lo abbracciò14.
© Paolo Melandri (1998-1999)
1 Il personaggio è realmente esistito: per i rapp. di d’A. con la cultura musicale faentina cfr. A. Zecchini, Carducci e d’Annunzio nella mia terra (pref. A. Sorbelli), Faenza (F.lli Lega), 1933. (Io ho attinto l’aneddoto – attestato anche da alcune preziose fotografie in mio possesso – che ritraggono A. Melandri [-Paolo] nell’atto di ricevere dalle mani di Francesca la coppa tempestata di gemme – da una verìdica tradizione di famiglia. Devo però precisare che il celebre tenore non fu –nonostante l’identità del cognome – mio consanguineo, sibbène conoscente de’ miei maggiori.)
2 Il poeta definiva la località «Settignano del Desiderio», che latinamente vale ‘rimpianto’.
3 Cfr. Soderini, Trattato degli alberi, citato dal Tommaseo-Bellini sub voce ‘tarlo’.
4Mazzamurello: spirito folletto.
5 Cfr. il Proemio alla Vita di Cola di Rienzo.
6 Ci atteniamo alla terminologia critica dell’epoca, registrando possibili cogitationes dannunziane.
7 L’opera cui alludiamo e che citiamo ripetutamente è Le dit du sourd et muet qui fut miraculé en l’an de grâce 1266, de Gabriele d’Annunzio qu’on nommoit Guerri de Dampnes.
8 Baccara, compagna del poeta.
9 Cfr. G. d’Annunzio, Canto novo (ed. 1882), II, x, 1.
10 Cfr. G. d’Annunzio, Notturno, I Offerta.
11 Cfr. Omero, Odissea XI, 90 sgg. La frase citata è al v. 100.
12 Cito da ‘Il commiato’ di Alcyone, con il quale d’Annunzio dedicava il libro all’amico.
13 Cito da Pascoli, Odi e inni, ‘La piccozza’, v. 30: ‘con la piccozza d’acciar ceruleo’ e v. 50: ‘la mia piccozza d’acciar ceruleo’. Anche d’Annunzio cita la iunctura pascoliana nella prima prosa della Contemplazione della morte.
14 Credo fermamente ad un’amicizia autentica (soprattutto da parte dannunziana) tra Pascoli e d’Annunzio, nonostante la famosa lite di cui tratta magistralmente A. Traina in I fratelli nemici. Allusioni antidannunziane nel Pascoli, «Quaderni del Vittoriale» 23 (1980), pgg. 229-240 (=Poeti latini e neolatini, ser. II, Bologna 1981, pgg. 241-250). Non diversamente mi è possibile interpretare la lunga affettuosa lirica conclusiva di Alcyone, piena di ‘echi’ pascoliani, percorsa da autentica ammirazione per l’amico-rivale, e le pagine commosse di Contemplazione della morte. A questa discussa amicizia, da sempre oggetto del mio più vivo interesse (e sulla quale, a dire il vero, son già stati spesi fiumi d’inchiostro), vorrò forse un giorno dedicare uno studio particolare (rintracciando, questa volta, allusioni filopascoliane nel d’Annunzio).
*
Esercizi di concentrazione
Esercizi di concentrazione,
una novelletta
Leggevo disteso nella penombra della mia camera quando mi accorsi d’essermi distratto osservando salire in alto il fumo della sigaretta, e disperdersi lassù in informi nebulose.
Che cosa poteva avere di interessante? – mi chiesi.
Il fumo saliva diritto nell’aria calma azzurro e luminoso come sempre – ma, davanti ai vetri della finestra, ecco il mistero: contro lo sfondo chiaro del cielo in lontananza il fumo si stagliava opaco e rosso-bruno.
Lungamente indugiai con lo sguardo sulle mutazioni di colore di quel fumo prodigioso.
La narcosi di mutevoli fantasticherie mi afferrava pian piano. E la coscienza si assopiva osservando il colore che muta, quando passa dall’oscuro alla chiarità solare.
E mi sembrava che qualcosa di me, qualche pensiero della consistenza di un arabesco di fumo, prendesse solidità.
Tralasciai di leggere, completamente indifferente a tutto. Non mi scossi neppure quando ebbi sentore che dovevano avere bussato alla porta.
Era l’uomo dalla lunga toga.
E non era un’allucinazione e nondimeno non era reale. Ma è strano che sia sempre il primo a venire quando, per l’orrore che s’accompagna sempre alla solitudine, e specialmente quando la si ama, sembra che nella mente qualche animale bisognoso di compagnia si diverta ad evocare fantasmi.
Un tempo l’uomo entrava senza preavvisi, quando eravamo in maggiore dimestichezza. Ora ostenta un certo distacco.
È un vecchio amico, di quelli che se ne hanno a male quando s’accorgono che preferite altri a lui. Ma si sa come succede: chi ci fu caro un tempo, a lungo andare, se si mantiene sempre lo stesso senza mostrarci via via lati nuovi e interessanti della personalità, finisce con l’annoiarci.
Era entrato per inveterata abitudine. Non sono io che lo cerco. Lui viene lo stesso, e perché m’accorga che non mi serba rancore, ogni volta bussa.
Ha una grande toga nera, sul petto una corazza, il volto coperto di bende; al posto degli occhi due cavità, buie. Dentro è tutto cavo: l’ho guardato.
La gente non ardisce di fissarlo in viso, per quell’orrendo vuoto. Ma lo ascolta volentieri, perché è alla mano, e ha buoni consigli per tutti.
Ma in quella cavità buia par davvero di dover sprofondare e morire. Io l’ho visto. Lo conosco. E per provare gli ho anche messo le mie dita sottili negli occhi, nel vuoto. Non c’è proprio nulla. Però la voce ha un timbro simpatico, suadente.
In genere i fantasmi riescono meglio nella voce, anche se molti di loro hanno la debolezza di volerla far risultare cavernosa a tutti i costi. Bisogna riconoscergli che non ha il cattivo gusto di farlo.
Mi hai chiamato? – chiese.
Non gli dissi di no: dispiace sempre l’offesa diretta.
Stavo appunto osservando – dissi – il fumo che sale…
… e che prima ‘sembra’ azzurro e poi ‘sembra’ rosso?…
Sì. E non so più perché, mi son messo a pensarci su.
Si sedette, o meglio si afflosciò in un ammasso informe. Non potevo ridere, così dovetti distogliere gli occhi. Non era sdraiato né stava appoggiato sul dorso; la stoffa leggera della toga avvolgeva la corazza come una coperta sinuosa che nessun occhio riusciva a penetrare. Quella via di mezzo tra forma e ammasso era ripugnante a vedersi. Disse, con tono di rimprovero:
A pensare per ore? e su sciocchezze del genere? Ah, una volta tu non eri così.
Una volta ti preoccupavi di spiegare, e basta: non facevi il moralista.
Lasciamo perdere…– disse con voce nasale – se t’interessa saperlo – e prese quel suo fare distinto – ex cathedra – quel che hai osservato non è che il fenomeno ottico dello «spettro d’emissione» e dello «spettro d’assorbimento»; per cui un gas o vapore di colore, poniamo, azzurro, diventa, interposto come un filtro a luce più intensa, di colore opposto. Vi è altro? A che pensi?… Oh, non ti pare sufficiente? Che altro cerchi? Beh, scusami se ho troncato le tue fumose elucubrazioni…
Era trionfante.
Avrei voluto dirgli: sei uno spettro. Dissi:
Ah! è così? Grazie.
Desideravo vivamente che se ne andasse. Così lasciai perdere le risposte che avrebbero potuto diventare i pericolosi prodromi di una discussione. Mi feci forza e non gli dissi quello che pensavo.
Detestavo i suoi discorsi da quando avevo scoperto che erano privi di una briciola di buon senso. Umanamente non valevano nulla. Erano ripugnanti alla mia filantropia. Nulla valevano quando bisognava applicarli alla prassi quotidiana.
Lui non potrebbe capirlo.
Vive solo in mezzo alle sue speciali ‘categorie’ – non ne conosce altre.
Fu di nuovo lui a rompere il silenzio.
Scusami – disse – se devo andare via. Ma ho un lavoro troppo interessante da finire.
Lo guardai mentre si allontanava tra i cipressi foschi del giardino.
Il giorno svaniva lentamente.
Se sapesse la verità – pensai – di certo non potrebbe sopravvivere.
Dal mozzicone nel portacenere si alzava sempre il tenace filo di fumo.
Dovrei accendere la luce – pensai. Ma non mi andava d’alzarmi.
Devo uscire da questo cerchio – mi dissi – sì, devo uscirne, ma senza schivarlo.
E mi levai in piedi.
© Paolo Melandri (1997 ca.)
*
La Passione secondo San Giovanni
Ho riletto il racconto della Passione nell'Evangelo di San Giovanni. Quante volte mi sono accinto ad affrontare l'argomento, e ne ho tremato! Mi sembra che nessuno fino ad oggi abbia rappresentato con la potenza e la vastità necessarie quell'intima tragedia (la più chiusa e profonda ch'io conosca) la quale incomincia dal punto in cui subitamente, come il nùvolo sui monti di Moab alla fine dell'estate, viene sul figlio dell'uomo l'ombra della morte. Nel portico di Salomone, ricorrendo la festa della dedicazione di Gerusalemme, ai Giudei che l'attorniano ostili dichiara: «Io e il Padre siamo una medesima cosa». I Giudei levano le pietre contro di lui per lapidarlo. Egli riesce a scampare dalle loro mani; e se ne va nascostamente di là dal Giordano, al luogo dove Giovanni prima battezzava. E quivi dimora per fuggire quelli che vogliono pigliarlo. La certezza della morte prossima e violenta gli appare quando appunto egli confonde se stesso col Padre, quando dice: «Se io non faccio le opere del Padre mio, non crediatemi; ma se io le faccio, benché non crediate a me, credete alle opere, acciocché conosciate, e crediate che il Padre è in me, e che io sono in lui.» Incrollabilmente egli crede nel suo messiato, ha profonda coscienza della sua dignità messianica; ma ecco che la persecuzione e la morte lo sovrastano, ecco che sta su lui la possibilità di disparire, prima che il Regno sia instaurato, ecco che egli mandato da Dio deve conciliare nel suo spirito sbigottito l'accettazione del patimento e del supplizio con la perfezione del suo compito regale. Qui comincia la sua meravigliosa angoscia; e qui veramente la forza del dramma ci afferra alle viscere.
© Paolo Melandri (26. 1. 2018)
*
Allegro moderato
La memoria crede prima che il conoscere ricordi. Crede più a lungo di quanto rammenti, più a lungo perfino di quanto il conoscere immagini. Conosce ricorda crede un corridoio dentro un grande lungo complicato edificio buio, freddo e rimbombante, fatto di mattoni rossi intristiti dalla fuliggine di tanti altri comignoli oltre ai propri, in mezzo a uno spiazzo recintato ricoperto di cenere compressa, senza un filo d'erba, circondato da sobborghi tutti fabbriche fumanti e chiuso in una rete d'acciaio e fil di ferro alta tre metri, come un penitenziario o uno zoo, dove con infantili trilli di passeri, a erratiche folate improvvise, orfani nelle loro identiche uniformi di denim blu, dentro e fuori dal ricordare ma nel conoscere immutabili come i tetri muri, le tetre finestre su cui con la pioggia la fuliggine dei comignoli ogni anno più incombenti colava come lacrime nere.
© Paolo Melandri (16. 1. 2018)
*
Mater
Mia madre mi ha voluto. Mi conosceva, quando mi portava nel suo grembo. Mi conosceva meglio di quel che io stesso potrò mai conoscermi, arrivassi anche a cento anni. Mi voleva, qualsiasi fosse la mia futura evoluzione fisica, mentale, etica, mi voleva così come sono. Fossi nato idiota, storpio o assassino, mi avrebbe amato in modo ancora più fervido. Le lacrime di lei sono più preziose dell'orgoglio del padre, quando vede il figlio varcare la soglia incoronato di alloro.
© Paolo Melandri (13. 1. 2018)
*
Occhio e forbice
È possibile tracciare un disegno della forbice, ritrarla in posizioni diverse: come un coltello che si apre e di nuovo si richiude. Un modello che si presta ad essere mostrato come un'ombra su uno schermo luminoso: un'immagine muta che dà però dimostrazione delle molteplici realizzazioni mandate a effetto attraverso il suo aprirsi e chiudersi. Una potenzialità semplice, una possibilità illimitata. Si pensa in primo luogo alla tenaglia, poi, in modo molto generico, alla forma fondamentale del gesto che afferra. Di parrucchieri, censori, strateghi, si dice che danno colpi di forbice. Un esercito all'attacco viene «sforbiciato».
La forbice che non taglia può anche comparire in un'opera d'arte, per esempio in un ritratto di famiglia. Una brava donna di casa tiene volentieri accanto a sé un paio di forbici; a differenza dell'originale, non c'è bisogno che la sua raffigurazione sia troppo precisa.
Ci sarebbe qui da aspettarsi l'obiezione che chiama in causa il Surrealismo, in cui è appunto la precisione ad accampare pretese di stile. È proprio quanto la distingue da una semplice riproduzione, anche da quella fotografica. È pur vero che vi sono, tra i fotografi, registi che non si limitano a copiare l'oggetto, ma lo dispongono in una sua dimensione.
L'incremento di senso non dà forza alla realtà, ma la scuote. Desta perciò l'impressione che si debba tornare a guardare con attenzione. L'intelletto avanza pretese che sono indebolite dall'opera d'arte. È probabile che questa sia la ragione per cui De Chirico si è allontanato dalla sua opera giovanile.
L'altra faccia della medaglia è il rifiuto dell'oggettività. Per l'occhio educato a guardare gli oggetti è arduo dare un giudizio sul livello dell'esecuzione. Si potrebbe raggiungere il punto in cui la forbice scompare come oggetto e viene tuttavia conservata come motivo: questo ci porterebbe vicini alla musica. L'unicorno spunta fuori dall'ombra.
© Paolo Melandri (8. 1. 2018)
*
Uno sguardo laggiù
Talvolta, dopo essermene stato per un certo tempo solo e in disparte dal mondo, un po' dimentico di essere un'anima priva di pace, faccio a occhi aperti sogni ora labili e simili a ombre, ora vividi e di solido aspetto, come la materia del mondo che calpesto. Siano labili o vividi, non è mai in mio potere di alterarli in modo alcuno. Essi hanno una loro volontà, e sciamano a onde di qua e di là, cangiando in accordo ai suoi ordini. Un giorno mi baluginò davanti un immenso abisso di tenebre, intorno al quale correva un parapetto in tondo, e sul parapetto sedevano scimmie innumerevoli che mangiavano pietre preziose dal palmo delle mani. Le pietre dardeggiavano cremisi e verdi, e le scimmie le divoravano con appetito insaziabile. Compresi che vedevo là il mio stesso Inferno, l'Inferno dell'artista, e che tutti coloro che avevano mangiato cose mirabili e belle, con sete troppo avida, avevano perduto pace e forma ed erano divenuti informi e volgari. Con lo sguardo sono sceso negli Inferi degli altri, e in uno ho visto un Pietro infernale, con una faccia nera e labbra bianche, che pesava su una curiosa bilancia a due piatti non solo le cattive azioni commesse, ma anche le buone azioni non fatte o fatte male, di certe ombre invisibili. Potevo vedere i piatti alzarsi e abbassarsi, ma non riuscivo a vedere le ombre che sapevo essere in folla intorno a lui. In un'altra occasione vidi una quantità di dèmoni di tutte le forme: pesci, serpenti, scimmie, cani, seduti intorno a un abisso nero come quello del mio Inferno, che guardavano il riflesso lunare dei cieli riverberante dal profondo dell'abisso.
© Paolo Melandri (7. 1. 2018)
*
La brezza verso la capanna
Ultimamente ho continuato a ripensare al giorno perenne dell'estate nei mari del Sud. Me ne sto qui seduto e ci penso, e penso a una capanna, e mi metto a scrivere qualcosa per ingannare il tempo e per mio diletto. Il tempo è così lento, non riesco a farlo scorrere in fretta come vorrei, anche se non c'è nulla che mi addolora e vivo la più allegra delle vite. Sono contento di tutto, e con i miei quarantatré anni non sono certo vecchio. Qualche giorno fa ho ricevuto per posta due piume d'uccello da un luogo lontano, da una persona che non era tenuta a mandarmele, due verdi penne d'uccello in un foglio di carta da lettera ornato con una corona e sigillato con un'ostia. Anche la vista di due penne d'un verde così diabolico mi dà gioia. Del resto nulla mi tormenta se non di tanto in tanto un po' di reumatismi al piede sinistro, strascico di una vecchia ferita d'arma da fuoco ormai rimarginata.
Ricordo che due anni fa il tempo scorreva in gran fretta, incomparabilmente più in fretta di adesso: un'estate finì senza che nemmeno me ne accorgessi. Fu due anni fa, nel 20** – voglio metterlo per iscritto per mio diletto –, che qualcosa mi accadde, oppure lo sognai. Ho dimenticato ormai molte cose che hanno a che fare con quegli avvenimenti, perché da allora non ci ho quasi più pensato, ma ricordo che le notti erano piene di luce. Tante cose, del resto, mi apparivano stravolte: l'anno aveva dodici mesi, ma la notte diveniva giorno e non si vedeva mai una stella in cielo. E la gente che incontravo era particolare, di natura diversa dalla gente che conoscevo prima: bastava loro una notte perché, da bimbi quali erano, sbocciassero in tutto il loro splendore, maturi e perfettamente adulti. Non era una stregoneria, ma io non avevo mai visto niente del genere. Ah, no davvero.
In una grande casa verniciata di bianco, giù in riva al mare, incontrai una persona che, per breve tempo, tenne occupati i miei pensieri. Non ce l'ho sempre in mente, non più, no, anzi l'ho proprio dimenticata; ma ripenso a tutto il resto, ai gridi degli uccelli marini, alla mia caccia nei boschi, alle mie notti, a tutte le calde ore dell'estate. D'altro canto, fu per puro caso che la conobbi, e senza quel caso non sarebbe stata nei miei pensieri un solo giorno.
Dalla mia capanna potevo vedere un intrico di isole, isolotti e di scogli, un po' di mare, qualche vetta azzurrina, e dietro la capanna si stendeva il bosco, un bosco immenso. Io mi sentivo colmare di gioia e di gratitudine al profumo delle radici e delle foglie, del grasso aroma del pino che ricorda l'odore del midollo; solamente nel bosco tutto si placava in me, la mia anima diveniva imperturbabile, carica di energia. Giorno dopo giorno salivo sui monti con Esopo al fianco e non desideravo altro che continuare a salire lassù giorno dopo giorno, anche se metà del terreno era ancora ricoperto di neve e di molle fanghiglia. Il mio unico compagno era Esopo. Adesso ho Cora, ma a quei tempi avevo Esopo, il mio cane, che poi uccisi con un colpo di fucile.
Spesso, di sera, quando tornavo alla capanna dopo la caccia, una gradevole sensazione di trovarmi a casa mi faceva correre i brividi per tutto il corpo, e dava al mio animo un dolce tremito, e allora mi mettevo ad andare su e giù parlando con Esopo, e gli dicevo quanto stavamo bene. Ecco, adesso ci accendiamo un bel fuoco e ci arrostiamo un uccello qui sul focolare, dicevo, che ne pensi? E quando tutto era pronto e avevamo mangiato entrambi, Esopo strisciava fino al suo posto, dietro al focolare, io mi accendevo la pipa e mi sdraiavo un po' sulla branda ad ascoltare il pigro mormorio del bosco. Spirava un vento leggero, la brezza scendeva verso la capanna e io distinguevo con chiarezza il chiacchiericcio del fagiano di monte, lassù sulla cima alle mie spalle. Per il resto era tutto silenzio.
E spesso mi addormentavo così, disteso, vestito da capo ai piedi, e non mi risvegliavo finché gli uccelli marini non cominciavano a gridare. Allora guardavo fuori dalla finestra e vedevo i grandi edifici bianchi della base commerciale, le banchine della città, il negozio dove compravo il pane, e me ne stavo sdraiato ancora un po', stupito di trovarmi lì in una capanna, nei mari del Sud, ai margini del bosco.
Poi Esopo, vicino al focolare, scuoteva il lungo corpo magro facendo tintinnare il collare, sbadigliava, scodinzolava, e io saltavo giù dalla branda dopo quelle tre, quattro ore di sonno, perfettamente riposato e pieno di gioia per tutto, per tutto.
Così passarono molte notti.
© Paolo Melandri (3. 1. 2018)
*
Il sogno del mondo
In questi giorni, sulla costa, sul Mediterraneo, deve essere magnifico. Ma se non si può partire per destinazioni lontane, si scoprano almeno i dintorni, come la radura della foresta di Camaldoli. Ora si ode il tamburello del picchio e, subito dopo, il suo richiamo, mentre perlustra un altro angolo del bosco. Intanto il cuculo svolazza, le allodole girano vorticosamente sulle superfici dei campi, la poiana si dondola come su desolate distese primordiali. Da queste parti, i più vecchi in gioventù hanno visto perfino la cicogna nera.
Qui anche oggi regnava una grande pace. Le angustie sembrano molto lontane. I fiori sono più forti, più reali. Tra i pini era spuntata l'erba, e nel terreno umido sbocciavano grandi orchidee pallide, l'iperico, i lupini azzurri.
Sulla via del ritorno, nella brughiera, ho visto una grossa ammofila portare una larva fino al suo nido. Non la trascinava camminando all'indietro, come scrivono certi autori, ma aveva afferrato la preda con le mascelle e le zampine anteriori e correva sulla sabbia tenendola stretta, come se fosse a cavallo di un bastoncino. Lo spettacolo aveva tutte le caratteristiche degli incontri tra erbivori e carnivori: da una parte il predatore estremamente mobile nelle sue articolazioni, il corpo segnato di nero e rosso vivo, correva di qua e di là come una fiamma; dall'altra la vittima, di un verde smorto, paralizzata, giaceva come un'ombra sotto di lui.
Alla vista di questa scena mi è tornato alla mente ancora una volta il pensiero: perché mai nel primo caso di omicidio è stato il contadino a uccidere il pastore e non viceversa? Fuit autem Abel pastor ovium et Cain agricola.
Una pallida aureola dorata orlava la mezzaluna, cinta a sua volta da un cerchio del colore di un opale latteo. In mezzo, come la membrana di un tuorlo, un bruno anello di picrina. Anche il paese e i campi erano immersi nei colori lunari. Per cogliere la ricchezza che traluce dovremmo avere l'occhio della sfinge dell'oleandro. Il planare morbido di questi animaletti fa intuire l'esistenza di un mondo di piaceri sopraffini, con suoni, profumi e colori che la nostra scala non può raggiungere. Le saturnie e le catocale svolazzano sulle aiuole di violette, umide di nettare; il sogno regna sul mondo.
© Paolo Melandri (1. 1. 2018)
*
Piccoli borghesi
Era il millenovecentoventicinque. Stavo ancora dormendo quando verso le nove fui svegliata dal campanello della porta. Feci finta di non sentire e riaffondai la testa fra le lenzuola. Ma il campanello suonò di nuovo con insistenza. Fui costretta ad alzarmi, ad infilarmi la vestaglia e ad aprire la porta: era Carlo.
Non vedevo mio padre da molto tempo. La sua presenza mi aveva sempre turbato, ma quel giorno il suo aspetto che era cambiato sensibilmente dall'ultima volta che lo avevo incontrato mi spaventò.
Entrò in casa e mi guardò con un senso di soddisfazione orgogliosa, di complicità timida e di falsa umiltà.
Dopo il mio ritorno dall'America non l'avevo più visto. Lo guardai con il vecchio terrore che avevo sempre voluto trasformare in odio e che ora si mescolava ad una strana angoscia.
Carlo, povero Carlo. Che cosa ti è successo? Il tuo destino si sta dunque compiendo sino in fondo? Il cappotto era in cattivo stato, il viso pallido e smorto, lo sguardo sperduto nel vuoto.
Tuttavia aveva conservato un briciolo del suo modo di fare brillante e guardava le cose che si trovavano intorno a lui con un'aria falsamente allegra. Quello sguardo gettò sulla mia esistenza una luce inquietante.
In un angolo dello studio che formava tutto il mio appartamento il letto era sfatto e attraverso la porta semiaperta si poteva vedere un fornelletto elettrico vicino alla vasca da bagno. Il tappeto era frusto, le lenzuola non troppo pulite e ai piedi del letto erano accatastati confusamente libri, manoscritti, il telefono e un portacenere pieno di cicche.
Devo dire però che c'erano anche alcuni fiori stupendi e un magnifico nudo di Segonzac appeso alla parete. D'altronde lo studio era decoroso ed arredato con un certo gusto.
Lo sguardo di Carlo, che si soffermava lentamente su ogni oggetto, pareva esprimere un senso di complicità per il disordine; quando invece si posava su di me esprimeva un sentimento di orgoglio. Non era più venuto in casa di sua figlia da quando lei si era sposata ed era la prima volta che la vedeva in quello stato, mezzo svestita, con il corpo di una donna matura di trent'anni. In che cosa poteva assomigliare la mia pelle alla sua? Infilai una vestaglia meno trasparente sulla prima e mi annodai un foulard intorno al collo. La mia pelle era di una qualità superiore a quella di una qualsiasi Rosa, di cui Carlo era andato tanto orgoglioso.
© Paolo Melandri (30. 12. 2017)
*
Come la risacca
Tra la varietà dei possibili movimenti vi è quello della pulsazione che alterna l'inizio alla fine: ogni strada può essere ripercorsa al ritorno. A ogni separazione fa seguito un'attrazione, come un rimpianto. Una perdita sarà compensata, da una nascita o da una morte.
Negli esseri più grandi come in quelli più piccoli è serbata una forza pulsante, in essi continua a vibrare il moto dell'origine. Nel cosmo, che sorge e tramonta, il tempo pronuncia la sua preghiera, come in ogni girasole.
La vita svolge il suo corso e ritorna, come il frangente: l'onda ricade e ritorna a gonfiarsi, riacquistando la sua forza originaria. Vi si presti attenzione, considerando la concentrazione di tempo che la coscienza non può sciogliere e che, tutt'al più, riesce a trasformare. L'onda si trasforma in luce.
© Paolo Melandri (24. 12. 2014)
*
Nello spazio di uno sguardo
Di là dalle pianure di flanella, i grafici d'asfalto e gli orizzonti di ruggine sbilenca, e di là dal fiume tabacco sormontato da alberi piangenti e monetine di sole che filtrano sull'acqua della foce, nel punto oltre il frangivento, dove i campi incolti rosolano striduli al caldo antimeridiano: sorgo, farinello, leersia, salsapariglia, cipero, stramonio, menta selvatica, soffione, setaria, uva muscadina, verza, verga aurea, edera terrestre, acero da fiore, solano, ambrosia, avena folle, veccia, gramigna, fagiolini spontanei invaginati, tutte teste che annuiscono dolcemente a una brezza mattutina che è la morbida mano di una madre sulla guancia. Uno strale di storni scoccato dalle stoppie del frangivento. Il lucore di rugiada che resta lì a svaporare tutto il giorno. Un girasole, altri quattro, uno chino, e lontani cavalli rigidi e immoti come giocattoli. Annuiscono tutti. Suoni elettrici di insetti indaffarati. Sole biondo birra, cielo pallido e volute di cirri così alte da non fare ombra. Insetti indefessamente indaffarati. Quarzo, selce, scisto e croste di condrite ferrosa nel granito. Terra antichissima. Guardatevi intorno. L'orizzonte tremola, informe. Siamo tutti fratelli?
Ma ecco i corvi solcare il cielo, tre o quattro, non a stormo, in volo, silenziosi e malintenzionati, si dirigono verso il grano puntando al filo spinato del pascolo oltre il quale un cavallo annusa il sedere di un altro, che si premura di alzare la coda. La marca delle tue scarpe impressa nella rugiada. Un refolo di erba medica. Le lappole sui calzettoni. Secca frizione in un canale sotterraneo. Filo spinato rugginoso e pali sghembi, più simbolo di reclusione che recinto vero e proprio. «Divieto di caccia». Il fruscio della statale di là dal frangivento. Le mucche sparse al pascolo rivoltano tortini di terriccio per raggiungere i vermi, le sagome dei vermi impresse nel letame capovolto che induriscono cuocendo tutto il giorno al sole e non vanno più via, minuti solchi evacuati a schiera e spire inserte che non si chiudono perché la testa non tocca mai la coda. Leggete questo.
© Paolo Melandri (19. 12. 2017)
*
Gli uomini e le rovine
Ciò che voglio dire è che ci troviamo immersi nella corrente e che le sue acque scorrono lentamente e sono spesso opache, oggi la corrente si avvia verso un'ansa dell'anima: niente causalità, niente psicologia e niente pensioni, persino gli animali si sentono portati alla contraddizione: i gatti sono sazi di topi e gli zigoli si scrollano con disgusto davanti ai vermi. Viceversa rimane una certa unanimità per quel che riguarda le tonalità di scialli e borse in questo fine stagione, tonalità cannella, zenzero e ambra, i lobi delle orecchie vengono ricoperti di grossi orecchini e il Rouge baiser e l'After Shave Lotion rifioriscono già in quantità sufficienti uscendo dalle rovine.
© Paolo Melandri (14. 12. 2017)
*
In città
Una giornata nella casbah, da un mattino all'altro; e intanto, ho parlato poco di quanto riguarda il servizio.
La lunghezza di una giornata non è stabilita dall'orologio. Dipende dalla nostra fantasia, dal gioco dei nostri pensieri. Le immagini abbreviano il tempo, poiché esorcizzano la noia, moltiplicando nel contempo i contenuti. L'ideale sarebbe un attimo in cui il tempo si concentra, anzi si annulla, e tutto diventa possibile. La luce guadagna in forza, diventa assoluta.
Questa mattina viene anche il cambio di turno. Faccio le consegne di tutte le scorte al bar, deposito la mia divisa e la chiave dell'office. Lo studio rimane chiuso durante la mia assenza: il Grande Luminar è cosa segreta.
Posso adesso avviarmi in città; sull'altura della rocca vi è già un buon tepore. Il sentiero che ne discende taglia le anse dello stradale: indica come una freccia rossa la direzione del porto. Verdi lucertole lo attraversano furtive, scomparendo in mezzo alle euforbie. Le spine non le intralciano. Ho in tasca il salario e giocherello con le monete d'oro. Farò tappa al porto.
Latifah mi attende; l'ho fatta avvisare da Madame Posa. Latifah stessa non può ricevere ordini; possiede soltanto il fonoforo grigio, ch'è limitato a comunicazioni ufficiali dalla casbah e che consente solo di ascoltare ma non di trasmettere. Se, nell'ambito della nostra società atomizzata, si sono conservati residui di una gerarchia di classe o di casta, è in tal modo che si manifestano. I diritti sono di natura dinamica: si fondano sul potere e non sulla proprietà.
Latifah – detto tra noi – è stata la prima venuta che mi è capitata fra i piedi. L'avevo notata la prima volta ch'ebbi il cambio di turno. La sua zona di caccia si trova nella parte superiore del porto, in mezzo ai magazzini di forniture nautiche, agli uffici dei mediatori e a piccole osterie. È là che suole gironzolare su e giù; gli intervalli sono segnati dall'«Albergo» di Madame Posa – un misero hotel de passe dalle scale anguste, stretto fra due case, a molti piani; davanti al locale di mescita, sul selciato, vi sono due tavolini rotondi e delle sedie. Madame affitta a ore; è raro che qualcuno desideri pernottare.
Latifah non rivolge la parola, ma la rivelano il passo lento e lo sguardo interrogativo: attende di essere abbordata. E poi, il fonoforo grigio. Quassù, la clientela è gente bene – – – piloti, commissari di bordo, stewards scelti, anche un notaio magari, o un effendi, che abbia voglie improvvise: non perderà molto tempo.
Io mi sono abituato a lei. In fondo, mi vanno più a genio quelle del basso-porto – – – figure statuarie con seni impetuosi e meduse della zona fluviale, che dondolano le chiappe con sguardi sfrontati. Però, laggiù è raro poter evitare gli alterchi. Specialmente quando vi è all'àncora una grossa nave, le guardie hanno un gran daffare.
Ci sediamo a uno dei tavolini tondi: dentro la lamiera, è inserito un disegno geometrico. Quando si versa un bicchiere, non rimangono tracce. Madame serve l'aperitivo. Il sole è sopra i tetti, la luce è buona. Esamino Latifah come un mercante di schiavi prima dell'accettazione; vi è in questo qualcosa di arcaico, dell'antica Persepoli. Soprattutto la dentatura è importante: rivela la struttura ossea. A sinistra in alto un dente d'oro, che non dà alcun fastidio. Lo mostra un sorriso, che conferisce ai lineamenti una profondità misteriosa. È un errore inestirpabile degli uomini scorgervi un indizio di intelligenza.
Non mette rossetto, se non sulle labbra; questo fatto e i capelli neri, che ricadono sulla fronte, rendono il viso ancora più pallido; la pelle ha pori larghi.
Una volta, mentre stava di nuovo ritta contro il caminetto, l'atmosfera si fece sinistra. La luce cominciò a tremolare come prima di un cortocircuito, ma poi non venne il buio bensì una luce splendida, accecante. Tenevo il braccio davanti agli occhi: la luce trapassava radio e cùbito. Le mura pareva fossero state risucchiate dal vento, si distinguevano soltanto le strutture. Vidi presso il caminetto uno scheletro, una impalcatura di ossa col dente d'oro, accanto alle cosce le fibbie della giarrettiera e lo scudo, ch'ella aveva già riposto, la piccola spirale sotto la bocca dell'utero.
Un esperimento delle catacombe – o fallito, oppure progettato in sede dimostrativa. Talora interventi simili generano inquietudine in città, provocando una sorta di paralisi. Gli orologi si arrestano; segue un black-out, quasi che il tempo rimanga bloccato. Laggiù, sono in grado di provocare anche fenomeni sismici e tenebre. Una breve scossa alla potenza dei Khan, che viene dimenticata come un incubo.
© Paolo Melandri (13. 12. 2017)
*
La panca davanti alla porta
Il compito di un autore, ammesso che ciò abbia un senso anche per qualcun altro, è di fondare una patria spirituale, una residenza per lo spirito. Potrà essere una nicchia modesta, con un'immagine, solo una panca davanti a una porta, o una casa in campagna, un palazzo, ma anche la vastità dei boschi e catene montuose, o lo spazio cosmico. La poesia domina l'universo in modo molto più profondo e durevole di qualsiasi sapere e di qualsiasi politica. Ci riporta ancora oggi tra le mura di Troia, nel palazzo di Agamennone. Se la sicurezza, l'accoglienza di un luogo si fondano sull'heros, l'«eroe», il poeta fa in modo che egli sia riconosciuto e ricordato: fa sì che diventi una patria.
I poeti dominano i grandi rifugi, i veri alberghi. Ecco perché, laddove essi manchino, crescono deserti spaventosi. Certo, continuano a esistere luoghi abitabili, divengono però inospitali, insensati, intimamente sconosciuti.
© Paolo Melandri (13. 12. 2017)
*
Naturalmente una donna
Così dicendo Ducacci aveva fatto un cenno del capo in direzione di una signora che pranzava a uno dei tavolini in compagnia di un vecchio. Ettore l'aveva notata al primo sguardo: dovunque andasse, non poteva non attirare l'attenzione, e anche l'ammirazione – quella donna era bella.
La figura alta e sottile, indossava un tailleur nero che la stagliava nettamente contro il divano rosso. Teneva la testa pigramente appoggiata a una mano e sembrava prestare ascolto al suo accompagnatore anche se di tanto in tanto dava uno sguardo in giro agli altri clienti. Il volto colpiva per la sua regolarità: da lontano sembrava una maschera o una di quelle attrici che stilizzano sapientemente i propri tratti. I capelli castano scuri erano folti e aderenti al capo come la pelliccia di quegli animali che si accarezzano volentieri. Le coprivano le orecchie e metà della fronte. La linea del naso, leggermente troppo corta, dava al suo viso, specialmente quando guardava in su, un tocco di impertinenza. Di contro gli occhi erano grandi e lucenti come agate grigie incastonate nel marmo; e parevano ancora più grandi a causa delle ombre azzurre che li orlavano. La semplicissima eleganza dell'abito conferiva a quella creatura una sorta di conchiuso rigore formale che la faceva assomigliare a una gemma paga della propria luce. Contrastava nettamente con questo il suo fare distratto e trasognato.
Bellezza e inquietudine stridevano in quel volto. È sempre una disgrazia ereditare un potere senza la sicurezza che serve ad amministrarlo. Come un grande patrimonio, che è solo fonte di sventure se colui che lo possiede è un prodigo, così la bellezza può diventare pericolosa non solo per chi l'ha avuta in dono, ma anche per gli altri.
Ducacci, che conosceva bene coloro che vivono ai margini della società, coglieva al volo ogni elemento preoccupante. Sapeva che la contessa veniva preferibilmente evitata. Preoccupanti non erano quei lineamenti da grande gatta. Anche le tigri hanno le loro leggi. A mettere in guardia era un che di disordinato, una mancanza di equilibrio. Causa ed effetto malamente collegati. I processi che si svolgevano in quella testa erano imprevedibili. Le cose vi dovevano funzionare come in una stazione dove il puro capriccio decida se alzare o abbassare le sbarre, e come regolare gli scambi. Chiunque vi indugi si espone al pericolo di collisioni insensate. La bellezza era un'esca stupenda in cui si nascondeva un uncino.
Nel Medioevo un essere simile sarebbe stato sospettato di stregoneria, nel Settecento avrebbe avuto la reputazione di gran dama che agisce solamente in base al proprio arbitrio. Oggi si poteva intuire in tutto ciò una forzata debolezza. Le forme erano ormai quasi del tutto svuotate di contenuto, benché il loro aspetto esteriore sembrasse intatto. I nomi valevano ancora, i patrimoni si trasmettevano ancora per via ereditaria come ai vecchi tempi. Ma i singoli casi diventavano casi-limite in quanto da un lato erano ancora determinati dalla tradizione, e dall'altro già segnati dal declino – da quest'ultimo con maggiore ineluttabilità. Gli antichi tronchi davano ancora fiori, ma i frutti erano già sterili e ibridi.
© Paolo Melandri (9. 12. 2017)
*
Il colpo sul cannello
Ché in realtà già era possibile lanciare lo sguardo in una certa lontananza. Tutto era già molto ravvicinato, qualche volta già tutte le vele si trovavano l'una accanto all'altra: quelle di Salamina e quelle del Mayflower e quelle delle regate di Cannes. La rosa seguiva la sua dolce via ed essa colmava solo uno sguardo con tutti i suoi corimbi: dall'Asia, attraverso i giardini di Mida, alta una spanna sui pavimenti di marmo fino alle feste di Cleopatra, e andava ancora avanti, perdeva profumo e dolcezza, in Finlandia si trasformava nella Rosa Nera, e lì nella rosa dei morti e là nella rosa dell'olivo – e ora l'intera via colmava un solo sguardo!
Lo sguardo indietro! Ma anche lo sguardo in avanti sapeva qual era adesso la sua ora, gli enigmi della via li scorgeva, ma nulla era pronto a svegliarsi. Persino dal deserto di questa città distrutta, dal caldo ardente senz'acqua, dai pensieri senza compagni, dai monologhi che non erano neanche nuovi – persino tutto ciò pesava sullo sguardo, tutto ciò che pure avrebbe dovuto in un certo modo condurlo a risultati differenziati –, da tutto ciò egli ricavava sempre e solo una cosa: o tutto era nulla o tutto era qualcosa – a quest'ultima conclusione però non sapeva decidersi a causa della sua natura, del suo temperamento, del suo apparato ottico di registrazione, a parte il fatto che anche questa conclusione sfociava in un pieno svuotamento dei valori all'interno del sistema individuale, in una promiscuità, un livellamento delle forme che come origine e teleologicamente era identico al nulla.
Il fluido del pensiero aveva assunto un carattere catastrofico, faceva parte delle essenze che, nel corso degli ultimi secoli, erano chiamate «interiori» e che adesso però erano consunte, vuote, crollate – un paio di pelli scuoiate di gatto si decomponevano ancora in qualche cantuccio. E l'«esterno», il quale mandava in avanscoperta certi segni e che forse una volta o l'altra si sarebbe fatto più vicino, non aveva ancora profondità, probabilmente non ne possedeva affatto, possedeva altre dimensioni, cui nessuno ancora era arrivato.
L'uomo si trova in tutt'altra parte che la sua sintassi, le è avanti di gran lunga. L'uomo di oggi non fa conto né del passato né del futuro. Tutto deve essere contenuto nella frase che sta scrivendo, magari nel capoverso o, per il pittore, nel quadro; ma tutto ciò che va oltre, è impotenza, e conta sul buon volere degli altri. L'artista è l'unico che riesca a tener testa alle cose, che decida sul loro conto. Tutti gli altri tipi non fanno che rimasticare i problemi, li rimasticano per generazioni, per secoli, finché ristagnano e vanno a male, finché – in termini evoluzionistici – i cervelli si modificano e interviene la natura – dunque un'impresa indegna dell'uomo. Per questo ho detto: il colpo sul cannello, il colpo che distacca ogni cosa – perciò ho detto: il soffiatore di vetro.
© Paolo Melandri (9. 12. 2017)
*
Il disco
Ma poi ci sono punti di vista e sguardi in cui i mondi si unificano: il delirium con la bonifica, la roccia col frammento, la giungla col giardino pietrificato – Margherita si accosta a Lachesi, l'Epifania parla con l'ultima ora estiva e il mausoleo di Bonaparte scivola silenzioso verso una fossa comune. Terra tolemaica e cieli che lentamente si volgono, quiete e colore del bronzo sotto un cielo senza suoni. Per sempre accanto a nevermore, istante e durata insieme – la massima del soffiatore di vetro, il canto del loto, suona la sua speranza e il suo oblio. No, non sono un pessimista – donde traggo origine, dove vado a finire: tutto superato. Giro un disco e vengo girato, sono un tolemaico. Non gemo come Geremia, non gemo come Paolo: «Ciò che amo, non lo faccio, faccio solo ciò che odio» – sono colui che sarò; faccio solo ciò che mi appare.
© Paolo Melandri (8. 12. 2017)
*
Il colore delle domande
Ammettiamolo: museo delle cere, immagini, frammenti, che ricevono il colore dalle mie domande. Ma il pensiero che va in cerca di connessioni mi appare ancora molto più imperfetto. Se si dà uno sguardo d'insieme all'Europa, si scorgono delle masse che pensano, dietro e avanti, su e giù; si pensa per mare e per terra e sulle navi che sono in viaggio; si pensa per istinto primordiale, così come le scimmie si arrampicano in cima agli alberi, e si pensa per virtuosismo, così come gli artisti da circo tengono in equilibrio le palle; si pensa nelle quattro lingue universali e nei ventidue dialetti balcanici, col risultato che nessuno sa che razza di attività sia il pensiero e a che scopo ci sia.
© Paolo Melandri (8. 12. 2017)
*
Monotonia rossa
Il tiranno, anche quando scade al livello di despota, è più fecondo di aneddoti del demagogo. Silla e Mario sono esemplari, in proposito.
Un grande demagogo manifestatosi all'epoca in cui venne scoperto il pianeta Plutone, era un dilettante di pittura, come Nerone di canto. Era un dilettante anche in altri campi, come la strategia, per disgrazia di molti, però era tecnicamente perfetto, chauffeur per tutte le direzioni, e finì col farsi cremare cosparso di benzina. I suoi contorni dileguano nell'insignificanza: l'afflusso di cifre li cancella. Per lo storico come per l'anarca, il ricavato è scarso. Monotonia rossa, persino nei misfatti.
© Paolo Melandri (7. 12. 2017)
*
I giardini di Proserpina
Il popolo fuorirete ritiene che le catacombe siano sottoterra: occorre distinguere. Ezio è cauto nelle sue allusioni, tuttavia mi è possibile supporre ch'egli abbia soggiornato in caverne sorte ad opera di forze plutoniche e del concorso umano. Laggiù esistono estesi giardini, con una flora la cui magnificenza vince di gran lunga quella della superficie. Un calore temperato e una luce di particolare forza e splendore creano prodigi. I botanici hanno scatenato energie naturali rimaste, fin'oggi, ignote. Chiesi ad Ezio: «La cosa appare strana in quanto i biologi sono del partito delle foreste, no?».
«Lei sa però che Proserpina, mentre coglieva fiori in un prato, venne rapita da Plutone e trasportata agli inferi».
Infatti: la risposta rimandava ad epoche in cui luminari della scienza, con l'astuzia o la violenza, caddero vittima dell'avversario e ne furono «stravolti».
© Paolo Melandri (7. 12. 2017)
*
La barba di Barbarossa
Non vi è nulla di geniale che sia inventato: esso deriva piuttosto dall'ispirazione. Il bambino è geniale per natura: conserva memoria dell'origine, che si perde non solo con il tempo, ma anche attraverso di esso.
Geniale è l'osservazione che vede la barba di Barbarossa crescere attraverso il tavolo. Accade fin tanto che l'imperatore sogna. Egli si desta, appare nel tempo quando la barba tocca ormai il pavimento. La lancetta ha compiuto il suo giro, la campana rintocca.
Nel mondo in cui la forbice non taglia, la barba può crescere anche attraverso la pietra.
© Paolo Melandri (26. 11. 2017)
*
Una domenica mattina a Parigi
Era la prima domenica di settembre, una giornata azzurra. Spesso in quest'epoca lo splendore dell'estate concentra le sue forze in un'ultima festa prima che avvampino i colori autunnali. Le notti sono più fresche; così l'alba si bagna di rugiada e la mattina è tiepida e gradevole. Il fogliame degli alberi si è scurito; si staglia contro il cielo come un metallo a sbalzo. Anche nelle città si attenua la calura; e vi penetra un'aura di lusso e di gaiezza.
Eraldo contemplava il piccolo giardino della Trinité. I giardinieri avevano già piantato nelle aiole i primi fiori dell'autunno. Su una bordura sottile fioriva ancora, drizzandosi da un tenero verde, la canna d'India. La sua fascia era interrotta da aiole circolari su cui sorgeva un astro azzurro dalle molte stelle. Le infiorescenze rifulgevano al sole. Sciami d'api e di moscerini le avvolgevano ronzando. Una vanessa a bande rosso brune riposava sul cuscino di un fiore. Ruotava senza fretta sul suo velluto e apriva le ali a pigri intervalli. Era certo venuta da lontano, superando in volo tetti altissimi. Un'altra vanessa si unì a lei. Le due farfalle cominciarono a descrivere dei cerchi e si levarono in alto fino a svanire del tutto nell'azzurro.
Da Saint-Lazare si udivano voci acute, infantili; erano gli strilloni dei giornali della domenica. Le campane si misero a suonare, e una folla vestita a festa uscì dal portale della chiesa dirigendosi verso le vetture che attendevano sulla piazza. Era un corteo nuziale. Chicchi di riso furono sparsi sul tappeto davanti alla giovane coppia. A quella vista Eraldo si riscosse dall'oziosa contemplazione in cui era irretito. Si mescolò ai passanti che confluirono insieme per poi tornare a disperdersi non appena le vetture si misero in moto. Poi, come uno cui non importi affatto imboccare una strada piuttosto che un'altra, svoltò nella Rue Blanche e si avviò pigramente su per la collina.
All'ombra delle case faceva più fresco; le strade erano state innaffiate da poco. L'acqua scorreva a valle dai bordi dei marciapiedi. Il quartiere, solitamente animato da una chiassosa alacrità, quel mattino era più tranquillo; mancavano i venditori ambulanti che offrivano per le strade pesce, frutta e verdura. Oggi si vedevano solo i chioschi dei fiorai. La città sembrava più vuota e perciò più solenne; gran parte della popolazione si trovava in riva al fiume oppure nei sobborghi. Si vedevano ancora le ultime carrozze uscire dalla città; erano cariche fin sul tetto di giovanotti accompagnati da ragazze in abiti variopinti. A mezzogiorno sarebbero stati in mezzo al verde e non sarebbero rientrati che a tarda sera. Qui i cavalli andavano al passo; gli zoccoli sdrucciolavano sul ripido selciato.
Per quanto abitasse nella città da oltre un anno, ciascuna di queste passeggiate era per Eraldo un'esperienza arcana. Quasi non gli sembrava di aggirarsi per piazze e strade, pensava semmai di percorrere le fughe di stanze e i corridoi di una grande casa sconosciuta, o anche di errare in cunicoli scavati in una roccia stratificata. In certe viuzze e a certi incroci l'incantesimo era più forte che mai. Eraldo non riusciva veramente a farsene una ragione. Più che i monumenti e i palazzi, testimoni di un antico passato, lo commuoveva l'anonima vita che aveva fatto sì che questa capitale somigliasse a un banco di corallo – la materia prima del suo destino. Perciò si sentiva a suo agio specialmente nei quartieri che erano cresciuti contro tutte le regole dell'architettura e si erano conglomerati nel corso dei secoli. Un'infinità di sconosciuti avevano vissuto, sofferto e gioito in quei quartieri. Un'infinità di persone abitavano ancora su quel suolo. La loro vita si era trasmessa alla malta. Era una forza incredibilmente concentrata, addirittura prodigiosa. E lui era sempre animato dalla sensazione che quel prodigio potesse prender forma da un istante all'altro: attraverso una lettera, un messaggio, un'avventura o un incontro di quelli che si vivono nelle grotte e nei giardini delle fate.
Durante queste passeggiate egli si sentiva invaso da una grande tenerezza. Era accordato come una corda lenta, che quasi non ha bisogno di una mano che la suoni. Un alito di vento, un raggio di sole bastavano a farla vibrare. L'inviolato lo avvolgeva come un bagliore che si fa visibile anche agli occhi più ottusi.
© Paolo Melandri (23. 11. 2017)
*
Il moscardino
Scomparire è ancora meglio che tuffarsi sott'acqua: al costume dei ranocchi, preferisco quello dei topi. Non penso, però, a quelli neri e grigi delle case e dei giardini, ma al topo giallo-rosso della foresta tropicale, che somiglia ad un minuscolo scoiattolo. Si nutre di noci, di cui nel primo autunno reca una provvista nel suo nido invernale. Là, dorme ben nascosto per sei mesi o più, mentre le folglie cadono sul terreno boschivo e le ricopre poi la neve.
Io ho preso le mie precauzioni secondo il suo modello. Il moscardino, o topo di nocciole, è parente della marmotta: fin da bambino mi raffiguravo la vita di questo sognatore altamente comoda. Non è un caso che, dopo la morte del padre, io mi sia smarrito in questo mondo protettore. Nella mia solitudine, nel solaio di casa, io mi tramutavo in moscardino. Per anni, esso fu il mio animale totemico.
Mi sono cercato, ai margini della foresta, un posticino per la mia tana. Il foro d'ingresso non dovrebbe trovarsi al livello del suolo, è meglio una fessura nella roccia o dentro un tronco cavo. Di là iniziai a scavare il cunicolo, giorno per giorno, sempre più in fondo, raschiando fuori il terriccio, che poi sparpagliavo perché non ne rimanesse traccia.
Una volta giunto abbastanza in fondo, scavai un secondo cunicolo verso l'alto, come uscita di sicurezza. Per ogni ingresso bisogna provvedere alla sortita, per ogni via pensare al ritorno: questo mi risultava chiaro fin da allora. Il lavoro doveva avvenire in assoluto silenzio e con cautela; dall'alto vi era di giorno la minaccia dello sparviero, e di notte del gufo, al suolo animali ostili, in primo luogo la vipera – il moscardino è sempre minacciato. È il tributo che paga alla sua libertà.
Dopo aver scavato i cunicoli, si passava all'abitazione, una comoda cameretta, non troppo piccina, né troppo grande. Che vi potesse stare anche una femmina, non mi veniva ancora in mente. Nemmeno per la mamma c'era da provvedere: era presente ovunque, era la tana stessa.
Una volta apprestata la cameretta e levigato bene il suo ovale, scavai il cunicolo di approccio alla dispensa. Questo era più grande, con una curvatura a forma di focaccia: con un granaio simile non vi sarebbe stata penuria. Non bisognava dimenticare nemmeno quel certo posticino: il moscardino è celebrato per la sua pulizia. Non ha il sentore degli altri topi, soltanto in primavera emana un profumo di muschio. Il posticino nell'inverno si sarebbe riempito di grani neri: anche in questo, non pensavo solo alla bocca, ma anche allo scarico.
Dopo la costruzione, passai all'arredamento. Per un giaciglio in cui occorreva trascorrere, sognando, l'inverno, le piume più fini erano giusto quel che ci voleva. Conoscevo luoghi ove la scelta era già fatta: i nidi degli scriccioli e dei regoli. Ne andai in cerca, non appena udivo il «si-si-si» dei regoli: è il richiamo quando la covata ha preso il volo. Il moscardino si arrampica cauto fra i rami. Trovai lassù le piume ch'essi si erano strappati, le fibrille che vi avevano trasportato, e me ne presi la mia parte.
Ai margini della foresta, s'inerpica tra le ortiche e le scabiose la cùscuta trifoglina. Essa merita il suo appellativo perché forma cuscini di fili morbidi come seta, che nel primo autunno inaridiscono. Anche di questi feci raccolta: li intrecciai al mio giaciglio e vi aggiunsi rose canine e foglie di biancospino.
Lavoro volentieri: coi piedi trattenevo le fibre, con mani e bocca le intessevo. Vi riuscivo senza fatica, sebbene avvenisse al buio. Quando le materie sono gradevoli al tocco e al movimento, il lavoro può diventare un gioco: il godimento materiale si trasforma in piacere spirituale.
Tale era il mio umore nella tana, e si intensificò al cadere delle prime noci – con un suono che disinguevo fra tutti. Era come un bàttito, un annuncio. Così è la profezia che prediligo. Non vuote promesse, ma fenomeni, una piccola moneta spicciola, materiale. Io sono come Tommaso: mostra le tue piaghe! Allora mi convinco. Presto le noci caddero in gran copia; se il vento passava nel fogliame, era come se grandinasse.
© Paolo Melandri (10. 11. 2017)
*
Nota di diario
Il diamante non mi piace granché. Non lo trovo bello. Quel po' di bellezza che sa dare ai volti non è tanto un suo effetto quanto un loro riflesso. Non ha né la trasparenza marina dello smeraldo né lo sconfinato azzurro dello zaffiro. Gli preferisco il color sauro della luce del topazio, ma soprattutto il sortilegio crepuscolare delle opali. Queste sono emblematiche e duplici. Se il chiaro di luna irida metà della loro faccia, l'altra sembra colorata dai bagliori rosa e verdi dell'occaso. Non ci rapiscono tanto i colori che esse ci mostano, quanto ci turba il sogno che in esse ci figuriamo. A colui che al di fuori di sé non incontra altro che la forma del proprio destino, esse gliene mostrano il volto alternativo e taciturno.
Ve n'erano in gran quantità nella città ove mi condusse Hermas. La casa in cui abitavamo la si apprezzava più per la bellezza dei luoghi che per la piacevolezza degli abitanti. La prospettiva degli orizzonti era studiata meglio di quanto non lo fosse la sistemazione dei luoghi. Vi si poteva fantasticare a proprio agio, ma non era facile dormirvi. Era più pittoresca che confortevole. Spossati dal caldo, durante il giorno, i pavoni facevano risuonare per tutta la notte il loro grido fatidico e beffardo che, in verità, è più propizio alla fantasticheria che favorevole al sonno. Il frastuono delle campane impediva di trovare al mattino, in cambio di quello che si gusta solo prima dell'alba, un secondo sonno che compensi almeno in parte la stanchezza che viene dall'essere stati del tutto privati del primo.
© Paolo Melandri (6. 11. 2017)
*
Nel cantiere del miele
Il tempo passò a volo mentre mi dilettavo di quello spettacolo. Gradualmente penetrai nella costruzione, nel sistema dell'invenzione. Gli alveari erano disposti in lunga fila davanti al muro. In parte erano di forma tradizionale, in parte trasparenti, fatti, sembrava, della medesima sostanza delle api. I vecchi alveari erano abitati da api naturali. Probabilmente questi sciami erano lì soltanto per dimostrare la grandezza del trionfo sulla natura. Zapparoni aveva certamente fatto calcolare quanto nettare uno sciame può produrre al giorno, all'ora, al secondo. Ora lo collocava sul campo sperimentale accanto agli automi.
Ebbi l'impressione che egli avesse posto in imbarazzo gli animaletti dalla economia antidiluviana, infatti ne vidi spesso qualcuno volarsene via da un fiore che prima era stato toccato da un concorrente di vetro. Se invece il calice era stato visitato prima da un'ape vera, vi rimaneva sempre un piccolo dessert.
Da questo conclusi, senza alcuna difficoltà, che le creature di Zapparoni procedevano in modo più economico, cioè che succhiavano in modo più esauriente. O forse, la forza vitale dei fiori si esauriva dopo che erano stati toccati da un pungiglione di vetro?
Comunque sia, l'evidenza insegnava che questa era un'altra delle fantastiche invenzioni di Zapparoni. Osservai poi il movimento davanti alle costruzioni di vetro che rivelava un metodo complesso. Credo che sia stato necessario l'intero corso dei secoli sino ai tempi nostri per indovinare il segreto delle api. Dell'invenzione di Zapparoni acquistai, dopo averla contemplata dalla mia poltrona soltanto forse un'ora, una concezione più precisa.
Gli alveari di vetro si distinguevano a prima vista dagli antichi per il grande numero di aperture. Non somigliavano tanto ad apiari quanto a centrali automatiche di telefoni. Non avevano poi autentiche aperture, infatti le api non vi entravano. Non vedevo dove si riposavano o venivano fermate o dove avevano la rimessa, infatti non saranno sempre state al lavoro. In ogni caso nell'arnia non avevano nulla da cercare.
Le aperture avevano piuttosto qui la funzione che hanno nei distributori automatici o quella dei fori di contatto in una presa elettrica. Le api vi si avvicinavano, attirate magneticamente, vi introducevano il pungiglione vuotandovi il nettare di cui avevano piena la piccola pancia. Poi ne venivano allontanate con forza quasi come proiettili. Era un prodigio che in questi viavai, nonostante la grande velocità del volo, non avvenissero urti. Sebbene la manovra fosse compiuta con un grande numero di unità, avveniva con perfetta precisione; doveva esservi un principio centrale che le dirigeva.
Evidentemente il procedimento naturale era stato semplificato. Così ad esempio era risparmiato tutto quanto riguardava la produzione della cera. Non c'erano né grandi né piccole celle e nulla che stabilisse la differenza tra i sessi, ogni cosa raggiava d'uno splendore perfetto ma completamente privo di erotismo. Non c'erano né uova né larve, né fuchi né regine. Se ci si voleva attenere a una stretta analogia, Zapparoni aveva approvato e sviluppato soltanto un alveare di operaie neutre. Anche su questo punto aveva semplificato la natura, la quale già con l'uccisione dei pecchioni aveva osato una iniziativa economica. Sin dall'inizio egli aveva escluso maschi e femmine, madri e nutrici.
Se mi rammento bene, il nettare che le api succhiano subisce diverse trasformazioni nel loro stomaco. Zapparoni aveva tolto anche questa fatica alle sue creature sostituendola con una chimica centrale. Vedevo come il nettare incolore iniettato attraverso i fori veniva raccolto in un sistema di tubi di vetro, nei quali gradualmente cambiava colore. Intorbidato sulle prime da una sfumatura di giallo, diveniva color paglia e arrivava in fondo con una stupenda tinta di miele.
La metà inferiore dell'apparecchio serviva da serbatoio o luogo di raccolta, che si riempiva a vista d'occhio della deliziosa sostanza. Potevo seguire l'aumento sulla misura incisa nel vetro. Se col binocolo osservavo i cespugli intorno e il fondo del prato, e poi riportavo lo sguardo sugli apparecchi, vedevo che il deposito del miele era salito di diverse linee.
Presumibilmente l'aumento e in genere il lavoro non venivano osservati soltanto da me. Distinsi un'altra specie di automi che oziavano davanti agli apparecchi o anche aspettavano come fanno i sorveglianti o gli ingegneri in una officina o in un cantiere di costruzione. Si distinguevano facilmente dagli altri perché erano color fumo.
© Paolo Melandri (5. 11. 2017)
*
Le memorie di Firzatti
Per un istante avevo dimenticato che mi trovavo lì per chiedere lavoro; ma soltanto per un istante. Se qualche cosa poteva sollevarmi dalla miseria, sarebbe stata una parola sul nostro mondo e il suo significato dalla bocca di uno dei suoi àuguri, il breve cenno di un capo.
Zapparoni possedeva molti volti, come la sua opera molti significati. Dov'era il minotauro in questo labirito? Era il buon nonno che faceva la fortuna di bambini, di massaie e di ortolani, era il fornitore militare, che nel medesimo tempo predicava la morale all'esercito e lo attrezzava con inaudita raffinatezza, era l'audace costruttore, al quale importava unicamente il gioco intellettuale e che voleva descrivere una curva che riconducesse alle forme primitive? O si doveva semplicemente produrre una nuova armatura, come se ne trovano in tutte le classi del mondo animale e la natura per quest'opera ingaggiava l'intelletto, ricorrendovi come a un mezzo? Ciò avrebbe spiegato molti tratti ingenui, che sorprendono negli attori del dramma.
Anzitutto, quale era la sua posizione di fronte all'uomo, senza il quale tutto era pazzia? Procedeva dall'uomo e doveva tornare all'uomo. Si potrebbe benissimo immaginare una rosa, una vite senza spalliera, però non mai l'opposto. Voleva rendere l'uomo più felice o più potente o lo voleva più felice e più potente a un tempo? Voleva dominarlo, atrofizzarlo, o introdurlo in regni incantati? Vedeva nell'automa un grande esperimento, una prova da subire, una domanda alla quale rispondere? Lo ritenevo capace di considerazioni teoriche, anzi, teologiche; avevo veduto la sua biblioteca e lo avevo guardato negli occhi.
È una grande cosa venire a sapere dalla bocca di un saggio in quali faccende siamo irretiti e quale significato hanno i sacrifici che ci vengono richiesti davanti a immagini velate. Anche se dovessimo udire cose spaventose, sarebbe sempre una fortuna vedere lo scopo al di là dell'ottuso vortice.
Intanto non toccava a me porre domande, al contrario. Il saluto mi aveva fatto l'effetto di una doccia fredda. Per un istante fui tentato di difendermi. Ma sarebbe stato un errore, e mi contentai dunque di dire:
«È stato molto gentile a volermi ricevere personalmente, eccellenza».
Il titolo gli spettava, come molti altri; mi ero informato da Twinnings.
«Mi chiami semplicemente per nome, come fanno tutti i lavoratori delle nostre officine.»
Non diceva le mie officine e i miei lavoratori. Ci eravamo seduti su due sedie da giardino e guardavamo il prato. Zapparoni aveva incrociato le gambe e mi guardava sorridendo. Portava pianelle di marocchino, e in genere dava l'impressione di un uomo che passa piacevolmente la mattina fra le sue quattro mura. Aveva piuttosto l'aria di un artista, di un romanziere alla moda o di un grande compositore, il quale da molto tempo ha lasciato le preoccupazioni materiali dietro di sé ed è sicuro dei suoi mezzi e dell'effetto che produce.
Arrivava da lontano il ronzio delle officine. Presentivo che avrebbe incominciato subito a interrogarmi. Vi ero preparato, ma non avevo nessun discorso pronto, come nei tempi passati in simili incontri. Ogni aspirante vuol fare una determinata impressione, rappresentare il tipo ideale che nella propria mente ha formato di sé. Presenta il suo parere. Qui era impossibile, perché non sapevo precisamente che cosa mi chiedeva. Inoltre la tecnica della interrogazione ha fatto grandi progressi. Anche se difficilmente potrà accertare che cosa sia un uomo, pure coglie con grande precisione che cosa non è, che cosa si sforza di sembrare.
Perciò la cosa migliore è rispondere sempre chiaro e tondo.
«Lei viene al momento giusto», cominciò, «per illuminarmi sopra un particolare, che mi ha colpito in questo istante durante la lettura.»
E accennò al suo gabinetto. «Ho incomiciato le Memorie di Firzatti; che lei probabilmente conosce. Dev'essere approsimativamente della sua classe.»
Questa osservazione colpì giusto più di quanto Zapparoni supponesse, se non l'aveva fatta per pungermi. Firzatti era stato uno dei miei compagni di corso. Lo conoscevo bene; avevamo studiato insieme.
© Paolo Melandri (2. 11. 2017)
*
Il problema del compito
Il prolema è indivisibile: l'uomo è solo. In definitiva non ci si può affidare alla società. Benché il più delle volte sia nociva e spesso perfino distruttiva, la società può anche aiutare, ma non più di un bravo medico – fino al limite inevitabile dove la sua arte vien meno.
Soprattutto niente malinconia. Il singolo può darsi conforto conoscendo la propria situazione. Un tempo le religioni gli facilitavano il compito. Il loro stretto legame con l'arte non è casuale, poiché ne sono le invenzioni supreme.
Ora che gli dèi ci hanno abbandonati, siamo costretti a ricorrere alla loro origine, l'arte. Dobbiamo farci un'idea della cosa o della persona che raffiguriamo. Da qualche parte dev'esserci un laboratorio. Un vasaio produce anfore, brocche, comuni stoviglie. La sua materia prima è la creta; tutto nasce nel volgere dei tempi, quindi ricade in polvere e ridiventa materia prima, per noi.
La nostra posizione sociale o morale non ha alcun rilievo in tutto questo. Possiamo essere un principe o un bracciante, un pastore, una puttana, un tagliaborse – o il più delle volte, come me, un uomo comune.
Ognuno ha il suo ufficio, il suo compito. Quale sia stato il pensiero che ha presieduto alla nostra creazione, quale lo scopo cui siamo chiamati – chi ce ne trasmette anche una vaga idea ci nobilita.
© Paolo Melandri (2. 11. 2017)
*
La comparsa dei titani
Adesso erano diventati d'obbligo i cortei, ma il giorno era rimasto, perché ogni regime vive del mito, seppure in forma attenuata. Nella folla doveva agire un ricordo che, dopo che le bandiere erano state arrotolate, la sospingeva all'aperto, dal vero signore della festa. Questi, se anche non era apparso, certamente si faceva sentire; la metamorfosi era straordinaria. Anch'io ne fui afferrato, benché fossi triste quando arrivai.
Era salita la nebbia, come spesso a quell'ora. Sopra di essa dovevano splendere le stelle, ma uomini e cose trasparivano, quasi irreali, solo attraverso un fitto velo. Nelle osterie della città si faceva musica, ma solo il ditirambo di un timpano penetrava nel parco artistico, come i remoti rintocchi di un gong.
Camminavo nel grande viale. Anche le statue si erano trasformate; non erano più opere d'arte né la loro caricatura. Il presidente del partito era diventato Eracle, il carnefice si era tramutato nell'ultimo beatificante, nel dio indiano. Perfino il cemento svelava il suo segreto; i suoi atomi erano gli stessi del marmo – gli stessi addirittura del nostro cuore, del nostro cervello. Era sceso il silenzio; la folla si era dispersa nel parco. Teneva un grande concubito.
Ora dovrei parlare dell'incontro che mi fu accordato, ma l'indicibile si sottrae alla parola. Rompere il silenzio sarebbe già tradimento. Una cosa simile non mi venne concessa mai più. Non so nemmeno se ci fu un contatto. Ma il mio nichilismo si fonda su fatti reali.
© Paolo Melandri (1. 11. 2017)
*
Nel vortice delle galassie
È ormai tempo che mi dedichi al mio problema. Chi non ce l'ha, un problema – ciascuno ne ha uno e perfino più d'uno. Hanno valori diversi: il problema principale invade il centro dell'esistenza, rimuove gli altri. Senza sosta ci accompagna come un'ombra e incupisce la mente. È lì anche quando ci svegliamo di notte; ci balza addosso come un animale.
Un uomo di tanto in tanto ha mal di testa; non è piacevole, ma esistono dei rimedi. Il caso si fa serio se un giorno egli sospetta che ci sia sotto qualcosa – forse un piccolo tumore. Ora l'ansia fugace diventa permanente; diventa l'ansia principale.
2.
Eppure anche un'ansia principale come questa è cosa di tutti i giorni. Ce ne convinciamo pensando alla statistica – infatti, mentre il nostro uomo rimugina sul suo tumore, nello stesso momento un'ansia identica opprime sul pianeta migliaia d'altri. Egli dunque la divide con loro? Certamente, e tuttavia rimane il suo problema privato e indivisibile. È in gioco l'insieme – sotto il mal di testa si nascondeva il tumore, ma ancor più sotto forse c'è dell'altro, per esempio un carcinoma.
Va anche considerata l'eventualità che non ci sia sotto NIENTE – il problema si fonda sull'immaginazione. Anche l'angoscia ha le sue mode – oggi predilige la guerra atomica e il carcinoma, dunque la rovina collettiva e quella personale.
Un tempo, quando infieriva la paralisi, specie negli strati superiori e lì in particolare fra gli artisti, molti si immaginavano di esser colpiti da questo male, e più d'uno per questo si uccise. Ma è proprio quando sotto non c'è niente che il problema diventa più inquietante. Il terrore non incombe più in una forma o nell'altra, ma con tutto il suo indiviso potere.
3.
A colazione, quando mescolo nella tazza e seguo la rotazione degli addensamenti, mi balza agli occhi la legge secondo cui si muove l'universo – nel gorgo delle nebulose, nel vortice delle galassie.
Dal che possono trarsi conseguenze intellettuali e anche pratiche. Lo spettacolo mi ricorda la mela di Newton, o il vapore che Watt fanciullo vide scaturire dalla teiera ben prima d'inventare la sua macchina. «Questo dà da pensare» diciamo. A quanto sembra l'atto di pensare è preceduto dalla sintonia con la materia, a cui segue quello stato di fantasticheria che genera il pensiero e lo suscita.
Ma a che serve? Che l'universo ruoti o si disgreghi – sotto rimane il problema.
© Paolo Melandri (31. 10. 2017)
*
Il Regno della Cappa
Noi eravamo dietro un piccolo cespuglio ricco di bacche rosse come fiamme e guardavamo verso la radura del Regno della Cappa. Il tempo era mutato e non vi era quivi traccia dei cortei di nebbia che ci avevano scortato sin dalle Scogliere di Marmo. Le cose apparivano anzi in piena chiarezza, in un'aura silente e immota come nel centro di un ciclone. Anche le voci degli uccelli erano ammutolite e solo il cuculo svolazzava qui e là al margine del bosco, secondo il suo costume. Ora vicino e ora lontano udivamo il suo richiamo irridente e interrogativo, cucù, cucù, e un brivido ci trascorreva nelle vene.
La radura era coperta di erba secca, e questa cedeva solo dove cresceva il grigio cardo che si trova negli spiazzi pietrosi. Dal terreno secco si innalzavano stranamente verdeggiando due grandi cespi, che al primo sguardo ritenemmo arbusti di lauro; ma le foglie di questi erano macchiate di giallo come se ne vedono di simili nei negozi di macelleria. Essi crescevano ai due lati di un vecchio cascinale dalla porta spalancata, costruito nella radura; e la luce, che illuminava il luogo, non era luce solare e nondimeno, risplendente e senz'ombra, dava aspro rilievo alla costruzione intonacata di bianco. I muri erano divisi in spartimenti, formati da nere travi su tre piedi, e sopra di esse saliva appuntito un grigio tetto di legno. Pali e picche si trovavano colà, appoggiati ai muri.
© Paolo Melandri (30. 10. 2017)
*
Un soffio di alabastro
Era circa l'una del mattino. Prima di coricarmi, aprii la finestra e accesi una sigaretta. Il rumore di un'automobile che passava sul viale attraversò il silenzio. Gli alberi rinfrescavano l'aria scuotendo le loro cupe chiome. Nessun ronzar d'insetto, nessun rumore d'anima vivente saliva dal suolo sterile della città. La notte era punteggiata di stelle, i cui scintillii, nella trasparenza dell'aria, meglio che nelle altre notti, apparivano diversamente colorati. La maggior parte ardevano di luce bianca, ma ce n'eran pure di gialle e di color arancione, come fiamme di lampade agonizzanti. Parecchie invece erano blu, e ne vidi una d'un blu così pallido, così limpido e dolce, da cui non mi riusciva distogliere la vista. Mi rammarico di non conoscerne il nome, ma me ne consolo pensando che gli uomini non danno alle stelle il loro vero nome.
Pensando che ciascuna di quelle gocce di luce illumina dei mondi, mi domando se, come il nostro sole, esse non illuminino innumerevoli sofferenze e il dolore non colmi gli abissi celesti.
© Paolo Melandri (29. 10. 2017)
*
Melancholia
Orologi a polvere: sono certo che il lettore conosce quel particolare stato d'animo in cui un oggetto, non importa se usato tutti i giorni oppure osservato solo di sfuggita, acquista ai nostri occhi uno speciale fascino. È così che hanno sempre inizio passione e collezionismo. Incominciamo a immergerci nell'oggetto, a penetrarlo in profondità. Esso ci svela i suoi segreti e, se avremo pazienza, scopriremo che a ogni passo se ne presenta uno nuovo. Le radici del più piccolo fiore si ramificano all'infinito, e solo la nostra passione ce le rivela. Ciò che non si manifesta è solo dissimulato.
Qualcosa di simile accadde a me con gli orologi a polvere. Il primo di cui venni in possesso mi fu regalato da Niccolò Valentini, il quale, purtroppo, come più d'uno tra i miei cari amici, è scomparso in guerra. Lo considerai come una stravaganza, uno di quei curiosi oggetti che si tengono sugli scaffali o tra i libri. Solo molto più tardi, mentre ero dedito a lavori notturni, mi colpì il fatto che questa clessidra, serrata tra le sue aste metalliche come in una gabbia per grilli, emanava un rassicurante senso di pace, l'idea di una tranquilla esistenza. Erano forse gli anni che le avevano conferito lo splendore opalino, il velo sottile che presentano di solito i vetri riesumati? La bianca polvere fluiva silenziosa da un recipiente all'altro. Si incavava a forma di imbuto in quello superiore e si inarcava a cono in quello inferiore. Questo piccolo monte, formato da tutti gli attimi perduti che cadevano gli uni sugli altri, lo si poteva intendere come un segno consolante del fatto che il tempo dilegua ma non svanisce. Cresce in profondità.
Questa affinità dell'orologio a polvere con la quiete degli studi eruditi e con l'intimità della casa è stata più volte osservata. Entrambe le situazioni sono testimoniate da quadri famosi: la Melancholia e il San Girolamo nello studio di Dürer. Nel primo vediamo un angelo in atteggiamento pensoso, con in mano un compasso e circondato da uno strumentario faustiano di cristalli, bilance, serie numeriche. Un fuoco alchemico arde sullo sfondo cosmico. L'altro quadro mostra il santo nella sua cella mentre è intento a scrivere. L'arredamento è costituito da libri, fogli fitti di appunti, un teschio e un crocifisso. Sotto la panca ci sono un paio di scarpe da giardino; il sole illumina la stanza attraverso i vetri piombati.
In entrambi i quadri si osserva un grande orologio a polvere, una vera e propria clessidra. E in entrambi essa è raffigurata a metà del suo corso, il che significa, probabilmente, che il pittore osserva il santo e l'angelo nel pieno della loro attività. Ne è riprova il fatto che, nella Melancholia, la bilancia è in equilibrio, la campana oscilla e il fuoco arde. Siamo nel cuore del tempo.
© Paolo Melandri (28. 10. 2017)
*
Silenzio e notte
Ma si deve ricordare, e ricordare con tutto il cuore, un'altra, un'ultima, veramente estrema conversione della mente che, alla fine di quest'opera d'infinito lamento tocca lieve, superiore alla ragione, e con quel silenzio parlante che solo alla musica è dato, il nostro sentimento. Alludo al tempo finale della Cantata, nel quale il coro si perde: è un brano orchestrale che sembra il lamento di Dio per la perdita del suo mondo, quasi un doloroso «non sono stato io a volerlo» del Creatore. Qui, verso la fine, mi pare che siano raggiunti gli estremi accenti della tristezza e che l'ultimo strazio si sia fatto espressione; e, non voglio dirlo, ma sarebbe come intaccare la mancanza di concessioni in questa opera e il suo inguaribile dolore, se volessimo asserire che fino alla sua ultima nota essa offra un altro conforto tranne quello che sta nell'espressione stessa mediante il suono: nel fatto dunque che al creato è data una sua voce per esprimere il proprio dolore. No, fino all'ultimo questo cupo poema musicale non ammette alcun conforto o conciliazione o trasfigurazione. E se al paradosso artistico che dall'edificio totale nasce l'espressione in quanto lamento corrispondesse il paradosso religioso che dalla più profonda dannazione, sia pure come lieve interrogativo, germina la speranza? Sarebbe la speranza al di là della disperazione, la trascendenza della disperazione – non il tradimento ai suoi danni, bensì il miracolo che va oltre la fede. Ascoltate questo finale, ascoltatelo con me: i gruppi di strumenti si ritirano l'uno dopo l'altro e quello che rimane è soltanto il sol sopra il rigo di un violoncello, l'ultima parola, l'ultimo suono svanente che si spegne adagio nel pianissimo. Poi non c'è più nulla – silenzio e notte. Ma il suono che ancora vibra nel silenzio, quel suono svanito che soltanto l'anima ancora ascolta, ed era la fine della tristezza, ora non lo è più, muta di significato, è quasi un lume nella notte.
© Paolo Melandri (27. 10. 2017)
*
Mosè
La sua nascita era irregolare; per questo amava intensamente la regola, l'inviolabile, il comandamento e il divieto.
Giovane ancora, aveva ucciso, in una vampa di passione; per questo sapeva, meglio di chiunque non sia passato per quell'esperienza, che uccidere è, sì, delizioso, ma aver ucciso è tremendo; e che tu non devi uccidere.
I suoi sensi erano ardenti; per questo anelava a ciò che è spirituale, puro e santo: all'Invisibile, che gli appariva spirituale, santo e puro.
Fra i medianiti, popolo diffuso ed operoso di pastori e mercanti del deserto, presso i quali, avendo ucciso, era dovuto riparare in Egitto sua terra natale (di ciò, appresso), fra i medianiti aveva conosciuto un dio che non si vedeva, ma che ti vedeva; un dio che dimorava sulla montagna e nello stesso tempo sedeva, invisibile, su di un'arca portatile, in un padiglione donde rendeva oracoli per mezzo di sorti agitate in un sacchetto. Questo nume, chiamato Yahweh, per i figli di Midian era un dio fra tanti; non attribuivano grande importanza al suo culto, praticandolo con gli altri per sicurezza e a buon conto. Avevano avuto l'idea che fra gli dèi ce ne fosse magari anche uno invisibile, un dio senza immagine; e gli offrivano sacrifici tanto per non trascurare nulla, non far torto a nessuno e non attirarsi dispiaceri da nessuna parte.
Per contro, Mosè, in virtù della sua sete di purezza e di santità, fu scosso profondamente dall'invisibilità di Yahweh; gli parve che nessun dio visibile potesse competere per santità con un dio invisibile e si stupì che i figli di Midian non dessero quasi peso ad una dote che a lui appariva gravida di conseguenze immense. Mentre custodiva nel deserto le pecore del fratello della sua moglie medianita, ebbe lunghe, faticose e intense meditazioni, fu scosso da ispirazioni e rivelazioni, le quali, in un determinato caso, uscirono dal suo intimo stesso, percuotendo la sua anima sotto la specie di una fiammeggiante visione esteriore, di un'ingiunzione precisa, di una missione cui era impossibile sottrarsi, e giunse alla convinzione che Yahweh non fosse se non 'El 'elyon, l'Unico-Sommo, 'El ro 'i, il dio che mi vede; che non fosse se non colui che era detto 'El Shadday, il dio della Montagna, 'El 'olam, il dio del mondo e dell'eternità, – in una parola, che Yahweh non fosse se non il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il dio dei padri, vale a dire dei padri di quelle povere ed oscure tribù asservite, sradicate e già completamente confuse nella loro adorazione della divinità, che ora dimoravano in terra d'Egitto: il cui sangue scorreva, per parte di padre, nelle vene di lui, Mosè.
Per tutto ciò, e colmo di quella scoperta, con l'anima greve di quella missione, ma pur tremante del desiderio di adempiere al comandamento, egli interruppe il suo soggiorno di molti anni presso i figli di Midian, caricò su un asino Zippora sua moglie, donna d'alto lignaggio, figlia di Regu'el, re sacerdote di Midian e sorella del figlio di lui Ietro, proprietario di armenti; prese con sé anche i due figli Ghershom ed Eleazaro, e, in sette giornate di cammino verso occidente, tornò per molti deserti in terra d'Egitto, in quell'incolto Paese Basso, là dove il Nilo si divide, e dove, in un distretto chiamato Kos o anche Goshem, Gosem o Gosen, dimorava e serviva il sangue di suo padre.
Là giunto, cominciò subito, dovunque andasse o si trovasse, nelle capanne o ai pascoli o sui luoghi di lavoro, a spiegare a quel sangue la sua grande esperienza: aveva allora un suo strano modo di agitare fremendo i due pugni, con le braccia tese lungo i fianchi. Annunciava che il dio dei padri era stato ritrovato, che si era rivelato a lui, Mosè figlio di Amram, da un cespuglio che ardeva e non si consumava, sul monte Horeb, nel deserto di Sin; si chiamava Yahweh, il dio, ciò che significa io sono colui che sono d'eternità in eternità, ma anche aura spirante e possente rombo; che amava il suo sangue ed era disposto a stringere con esso un patto d'elezione sopra tutte le genti, sotto una certa condizione: sotto condizione cioè che il popolo si votasse esclusivamente a lui e fondasse una comunità intesa al culto, unico e senz'idoli, dell'Invisibile.
© Paolo Melandri (22. 10. 2017)
*
Nel giardino di Zapparoni
Gli uccelli tacevano. Sentii di nuovo il mormorio del ruscello nel calore del fondo. Poi mi svegliai di colpo. Già di prima mattina ero stato in piedi, tormentato dall'inquietudine di chi corre dietro al suo pane. In tale stato d'animo il sonno ci sorprende come un ladro.
Dovevo soltanto avere chiuso gli occhi, infatti il sole si era appena mosso. Il sonno nella luce violenta mi aveva stordito. Mi orientai con difficoltà; il luogo era ostile.
Anche le api avevano terminato il loro sonno meridiano; l'aria era piena del loro ronzio. Pascolavano sul prato, sfioravano a sciami la spuma bianca che lo copriva o si tuffavano nella sua variopinta profondità. A grappoli si appendevano al chiaro gelsomino che orlava la strada, e quando sciamavano dall'acero in fiore accanto al boschetto l'aria risuonava come una grande campana, che continua a lungo a vibrare dopo che mezzogiorno è suonato. Di fiori non c'era scarsità; era uno di quegli anni di cui gli apicoltori dicono che vestono di miele i pali delle arnie.
Eppure c'era qualcosa di strano in quel pacifico commercio. Tolti i cavalli e la selvaggina, conosco poco gli animali, infatti non ho mai trovato un maestro che mi facesse appassionare per loro. Per le piante, la cosa è diversa, infatti avevamo un professore di botanica entusiasta, col quale spesso facevamo gite. Quanto può dipendere nella nostra storia da tali incontri. Se dovessi compilare un elenco degli animali che conosco, mi basterebbe un foglietto di carta. Lo dico soprattutto per gli insetti che riempiono il mondo a legioni.
Comunque so press'a poco come sono fatti un'ape, una vespa e anche un calabrone. Mentre lì seduto le contemplavo sciamare, mi pareva che a volte ne passassero alcune che spiccavano stranamente. Dei miei occhi posso fidarmi; li ho messi alla prova non soltanto per la caccia alle galline. Non mi costava nessuna fatica seguire una di quelle api con lo sguardo, finché si posò sopra un fiore.
Allora ricorsi al binocolo e vidi di non essermi ingannato.
Sebbene io, come ho già detto, conosca poco gli insetti, ebbi subito l'impressione di una cosa imprevista e supremamente bizzarra, quasi l'impressione di un insetto piovuto dalla luna. Poteva aver lavorato a fabbricarlo un demiurgo, in regni remoti, il quale una volta avesse sentito parlare di api.
L'ape mi lasciò tutto il tempo di contemplarla, inoltre adesso da tutte le parti arrivavano insetti simili come operai all'ingresso dell'officina quando la sirena ha chiamato al lavoro. In queste api colpiva subito la grandezza. Certo non erano come quelle incontrate da Gulliver a Brobdingnag e contro le quali si difese col pugnale, però erano di molto più grosse di un'ape e persino d'un calabrone. Avevano press'a poco la circonferenza di una noce ancora nel mallo. Le ali non erano mobili come negli uccelli o negli insetti, ma giravano intorno al corpo in un orlo rigido, piuttosto come un piano destinato a stabilire l'equilibrio o a sollevare l'automa.
La grandezza dava meno nell'occhio di quel che si potrebbe pensare, infatti l'animale era assolutamente trasparente. L'impressione che ne ebbi mi venne soprattutto dai riflessi provocati dai suoi movimenti alla luce del sole. Quando stava come in quel momento, davanti a un fiore di convolvolo, di cui penetrò il calice con la proboscide formata da uno scandaglio di vetro, era quasi invisibile.
Lo spettacolo mi avvinse in un modo che mi fece dimenticare il luogo e l'ora. Un simile stupore ci prende quando ci viene mostrata una macchina nella cui forma e nel cui modo di funzionare si rivela una nuova trovata. Se un uomo della prima metà dell'ottocento venisse portato per magia a uno dei nostri grandi incroci, il movimento gli darebbe la sensazione di una confusione monotona. Dopo un periodo di sbalordimento comincerebbe a capire, o a sospettarne le regole. Saprebbe distinguere le motociclette dalle vetture per il trasporto delle persone e delle merci.
Così accadde a me quando compresi che quella non era una nuova specie zoologica, ma un meccanismo. Zapparoni, quell'uomo diabolico, aveva ancora una volta invaso il campo della natura, o piuttosto ne aveva corretto le imperfezioni, abbreviando e accelerando il viaggio dell'ape al lavoro.
Mossi attentamente il binocolo per seguire le sue creature che guizzavano nello spazio come diamanti lanciati da robuste fionde. Ne udivo il sibilo, che si interrompeva bruscamente quando frenavano di colpo davanti ai fiori. E dietro di me, presso le arnie ora in piena luce, si moltiplicava in un sibilo chiaro e ininterrotto. Doveva essere costato sottili studi evitare gli urti nei punti dove gli sciami si ammassavano negli intervalli di volo.
Il procedimento, devo riconoscerlo, mi colmava di quel piacere suscitato in noi dalle soluzioni tecniche, che è anche un riconoscimento tra iniziati: qui trionfava lo spirito del nostro spirito. Mi accorsi di diverse specie di automi che pascolavano nei campi e nei cespugli. Animali forniti di particolare vigore portavano un intero gruppo di pungiglioni che tuffavano negli umbrelli e nei grappoli di fiori. Altri erano armati di braccia prensili, che posavano come delicate pinze intorno ai fasci di fiori per spremerne il nettare. Altri apparecchi mi rimanevano incomprensibili. Comunque Zapparoni aveva in quell'angolo un campo di esperimento per brillanti trovate.
© Paolo Melandri (22. 10. 2017)
*
Canto senza fine
Nel bosco sopra Lerici restava ancora un tratto della vecchia strada maestra, quella che un tempo tutti avevano dovuto percorrere ma che adesso era evitata, perché non faceva altro che attorcigliarsi su e giù per tutti i possibili cocuzzoli e colline e non aveva mai il buon senso di aggirarli. Il tratto esistente tuttora era così scosceso che non veniva più utilizzato dalle vetture, ma i viandanti qualche volta vi si inerpicavano, perché era una buona scorciatoia.
Correva ancora larga come una vera strada statale, coperta di bella ghiaia gialla, anzi addirittura più bella di prima, perché non presentava tracce di ruote, né fango, né polvere. Lungo i margini continuavano a fiorire i soliti fiori delle strade maestre. Ranuncoli d'ogni specie e cerfoglio selvatico si assiepavano in schiere fitte, ma i fossati si erano riempiti di germogli e un'intera fila di abeti vi aveva affondato le radici. Non erano che giovani abeti che vi crescevano, tutti della stessa altezza, con rami dalle radici alla cima. Stavano fittamente serrati gli uni agli altri come nelle siepi delle tenute, senza neanche uno secco o avvizzito. Erano tutti chiari, in cima, per i giovani germogli, e tutti cantavano e ronzavano come calabroni nelle belle giornate estive, quando il sole riversava su di loro la sua luce da un cielo limpido.
Tornando dalla chiesa, quella domenica in cui per la prima volta si era mostrato nel suo abbigliamento imperiale, Giovanni Silvani andò a finire proprio sulla vecchia strada maestra. Era una calda giornata di sole, e mentre si arrampicava su per il pendio gli giunse così forte la musica degli abeti da restarne stupito. Gli sembrò di non averli mai sentiti cantare in quel modo, e gli venne l'idea che doveva assolutamente scoprire perché mai fossero così chiassosi proprio quel giorno. E poiché non aveva la minima fretta, si mise a sedere in mezzo a loro sulla bella strada di ghiaia, posò il bastone accanto a sé, si tolse il berretto per asciugarsi il sudore dalla fronte e poi rimase fermo con le mani giunte ad ascoltare.
C'era una quiete assoluta nell'aria e non poteva essere il vento a far vibrare tutti quei minuscoli strumenti. No, si era piuttosto portati a credere che gli abeti si fossero messi a suonare per mostrare la loro gioia di essere così giovani e sani, di trovarsi lì così in pace lungo la strada abbandonata, e di avere tanti anni davanti, prima che a qualcuno venisse in mente di abbatterli.
Se era davvero così, non si capiva però perché proprio quel giorno gli abeti suonassero con tanto slancio. Di tutti quei giorni preziosi potevano anche gioire in ogni bella giornata d'estate, mica avevano bisogno di organizzare per questo un concerto speciale.
Giovanni sedeva silenzioso in mezzo alla strada maestra, in ascolto.
Era bello lo stormire degli abeti, anche se era sempre sulla stessa nota e non faceva pause che permettessero di distinguervi un ritmo o una melodia.
Sì, era dolce e bello starsene lì sul pendìo del bosco; tanto bello da non meravigliarsi affatto che gli alberi si sentissero lieti e felici. Strano, piuttosto, era che gli abeti non sapessero suonare meglio di quanto facevano. Guardò i loro ramoscelli, dove ogni ago era sottile e verde e ben conformato e messo al giusto posto. Aspirò l'odore di resina che emanavano. Non vi è erba nei prati, né fiore nei campi che abbia un così buon profumo. Osservò le loro pigne ancora verdi, le cui scaglie sono disposte con tanta arte per vegliare sui semi.
Ma il motivo era uno solo e sempre quello, e a furia di ascoltarlo a Giovanni venne sonno. Forse non era neanche una cattiva idea sdraiarsi sulla bella strada di ghiaia pulita e concedersi una piccola siesta.
Ma aspetta! Che succede? Appena poggiato il capo a terra e chiuse le palpebre, gli parve che il mormorio cambiasse. C'era un ritmo, ora, e c'era anche una melodia.
Quello di prima non era che un preludio, come si fa di solito in chiesa prima di incominciare il salmo. Ora gli giungevano anche le parole e parole che poteva comprendere.
Sì, era esattamente quel che aveva intuito da subito, senza volerlo ammettere, neppure nei suoi pensieri. Ma gli alberi sapevano tutto quello che era successo, anche loro. Era proprio in suo onore che avevano suonato così forte, quand'era arrivato.
Ora era di lui che cantavano, non vi erano dubbi, credendo che dormisse. Non volevano, forse, che sentisse come lo festeggiavano.
Che canzone, che melodia! L'imperatore stava sdraiato con gli occhi chiusi, ma proprio per questo sentiva ancora meglio. Non una nota gli sfuggiva.
Cantati i primi versi, vi fu un intermezzo senza parole; e questa era la cosa più stupenda.
Questa era musica! E non solo i giovani alberelli lungo la vecchia strada suonavano, ma tutto il bosco con loro. Erano organi e tamburi e trombe. Erano flauti dei merli e zufoli dei fringuelli, erano mormorio di ruscelli e ninfee, tintinnare di campanule e tambureggiare di picchi.
Mai Giovanni aveva udito qualcosa di più meraviglioso. E mai aveva ascoltato una musica in un modo così intenso. Gli penetrava così a fondo nelle orecchie che mai l'avrebbe potuta dimenticare.
Quando il canto finì e il bosco tornò silenzioso, si alzò come da un sogno. E subito si mise a ripetere quella canzone imperiale del bosco, per non dimenticarla.
© Paolo Melandri (20. 10. 2017)
*
Nuovi regni
Nella casa e sul terrazzo pareva che il tempo avesse rallentato il corso. Si ha in sentimento simile quando attraversando i boschi si passa nelle zone più antiche. Nessun segno ci avvertiva che non si era nella prima metà del diciannovesimo secolo o meglio ancora nel diciottesimo. I muri, le travature, i tessuti, le pitture e i libri, tutto attestava una lavorazione solida. Si sentivano le antiche misure, il piede, il braccio, il pollice, il palmo, la linea. Si sentiva che alla luce e al fuoco, al letto e alla mensa si accudiva ancora all'antica, si sentiva il lusso della cura umana.
L'esterno era diverso, sebbene fosse gradevole camminare sulla sabbia soffice e gialla come l'oro. Ogni due o tre passi, le orme si cancellavano. Vedevo un piccolo vortice, come se un animaletto nascosto nella sabbia si scuotesse. Poi il sentiero tornava a stendersi liscio come prima. Però non avevo bisogno di questa percezione per notare che qui il tempo scorreva più rapidamente e che ci voleva una maggiore vigilanza. Nei bei tempi passati si giungeva in luoghi dove c'era «odore di polvere». Oggi la minaccia è più anonima, è nell'atmosfera; però la si sente. Si entra in regni nuovi.
Il sentiero incantava; invitava a sognare. A volte il ruscello gli si avvicinava tanto da rasentarlo. Sulle sue sponde fioriva l'iris gialla, e sulle rive sabbiose il tartaro. Dei martin pescatori svolazzavano sopra e scendevano a bagnarsi il petto.
© Paolo Melandri (19. 10. 2017)
*
Passi di silenzio
Notti d'estate e mare calmo e boschi infinitamente silenziosi. Non un grido, non un rumore di passi sui sentieri, il cuore era colmo come di un vino cupo.
Falene e sfingi entrano in volo senza rumore dalla finestra, attratte dal bagliore del focolare e dal profumo del mio fagiano arrosto. Cozzano contro il soffitto con un rumore sordo, mi svolazzano intorno alle orecchie facendomi venire i brividi, quindi si posano sulla fiaschetta bianca della polvere appesa alla parete. Io le osservo, posate e tremanti, e loro mi guardano; ci sono bombici, rodilegno rossi, falene. Alcuni di loro mi sembrano delle viole del pensiero volanti.
Esco dalla capanna e mi metto in ascolto. Niente, nessun rumore, tutto dorme. L'aria risplende di insetti in volo, di miriadi di ali vibranti. Là, ai margini del bosco, ci sono felci e aconiti, l'uva ursina è in fiore, amo i suoi piccoli fiori. Grazie, mio Dio, per ogni fiore d'erica che ho visto: sono stati come piccole rose sulla mia strada, e io piango d'amore per essi. Da qualche parte, nelle vicinanze, cresce il garofano selvatico, non lo vedo, ma ne sento il profumo.
Ma adesso, nelle ore notturne, sono sbocciati all'improvviso grandi fiori bianchi nel bosco: i loro stigmi sono aperti, respirano. E pelose sfingi del crepuscolo si posano nelle loro corolle e fanno tremare l'intera pianta. Io vado da un fiore all'altro: sono ebbri, sono fiori ebbri di sesso, e io li vedo inebriarsi.
Passi leggeri, un respiro umano, un gioioso «buonasera».
Rispondo e mi getto a terra sulla strada, abbracciandole le ginocchia e il povero abito.
Buonasera, Eva! ripeto, consumato dalla felicità.
Quanto mi ami! mormora.
Ho ben ragione di provare gratitudine! rispondo. Tu sei mia, e il mio cuore se ne sta tutto il giorno quieto dentro di me, pensandoti. Sei la ragazza più bella di questo mondo e io ti ho baciata. Spesso arrossisco di gioia al solo ricordare d'averti baciata.
Come mai sei così innamorato di me proprio stasera? domanda.
E io lo ero per ragioni innumerevoli, mi era bastato pensare a lei per innamorarmene. Quello sguardo sotto le alte sopracciglia arcuate sulla fronte, e quella pelle scura, incantevole!
Non dovrei essere innamorato di te? dico. Io ringrazio ogni singolo albero perché stai bene e sei in salute.
© Paolo Melandri (13. 10. 2017)
*
Eva
E notti vanno e giorni vengono. Sono passati già tre giorni da questo colloquio. Eva cammina lungo la strada con un fardello. Ma quanta legna ha portato a casa dal bosco questa bambina, durante l'estate? Deponi il tuo fardello, Eva, e fammi vedere se i tuoi occhi sono sempre così azzurri. I suoi occhi erano rossi.
No, torna a sorridere, Eva! Non ti resisto più, sono tuo, sono tuo…
Sera. Eva canta, io ascolto il suo canto e un ardore mi pervade.
Canti questa sera, Eva?
Sì, sono felice.
E, siccome è più bassa di me, fa un piccolo salto per cingermi il collo.
Ma, Eva, ti sei graffiata le mani? Che peccato che te le sia graffiate!
Non fa niente.
Il suo volto irradia una luce meravigliosa.
Eva, hai parlato con il signor Vegetti?
Una volta.
Che cosa ti ha detto? E cosa gli hai detto tu?
È diventato molto duro con noi, fa lavorare mio marito giorno e notte al molo, e anche a me fa sbrigare ogni genere di lavori. Mi ha ordinato di sbrigare lavori da uomo.
Perché lo fa?
Eva abbassa gli occhi.
Perché lo fa, Eva?
Perché ti amo.
Ma come fa a saperlo?
Gliel'ho detto.
Pausa.
Voglia Iddio che non sia così duro con te, Eva!
Ma non fa niente. Ormai non fa più niente.
E la sua voce risuonava nel bosco come un leggero canto vibrante.
E le foglie si fanno ancor più gialle, si va verso l'autunno, altre stelle sono giunte in cielo e ora la luna appare come un'ombra d'argento immersa nell'oro. Non faceva freddo, niente, solo un fresco silenzio e un fluire di vita nel bosco. Ogni albero aveva i suoi pensieri. Le bacche erano mature.
© Paolo Melandri (9. 10. 2017)
*
Camera di studio
Erano questi i pensieri che mi opprimevano mentre guardavo il fondo del ruscello, sulle cui sponde il contadino arava. Piano piano la superficie marrone, il terreno arato si allargava. Ecco un bilancio migliore del mio.
Ma i pensieri non ci assalgono come ho riferito. Siamo noi che li colleghiamo, che ce ne rendiamo conto. Li ordiniamo in un prima e un dopo, li disponiamo l'uno accanto all'altro, in una successione, una contiguità che non hanno quando nascono in noi. Allora nel firmamento interiore splendono, come stelle cadenti, luoghi, nomi, cose ora informi. Si mescolano i morti con i vivi, i sogni con le cose vissute. Quali segni sono mai questi, e dove vagabondiamo noi nella notte? Vidi il nobile volto di Lorenzo, che saltò dalla finestra. Non era quello il nostro destino, la nostra realtà? Un giorno avremmo toccato terra. C'erano stati tempi, in cui la vita era valutata quasi soltanto come la preparazione di quel momento; forse erano stati meno privi di senso del nostro.
Un tenue tremore mi fece sussultare. Qualcuno doveva essere entrato. Balzando in piedi mi trovai di fronte a un vecchio che mi guardava. Doveva essere venuto da un gabinetto, che ora vedevo attraverso la porta aperta. Vidi l'angolo di un grosso tavolo, ancora illuminato da una lampada, nonostante l'ora meridiana, coperto di carte scritte e stampate e di libri aperti.
Lo sconosciuto era vecchio e piccolo ma mentre giungevo a queste conclusioni, sentivo subito che non dicevano nulla. Era davvero sconosciuto? ed era vecchio e piccolo? Ricco di anni certamente, infatti vedevo capelli bianchi brillare sotto la visiera che portava per proteggersi gli occhi. Inoltre i tratti del viso recavano l'impronta caratteristica lasciata da una lunga vita. Qualcosa di simile si trova nei grandi attori, che hanno impersonato lo spirito dei secoli. Però mentre in loro il destino li ha lavorati in superficie, il destino di quest'uomo aveva lavorato in profondità: egli non recitava.
Fissare l'età era una cosa secondaria, perché lo spirito non ha età. Quel vecchio poteva affrontare un rischio, fisico, morale o intellettuale, più facilmente di innumerevoli giovani e subire la prova meglio, perché si univano in lui potenza e intuito, astuzia acquistata e dignità innata. Quale era il suo animale araldico? Una volpe, un leone, uno dei grandi uccelli da rapina? Dovetti piuttosto pensare a una chimera, di quelle che nidificano sulle nostre cattedrali e guardano giù con saggio sorriso.
© Paolo Melandri (8. 10. 2017)
*
Avvicinamenti
Questa è la terza notte di ferro, Eva, ti prometto che domani sarò un'altra persona. Ora lasciami solo. Domani non mi riconoscerai nemmeno, riderò e ti bacerò, mia deliziosa.
Pensa, mi resta soltanto questa notte, e poi diventerò un altro uomo, tra qualche ora sarò cambiato. Buonanotte, Eva.
Buonanotte.
Mi stendo più vicino al fuoco e contemplo la fiamma. Una pigna cade dal ramo, e cade anche qualche ramo secco. La notte pare un abisso sconfinato. Chiudo gli occhi.
Dopo un'ora i miei sensi cominciano a vibrare con un ritmo particolare, risuono all'unisono con il grande silenzio, risuono all'unisono. Guardo la mezzaluna, è lì, in cielo, come una conchiglia bianca, e provo un sentimento d'amore per lei, sento che sto arrossendo. È la luna, dico sottovoce, con passione, è la luna! E il mio cuore batte verso di lei, in un palpito, sommesso. Questo, dura qualche minuto. Soffia un vento leggero, un vento estraneo mi raggiunge, una strana pressione dell'aria. Strano. Che cos'è? Mi guardo intorno e non vedo nessuno. Il vento mi chiama e la mia anima si piega consenziente a quel richiamo, io mi sento sollevare, strappare al mio mondo, stringere contro un seno invisibile, i miei occhi si bagnano di lacrime, tremo. Dio è lì vicino, da qualche parte, e mi osserva. Dura ancora qualche minuto. Mi volto, la strana pressione svanisce e vedo qualcosa che pare il dorso di uno spirito che entra silenzioso nel bosco…
Combatto per qualche istante contro un greve senso di stordimento, le emozioni mi hanno sfinito, mi sento mortalmente stanco e mi addormento.
Mi risvegliai che la notte se n'era andata. Ah, per tanto tempo ero vissuto in uno stato miserabile, febbricitante, in attesa di soccombere a questa o quella malattia. Spesso le cose mi apparivano capovolte, vedevo tutto con occhi infiammati, una profonda malinconia era padrona di me.
Adesso era passato.
© Paolo Melandri (8. 10. 2017)
*
Tardo autunno
Il bosco è ormai spoglio di foglie e silenzioso, senza più il canto degli uccelli. Solo le cornacchie lanciano i loro gridi rauchi alle cinque del mattino e si spargono poi sui campi. Le vediamo mentre ci rechiamo nel bosco, Falcetti ed io: la covata dell'anno, che non ha ancora imparato a temere il mondo, ci saltella davanti sul sentiero.
Poi incontrammo il fringuello, il passero dei boschi. Ha già fatto un giro nella foresta e ora torna dagli uomini, tra cui gli piace tanto stare e che esplora da tutti i lati. Piccolo, strano fringuello! In realtà è un uccello migratore, ma i suoi genitori gli hanno insegnato che è possibile svernare anche qui. E lui insegnerà ai suoi piccoli che è solo qui che si può svernare. Però gli scorre ancora dentro il sangue del viaggiatore, non ha smesso di essere un vagabondo. Un giorno si raduna con tutti i suoi, e insieme volano al di là di molte parrocchie, da gente tutta diversa, che vuole imparare a conoscere altrettanto bene. Allora il boschetto di tremoli rimane senza fringuelli, e può passare un'intera, lunga settimana prima che un nuovo stormo di queste creature alate torni a posarvisi… Mio Dio, quante volte mi sono divertito a osservare un fringuello!
© Paolo Melandri (7. 10. 2017)
*
Sulle soglie del bosco
Ringraziai e uscii. La signora aveva un'abitudine che sicuramente aveva conservato dagli anni della giovinezza: di tanto in tanto lanciava occhiate oblique, benché non ci fosse traccia di malizia in quel che diceva…
Le foglie cominciavano qua e là a ingiallire nel bosco, e aria e terra profumavano d'autunno. Solo i funghi erano nel loro momento d'oro, spuntavano dappertutto e crescevano belli e grossi sui loro tozzi gambi: porcini, prataioli e lattari. Ogni tanto anche un ovolaccio mostrava il suo cappello punteggiato ed esibiva il suo colore rosso. Strano fungo! Nasce dallo stesso suolo dei funghi commestibili, si nutre della stessa terra e riceve allo stesso modo il sole e la pioggia del cielo, è grasso e sodo e di buon sapore… solo che è pieno di spudorata muscalina. Una volta pensai di inventarmi una bella, antica leggenda sugli ovolacci e raccontare che l'avevo letta in un libro.
Ho sempre trovato interessante osservare la lotta di ogni fiore e di ogni insetto per opporsi alla morte. Quando il sole era caldo riprendevano vita e, per qualche ora, si abbandonavano all'antica gioia; le mosche grandi e forti erano vitali come in piena estate. Viveva lì una specie particolare di altiche che non avevo mai visto prima. Erano piccole e gialle, non più grandi di una virgola in corpo otto, ma saltavano a una distanza mille volte superiore alla loro lunghezza. Che forze smisurate aveva una simile creatura in proporzione alle sue dimensioni! Ecco qui un ragnetto con una specie di perla giallina come parte posteriore. Una perla così pesante che l'animale deve arrampicarsi sui fili d'erba con la schiena rivolta verso il basso. Quando incontra ostacoli che non può superare con la sua perla si lascia cadere e ricomincia da capo su un altro filo d'erba. Un simile ragno-perla non è un ragno e basta. Se per aiutarlo a rimettersi in piedi gli tendo una foglia che gli faccia da base, lui ci arranca sopra per un po' e scopre che no, qualcosa non va. Poi, camminando all'indietro, si ritrae da quella base-tranello… Sento qualcuno gridare il mio nome giù nel bosco.
© Paolo Melandri (4. 10. 2017)
*
Sotto la stella autunnale
Il mare si stendeva scintillante come uno specchio ieri e si stende scintillante come uno specchio oggi. È l'estate di San Martino e sull'isola fa caldo – e che dolcezza, che tepore! – ma non c'è sole.
Sono passati tanti anni da quando ho provato una simile pace, forse venti, o trenta, o forse è stato in una vita precedente. Ma una volta, penso, questa pace devo averla già assaporata, visto che sono qui a passeggiare canticchiando estasiato, e ogni sasso, ogni filo d'erba attira la mia attenzione e sembra ricambiarmi con uguale interesse. Siamo vecchi amici.
Mentre, seguendo il sentiero mezzo nascosto dall'erba, penetro nel bosco, il mio cuore freme di una gioia ultraterrena. Ricordo un luogo sulla costa orientale del mar Ionio dove sono stato una volta. Era come qui, e il mare era calmo e greve e color grigio ferro come ora. Mi addentravo nel bosco, mi sentivo commuovere fino alle lacrime, ero rapito, continuavo a ripetere: Dio del cielo, e pensare che sono tornato!
Come se fossi già stato lì!
Ma forse c'ero davvero arrivato una volta da un altro tempo e un'altra terra, dove il bosco e le stelle erano le stesse. Forse ero stato un fiore del bosco, o un coleottero che aveva per casa un'acacia.
E ora sono qui. Può essere che abbia volato per il lungo cammino, può essere che fossi un uccello. O forse il nocciolo di un frutto inviato da un mercante persiano…
Ecco, ora sono lontano dal chiasso della città e dalla ressa e dai giornali e dalla gente, sono fuggito da tutto perché ho sentito il richiamo della campagna e della solitudine da cui provengo. Vedrai, tutto andrà bene! penso, e sono pieno di speranza. Ah, sono già fuggito così e poi sono tornato in città. E sono fuggito di nuovo.
Ma ora è mia ferma intenzione trovare la pace a qualsiasi costo. Per il momento ho preso in affitto qui una stanza, e la vecchia Gilda è la mia padrona di casa.
I sorbi sono coperti di mature bacche di corallo tutt'intorno, nel bosco di conifere, e le lasciano cadere a terra in pesanti grappoli. Si vendemmiano e si riseminano da soli, ogni anno sprecano un'incredibile sovrabbondanza: su un solo albero conto oltre trecento grappoli. E qua e là sui pendii vi sono ancora fiori caparbi che si rifiutano di morire benché, in fin dei conti, il loro tempo sulla terra sia già finito.
Ma anche il tempo della vecchia Gilda è finito, e guarda un po' se muore! Si comporta esattamente come se la morte non la riguardasse. Quando i pescatori stanno sulla riva a sporcare dappertutto, incatramando le nasse o dipingendo le barche, la vecchia Gilda va da loro con gli occhi spenti, ma con il più scaltro spirito mercantile.
“Quanto costa oggi lo sgombro?” domanda.
“Quel che costava ieri”, è la risposta.
“Allora potete tenervelo.”
E Gilda se ne torna sui suoi passi.
Ma i pescatori sanno fin troppo bene che Gilda non è tipo da far solo finta di andarsene: è già capitato che se ne sia tornata a casa senza nemmeno voltarsi. “Ehilà!” E le gridano dietro che oggi avrà uno sgombro in più per ogni mezza dozzina, visto che è una vecchia cliente.
E Gilda compra il pesce…
Sulle corde dei panni sono appese sottane rosse, bluse azzurre e biancheria pesantissima: tutto filato e tessuto sull'isola dalle vecchie rimaste. Ma sono stese ad asciugare anche le eleganti sottovesti senza maniche tanto adatte a gelarci dentro, e le camiciole di lana che, tirandole, possono esser ridotte a una fune. Da dove vengono queste mostruosità? Ah, sono quelle delle figlie, le ragazze dei nostri tempi, che se le sono guadagnate in città. Se le si lava di rado e con attenzione durano giusto giusto un mese. E ci si ritrova così deliziosamente nude dentro quando i buchi cominciano a propagarsi nel tessuto.
Non sono un imbroglio, invece, le scarpe della vecchia Gilda. A intervalli ragionevoli va a trovare un pescatore della sua età che condivide il suo modo di pensare, e lui le unge tomaie e suole con un grasso forte, contro cui l'acqua è del tutto impotente. Vedo come il grasso viene bollito sulla riva: ci sono dentro sego, catrame e resina.
Ieri, mentre passeggiavo sulla spiaggia guardando i pezzi di legno portati dal mare, le conchiglie e i sassi, ho trovato un frammento di vetro da specchi. Non capisco come sia arrivato fin qui, ma ha tutta l'aria di un errore, una menzogna. Non è possibile che un pescatore l'abbia portato qui in barca, l'abbia posato e se ne sia ripartito! L'ho lasciato dov'era. Era grossolano, comune, semplice, forse era un pezzo di finestrino di un tram. Un tempo il vetro era raro e color verde bottiglia… Dio benedica quei bei tempi antichi in cui esistevano cose rare!
Sale ora il fumo dalle case dei pescatori all'estremità meridionale dell'isola. È sera, la farinata è sul fuoco. E quando il cibo sarà consumato, la gente a modo se ne andrà a letto per alzarsi di nuovo all'alba. Solo i giovani scapestrati continueranno a bighellonare di casa in casa, rimandando il tempo del rientro senza capire il proprio bene.
© Paolo Melandri (2. 10. 2017)
*
Caccia grossa
Con le metamorfosi da rapace diurno in notturno muta anche l'inclinazione dal cane al gatto, che entrambi vengono allevati nella casbah. Lo spazio tra la rocca e le mura anulari di cinta, per motivi di sicurezza è incolto e spianato, quindi destinato a campo di tiro. Là, all'ombra dei bastioni, sonnecchiano robusti mastini, o giocano sullo spiazzo tutt'intorno. Poiché gli animali possono diventar molesti, un ponte conduce dal luogo ove si arrestano le macchine fino all'ingresso della casbah.
Quando io ho da fare sullo spiazzo, non vi metto mai piede senza uno dei guardiani; mi stupisco della pacatezza con cui questi toccano gli animali. A me ripugnano perfino i musi che mi urtano o le lingue che mi leccano la mano. In molte cose gli animali sono più intelligenti di noi. Evidentemente essi fiutano il mio imbarazzo, che potrebbe crescere fino alla paura – – – allora mi si avventerebbero addosso. Con loro non si sa mai dove abbia fine il gioco. È una cosa che hanno in comune col Condor.
I mastini, tibetani scuri dai musi e le sopracciglia gialli, servono anche alla caccia. Sono folli di gioia quando la mattina presto odono il corno. È possibile aizzarli contro i più robusti avversari: assalgono il leone e il rinoceronte.
Questa muta non è, però, l'unica. Distante dalla casbah, ma visibile dall'alto, si estende sulla spiaggia un insieme di costruzioni adibito a stalle, rimesse, voliere, campi d'equitazione aperti e coperti. Là vi sono anche i canili dei levrieri. Il Condor ama galoppare coi suoi favoriti sull'immediata riva del mare; è il momento in cui sciama intorno a loro il branco dei cani della steppa, destinati alla caccia delle gazzelle. La loro falcata ricorda i corridori e i giocatori di palla, che trionfano qui nell'arena: intelligenza e carattere sono immolati alla furia dell'inseguimento. Hanno crani sottili dalle fronti piatte, muscoli che giocano nervosamente a fior di pelle. Inseguono a morte la vittima con lunga caccia, instancabili, quasi si esaurisse in loro un meccanismo a spirale.
La gazzella spesso riuscirebbe ancora a sfuggire, se non venisse puntata dal falconiere. Si scappuccia lo sparviero, che viene scagliato in aria; i cani, e dietro di loro i cacciatori a cavallo, seguono il suo volo, che li guida alla selvaggina. Una caccia simile, sulle vaste pianure ricoperte soltanto di erba alfa, offre un grande spettacolo; il mondo diventa più semplice, mentre cresce la tensione.
© Paolo Melandri (1. 10. 2017)
*
Notti luminose
Era una notte magnifica.
Le poche persone che ancora si vedevano per strada apparivano allegre. Spingendo una carriola, un uomo avanzava nel cimitero e cantava a bassa voce; per il resto, il silenzio era tale che a parte quel canto null'altro si udiva. Dall'altura presso la casa del dottore la cittadina appariva come uno strano, gigantesco insetto ramificato, una bestia favolosa che si fosse appiattita al suolo, allungando zampe, corna e tentacoli in tutte le direzioni. Soltanto qua e là muoveva qualche giuntura o ritirava qualche tentacolo: come in quel movimento, giù al mare, dove un piccolo battello scivolava silenzioso sulle onde aprendo un solco nell'acqua nera. Il fumo del sigaro di Minuto si levava azzurro verso l'alto. Lui avanzava respirando la fragranza del bosco e dell'erba, e fu preso da una commovente sensazione di contentezza, da un'allegria strana e incontenibile che gli fece affluire le lacrime agli occhi e quasi non gli toglieva il respiro. Camminava al fianco di Jetta, che ancora non aveva detto nulla; nel passare davanti al cimitero lui aveva fatto qualche commento sulla serata in casa del dottore, ma lei non aveva risposto. In verità, il silenzio e la bellezza della notte lo avevano a tal punto affascinato, lo avevano penetrato di tanta ebbrezza, che il respiro gli si fece affannoso e lo sguardo vago. Oh, il fascino delle notti luminose!
© Paolo Melandri (28. 9. 2017)
*
Gli accenni di Twinnings
Tuttavia pochi avevano la velleità di abbandonare un lavoro dove erano trattati e pagati in modo principesco. Qualche eccezione però c'era. È un'antica verità che l'uomo non si contenta mai. Inoltre gli operai di Zapparoni erano oltremodo difficili a trattare. Questo dipendeva dal carattere molto personale del lavoro; il contatto con oggetti piccolissimi e spesso bizzarri generava col tempo uno spirito stravagante ed esageratamente scrupoloso, creava indoli che si infastidivano per un pulviscolo nei raggi del sole e trovavano un pelo in ogni uovo. Costoro erano artisti capaci di fabbricare ferri per i piedi delle pulci e attaccarli con le viti. Il mondo degli automi zapparoniani, già abbastanza strano in sé, era animato da spiriti che si abbandonavano alle bizzarrie più strambe. Nel suo ufficio privato, si diceva, avvenivano spesso scene da gabinetto di un grande alienista. Purtroppo non c'erano ancora robot capaci di produrre altri robot. Sarebbe stata la pietra filosofale, la quadratura del cerchio.
Zapparoni dovette rassegnarsi ai fatti. Appartenevano all'essenza delle sue aziende. Vi si rassegnò e non senza abilità. Nella sua officina modello egli riservava per sé i rapporti coi dipendenti, rivelandovi il fascino, la versatilità di un impresario meridionale. Arrivava così sino ai limiti del possibile. Essere sfruttati un giorno da Zapparoni, era il sogno di tutti i giovani appassionati della tecnica. Di rado egli perdeva il dominio di sé e l'amabilità. Ma allora accadevano scenate tremende.
Naturalmente, egli cercava di garantirsi nei contratti di assunzione, sia pure con molto garbo. I contratti erano a vita, provvedevano stipendi mobili, premi, assicurazioni e, in caso di rottura del contratto, punizioni e penali. Chi aveva concluso un contratto con Zapparoni e poteva chiamarsi maestro o autore nelle sue officine, poteva ben vantarsi di essersi fatto una bella posizione. Aveva la sua casa, la macchina, le vacanze pagate a Teneriffe o in Norvegia.
Certo, v'erano delle restrizioni. Erano però appena sensibili, e consistevano, per dire pane al pane, in un ben calcolato sistema di vigilanza. A questo fine servivano diverse istituzioni, chiamate con i nomi insignificanti con i quali oggidì si camuffa il servizio di sicurezza: uno si chiamava, credo, Ufficio di Liquidazione. Gli incartamenti, che vi si conservavano su ogni impiegato delle officine Zapparoni, erano simili agli incartamenti della polizia, ma molto più particolareggiati. Oggi bisogna conoscere bene gli uomini, per sapere che cosa c'è da attendersi da loro, perché le tentazioni sono grandi.
In tutto ciò non v'era nulla di riprovevole. Le precauzioni contro gli abusi di fiducia fanno parte dei doveri di colui che vuole dirigere una grande officina. Se si sapeva aiutare Zapparoni e salvaguardare i suoi segreti d'ufficio, si stava dalla parte buona.
Però cosa accadeva se uno di questi tecnici si congedava legalmente? O semplicemente se n'andava, e pagava la penale convenuta? Era questo un punto debole nel sistema di Zapparoni. In fin dei conti non poteva legarli con le corde. Era un grosso pericolo per lui. Nel suo interesse doveva dimostrare che questi licenziamenti non giovavano a chi si licenziava. Vi sono molti mezzi per richiamare qualcuno all'ordine, specialmente quando non si bada minimamente al danaro.
Per cominciare, si può levargli il fiato con le cause. E questo poteva bastare per mettere giudizio a parecchi. Ma c'erano lacune nella legge, che già da molto tempo non teneva dietro allo sviluppo tecnico. Ad esempio in questo caso come definire i diritti d'autore? Lo splendore che fioriva al vertice dell'opera collettiva non apparteneva al merito personale, e non poteva così semplicemente essere staccato e portato via. E così l'abilità tecnica, che si era sviluppata nel corso di trenta, quarant'anni con l'aiuto e a spese dell'officina. Non era soltanto una proprietà individuale. Ma l'individuo era indivisibile o no? Ecco questioni per le quali il senno grossolano della polizia non era sufficiente. Vi sono posti di fiducia, che sottintendono indipendenza. Il difficile sta nell'indovinare; non si fa nessun diretto accenno né per iscritto né a voce. Bisogna comprendere per intuito.
Questo, press'a poco, potei dedurre dagli accenni di Twinnings. Erano combinazioni, supposizioni. Forse egli sapeva di più, forse anche meno. In simili casi si preferisce dire troppo poco anziché troppo. Avevo già capito abbastanza: si cercava un uomo che si assumesse l'incarico dei panni sporchi.
© Paolo Melandri (28. 9. 2017)
*
Le officine Zapparoni
Ecco Giacomo Zapparoni, un altro di quelli che non possono contare il danaro che hanno, sebbene il padre fosse venuto d'oltremare col bastone in mano. Non si poteva aprire un giornale, una rivista, mettersi a sedere davanti a uno schermo, senza imbattersi nel suo nome. Le sue opere erano a portata di mano; egli aveva costruito un monopolio sfruttando le invenzioni altrui, ma anche le proprie.
I giornalisti raccontavano cose fiabesche su quel che egli produceva. Si regala a chi ha: probabilmente lasciavano libero campo alla loro fantasia. Le officine Zapparoni costruivano dei robot per ogni scopo immaginabile. Eseguivano ordinazioni speciali e anche modelli in serie che si trovavano in ogni famiglia. Non erano i grandi automi, ai quali si pensa subito nell'udir parlare di robot. La specialità di Zapparoni erano i robot lillipuziani. A parte alcune eccezioni, i più grandi erano su per giù delle dimensioni di un cocomero, mentre i più piccoli erano minuscoli e rammentavano le curiosità cinesi. Operavano come formiche intelligenti, però sempre in gruppi che lavoravano come meccanismi, dunque non secondo reazioni chimiche e fisiche. Così volevano le massime commerciali di Zapparoni, o, se si preferisce, le sue regole del gioco. Spesso pareva che, tra due soluzioni, egli preferisse a ogni costo la più raffinata. Ma questo era proprio del tempo, e favoriva i suoi interessi.
Zapparoni aveva cominciato con piccolissime tartarughe, che chiamava selettori e che erano preziose nei più sottili processi di selezione. Contavano, pesavano e assortivano pietre preziose e biglietti di banca, scartando i falsi. Il principio si era esteso al lavoro in campi pericolosi, al lavoro degli esplosivi e delle sostanze infette o radioattive. C'erano sciami di selettori che non soltanto scoprivano piccoli focolai d'incendi, ma li spegnevano anche sul nascere, altri che correggevano le manchevolezze delle condutture e altri ancora che si nutrivano di sporcizia e diventavano indispensabili in ogni operazione che richiedesse una pulizia perfetta. Mio zio, il senatore, il quale vita natural durante aveva patito per la febbre del fieno, poteva risparmiarsi i viaggi in alta montagna, da quando Zapparoni aveva messo in commercio selettori allenati contro il polline.
Presto i suoi apparati erano diventati indispensabili, non soltanto nell'industria e nella scienza, ma anche nella casa. Risparmiavano la mano d'opera e conferivano alla tecnica una vita sconosciuta in passato. Un cervello ingegnoso aveva scoperto una lacuna che nessuno aveva veduto prima di lui; e l'aveva colmata. Ecco come si fanno gli affari migliori, i più grossi.
Twinnings accennò a quello che credeva fosse il punto debole di Zapparoni. Non lo sapeva con precisione; però da un calcolo approssimativo, sembrava fosse nei suoi rapporti con gli operai. Quando si ha l'ambizione di costringere la materia a pensare, non si può fare a meno di cervelli originali. Tanto più quando si deve lavorare su dimensioni ridottissime. Probabilmente in principio fu meno difficile fare una balena che un colibrì.
Zapparoni disponeva di una base di eccellenti forze tecniche. Preferiva che gli inventori, i quali gli portavano modelli, entrassero stabilmente al suo servizio. Riproducevano le proprie invenzioni o le trasformavano. Il che era necessario soprattutto in tutte le sezioni soggette alla moda, ad esempio per i giocattoli. Non si erano mai vedute follie come nell'èra di Zapparoni. Aveva creato un regno lillipuziano, un vivente mondo di nani, che faceva dimenticare il tempo, in un miraggio, non soltanto ai bambini ma anche ai grandi. Superiore al gioco della fantasia. Però questo teatro di nani ogni anno, a Natale, doveva essere ornato di nuove scene, popolato di nuove figure.
Zapparoni occupava operai ai quali assegnava stipendi da professori, anzi, da ministri. Glieli rendevano lautamente. Un licenziamento significava per lui una perdita insostituibile, anzi, una catastrofe, se l'operaio avesse continuato il lavoro altrove, sia in patria, sia, peggio ancora, all'estero. La ricchezza di Zapparoni, la sua potenza monopolistica riposavano non soltanto sul segreto professionale, ma anche sopra una tecnica del lavoro che era stato possibile mettere insieme soltanto nel corso di decine e decine di anni, e nemmeno da tutti. E questa tecnica dipendeva individualmente dall'operaio, dalle sue mani, dalla sua testa.
© Paolo Melandri (27. 9. 2017)
*
Vittoria
Sicuro, che cosa era l'amore? Un soffio di vento che mormora nelle rose, o no, una gialla fosforescenza che scorre nel sangue. L'amore era una musica diabolica, infuocata, che fa battere a ritmo di danza persino il cuore dei vecchi, era come la margherita che tutta si apre al giungere della notte, come l'anemone che si chiude a un soffio e muore se toccato.
Tale era l'amore.
Poteva distruggere un uomo, risollevarlo, prostrarlo di nuovo; poteva amare oggi uno, domani un altro, domani sera un terzo, tanta era la sua incostanza. Ma poteva anche resistere come un sigillo infrangibile, fiammeggiare inestinguibile sino al momento di morire, tanto era eterno. Quale era dunque l'amore?
Oh, l'amore è una notte d'estate, con in cielo stelle e profumi sulla terra. Ma come mai induce l'adolescente a seguire furtivi cammini, e il vecchio ad ergersi sulla punta dei piedi, nella sua camera solitaria? Ah, l'amore fa del cuore umano una fungaia, un giardino opulento dove crescono funghi misteriosi ed insolenti.
Non spinge egli forse il monaco a introdursi in chiusi giardini, a spiare alla finestra delle dormenti, nella notte? non empie forse la monaca di follia, non oscura la mente della principessa? Egli curva la testa del re nella polvere della strada, gliela fa spazzare coi capelli, e il re frattanto mormora fra sé impudiche parole e ride tira fuori la lingua.
Tale era l'amore.
Ovvero, no, no, egli è tutt'altra cosa, e nulla al mondo gli somiglia. Venne sulla terra una notte di primavera, allorché un adolescente vide due occhi, e li guardò, li fissò. Baciò una bocca, e nel suo cuore fu come l'incontro di due raggi, lo scintillio di un sole verso una stella. Cadde in un abbraccio, e nulla più udì, nulla più vide del mondo intero.
L'amore è la prima parola di Dio, il primo pensiero che veleggiò per il suo cervello, quando egli disse «Sia fatta la luce!». L'amore nacque, e tutto ciò ch'egli aveva creato era molto buono, e nulla voleva cambiarvi. E l'amore fu l'origine del mondo, il signore del mondo; ma tutte le sue strade sono piene di fiori e di sangue, di fiori e di sangue.
© Paolo Melandri (25. 9. 2017)
*
La via del bosco
Poi, di nuovo, isole di sterpaglia, negli spiazzi deserti. In una di tali isole si scorgeva un sentiero battuto, una pista di selvaggina. Sfinito a morte, la seguii ciecamente, a tastoni. Conduceva ad un pianoro libero; vi cresceva un cipresso, la cui altezza sfuggiva ad ogni immaginazione. Se il cielo fosse stato nuvoloso, non ne avrei scorto la cima. Il tronco era cavo; l'accesso all'interno non risultava dalla decomposizione del legno ma era intagliato a riquadro dentro l'alburno, come un portale. Gli alberi sono i nostri migliori amici: mi azzardai a entrarvi.
Nel buio, guadagnai l'interno a quattro zampe; il suolo era ricoperto di pelli, o piuttosto di un vello che sembrava esser scaturito da esso come dal dorso di un animale. Un giaciglio magnifico: mi distesi sopra e in un baleno piombai in un sonno simile alla morte.
Non so quanto tempo io abbia riposato là. Quando mi destai, mi sentii rinato, come dopo un bagno dentro la fonte dell'eterna giovinezza. L'aria era deliziosa: profumava di legno di cipresso, la cui resina bruciando si muta in incenso.
Il sole del mattino penetrava nel portale aperto nel legno. Mi drizzai: la mia pelle riluceva, lavata dal sangue, e delle spine non vi era più traccia alcuna. Dovevo aver sognato. Ma, nel frattempo, qualcuno si era preso cura di me. Che significa fra-tempo? Una pausa fra due istanti, o anche fra due forme di esistenza.
Accanto a me, vi era una veste, una sorta di burnus: era tessuta del medesimo oro come il tappeto. Inoltre dei sandali e un vassoio con pane e vino – una elargizione grande e immeritata. Ma da chiunque venisse – qui non era possibile altra forma di risposta che la preghiera.
© Paolo Melandri (24. 9. 2017)
*
Annotazioni
Il ritiro nella foresta somiglia al delitto perfetto, tanto nella sua progettazione come negli insuccessi. Nulla è più facile della decisione a rendersi padrone di se stesso, nulla è più arduo della sua attuazione. L'uomo ha disimparato ad essere autonomo – a stare sui propri piedi, a diretto contatto del suolo. Malvolentieri rinuncia all'aiuto e alle connivenze. Ciò causa già le prime falle nel sistema.
Anche qui, nel Sud, individui senza dimora si sono fatti una fama – isolani come quelli del Nord, e come loro pecorai e assassini. Il pecoraio è più audace e più libero del bovaro: è meno legato alla terra, ha per pascoli i deserti. L'aratro, il giogo, il recinto, la casa sono invenzioni del bovaro e quindi gradini del servaggio e del profitto. Si tratta di fenomeni: alle loro spalle si drizzano i grandi segni dell'Ariete e del Toro.
Annotazioni simili sono oziose in città, dove non si è più capaci di distinguere tra ragione e causa. La causa ha una ragione, ma la ragione non ha causa. La causa spiega, mentre la ragione si fonda sull'imperscrutabile – ma ciò sia detto en passant.
© Paolo Melandri (23. 9. 2017)
*
Maestri [fragmentum]
Vi furono ore in cui i portali della storia si spalancavano, i sepolcreti si aprivano. I morti giungevano con le loro sofferenze, le loro delizie, la cui somma resta sempre uguale. Venivano evocati alla luce del sole, che splendeva per loro come per noi. Un raggio colpiva la loro fronte: ne avvertivo il calore, quasi che il trilobita si muovesse nella mia mano. A noi era dato prender parte alla loro speranza: quella speranza, sempre delusa, che si trasmette di stirpe in stirpe. Sedevano in mezzo a noi, spesso amici e nemici non si distinguevano quasi gli uni dagli altri, era possibile discutere sui loro contrasti. Noi diventavamo i loro avvocati. E ognuno aveva ragione.
Ci porgevamo le mani: erano vuote. Ma noi porgevamo ad altri la ricchezza del mondo.
Stavamo seduti insieme nel giardino – – – si era fatto tardi; la luna piena era alta dietro la casbah, ritagliata come un sigillo nel suo disco. Netti se ne distaccavano la cupola e i minareti.
A tratti, uno di noi lasciava la cerchia per prender fiato, come avevo fatto io allora, dopo la lezione sull'emiro Musa e la Città dell'Ottone.
Infine, anche Vigo parve sopraffatto – non da spossatezza perché il suo viso ardeva; si levò: «Ragazzi, lasciatemi solo».
© Paolo Melandri (23. 9. 2017)
*
Appunti del bar notturno
Se il Condor venisse rovesciato ad opera dei tribuni, le cose non cambierebbero molto, perché anch'essi devono servirsi della violenza. Cambia soltanto lo stile. Il tiranno viene rimpiazzato da demagoghi. Il demagogo regge il timone in quanto conferisce al plebiscito l'indirizzo da lui desiderato. L'arte consiste nel modo di porre la questione: se riesce, la risposta sarà schiacciante, non soltanto perché massiccia ma anche per l'uniformazione intellettuale, che raggiunge fin le punte estreme.
Il Condor cerca di evitare il plebiscito: si tratterebbe per lui di una lingua straniera. In compenso, dispone della manifestazione popolare. Qualora l'opposizione si facesse troppo ostensibile, il Domo sarebbe sempre in grado di scatenare, e poi acquetare, al porto o nei mercati, una bufera di massa. Come preludio, una stampa clandestina, da lui tollerata, comicerebbe a reclamare teste nello stile dell'«Ami du Peuple»: il che nella maggior parte dei casi è già sufficiente. Altrimenti l'ira popolare divampa e si fa virulenta.
In simili circostanze, non si vedono né soldati né poliziotti, e nemmeno membri del partito. Al contrario – il Domo ne richiede l'intervento soltanto se si prevarica oltre i vetri rotti.
Nella sua potenza, il Condor prende i propri avversari sotto la sua protezione.
Il potere non si risolve esclusivamente nella politica: elementi personali vi confluiranno inevitabilmente. È questo il limite dinanzi al quale sia tiranni che demagoghi si abbassano fino al dispotismo. È qui che s'inserisce l'illusione, che travalica il potere sfiorando spesso la comicità. Nerone, malgrado la voce debole, voleva essere il primo anche come cantante. Ho seguito di recente la sua grottesca esibizione nel circo di Napoli, prima della quale cinquemila hippies erano stati scaglionati in bande sulle gradinate, per applaudirlo. Le acclamazioni s'iniziarono col «ronzìo d'api», aumentando a «suono di mattoni forati», fino a sfociare nell'arena con l'intensità di un «fracasso di anfore sbattute».
Un altro, Commodo, che si atteggiava a discendente di Eracle, abbatteva personalmente le fiere nel Colosseo e sbevazzava dentro una coppa a forma di clava. Questo Commodo m'interessa, peraltro, come tipo di anarca fallito. Non intendo riferirmi a particolari quali quelli riferiti da Lampridio – per esempio, ch'egli radunava a palazzo donne di alto lignaggio, le faceva spogliare, esaminandole poi intimamente come un incettatore di bordello.
Che l'anarca studi la storia dei Cesari ha, per lui, un significato teorico – – – essa costituisce per lui un campionario di modelli e di soluzioni possibili. In pratica, tuttavia, l'autodisciplina è l'unica forma di dominio che gli si attagli. Anche lui può uccidere chiunque – questa consapevolezza è profondamente murata nelle cripte della sua coscienza – e innanzitutto sopprimersi, se non riesce a bastare a se stesso.
© Paolo Melandri (22. 9. 2017)
*
Supposizioni
È avvenuto dopo una delle grandi devastazioni. Era già trascorsa da anni. Il deserto, fin da prima coperto di scarsa vegetazione, era ormai del tutto inaridito. Le carovaniere apparivano orlate di scheletri di uomini e di animali. Le ossa rilucevano al sole come opali: erano calcinate. Non era stata la decomposizione a sbiancarle. La carne deve esser stata consumata in un attimo. Anche le capanne di argilla delle oasi, le case intorno ai pozzi di trivellazione si erano fuse allo stesso modo: la creta e le pietre erano vetrificate. Sui muri si disegnavano profili di palme, cammelli e uomini, riflessi delle radiazioni cui era seguita la vampa. Da una torre di trivellazione pendevano giù le putrelle superiori, come uno zampillo che si fosse congelato. L'imboccatura di un cannone era piegata come quella di un tubo di gomma; sotto, gocce d'acciaio maculavano la sabbia. Anche le catastrofi hanno il loro stile.
Ero solo. Dei miei compagni, taluni avevano già rinunziato dopo le prime marce, perché erano morti all'altezza di quegli orrori; molti dovevano esser morti di sete o dentro le vallate contaminate. Ancora una volta ero l'ultimo: fa parte delle esperienze dell'età, si diventa stanchi di sopravvivere.
Non so come raggiunsi la foresta. Probabilmente nubifragi avevano colmato le antiche pozze d'acqua. Inoltre, mi ero allontanato dal centro della devastazione; nell'aria roteavano i primi avvoltoi. Poi scorsi piante e animali, tra i quali alcuni a me sconosciuti. Taluni rammentavano illustrazioni di vecchi libri di favole, come se un demiurgo le avesse raccapezzate qua e là.
Si sa che le marce, spinte fino alla spossatezza, provocano delle visioni. D'altra parte, quelle figure mi ricordavano esperimenti cui un tempo mi ero dedicato, e può darsi che una tale reminescenza le avesse proiettate, ingrandite, nel deserto. Anche un fatto simile può acquistare realtà: dopotutto, ogni esperimento è una reminescenza realizzata.
© Paolo Melandri (22. 9. 2017)
*
Il risveglio della terra [N° 1]
Il lungo, lunghissimo sentiero fra gli acquitrini e le foreste, chi l'ha tracciato, se non l'uomo? Prima di lui, niente sentiero; dopo, di quando in quando, sulla landa e per le paludi, un animale seguì la via appena percettibile e la marcò con un'impronta più netta. Alcuni uomini, fiutata la pista dell'animale, cominciarono poi a servirsi del sentiero nelle loro corse di campo in campo. Così nacque il sentiero dell'altipiano, il vasto territorio senza padrone, la terra di nessuno.
L'uomo arriva, diretto verso la meta. Ha con sé un sacco, carico di viveri e di alcuni arnesi. È robusto e rude; ha la barba rossa e incolta; cicatrici sul viso e sulle mani testimoniano il lavoro o la guerra. Forse, fuggendo il castigo, cerca di nascondersi qui; oppure, forse è un filosofo che aspira alla pace: così è venuto, l'essere umano, in mezzo a questa spaventosa solitudine. Egli va e va. Attorno a lui, gli uccelli e gli altri animali che camminano o strisciano sulla terra. Talvolta, pronuncia alcune parole, come a se stesso: «Eh, mio Dio!». Quando ha varcato le paludi e giunge a una località più accogliente, in una piana aperta in mezzo ai boschi, posa a terra il sacco e inizia l'esplorazione del luogo. Guarda, esamina; e in capo a un'ora, torna, rimette il sacco in spalla e riprende il cammino. Così per tutta la giornata. Vede declinare il sole, la notte cadere. Si getta allora nella brughiera, e dorme, il viso protetto dal braccio piegato.
Ancora qualche ora, poi riparte, «eh, mio Dio!», puntando sempre diritto alla meta; e vede di nuovo lo spuntar del sole. Si nutre di galletta e di formaggio di capra, si disseta al ruscello, e riprende la marcia. Anche quel giorno, chissà quanti luoghi esplorerà, che gli sembreranno accoglienti, in mezzo ai boschi. Che cosa cerca infine? Una terra, un campo? Forse è un emigrante. Tiene bene aperti gli occhi e osserva; talvolta, per veder meglio, sale su un'altura. Frattanto, il sole tramonta.
L'uomo sale il versante occidentale della valle, ricoperto di legname odoroso, di alberi sempre verdi e di praterie. Scende lungo una verde china; laggiù riluce il riflesso di un fiume; l'uomo distingue una lepre che lo varca d'un sol balzo, e approva col capo, soddisfatto che la larghezza del fiume permetta il salto. Una pernice, che stava covando, si alza improvvisamente fra i suoi piedi, con stridi di spavento; e l'uomo ancora approva col capo, poiché ha trovato selvaggina di pelo e di piuma. Va fra i cespugli di mortella e di mirtilli, gli stellari silvestri e le felci; si ferma per scavare la terra e scopre qui dell'humus, là della torba, che la caduta delle foglie e i rami secchi ingrassano da migliaia di anni. L'uomo si decide, si stabilisce qui; sì, ecco che cosa fa: si stabilisce. Per due intere giornate percorre i dintorni; ma ogni sera torna alla prateria, e ogni notte dorme sul duro suolo. Si sente già a casa propria; ha già il suo letto sotto una roccia.
Il più difficile era stato trovare il luogo, questo luogo che non fosse di nessun altro. Ormai i giorni appartenevano al lavoro. Egli cominciò con lo strappare la corteccia degli alberi nei boschi delle vicinanze, mentre ancora vi scorreva la linfa; la mise sotto forti pesi e la fece seccare. Quando ne ebbe un bel mucchio, la portò al capoluogo ripercorrendo tutte le miglia che già aveva percorso, e la vendette ai costruttori; poi, tornò alla sua sede, recando nuovi sacchi di viveri e di attrezzi, farina, lardo, una marmitta, una vanga. Andò e tornò così, innumerevoli volte, per il noto sentiero, sempre più inverosimilmente carico. Un portatore nato, una macchina lanciata attraverso la foresta, ecco che cos'era, ormai; camminare molto, portar molto, questo era il suo ideale; recar sul dorso gravi carichi era nulla per lui: la sua fatica gli pareva una ben pigra bisogna.
Un giorno oltre il fardello condusse due capre e un capretto. Era fiero delle sue capre, come se si fosse trattato di una intera mandria di vacche, e le trattava umanamente.
© Paolo Melandri (21. 9. 2017)
*
Inferno
L'inferno? ma io sono stato educato al più profondo disprezzo per l'inferno, che m'hanno insegnato a considerare come una fantasia da gettare nell'immondezzaio dei pregiudizi. E però non posso negare i fatti, qualcosa è cambiato, e qui sta la novità nell'interpretazione delle pene dette eterne: noi ci siamo già, nell'inferno. La terra, è l'inferno, la prigione costruita con un'intelligenza superiore, in modo ch'io non possa fare un passo senza urtare la felicità altrui, e che gli altri non possano essere felici senza farmi soffrire.
Il fuoco dell'inferno è il desiderio di arrivare; le potenze suscitano il desiderio e concedono ai dannati di raggiungere i loro scopi. Ma quando la meta è raggiuta e le ambizioni sono appagate, tutto appare senza valore, e la vittoria è nulla! vanità delle vanità, tutto è vanità. E allora, dopo la prima disillusione, le potenze soffiano sul fuoco del desiderio e dell'ambizione, e il tormento maggiore non è la fame insoddisfatta ma la brama saziata che ispira il disgusto di ogni cosa. Così, il Demonio subisce indefinitamente il castigo, perché ottiene tutto ciò che desidera e all'istante, così che non può godere di nulla.
Sono all'inferno e la dannazione grava su di me. Esaminando il mio passato, rivedo la mia infanzia già organizzata come uno stabilimento di detenzione, una camera di tortura, e per spiegare i supplizi inflitti a un bambino innocente non resta che ricorrere all'ipotesi di un'esistenza precedente dalla quale siamo ricacciati quaggiù, per espiare le conseguenze di colpe dimenticate. Ma le potenze non m'accordano più tregua.
© Paolo Melandri (17. 9. 2017)
*
Solo [N° 4]
Quando però torno a casa e mi metto alla scrivania mi sento veramente vivo e le energie che ho attinto dall'esterno, sia dal trasformatore delle disarmonie che dall'interruttore delle armonie, tornano utili ai miei più svariati fini. Allora vivo, e vivo le molte vite dei personaggi che descrivo; sono contento con chi è contento, cattivo con chi è cattivo, buono con chi è buono; sguscio fuori dalla mia personalità e parlo come fossi un bambino, una donna o un vecchio; sono re e mendicante, sono il potente, il tiranno e il più disprezzato di tutti, l'orditore dei tiranni che lo opprimono; qualsiasi opinione mi appartiene e qualsiasi religione è la mia; vivo in qualsiasi epoca e io stesso non esisto più. È una condizione che dà una felicità indescrivibile.
© Paolo Melandri (16. 9. 2017)
*
Solo [N° 3]
Non ho mai odiato gli altri, piuttosto il contrario, ma ho avuto paura di loro, fin da quando sono nato. La mia socievolezza era così grande che potevo stare con chiunque, e fino ad ora ho considerato la solitudine una condanna, come probabilmente è. Ho chiesto infatti a degli amici che sono stati in prigione in che cosa consistesse sostanzialmente la pena e mi hanno risposto: nella solitudine. Questa volta, a dire il vero, sono stato io a cercare di star solo, ma avevo posto una tacita condizione: di avere la facoltà di andare a trovare i miei conoscenti quando ne avessi voglia. Perché, dunque, non lo faccio? Non posso, perché quando salgo le scale mi sento un mendicante e una volta davanti al campanello torno indietro. Tornato a casa, però, sono contento, specialmente se passo in rassegna con l'immaginazione quello che avrei dovuto ascoltare se solo fossi entrato in quella casa. Non essendo i miei pensieri all'unisono con quelli di nessuno, mi sento ferito da qualsiasi cosa dicano, e prendo spesso una parola innocente per un insulto.
L'inverno è tornato; il cielo è grigio e la luce viene dal basso, dalla neve bianca dei campi. La solitudine è all'unisono con la morte apparente della natura, ma a volte diventa troppo pesante. Ho desiderio di contatto umano, ma la solitudine mi ha reso ipersensibile come se la mia anima fosse priva della protezione della sua pelle, e sono ormai così viziato dalla libertà di governare i miei pensieri e i miei sentimenti che non riesco quasi a sopportare il contatto fisico con un'altra persona. Di più; qualsiasi persona mi si avvicini mi fa un effetto soffocante per il fatto stesso di invadere con la sua la mia sfera spirituale.
© Paolo Melandri (16. 9. 2017)
*
Solo [N° 2]
Credo di essere destinato a essere solo, e che sia un bene per me; desidero crederlo, altrimenti la realtà sarebbe fin troppo spietata. Ma nella solitudine la testa di tanto in tanto si carica troppo e minaccia di esplodere; è necessario quindi osservarsi bene. Cerco insomma di mantenere l'equilibrio tra quello che esce e quello che entra; ogni giorno devo trovare uno sfogo nella scrittura e prendere qualcosa di nuovo nella lettura. Se scrivo tutto il giorno, la sera sopraggiunge un vuoto desolato, mi sembra di non avere più niente da dire e di essere finito. Se invece leggo tutto il giorno, alla fine mi sento così ricolmo da voler scoppiare.
Inoltre devo equilibrare le ore di sonno e di veglia. Troppo sonno stanca al punto da diventare una tortura; troppo poco conduce all'isteria.
Il giorno in qualche modo passa, ma la sera è difficile, perché il fatto di sentire affievolire la propria intelligenza è doloroso quanto il sentirsi decadere spiritualmente e fisicamente.
© Paolo Melandri (15. 9. 2017)
*
Solo
In conclusione la solitudine è questo: avvolgersi dentro al filo di seta che fila la nostra anima, diventare crisalide e aspettare la metamorfosi, che avverrà sicuramente. Viviamo, intanto, delle nostre esperienze, e telepaticamente viviamo la vita degli altri. Morte e resurrezione, una nuova educazione a qualcosa di inusitato e sconosciuto.
Soli, disponiamo infine della nostra persona. Nessun pensiero che controlli i miei pensieri, nessun giudizio, nessun capriccio che mi opprima. Ora l'anima comincia a crescere in una libertà conquistata da poco e provo una immensa libertà interiore e una gioia tranquilla, una sensazione di sicurezza e di responsabilità.
Ho sempre voluto progredire ed elevarmi, per questo ho sempre avuto un grado di giudizio superiore rispetto a coloro che hanno voluto tirarmi in basso; ecco perché sono rimasto solo.
La prima tappa della solitudine è la resa dei conti con se stessi e con il proprio passato. È un lavoro lungo, un'educazione completa al dominio di sé.
Ma la conoscenza di sé – quando è possibile – è la forma di studio più proficua. Indubbiamente bisognerà affidarsi allo specchio di tanto in tanto, in particolare allo specchio per vedersi dietro, poiché altrimenti non è possibile sapere come siamo di spalle.
© Paolo Melandri (14. 9. 2017)
*
Ricordi dalle scogliere
Rammemoriamo volentieri i giorni di orgoglioso sentire, ma non dobbiamo neppur tacere dei giorni quando la debolezza predominava in noi. La distruzione ci appare, nelle ore di ripiegamento, in aspetti orrendi e simili alle immagini che si vedono nei templi dedicati agli dèi della vendetta.
Più di un mattino si levò grigio per noi, e ci aggiravamo sgomenti e senza gioia per l'Eremo della Ruta, o sedevamo meditabondi nell'Erbario e in biblioteca. Eravamo soliti in quei giorni chiudere le finestre ben saldamente e alla luce delle candele leggevamo fogli ingialliti, scritture che ci avevano un tempo accompagnati in più di un viaggio. Si ripercorrevano vecchie lettere, si aprivano per conforto libri noti, donde cuori da molti secoli disfatti irraggiano pur sempre calore, come l'ardore della grande estate della terra vive ancora nelle oscure vene del fossile.
In codesti giorni dominati dalla noia chiudevamo anche le porte che conducevano al giardino, perché il fresco profumo dei fiori era per noi già troppo vivace; e la sera mandavamo Erio nella cucina scavata nelle rocce, perché Lampusa gli riempisse una brocca del vino posto in cantina l'anno della cometa.
Quando poi il fuoco di sarmenti fiammeggiava nel camino, ponevamo sopra di esso, secondo un uso appreso in Britannia, le anfore del profumo. Per ciò raccoglievamo i petali delle fioriture, secondo le stagioni, e dopo averli lasciati asciugare li premevamo in un'ampia anfora ventruta. Quando poi, l'inverno, ne toglievamo i sigilli, il variopinto fiore si era da tempo scolorito, e i suoi colori erano simili a seta ingiallita e a pallida stoffa purpurea. Ma da quel grumereccio di fioriture saliva, quasi increspandosi, un profumo languido e meraviglioso, simile al ricordo di aiuole di reseda e di giardini di rose.
Noi bruciavamo, per quelle malinconiche feste, pesanti candele di vergine cera, che a noi erano state donate dal cavaliere provenzale Deodato, da gran tempo caduto fra i tauri monti selvaggi. A quella luce ricordavamo le ore di conversari con il nobile amico in sere lontane, trascorse sulla cerchia delle alte mura di Rodi, mentre il sole spariva dal cielo senza nubi del mare Egeo, e con il cadere del sole un tiepido aliare di vento veniva dai porti delle galere nella città, il dolce profumo delle rose vi si mesceva con l'odore dell'albero di fico, e l'essenza di lontani boschi e di declivi erbosi si confondeva alla brezza marina. Ma precipuamente dai fossati della fortezza, nel cui fondo la camomilla fioriva in gialli ammassi, uno squisito insinuante aroma saliva a noi.
Le ultime api cariche di miele allora si alzavano e volavano traverso le buche delle mura sino agli alveari dei piccoli giardini. Il loro ebbro frullo ci aveva ben di frequente divertiti, quando eravamo sui baluardi della porta di Amboise; e Deodato, nel separarsi da noi, ci aveva donato per il viaggio una soma della loro cera, «perché non abbiate a scordare le auree sussurratrici dell'isola delle rose». Veramente, quando bruciavamo i ceri, dal loro ardere sfavillava un tenero asciutto aroma di spezierie e di quei fiori che fioriscono nei giardini saraceni.
In tal guisa noi si levava il bicchiere ai vecchi e lontani amici e alle contrade di questo mondo. Se l'aura della morte ci alita intorno, l'angoscia prende noi tutti, e beviamo e mangiamo domandandoci per quanto tempo ancora ci sia un posto per noi a questo convito; perché la terra è bella.
© Paolo Melandri (29 luglio 2017)
*
Il riposo della Sacra Famiglia
La fuga in Egitto
All’ombra di una rupe possente, Guglielmo sedeva in un luogo orrido ed eminente, dove il sentiero erto, con una brusca svolta scendeva rapidamente verso il profondo. Il sole era ancora alto e illuminava le cime degli abeti sui precipizi della rupe ai suoi piedi. Annotava qualche cosa sul suo taccuino quando Felice, che si era arrampicato lì intorno, venne da lui con una pietra in mano.
«Come si chiama questa pietra, babbo?» disse quello.
«Non so» rispose Guglielmo.
«È proprio oro, quello che vi brilla così?» disse quello.
«Ma che oro! – replicò l’altro – Mi rammento che la gente lo chiama oro del gatto».
«Oro del gatto! – disse il fanciullo sorridendo – e perché?».
«Verosimilmente perché è falso e si crede che anche i gatti siano falsi».
«Me lo voglio tenere in mente» disse il figlio e ficcò la pietra nella sacca da viaggio di cuoio, ma subito dopo gli porse qualcos’altro e chiese: «Questo cos’è?».
«Un frutto – rispose il padre – e a giudicare dalle scaglie dovrebbe essere della famiglia dei coni d’abete».
«Ma non assomiglia a un cono, è troppo tondo!».
«Lo chiederemo a un guardiacaccia; loro conoscono tutto il bosco, e sanno come si semina, pianta e coltiva ogni tipo di frutto, ma poi lasciano che il tronco cresca e si sviluppi come può».
«I guardiacaccia sanno tutto: ieri la guida mi mostrò che un cervo era passato per il sentiero, mi fece tornare indietro per farmi notare la traccia, come la chiamava; io c’ero saltato sopra, ma allora distinsi chiaramente l’impronta di un paio di zoccoli: deve essere stato un cervo molto grande».
«Ti ho sentito sai mentre interrogavi la guida».
«Quello sapeva tante cose, eppure non è un guardiacaccia. Ma io voglio diventare un guardiacaccia. È davvero troppo bello stare tutto il giorno nel bosco e sentir cantare gli uccelli, sapere come si chiamano, dove sono i loro nidi, dove si prendono le uova e i piccolini, come si nutrono e quando si possono catturare i grandi: è troppo divertente».
Avevano detto appena questo che giù per il sentiero scosceso si mostrò una strana apparizione. Due fanciulli, belli come il giorno, in giacchette a colori che si sarebbero potute prendere più per camiciotti sciolti, venivano giù saltando, l’uno dietro l’altro, e Guglielmo ebbe modo di osservarli più da vicino quando, scorgendolo, sostarono un istante sorpresi davanti a lui. Intorno al capo del più grande ondeggiavano biondi, folti ricci biondi, che al vederlo, colpivano per primi, ma poi erano i suoi occhi azzurro chiari ad attirare lo sguardo, che si perdeva con piacere sulla sua bella figura. Il secondo, che pareva più un amico che un fratello, aveva capelli bruni e lisci che gli scendevano giù per le spalle e il cui riflesso sembrava specchiarsi nei suoi occhi.
Guglielmo non ebbe tempo di osservare più da vicino queste due creature così strane e inaspettate in quel luogo selvaggio, e intanto sentì la voce di un uomo che in tono serio ma amichevole chiamava da dietro lo sperone di roccia: «Perché vi siete fermati? Non sbarrateci il cammino!».
*
Divenire apprendisti
Ma adesso che tante cose mutano, non tocca anche a noi mutarci? Non potremmo provare a evolverci un poco, e gradualmente ad assumerci la nostra parte di lavoro nell'amore? Ci sono state risparmiate tutte le sue fatiche, e ci è scivolato fra le distrazioni, come talvolta cade in un cassetto di giocattoli un pezzo di autentica trina e piace e non piace più e infine giace fra quel che si è rotto e quel che è smembrato, peggiore di tutto. Siamo guastati dal piacere facile come tutti i dilettanti e ci reputano in odore di maestria. Ma che accadrebbe se disprezzassimo i nostri successi, se cominciassimo dal principio a imparare il lavoro dell'amore, che è sempre stato fatto per noi? Se ci presentassimo per divenire apprendisti, ora che tante cose mutano?
*
Sfogliando le pagine
Sfogliando le pagine
Già un’occhiata sommaria, lo sfogliare le pagine, genera a volte un’ebbrezza leggera. Veneri, Arianne, Galatee si sollevano dai loro giacigli, sotto arcate, raccolgono frutta, velano il loro lutto, lascian cadere violette, inviano un sogno. Venere assieme a Marte; Venere assieme ad Amore, distesa, un bianco coniglio accanto al fianco, due colombe, una bianca e una scura, ai piedi, davanti un paesaggio che si perde in lontananza. Procri si precipita fuori dai cespugli, cade pesantemente al suolo, su di lei Cefalo con un lungo orecchio scalfito, il cacciatore; aveva creduto di percepire il fruscio della selvaggina nascosta, è il marito e ora – a causa dello spiedo che ha scagliato – l’assassino; i sandali di lei sono legati con cordoncini a forma di ciambelle e sono consumati dalle danze, accanto ad essi sta, in lutto, il bel cane scuro.
Così si sollevano i mondi. Le Andromede, le Atalante, dormienti o in attesa, nude o coperte di pelli, ornate di perle, di fiori e davanti a specchi. Bianche e formose, le gambe tirate in su, spesso accosto ai loro salvatori le cui armature sono risplendenti. Ma le più sono molto sole, molto chiuse in se stesse, non riescono ad uscire dalla loro pallida carne sinuosa; sono in attesa, ma esitano di fronte a ogni rossore, ad ogni piacere. Molto represse: Cerere con la ghirlanda di frumento, tacita come i chicchi di grano; e una contadinesca figura femminile dell’autunno con marra, grappoli d’uva, tralci, per nulla ebbra, lo sguardo chinato a terra, uno sguardo amaro e inappagato.
Galatee approdano assieme ai delfini, abbandonano la grande conchiglia, alcune calcano la riva da sole, alcune in compagnia di naiadi e centauri. E ancora le colombe, anche i serpenti, anche le conchiglie e là il pavone e là la barca, su tutte le sponde, su tutti i pendii – stanno esitanti e si perdono.
L’esperienza immediata arretra. Ardono le immagini, il loro inesauribile sogno schermato. Rapiscono. Lo sguardo corporeo giunge solo al di là dello spiazzo fino alle rocche – ma il lutto arriva più avanti, profondamente addentro nella pianura, oltre i boschi, i vuoti colli, nella sera; l’immaginario; essa non tornerà più indietro, lì indugia, cerca qualcosa, che però è dissolto, e allora deve prendere congedo sotto la luce di cieli in frantumi – – questi però rapiscono, conducono lontano, riconducono a casa.
*
Realtà e progetto
Realtà e progetto
Nuovamente v’appressate, fluttuanti figure, che nei miei primi tempi appariste al mio sguardo turbato. Tenterò dunque questa volta di trattenervi? Troverò ancora il mio cuore incline a quel fantasticare? Ma voi premete in ressa. Bene: sia dunque vostro il dominio, così come emergete intorno a me dai vostri fondi brumosi! Passa entro il mio petto un fremito di giovinezza dall’alito magico che balena intorno al vostro corteo.
Immagini di giorni lieti portate con voi; e più d’una cara ombra si solleva. Simili a vecchia saga affievolita dal tempo, insieme mi balzano incontro e il primo amore e l’amicizia. Si rinnova il dolore; e il lamento ripercorre il labirintico corso della mia vita errante. E nomina i buoni, cui la sorte defraudò delle ore serene, via spariti prima di me.
I miei nuovi canti non li intenderanno più gli spiriti ai quali io cantai i miei primi. Polvere, la ressa degli amici; spenta, ahimè, l’eco di un tempo! Il mio dolore suona ad una folla ignota: anche il suo plauso è ansia al mio cuore. E chi altra volta esultava al mio canto, se ancora vive, erra disperso per il mondo.
Ed uno spasimo, per lungo tempo dissueto, mi trae a quell’austero e silente regno di spiriti. Ecco vibrare in indistinti accordi il bisbiglio del mio canto, simile all’arpa eolia. Un brivido mi prende; pianto segue al pianto. Il cuore irrigidito si sente intenerire. Quel che io posseggo lo vedo come in lontananza: quel ch’è scomparso mi diventa realtà.
*
Organi cerebrali
Organi cerebrali
Ho tenuto in queste mie mani organi cerebrali, cento o anche mille; alcuni erano molli, altri duri, tutti prossimi al disfacimento; uomini e donne, frolli e pieni di sangue. Ora tengo sempre il mio nelle mani e devo sempre indagare quel che posso fare di me. Se qui il forcipe avesse premuto un po’ più sulla tempia…? Se mi avessero colpito sempre sullo stesso punto della testa…? Cosa sono mai i cervelli? Da sempre avrei voluto volar via, come un uccello dalla forra; ora vivo fuori nel cristallo. Ma ora, vi prego, lasciatemi andare, torno a librarmi – ero così stanco – su ali è questo andare – con azzurra spada di anemoni – nel crollo meridiano della luce – nelle macerie del Sud – nel disfarsi delle nubi – fronte polverizzata – tempia dissolta.
*
La vita rappresentativa del principe e del poeta
La vita rappresentativa del principe e del poeta al tempo della belle époque
Via Alberto, l’arteria della residenza che collega la piazza Alberto e il Castello Vecchio con la Caserma dei Fucilieri della Guardia… verso mezzodì di un giorno feriale, in una stagione indifferente. Non piove, ma il cielo non è limpido: è di un bianco grigiastro uniforme, banale, senza festosità; e la strada è immersa in una luce scialba e torpida che preclude ogni senso di mistero, che esclude ogni stato d’animo personale. C’è un traffico mediocre, senza molto rumore e senza molta ressa, giusta il carattere poco industriale della città. Le vetture tranviarie passano scivolando, passa rotolando qualche carrozzella e sui marciapiedi si muovono i cittadini, esseri incolori, pubblico, gente… Due ufficiali, le mani nelle tasche diagonali del cappotto grigio, procedono l’uno verso l’altro: un generale e un tenente.
Il generale viene dalla parte del Castello, il tenente dalla Caserma. Il tenente è giovanissimo, imberbe, quasi fanciullo. Ha le spalle strette, i capelli scuri e gli zigomi larghi come molti del paese, gli occhi azzurri dallo sguardo un po’ stanco e un viso infantile dall’espressione affabile ma riservata. Il generale ha i capelli bianchissimi: è alto e robusto, ha una figura assai imponente. Le sue sopracciglia sembrano di bambagia e i baffi gli coprono, come cespugli, bocca e mento. Incede a passo lento e possente, la sua sciabola tintinna sull’asfalto, il pennacchio svolazza al vento e il grande risvolto rosso del cappotto si alza e si abbassa ad ogni passo.
Così i due si vengono incontro… È possibile che nascano complicazioni? Non è possibile. Agli occhi di ogni osservatore si presenta chiaro il naturale svolgersi di questo incontro. Qui vige il rapporto fra vecchio e giovane, fra comando e obbedienza, fra meriti di molt’anni e timido noviziato, qui c’è una forte distanza gerarchica, ci sono i regolamenti. Ordine naturale, segui il tuo corso!…
E invece che cosa accade?
Invece si verifica la scena seguente: sorprendente, penosa, deliziosa, strana. Il generale, scorgendo il giovane, modifica curiosamente il suo portamento. Raddrizza la persona pur sembrando più piccolo. Attenua per dir così, d’un colpo, l’ostentazione del suo incesso, fa cessare lo strepito della sciabola e, mentre il suo viso prende un’espressione burbera e insieme impacciata, è evidente che non sa dove guardare e cerca di nascondere il proprio imbarazzo guardando di traverso sull’asfalto, di sotto le sopracciglia di bambagia. Anche il tenente, a un’attenta osservazione, tradisce un lieve imbarazzo, che tuttavia in lui, meglio che nel vecchio generale, appare dominato da una certa grazia, da un sorriso modesto e insieme affabile, mentre gli occhi per ora guardano lontano oltre il generale, con calma tranquilla e voluta, senza sforzo apparente. E invece di fare il saluto prescritto, il giovanissimo tenente alza un po’ la testa e nello stesso tempo leva la mano destra, solo la destra, e fa specie! – dalla tasca del cappotto, e con questa destra inguantata di bianco fa un piccolo cenno di cortese incoraggiamento, non più che un aprir le dita della mano a palma in su; ma il generale, che ha atteso questo cenno a braccia penzoloni, corre con la mano all’elmo, fa uno scarto da parte lasciando libero, con un mezzo inchino, quasi tutto il marciapede e saluta il tenente, di sotto in su, rosso in viso e con gli occhi devoti e umidi. Solo allora il tenente, levata la mano al berretto, risponde al saluto del superiore; risponde e un’infantile affabilità illumina tutto il suo viso; risponde… e continua la sua strada.
Un prodigio! Una scena fantastica! Egli continua la sua strada. Lo guardano, ma egli non vede nessuno, guarda franco fra la gente, un po’ con lo sguardo di una signora che si sa osservata. Lo salutano e allora risponde al saluto, quasi con cordialità ma come di lontano. A quanto pare non cammina bene; è come se non fosse molto abituato a servirsi delle proprie gambe, o forse l’attenzione generale di cui è oggetto lo impaccia, tanto è irregolare ed esitante il suo passo: a volte sembra persino claudicante. Una guardia si mette sull’attenti, una signora elegante che esce da un negozio piega il ginocchio, sorridendo. La gente si volge a guardarlo, se lo indica col capo, solleva le sopracciglia e fa sommessamente il suo nome…
È Nicola Enrico, fratello minore di Alberto II, l’agnato più prossimo al trono. Eccolo là, lo si vede ancora. Ben noto eppure estraneo, egli si muove fra la gente, se ne va in mezzo alla folla ma par circondato da un vuoto. Se ne va solo, portando sulle esili spalle il peso della propria altezza.
*
La lappola [Fiori e braccianti]
La lappola
(Fiori e braccianti)
Ero tornato a casa per i campi. Si era nel mezzo dell’estate. Avevano raccolto l’erba e si preparavano a mietere la segale.
C’è un’incantevole varietà di fiori, in quel periodo dell’anno: rossi, bianchi, rosa; odorosi, teneri trifogli; insolenti margheritine; «m’ama non m’ama» bianco latte con il centro giallo scuro e il loro intenso puzzo di fradicio; la gialla colza con il suo odore di miele; alte campanule bianche e lilla, simili a tulipani; piselli rampicanti; ordinate scabbiose gialle, rosse, rosa, lilla, e piantaggini dal piacevole profumo appena percepibile; fiordalisi d’un azzurro brillante, al sole, appena spuntati, e celesti e rossicci, la sera, e prima di appassire; teneri fiori di cuscuta, dal profumo di mandorla, che avvizziscono subito.
Avevo raccolto un grande mazzo di fiori diversi, e stavo andando a casa, quando notai, in un fosso, una strana lappola color rosso vivo, in piena fioritura, di quel tipo che da noi chiamano «tartaro», e che falciano con cura, e quando per caso finisce nel fieno la buttano via, per non pungersi le mani. Mi venne in mente di strappar questa lappola e metterla in mezzo al mazzo. Scesi nel fosso e, dopo aver cacciato un calabrone peloso che si era andato a ficcare al centro del fiore e dormiva lì beato e pacifico, iniziai a strapparla. Ma era molto difficile: a parte il fatto che il gambo pungeva da tutte le parti, anche attraverso il fazzoletto nel quale avevo avvolto la mano, era così spaventosamente tenace che combattei con lei per cinque minuti, lacerandone ad una ad una le fibre. Quando, alla fine, ebbi strappato il fiore, il gambo era ormai tutto a brandelli, e il fiore stesso non sembrava più così fresco e bello. A parte quello, rozzo e grossolano com’era, non era adatto ai teneri fiori del mazzo. Rimpiansi di aver rovinato per niente un fiore che stava così bene al suo posto, e lo buttai. «Però che energia, che forza vitale», pensai ricordando gli sforzi con i quali l’avevo strappato. «Con che tenacia si è difeso, come ha venduto a caro prezzo la pelle».
La strada per casa passava per un campo di terra nera, maggese, appena arata. Camminavo in salita, tra la polvere della terra nera. Il campo arato era di un solo proprietario, molto grande, tanto che dai due lati della strada e di fronte, nell’altura, non si vedeva altro che il nero maggese uniformemente arato e non ancora erpicato. L’aratura era buona, e non si vedeva, in tutto il campo, una pianta, non un filo d’erba, tutto era nero. «Che essere rovinoso e crudele l’uomo; quanti diversi organismi viventi, quante piante ha distrutto per il mantenimento della propria vita,» pensai cercando qualcosa di vivo in mezzo a questo nero, morto campo. Di fronte a me, a destra della strada, si scorgeva un cespuglio. Quando fui più vicino, riconobbi nel cespuglio di quei «tartari» un fiore dei quali avevo strappato per niente e buttato.
Il cespuglio di «tartari» era composto da tre getti. Uno era strappato e quel che restava del gambo spiccava come un braccio amputato. Gli altri due erano in fiore. Questi fiori erano stati rossi, adesso ormai eran neri. Un gambo era rotto, e metà di esso, con il fiore sporco alla fine, pendeva in giù; l’altro, benché sporco anch’esso di terra nera, stava ancora dritto. Evidentemente sul cespuglio era passata la ruota dentata di un carro semovente, e solo dopo si era rialzato, e perciò era un po’ di traverso, tuttavia dritto. Come se gli avessero strappato una parte del corpo, rivoltato le interiora, staccato un braccio, cavato gli occhi. Ma lui stava dritto, e non si arrendeva all’uomo che, intorno a lui, aveva distrutto tutti i suoi fratelli.
«Che energia!» pensai. «L’uomo l’ha avuta vinta su tutto, ha distrutto milioni di piante, e questo ancora non si arrende».
*
Creator spiritus e sofistica sottigliezza
Creator spiritus e sofistica sottigliezza
(Un tentativo di saggio archetipico o
Scherzo cosmico)
Nelle sfere e nelle gerarchie celesti regnava allora, come sempre in occasioni simili, una soddisfazione lievemente ironica, una maligna gioia che cercava di mostrarsi il meno possibile, espressa, quando s’incontravano, solo con rapidi sguardi sotto ciglia pudicamente abbassate, tra un appuntirsi contegnoso delle labbra. Ancora una volta la misura era colma, esaurita era la mitezza, l’ora della giustizia era suonata. Iddio, molto contro voglia e contro i suoi progetti, sotto pressione del Regno del Rigore (davanti al quale, del resto, il mondo non poteva esistere come, d’altra parte, non si sarebbe nemmeno potuto edificarlo sul troppo molle terreno della semplice mitezza e della misericordia) si vide costretto, in regale accoramento, per restituire una volta ancora l’antico ordine, a intervenire, a radere al suolo e a distruggere: come al tempo del diluvio, come il giorno della pioggia di zolfo, quando il Lago di Sale aveva inghiottito le città del vizio.
La concessione fatta ora alla giustizia non era di quello stile e nemmeno di quelle proporzoni, non arrivava a un grado così terribile come al tempo della grande penitenza, quando tutto il mondo fu sommerso, e nemmeno come quando a due di noi, a causa del depravato senso di bellezza della gente di Sodoma, si voleva imporre un tributo intollerabile. Non tutta l’umanità finiva questa volta nell’inferno e nel carcere, e nemmeno una parte di essa traviata in modo da gridar vendetta al cielo. Quello che ora ci veniva messo davanti agli occhi era solo un singolo rappresentante della specie, un essere grazioso e arrogante, oggetto di predilezione, di sollecitudine e di un vasto disegno. E ciò a causa di un’idea bizzarra e offensiva, anche troppo nota alle sfere e alle gerarchie celesti e sempre fonte di nuova amarezza, non disgiunta però da pur giustificata speranza che l’amarezza sarebbe presto toccata a Colui che tale idea aveva concepito e attuato. E l’idea era questa: «Gli angeli sono creati a nostra immagine, ma non sono fecondi. Gli animali invece, guarda, sono fecondi, ma non sono a immagine nostra. Vogliamo creare l’uomo: a immagine degli angeli, ma fecondo».
Un’idea assurda. Più che superflua, aberrante, capricciosa, e gravida di pentimento e di amarezza. Noi non siamo “fecondi”, certamente no. Camerlenghi della luce, taciti cortigiani eravamo noi, e la storia di una nostra unione con le figlie degli uomini fu soltanto un pettegolezzo che corse di mondo in mondo, ma privo di fondamento. Tutto considerato, quali che fossero gli interessanti significati, superiori alla sfera animale, che quel privilegio animale, la dote della «fecondità» poteva racchiudere in sé… noi gli “infecondi”, noi comunque, non bevemmo l’iniquità come acqua. Egli avrebbe veduto un bel giorno in che situazione verrebbe a trovarsi con la sua specie d’angeli feconda! Forse avrebbe riconosciuto che una sua onnipotenza capace di unire padronanza di sé e saggia cura della propria tranquillità si sarebbe dovuta contentare della nostra onorata esistenza.
Questa onnipotenza, questa facoltà assoluta di immaginare e suscitare nuove forme, di dare esistenza con un semplice «fiat» aveva naturalmente i suoi pericoli… Anche la Somma Saggezza poteva non essere pienamente in grado di superarli, poteva non bastare del tutto a prevenire errori e passi inopportuni nell’esercizio di queste sue facoltà assolute. Per puro istinto di agire, puro bisogno di attuazione, ardente desiderio di «dopo questo anche quest’altro», «dopo gli angeli e gli animali anche l’animale angelico», la Somma Saggezza si avventurò in impresa non saggia, creò un essere palesemente precario e imbarazzante: un essere al quale, proprio perché creazione innegabilmente sbagliata, Egli, con solenne ostinazione, restò attaccato e dedicò una premura offensiva per tutti i cieli.
Ma Iddio, era Egli stato tratto da sé, di propria iniziativa, a questa creazione spiacevole? Nelle gerarchie e negli ordini celesti correvano supposizioni che, confidenzialmente e segretamente, negavano questa indipendenza; supposizioni indimostrabili ma con un fondamento di verosimiglianza, secondo le quali tutto era dovuto a un suggerimento del grande Semael, che, prima della folgorante caduta, era stato molto vicino al Trono. Il suggerimento rispecchiava proprio la sua natura e le sue intenzioni: e perché? Perché egli aveva avuto un grande interesse ad attuare e a introdurre nel mondo il Male, il pensiero più propriamente suo non concepito né conosciuto da altri prima di lui, e perché il repertorio delle cose del mondo per mezzo del Male non si sarebbe potuto arricchire che in una sola maniera: con la creazione appunto dell’uomo. Negli animali fecondi non si poteva in alcun modo parlare del Male, la grande trovata di Semael, e tanto meno se ne poteva parlare a proposito di noi, sterili immagini di Dio, infecondi camerlenghi della luce. Affinché il male venisse nel mondo era esattamente necessaria quella creatura che, secondo ogni supposizione, Semael aveva proposto di creare: un essere a somiglianza di Dio, eppur fecondo: l’uomo. Ma in ciò non si era forse neppure trattato di un inganno teso astutamente all’Onnipotenza creatrice: Semael nella consueta grandiosità non aveva fatto mistero delle conseguenze di quella creazione da lui raccomandata, cioè della nascita del Male, le aveva annunziate con aperta crudezza – sempre, s’intende, secondo la supposizione di quelle sfere – accennando al notevole incremento di vitalità che ne sarebbe derivato al Creatore. Bastava pensare soltanto all’esercizio della grazia e della misericordia, al compito di ordinare e giudicare, alla nascita dei meriti e delle colpe, dei premi e dei castighi o, più semplicemente, alla nascita del Bene, congiunta con quella del Male. Il Bene, infatti, doveva aspettare realmente nel grembo delle possibilità il suo opposto per poter assumere esistenza. Del resto la creazione si fondava essenzialmente su due principî opposti: era comiciata con la separazione della luce dalla tenebra; e così l’Onnipotenza avrebbe agito conseguentemente quando, partendo da questa divisione solo esteriore, era giunta a costruire il mondo morale.
L’opinione che questi fossero gli argomenti con in quali il grande Semael aveva lusingato il Trono guadagnandolo ai suoi consigli era molto diffusa tra le gerarchie celesti, ed erano consigli in verità molto insidiosi, tanto da far quasi sorridere, e occultamente ingannevoli, nonostante tutta la loro violenta sincerità, sfoggiata appunto per mascherare l’insidia. Una malizia per la quale nelle gerarchie angeliche non erano mancate del tutto comprensione e simpatia. La malizia di Semael consisteva in questo: se gli animali, dotati di fecondità, non furono creati a somiglianza di Dio, nemmeno noi, cortigiane immagini di Dio, a giudicar rigorosamente, lo fummo, perché a noi, grazie al cielo, venne pulitamente negata la fecondità. Le qualità ripartite tra gli animali e noi, divinità e fecondità, originariamente erano unite nello stesso Creatore, e a immagine sua sarebbe stato creato soltanto l’essere proposto da Semael, e in cui appunto si effettuò questa unione. Ma con questo essere, con l’uomo, venne il Male nel mondo.
Non era un caso ironico da suscitare un risolino di scherno? Proprio la creatura che, se si vuole, era la più somigliante al Creatore, portò con sé il Male. Per consiglio di Semael, Iddio si creò in essa uno specchio, non certo lusinghevole, anzi tutto l’opposto, e che Egli in séguito era stato più volte sul punto di annientare per collera e per imbarazzo, senza tuttavia giungere mai all’estremo; o perché non gli bastasse l’animo di far ricadere nel nulla l’essere da lui stesso chiamato in vita; o che amasse di più quest’opera mancata che quelle ben riuscite; o che non volesse riconoscere come definitivamente sbagliata una creatura tanto simile a lui; o infine perché uno specchio è un mezzo per conoscer se stessi e un giorno in un figlio dell’uomo, in un certo Abiram o Abraham doveva apparirgli l’intima consapevolezza di questa ambigua creatura di essere un mezzo con cui Dio avrebbe riconosciuto se stesso.
*
Marina Grande
Le pietre bianche
Voi tutti conoscete la selvaggia tristezza che suscita il rammemorare il tempo felice: esso è irrevocabilmente trascorso, e ne siamo divisi in modo spietato più che da quale si sia lontananza di luoghi. Le immagini risorgono, fluttuanti figure, più ancora allettanti nell’alone del ricordo, e vi ripensiamo come al corpo di una donna amata, che morta riposa nella profonda terra e che simile a un miraggio riappare, circonfusa di spirituale splendore, suscitando in noi un brivido di sgomento. Sempre di nuovo ritroviamo negli affannosi sogni il passato, in ogni suo aspetto, e come ciechi brancoliamo verso di esso. La coppa della vita e dell’amore ci sembra non esser stata colma sino all’orlo, per noi, e nessun rimpianto vale a ridonarci tutto ciò che non abbiamo avuto. Oh, fosse questa tristezza almeno d’insegnamento per ogni nuovo attimo di felicità!
Il ricordo di quegli anni di luce solare e di calmo splendore della luna ne diviene più dolce ancora, se l’orrore li terminò d’improvviso. E ora comprendiamo come già un felice caso per noi uomini sia il proseguire la vita nelle nostre piccole comunità, in una casa ove la pace regni, fra buoni conversari, accolti da un saluto affettuoso a mattina e a sera. Ahi, troppo tardi riconosciamo che la fortuna ci era in tal modo prodiga di doni.
Non altrimenti io rammemoro i tempi, quando vivevamo alla Marina Grande; e solamente il ricordo ne significa ora la magia. Mi sembrava allora che varie cause di ansia e qualche afflizione oscurassero i nostri giorni, e in primo luogo il dover stare in guardia contro il Forestaro. Noi vivevamo perciò secondo un certo rigore e in vesti semplici, seppure nessun voto ci legasse; e due volte per anno tuttavia ci concedevamo una maggiore libertà, una volta in primavera e una volta in autunno.
L’autunno festeggiavamo al modo dei saggi, facendo onore ai preziosi vini che maturano sulle colline al sud della Marina Grande. Quando negli orti, fra le rosse foglie e i grappoli scuri, udivamo i vicendevoli scherzosi richiami dei vendemmiatori, quando nelle piccole città e nei villaggi i torchi cominciavano a gemere e l’odore delle fresche vinacce in fermento aleggiava nei cortili, quasi lieve nebbia soffusa, noi scendevamo a cercare i venditori di vino e i cantinieri e i vignaioli, e bevevamo con loro dal boccale panciuto. Incontravamo sempre quivi altri lieti compagni, poiché il paese è ricco e bello, sicché la spensieratezza vi ha luogo e la scherzosità e il buon umore vi hanno il valore della moneta contante.
Così trascorrevamo le sere in liete cene. In queste settimane i guardiani dei vigneti si aggirano mascherati dal primo albeggiare sino a notte per gli orti e con schioppi e diani se ne tornano dalla ronda con corone di quaglie, di tordi screziati e di beccafichi, e ben presto la loro preda è servita a tavola in piatti adorni di pampani. E mangiavamo volentieri anche le castagne arrosto e le noci fresche assieme al vino nuovo, e in primo luogo gli squisiti funghi dei quali colà si va in cerca con i cani nei boschi, e il bianco tartufo e il rosso orecchia d’orso.
Sino a quando il vino era dolce ancora e color del miele sedevamo concordi a tavola, fra pacifici conversari, spesso cingendo amichevolmente con il braccio la spalla del vicino. Ma quando il vino principiava a perfezionarsi, separandosi dalla feccia, si risvegliavano argutamente gli spiriti vitali; e avvenivano quindi magnifici duelli, che le risate decidevano, e nei quali gli schermitori si distinguevano per il libero e agile svolgersi del pensiero, come solamente può acquistarsi in una lunga vita, ricca di studioso ozio.
*
Lettera di un viandante alla luna
Lettera di un viandante alla luna
Ti saluto, incantatrice e amica degli incantatori! Amica dei solitari, amica degli eroi, amica degli amanti. Amica dei buoni e dei malvagi. Complice di misteri notturni. Dimmi: dove c’è complicità non c’è forse già qualcosa che va al di là del semplice «sapere»?
Ricordo bene le ore in cui il tuo volto appariva, grande e terribile, alla finestra. La tua luce cadeva nella stanza come quella spada che, appena sguainata, paralizza spettrale ogni movimento. Quando ti levi sulle vaste pietraie ci vedi intorpiditi nel sonno, stretti gli uni agli altri, cerei in volto, simili alle infinite crisalidi bianche sopite negli angoli e nei cunicoli di città formicaio, mentre il vento notturno vaga per le grandi foreste di abeti. Non siamo per te come creature sperdute negli abissi marini, e ancora più remote di esse?
Sprofondata in un abisso mi sembrava anche la mia piccola stanza in cui mi ero alzato sul letto, immerso in una solitudine troppo profonda perché esseri umani potessero spezzarla. Mute e immobili le cose apparivano nella luce estranea come creature marine scorte sul fondo sotto un tappeto di alghe. Non sembravano enigmaticamente mutate? E non è la metamorfosi la maschera dietro cui si nasconde il mistero della vita e della morte? Chi non conosce quegli istanti di attesa indefinita in cui, sentendone la vicinanza, si tende l’orecchio per cogliere la voce dell’ignoto, e in cui solo a stento le forme trattengono il loro mistero? Uno scricchiolio nelle travi del tetto, il vibrare di un vetro su cui sembra passare lenta una mano invisibile: lo spazio è come carico di una presenza, tesa avidamente verso il sensorio in grado di captare i suoi segnali!
La lingua ci ha insegnato a disprezzare troppo le cose. Le grandi parole sono come il reticolo di meridiani e paralleli che avvolge la carta geografica. Ma un semplice pugno di terra non è forse più di un intero mondo rappresentato sulla carta? Allora il mormorio delle figure senza nome aveva un suono più strano, più seducente. Su steccati cadenti e pali da crocicchi sono scarabocchiati segni che il cittadino ignora. Ma il vagabondo li riconosce, li decifra, vi trova le chiavi per comprendere l’essenza di un intero paesaggio, i suoi pericoli e la sua sicurezza.
Ora, anche il bambino è come il vagabondo che abbia appena varcato la porta tenebrosa che ci separa dalla nostra patria eterna. Per questo sa ancora leggere nelle cose il linguaggio delle rune, che ci annunciano una più profonda fraternità dell’essere.
Allora io ti temevo come un essere dalla malefica forza magnetica, e immaginavo che non fosse consentito fissarti nel tuo pieno fulgore, se non si voleva essere privati del peso e sentirsi risucchiare irresistibilmente nello spazio vuoto. A volte sognavo di aver trascurato questa precauzione, e mi vedevo allora nella mia lunga camicia bianca, inerte come un sughero sull’acqua buia, sorvolare un paesaggio su cui incombevano minacciosi boschi notturni, mentre i tetti dei villaggi, dei castelli e delle chiese scintillavano come argento brunito: simili a un linguaggio di segni che parlasse direttamente all’anima con la sua geometria minacciosa.
Durante questi viaggi di sogno il corpo era irrigidito. Le dita dei piedi tese verso il basso, i pugni chiusi, la testa inclinata all’indietro. Non provavo paura, solo un senso di fatale solitudine in mezzo a un mondo estinto, misteriosamente dominato da potenze silenziose.
Come doveva cambiare più tardi questa immagine sotto l’influsso della luce boreale, il cui primo spuntare è avvertito dai cuori ardenti e superbi come una febbre dolorosa! C’è un’epoca in cui ci si vergogna delle proprie ebbrezze, e ce n’è un’altra in cui si torna ad approvarle. Così non si vorrebbe rinunciare alle ebbrezze dell’intelligenza e ai suoi eccessi perché ogni trionfo della vita contiene un assoluto, perché l’illuminismo non è solo illuminismo, ma qualcosa di più profondo: perché anche in esso è nascosta una scintilla della luce eterna e un’ombra dell’eterna tenebra.
Assalto doloroso all’infinito! Dovrà un cuore coraggioso vergognarsi di avervi preso parte? Quel che occorre è una nuova topografia.
*
Smemoramento futurista della Grande Guerra 1914 2014
Smemoramento futurista della Grande Guerra (1914-2014)
Braum! Vroum!… È il gran smatello!… Tutta la strada che sprofonda in riva al fiume!… È Orléans che crolla e il tuono al Grand Café!… Un tavolino vola e fende l’aria!… Uccello di marmo!… prilla, spacca in mille pezzi la finestra di fronte!… Tutto il mobilio che traballa, sprizza dalla vetrata, si sparpaglia in pioggia di fuoco!… Il fiero ponte, dodici arcate, barcolla, poi capitombola nella melma d’un sol colpo! Il fango del fiume tutto schizza!… rimescola, spazza la calca che urla soffoca trabocca dal parapetto!…
È un disastro…
La nostra caffettiera non ce la fa, ha i brividi, incastrata di traverso sul dosso, in mezzo tre camion sbanda, singhiozza, è morta! Macinino sfinito! Da lontano ci avverte che non ne può più! con cento attacchi d’asma… È nata per i piccoli servizi… mica per cose a rotta di collo dell’altro mondo!… Tutta la folla ci sbraita dietro il culo perché non ci muoviamo… Che siamo una scarogna maledetta!… Senti che idea!… I duecentodiciottomila camion, carriarmati leggeri e veicoli a mano ammassati fusi nel panico, si scavalcano per arrivare primi uno sopra quell’altro a passare il ponte che crolla, s’incastrano, si sventrano, si spiaccicano a chi fa peggio… Solo una bicicletta riesce a saltarci fuori e senza manubrio…
È un disastro… Crolla il mondo!…
«Muovetevi di lì cancheri che bloccate! Andate a cagare burini di merda!»
Mica ancora finita! Mica tutto detto! Ce ne resta da fare… Piroetta!
Il capo del Genio è lì che prepara un colpo! Un altro tuono del domineddio! Piazza la miccia all’estremità!… È un demonio!… Ma d’improvviso il coso esplode e gli scoppia netto tra le dita!… tutta la calca carica su di lui, lo sommerge, lo fa a pezzi, se lo tira dietro in folli sobbalzi… La colonna si muove, tutti i motori scoppiettano, scoreggiano in un fracasso mica sopportabile!… Discorsi tremendi e blasfemi!…
Tutto! il carnaio! le mercanzie! i carri! si precipitano sui cannoni che raschiano e macinano coi cingoli sbaraccando gli ostacoli sotto la direzione del furiere capo! È la sarabanda del panico, il balatrone sotto il fuoco della postazione mobile! È il trionfo dell’uomo di caucciù! Ah, viva lo scellerato cosmico, il celibe senza scrupoli con la bicicletta a cavatappi, il fetente blindato!…
Il Crucco mitraglia tremendo, fa un giro lassù in alto nel cielo! La troia! Col suo bzzz ci fa il contropelo! Ci annaffia dalle grandi altezze, ci avvolge tutti, ci fa rimbombare… È la furia omicida, salve folli e saette furibonde! a carambola tutt’intorno! Ci spruzza, ci cosparge a morte! E poi ci rimette in sussulto, se la gode da matti sta farandola! la furia che ci prende, che ondeggia tutt’intorno a noi! Ci abbiamo addosso una maledizione! Bombe! Tre enormi!… È l’invasamento! E pesanti poi! Una dopo l’altra!… La terra tira gli ultimi tutta sottosopra!… smolla, ci ha i brividi, geme fin lontano, a perdita d’orecchio… fino ai piccoli pendii dolci laggiù in fondo! Che crepi l’eco! in sto pentolone! Non c’è dubbio. Va sempre peggio!… Qua va a finire che fanno marmellata di noi!… tipo le cimici!… soffocati nei gas sulfurei! agglomerati nel salnitro delle deflagrazioni letali! Il maiale impazza! S’accanisce!… Non è contento delle nostre disgrazie! L’aereo tremendo! Ci spolvera un altro po’! Tre giravolte! Ed è la grandine!… Tutta una frittura l’atmosfera! Dei rigodoni sull’acciottolato!… Una signora che s’è presa un colpo nella schiena abbraccia una pecora là per terra, ci si contorce assieme sotto gli assali, si strascica in convulso… più in là… fa smorfie, crolla giù a croce!… fa un gemito… Si muove più…
*
La Grande Guerra dei Libri
La Grande Guerra dei Libri
Ed è certamente un’ignoranza minore vergare vocaboli con ogni consonante troppo scarsa piuttosto che aggiungerne alcune di troppo. Fine? Diciamolo con dei missili allora, arabescando così la pagina. Avete la vostra tazza scottante, la vostra sigaretta lato destro, lo zampino del vostro gatto, il chiodo di garofano, vibrissa di coniglio, peluzzo di vispistrello, l’ultimo fiato di talpa morente, bacca di tasso conservata tre anni nell’erbario (estratto concentrato), essenza di papaya fermentata 5 mesi, sospiro di coniglio bianco albino che scorge la luna attraverso una ragnatela irrugiadata, zampa di ragno costruttore della ragnatela, raggio di luna pallida circondata da infausti cirri, estratto di pallottola della Grande Guerra, eco sonoro verde di starnuto di Futurista sul punto di bestemmiare Promèteo, lontano la chiatta ha suonato, ricordo di reti di pescatori a Rimini, frammento di barriera corallina del Pacifico crollata durante un esperimento nucleare, profumo di ventata di foglie autunnali mentre a notte fonda si va a zonzo qua e là e suona l’ora, prati di primavera nel ricordo la terra tornerà a fiorire, ultimo sorso nella coppa di Confucio prima di salutare l’armata nell’addio, colore intenso fioritura di belato in pascoli collinari, contaminato campanaccio mucche annunzio del crollo dell’Occidente (Mahler, inizio Sesta Sinfonia), in alpeggi, ricordo un po’ sbiadito ultimo sguardo di Pietro Aretino, chiasso muto di pudendascopio, naso delicato della Maremma pikkiatori scelti, crepitio di spolette in trincea, sguardo radiografante giovanissimo Ernst Jünger nelle tempeste d’acciaio, frammento di tartaro di balena purificato da fuoco azzurrissimo d’azoto, piccolo prelievo di polvere sull’alambicco di Faust disseccata per 7 mesi sotto il sole di Vieste, la cicca del cacciavite nella canna del fucile mentre la mettevate in parole, onda d’emozione eco di frammento di liquerizia nella tabacchiera di Franz Joseph al momento di dichiarare guerra alla Serbia, dimenticanza del freddo di Filippo Tomaso Marinetti in ritirata in Russia, suono sonoro di starnuto di Napoleone in stracci, lo smantello gran baraonda di bombe dal cielo, la vostra lodaburla nell’aria pura… l’essenza di tutte ’ste cose, una bistecca, nuovo Seitan nuovo Tofu alimentazione toga stomodo che ti rende immortale leggerissimo danzatore funambolico sull’orlo di crateri spenti. Così perché, di grazia Signori Miei, firmare qualsiasi cosa dato che ogni parola, lettera, fatto fratto di penna, faccia di papera sono di per se stessi una firma perfetta? Un amico sincero lo si conosce molto più facilmente, e magari al meglio, dai rapporti personali, dalle abitudini da sera o da camera, dai gesti, le circostanze… tutto! dalle reazioni, ancora, agli appelli alla carità che dalle calzature, diciamo.
OGM incrocio grillotalpa e toporagno, suono intermittente ala di libellula, un soffio… là! grazia! e hop-là! fino alla prossima volta! e ancora!… ancora! Nebbie di Londra, svanire nel miraggio asessuato gamba di ballerina, appello appassionato di Cesare alle truppe… e medicina! E, conversando a proposito di Tiberiade…
*
Ho visto uno che sembra esatto Gesù Cristo
Accoccolato su un sasso sto bene, se scrivo non penso troppo. Passa uno che mi sembra esatto Gesù Cristo, però il molto dimagrito degli ultimi anni. Un altro in bici fa una gimkana tra balle di stoffa, e torna indietro a fare una curva difficile.
Nessuno ha un percorso rettilineo, tutti si incontrano e ripartono in diversa direzione, anche perché è impossibile andare dritti in mezzo alla quantità di roba sparsa per la piazza. Venditori di bevande, immobili in mezzo al viavai. Arriva la famiglia di uno con la mascherina antismog, seguito da moglie con grosso carico in testa, bambini nudi che le corrono dietro. Camion enormi fanno enormi manovre tra gente distesa per terra. Per terra sabbia, cartacce, bucce di banana merci, mosche, una lucertola smarrita. Il sarto con la macchina da cucire, incastrato tra un camion e una corriera, aggiusta un telone e si ferma a chiacchierare con un amico. Due donne con catini in testa pieni di pesci, il lustrascarpe con la sua cassetta di spazzole.
*
Dottor Dolore
Doctor Schmerz
Cielo nuvoloso, senza un filo di vento, si soffoca. Sui bordi della piscina alle otto non c’è nessuno, dormono ancora i turisti. Ci sono solo gli inservienti neri che spazzano e preparano le sedie a sdraio. Ieri abbiamo dormito quasi tutto il giorno… Le cose della notte. Sogno in varie lingue dove qualcuno mi diceva: «Doctor Schmerz’ treatment… it tooth le désespoir mal placé». Mi sono svegliato decifrando questa strana frase, col ricordo d’un panorama da fantascienza dove tutte le lingue si mescolavano. Mi sembra che “tooth” stesse per il francese “tue”, ma avendo qualcosa a che fare con i denti. Quanto al doctor Schmerz, era il mio guaritore bianco in sostituzione di quelli dogon, e me lo figuro con grandi denti.
*
Dàgli allora con sta cronaca
Uno può benissimo non votare mai e avere lo stesso la propria opinione… e anche più d’una… privilegio dell’età… a un dato momento, non leggi più gli articoli… solo la pubblicità… ti dice tutto… e la «rubrica dei necrologi»… sai quel che la gente desidera… e sai che sono morti… basta!… tutto il resto, blablabla… sinistra, centro o destra!… «Casse di tolleranza» come una volta le «case»… per tutti i gusti… le piccole manie e le grosse…
Li vedi stendere il piattello per i poveri rifugiati smirnoti, bulgaro-bastavi, afro-polacchi, tutti da far ben pietà, ma merda, e tu? tu non esisti più!… ancora non te ne sei reso conto?… cancellato…
La classe del ’74 ha fatto il suo tempo, d’accordo… eppure voglio dirvi una cosa è cent’anni avanti Gesù Cristo che bisognava nascere!… tutto quello che raccontiamo noi annoia!… le opere di teatro, i monologhi, uguale sbadiglio! e i cine e la tele… calamità! che cos’è che vogliono populo e l’élite: il Circo!… esecuzioni sgocciolanti!… rantoli veri, torture, trippe riempilarena!… mica più mezzecalze di seta, false tette, sospiri e mustacchi, Romei, Camelie, Cornuti… no!… una Stalingrado!… carrettate di teste mozze! eroi col cazzo in bocca! tornarsene a casa dai gran festival con una carriola piena d’occhi… mica più programmini taglio in oro! roba seria, sanguinolenta… basta coi trucchi pancrazi «ripetuti», niente!… il Circo farà chiudere tutti i teatri… farà furore la moda dimenticata… gli anni trecento prima di Gesù! «ma insomma, insomma!» dagli con sto romanzo! lo vuoi iniziare no? vengo subito!… l’abito da sera è di rigore? ma no! no! «la vivisezione dei feriti»!… ecco, tant’arte, secoli di sedicenti capolavori per niente! bufale! crimini!
*
Viva Natale
Eccoci a Natale!… mi lasceranno in pace, mi dico! soltanto a questo, a meno di essere completamente sgangherati, pensano i vecchi impostori… che li si lasci in pace… Viva Natale… niente di sberluccicante soprattutto, non hai più niente da dare, e non ricevi più visite… esente! Viva Natale!… neanche più regali ricevi! Viva Natale ancora una volta! più da dire grazie! Viva Natale!
Basta! suonano!… una volta, due volte, non il telefono… da basso! in fondo alle scale, tre volte… certo che posso fare il sordo, sono mica domestico.
Ancora driing!… il telefono… questa volta è veramente troppo! Molière è morto a furia di essere disturbato… Poquelin! Poquelin! quel piccolo Intermezzo! per piacere! e quel balletto… Luigi XIV dà una grande cena! stasera! duemila coperti. Proprio stasera! Molière è morto a furia di essere disturbato… avesse risposto: che vada a farsi fottere!… alle galere, Poquelin!… docile, è morto in scena, sputando i polmoni, spompato di sangue e di buona volontà… so quel che mi aspetta, io non Molière, a sfiancarmi per Luigi XIV…
Bisogna che mi distragga, è troppo… driing!… un altro campanello…
*
Il passato è passato
Adesso è come un altro mondo... Peccato... Proprio un peccato... Forse li rivedrò mai più i posti reali... Non mi permetteranno di tornarci lassù... con tutto che sarebbe il mio ultimo desiderio, ve lo dico. Peccato... fa tristezza... Sono costretto a immaginare... Adesso vi darò dei piccoli effetti artistici... Mi scuserete... non avrei dovuto ridurmi al melodramma... Però dopo tutto è la mia storia no?... Mettetevi un po' al mio posto... Non vorrei che vi raccontassero le cose in modo storto... dopo... quando non ci sarà più un solo testimone... nessuno vivo... che allora saranno solo spettegolate... storie da donnette... resti di vaccate ultrastravolte... Ah! se la godranno un sacco alle mie spalle!... gongoleranno al mio supplizio, a infangarmi di dritto e di rovescio! Se non prendo tutte le mie precauzioni sono già disonorato in anticipo! Se non racconto qua oggi stesso, adesso subito tutti i particolari! neanche un'ora... il tutto ben scrupoloso, esatto, meticoloso! è il passato... è passato...
*
Retrospettiva Uno sguardo sommario
Retrospettiva. Uno sguardo sommario
Già soltanto uno sguardo sommario, una scorsa veloce alle pagine procura a volte un soffio d’ebbrezza. Veneri, Arianne, Galatee si levano dai loro talami, sotto arcate, raccolgono frutti, velano la loro tristezza, spargono viole, suscitano un sogno. Venere con Marte; Venere con Amore, distesa, un candido coniglio al fianco, due colombe ai piedi, una bianca, l’altra scura, davanti a un paesaggio che si perde all’orizzonte. Procri si getta fuori dalla macchia, cade distesa a terra, chino su di lei Cefalo dal lungo orecchio scalfito, il cacciatore: credeva di aver udito il fruscìo di un animale nascosto – è lo sposo e ora, dopo aver lanciato il giavellotto, l’assassino; i sandali di lei hanno i lacci inanellati tra i fiori del cuoio, lì accanto veglia, mesto, il bel cane scuro.
Così si sollevano i mondi. Andromede, Atalante, nel sonno o in attesa, nude o vestite di pelli, adorne di perle, di fiori e davanti a specchi. Forme candide, tornite, le cosce sollevate, spesso accanto a salvatori dalle fulgide corazze. Ma nella maggior parte sono molto sole, molto raccolte in sé, non s’avventurano oltre le pallide carni sinuose; attendono, ma si scherniscono di fronte a ogni vampa, a ogni passione. Molto rattenute: Cerere con la corona di frumento, silenziosa come le sementi; e una figura contadina, foriera dell’autunno, con marra, grappoli d’uva, tralci di vite, tutt’altro che ebbra, lo sguardo chino, uno sguardo amaro e sconsolato.
Sopraggiungono Galatee con i delfini, scendono dalla grande conchiglia, calcano la riva in solitudine o in compagnia di naiadi e centauri. E di nuovo le colombe, anche i serpenti, anche le conchiglie, e là il pavone, qui la barca, qual siano le spiagge, qual siano i pendii – indugiano e dileguano.
L’esperienza immediata si ritrae. Ardono le immagini, il loro sogno inesauribile, protetto. Portano via con sé. Lo sguardo sensibile giunge solamente fino ai bastioni, oltre il piazzale – ma la tristezza si spinge più in là, nella profondità della pianura, oltre i boschi, i colli spogli, nella sera, nell’immaginario; non tornerà più a casa, rimane lì, in cerca di qualcosa, che però è andato distrutto, e allora deve prendere congedo nella luce di cieli infranti – questi però portano via con sé, portano lontano, portano a casa.
*
Marinetti e la Guerra [un racconto retrospettivo]
Marinetti e la Guerra (Retrospettiva)
Lui l’ha sempre saputo che la monarchia andava eliminata. Quanto a Pietro Badoglio, nuovo capo del gioverno dopo l’8 settembre 1943, nel 1917 Marinetti l’aveva descritto «Simpaticissimo semplice rude moderno pratico forte senza pose. Faccia tonda bella fronte». Ma nel suo ultimo biennio Effetì non è fra quelli che gli mandano telegrammi o lettere di felicitazioni. Pensa a Boccioni, pensa a Sant’Elia, pensa a tutti gli amici morti nell’«altra» guerra, nella Grande Guerra, al loro sacrificio reso vano dalla sconfitta incombente (il 10 luglio 1943 gli anglo-americani erano sbarcati in Sicilia). Lui non tradirà: è l’unica certezza nell’angoscia che lo divora.
È ogni giorno più malato e magro, la faccia gli è come caduta e la pelle del collo si affloscia sul papillon. Non è la magrezza a dargli l’aspetto invecchiato del suo ultimo anno di vita. È il tracollo dell’amata Patria, sempre maiuscola nella sua mente. A fine luglio spedisce ai futuristi l’appello Adorare l’Italia: sempre e comunque.
I Marinetti lasciano Roma per Venezia – con le sue gondole e il suo chiaro di luna – perché, dopo la costituzione della nuova Repubblica Sociale, era l’unica città che non subisse bombardamenti, e perché lì si svolgeva la vita della repubblica, non più quella trionfante della Serenissima, ma quella allo sbando di Salò. Dopo aver alloggiato in pensioni e hotel sempre più modesti, alla famiglia viene assegnata Casa Ravà sul Canal Grande, vicino a Rialto. Da quelle parti, forse nello stesso palazzo, cinque secoli prima aveva abitato Pietro Aretino, un altro eversore dei costumi e della lingua.
Chi sa se lo rattristava o gli scaldava il cuore il ricordo delle imprese compiute in giovinezza a Venezia, il lancio dei manifesti dalla torre dell’Orologio, i suoi insulti ai veneziani, il trionfo di Boccioni, gli amori e le vittorie. Di certo gli pesò che quella casa fosse stata requisita ai proprietari, ebrei.
Il 18 ottobre 1943 scrive una lettera a Mussolini per parlargli della sua malattia, per giustificarsi di non essere tra i combattenti. Il suo dolore più grande, precisa, è «vedere assassinare l’Italia te e il Fascismo»: un ordine non casuale, al quale aggiunge «e anche la mia tenace volontà di poesia futurista». Chiede un incontro, come tante altre volte, e come sempre Mussolini glielo concede quasi subito, di lì a una settimana. Che cosa si siano detti lo possiamo solo immaginare, a parte la scarna testimonianza del direttore del «Corriere della Sera», Ermanno Amicucci.
Non erano l’età o la salute a piegare Marinetti. L’uomo che aveva vissuto ogni stagione della propria esistenza con l’entusiasmo di un giovane era improvvisamente trasfigurato, e sul suo viso pareva scorgersi perfino un tratto di accidia e di rassegnazione. Aveva fatto breccia in lui qualcosa che somigliava alla malinconia, proprio la triste, indolente scontentezza che i poeti francesi tanto amati in gioventù chiamavano spleen e che lui traduceva con «tetraggine», più angosciante nel suono. Il clima e la nebbia non lo aiutano: Venezia è un luogo di suggestioni poco congeniali a un animo stanco, a un animo di futurista prostrato dalle guerre. Il poeta continua a cantare il coraggio degli italiani in guerra, ma non partecipa a nessuna manifestazione politica, non pronuncia neanche una parola di consenso alla rinnovata alleanza con i tedeschi. Celebra, sì, la lealtà degli adolescenti valorosi, che per non tradire si votano alla disperazione della bella morte: ne incontra alcuni, festosi come se andassero a un ballo. Neanche la loro vitalità irrazionale lo scuote dal torpore.
A volte l’ansia pare tramutarsi in veggenza sinistra. L’immaginazione, che un tempo viaggiava incontenibile, adesso si ferma su pensieri di morte, per sé e per il suo amato Paese. L’autunno veneziano, popolato di figure spettrali, intabarrate per difendersi dall’umidità delle calli, si infila nelle fibre sempre più esili del poeta. La calma e il tanfo ammorbante della laguna suggeriscono le atmosfere claustrofobiche e angoscianti di Morte a Venezia. La monotonia, stagnante e allungata come una metastasi cancerosa, è appena interrotta da qualche sussulto, una cartolina inattesa, l’amore per la moglie e le figlie, gli attestati di stima e amicizia del duce.
*
In angustiis I
In angustiis I
La verità, eccola, pura e semplice, l’editoria si trova in una crisi di vendite gravissima. Mica credere a un solo zero di tutte le pretese tirature di 100000! 40000!… neanche 400 copie!… incanta-gonzi! Ohimè!… Ohimè!… solo la «stampa rosa»… e ancora ancora!… se la cava abbastanza… e forse i «libri gialli»… i «verdastri»… Fatto sta che non si vende più niente… grave!… il Cinema, la televisione, i pc, i tablet, gli smartphone, gli elettrodomestici, lo scooter, l’auto a 2, 4, 6 cavalli, al libro gli fanno dei danni enormi… tutto a «vendita a rate», figuriamoci! e i «week-ends»!… e le belle vacanze bi! trimestrali!… e le crociere Lololulu!… ciao risparmi!… e sotto coi debiti!… non ci resta neanche un dindino!… allora, capirete, comprare un libro!… una roulotte? passi!… ma un libro!… la cosa più imprestabile del mondo!… si sa, un libro se lo leggono almeno in venti… venticinque lettori… eh, ma il pane e il prosciutto, facciamo un caso, se potessero far contenti così bene… una sola fetta! venti… venticinque consumatori! sai la cuccagna!… il miracolo della moltiplicazione dei pani vi lascia basiti, ma il miracolo della moltiplicazione dei libri, quindi della gratuità del lavoro di scrittore, non è mica un fatto tanto nuovo. Questo miracolo avviene, e come la cosa più pacifica del mondo, «alla truffalda», o con le buone maniere, nelle sale di lettura, ecc… ecc… In tutti i casi l’autore tira cinghia. È quel che conta! Perché lui, l’autore, senz’altro ci ha un cospicuo patrimonio personale, o la rendita di un grosso Partito, oppure ha scoperto (altro che la fissione dell’atomo!) il segreto di vivere senza mangiare. D’altra parte qualsiasi persona agiata (privilegiata, imbottita di dividendi) è pronta a dichiararvi come verità che non si discute, e anche senza metterci malizia: che solo la miseria libera il genio… che occorre l’artista soffra!… e mica poco!… parecchio e anche di più!… giacché egli partorirà soltanto nel dolore!… e che il Dolore è il suo Signore!… (scrive il Socle)… per giunta lo sanno tutti che la galera non gli fa mica male all’artista!… al contrario!… che la vera vita del vero artista non è nient’altro che un lungo o corto nascondino con la galera… e che il patibolo, per terribile che sembri, lo delizia appieno… il patibolo, diciamo, aspetta l’artista! un artista che sfugge al patibolo (o alla forca se preferite) può essere, passati i quaranta, considerato un pagliaccio… Dato che lui è emerso dalla folla, si è fatto notare, è normale e naturale che sia punito nel più esemplare dei modi… tutte le finestre sono già affittate, e senza ribassi, per assistere al suo supplizio, per vedergli finalmente far delle smorfie, sincerissime!
*
Miti ebraici sulla Creazione
Miti ebraici sulla Creazione
Profondo è il pozzo del passato. O non dovremmo dirlo imperscrutabile?
Imperscrutabile anche, e forse allora più che mai, quando si discute e ci si interroga sul passato dell’uomo, e di lui solo: di questo essere enigmatico che racchiude in sé la nostra esistenza per natura orientata al piacere ma oltre misura misera e dolorosa, e il cui mistero, come è comprensibile, forma l’alfa e l’omega di tutti i nostri discorsi e di tutte le nostre domande, dà fuoco e tensione a ogni nostra parola, urgenza a ogni nostro problema. Perché appunto in questo caso avviene che quanto più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si penetri e cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo scendere a lontananze favolose lo scandaglio, via via e sempre più recedono verso abissi senza fondo. Giustamente abbiamo usato le espressioni “via via” e “sempre più”, perché l’inesplorabile si diverte a farsi gioco della nostra passione indagatrice, le offre mete e punti d’arrivo illusori, dietro cui, appena raggiunti, si aprono nuovi tratti del passato, come succede a chi, camminando lungo le rive del mare, non trova mai termine al suo procedere, perché dietro ogni sabbiosa quinta di dune, a cui si prefiggeva di arrivare, altre ampie distese lo attraggono più avanti, verso nuovi promontori.
Ma ci sono inizi particolari e circoscritti che formano, concretamente e fattualmente, la scaturigine prima della tradizione di una determinata comunità o raggruppamento etnico e religioso, così che la memoria, pur consapevole di non poter mai scandagliare l’ultima profondità, può presso questa scaturigine acquietarsi, anche in rapporto alla propria origine nazionale, e arrestarsi come a un punto fermo della sua ricerca personale e storica.
Una lunga tradizione di pensiero, fondata sul più autentico sentimento di sé da parte dell’uomo, nata in tempi antichissimi ed entrata come retaggio nelle varie religioni, profezie e teorie della conoscenza che si sono succedute volta a volta in Oriente, nell’Avesta, nell’Islamismo, nel Manicheismo, nella Gnosi e nell’Ellenismo, ha per oggetto la figura dell’uomo primigenio o dell’uomo perfetto, dell’ebraico adam qadmon, che dobbiamo immaginarci come un giovinetto fatto di pura luce, creato prima dell’inizio del mondo quale prototipo e quintessenza dell’umanità; tutte le teorie e i racconti che ad esso si riferiscono, per quanto vari e mutevoli, concordano nell’essenziale. L’uomo primevo, così si narra, fu sin dall’inizio il combattente eletto da Dio nella lotta contro il male, che si era insinuato nel mondo creato da poco; sconfitto in tale impresa, fu fatto prigioniero dai demoni, chiuso nella materia, straniato dalla sua origine, ma venne tuttavia liberato dalle tenebre della sua esistenza terrena e corporea e ricondotto nel regno della luce per opera di un secondo messo di Dio, il quale, per misteriosa identità, non era altri che l’uomo, il suo nucleo più alto e più puro, costretto però a perdere una parte della sua luce che servì per la formazione del mondo materiale (per quem omnia facta sunt) e degli uomini terreni. Storie meravigliose in cui un elemento religioso, già percepibile, di redenzione (qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis) si nasconde dietro finalità cosmogoniche (factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium); ci viene infatti raccontato che l’uomo primo, figlio di Dio, conteneva nel suo corpo luminoso i sette metalli dei quali è costituito il mondo e che corrispondono ai sette pianeti. In un’altra versione si racconta che quell’essere di luce scaturito dalla Causa prima, dal Padre celeste, discese attraverso le sfere dei sette pianeti e da ognuno dei signori di queste sfere ottenne di partecipare alla loro natura. Poi, guardando la propria immagine riflessa nella materia, se ne invaghì, vi discese e così rimase imprigionato nei ceppi della natura al livello più basso. In tal modo si spiegherebbe appunto la doppia natura dell’uomo, che unisce indissolubilmente caratteri di origine divina e di libertà sostanziale con quelli della pesante schiavitù nei confronti del mondo inferiore.
In questa immagine narcisistica, piena di tragica grazia, il senso della tradizione comincia a purificarsi; tale purificazione avviene infatti nel momento in cui la discesa del figlio di Dio – e figlio dell’uomo – dal suo mondo di luce, il suo calarsi nella natura stessa cessa di essere un atto di semplice obbedienza a un ordine superiore e, come tale, scevro di colpa, per assumere il carattere di un’azione liberamente desiderata e struggentemente voluta, e quindi colpevole. Nello stesso momento comincia a rivelarsi il significato di quel “secondo messo” che, identico nel più alto senso all’uomo luminoso, sarebbe venuto per liberarlo dai lacci della tenebra e ricondurlo alla sua patria celeste. E la dottrina prosegue distinguendo il mondo nei tre elementi personali della materia, dell’anima e dello spirito, tra i quali, con la partecipazione della Divinità, comincia a intessersi quel romanzo il cui vero protagonista è l’avventurosa anima umana che appunto nell’avventura si rivela creatrice. Questo romanzo, in cui si uniscono il racconto delle prime origini e la profezia delle ultime cose e che è già di per sé tutto un mito, ci informa chiaramente sulla sede del paradiso e sulla storia del peccato originale.
Vi si narra che l’anima, cioè l’elemento primordiale dell’uomo, è stata, come la materia, uno dei princìpi, dotata di vita ma non di sapienza. O in misura così scarsa che, pur trovandosi al cospetto di Dio in un mondo superiore di pace e felicità, si lasciò sedurre e confondere dall’inclinazione – e qui la parola va presa nel senso originario di tendenza – per una materia ancora informe, bramosa di mescolarsi con lei, bramosa di generare da lei forme che potessero procurarle piaceri corporei. Ma la pena e il piacere di quella passione non diminuirono dopo che l’anima si lasciò sedurre ad abbandonare la sua dimora, anzi, crebbero fino a diventare un tormento poiché la materia, ostinata e pigra, desiderava rimanere nel suo informe stato originario e non voleva assolutamente saperne di assumere forme per far piacere all’anima, e agli sforzi di questa per plasmarla opponeva ogni genere di resistenza. A questo punto, sempre secondo la medesima leggenda, intervenne Dio perché comprese bene che, così stando le cose, non gli restava altro che accorrere in aiuto dell’anima, della fuorviata partecipe della sua natura. Egli la sostenne nella sua lotta d’amore con la riluttante materia, e creò il mondo, ossia creò nel mondo, per aiutare l’uomo primo, l’essere di pura luce, forme solide, longeve, affinché l’anima trovasse in queste piaceri corporei e generasse uomini. Ma subito dopo, proseguendo nell’attuazione di un suo piano lungamente meditato, fece un’altra cosa. Inviò all’uomo in questo mondo, come dice testualmente il documento a cui attingiamo, lo spirito, traendolo dall’essenza stessa della sua divinità e affidando a questo il compito di destare dal sonno l’anima chiusa dentro l’involucro umano nonché di mostrarle, per ordine del padre, che la sua sede non era la terra e che la sua passione sensuale era stata un peccato, causa della creazione del mondo. Ed è questo, in verità, che lo spirito cerca continuamente di spiegare all’anima prigioniera nella materia, sempre ammonendola che la creazione del mondo è solo una conseguenza del suo stolto mescolarsi con la materia e che, qualora essa se ne separi subito, l’esistenza del mondo delle forme verrà meno. Destare l’anima a tale comprensione è dunque il compito dello spirito e tutta la sua speranza e i suoi sforzi tendono a questo: che l’anima concupiscente acquisti conoscenza di tale verità, riconosca finalmente l’alto mondo superiore che è la sua patria, dimentichi il mondo inferiore e volga la sua brama verso la sfera sua propria della pace e della felicità per farvi ritorno. Nel momento in cui ciò accada, questo mondo inferiore si dissolverà, la materia riprenderà la sua inerte ostinatezza, sciolta dal suo legame con le forme si rallegrerà di nuovo, come nella primigenia eternità, di essere amorfa e, dunque, anch’essa a suo modo felice.
Tale la dottrina e tale il romanzo dell’anima. Non vi è dubbio che con ciò si è fatto l’ultimo passo “indietro”, si è raggiunto il più remoto passato dell’uomo, si è stabilita la sede del paradiso e si è ricondotta la storia del peccato originale, della conoscenza del bene e del male e della morte, alla sua pura forma di verità. È l’anima dell’uomo primigenio a rappresentare il principio più antico, o meglio uno degli elementi più antichi dell’universo, perché essa fu sempre, prima del tempo e delle forme, come sempre furono Dio e la materia. Per quanto riguarda lo spirito, in cui riconosciamo il “secondo messo” inviato da Dio per ricondurre l’anima alla sua patria, è certamente, seppure in modo non definibile, molto affine all’anima, ma non è l’anima, perché è venuto dopo di lei: è un ambasciatore di Dio, inviato con lo scopo di ammaestrare e liberare l’anima e di abolire il mondo delle forme. Se in certi passi della dottrina si afferma o si accenna allegoricamente a una superiore identità dell’anima con lo spirito, ciò ha nondimeno la sua buona ragione, la quale non si esaurisce nel fatto che in principio l’anima dell’uomo primigenio fu eletta da Dio a combattere contro il male del mondo, compito molto simile a quello più tardi attribuito allo spirito, inviato per liberarla. Ma la dottrina non ci spiega quella ragione, perché non è arrivata a definire completamente la parte che lo spirito recita nel romanzo dell’anima e così e ben chiaro che la dottrina, a questo riguardo, deve trovare il suo compimento.
*
Frammenti di ricordi perfettibili
Ricordi perfettibili
Fin dall'età di quindici anni, anche quando sono con altra gente (anzi proprio allora), ho sempre avuto la sensazione che il mio io rimanga chiuso nel profondo del mio corpo, e abbia rapporti con il mondo soltanto attraverso gli occhi. Parlo con altre persone, e intanto sono interiormente assorto in tutt'altro genere di cose; osservo me stesso mentre mi comporto così, e sono stupito di ciò che dico. Perciò racconto tante bugie, solo per il bisogno istintivo di non prendere parte con il mio più vero io alla conversazione. Mi diverto, conversando, a dire ad altri qualcosa di diverso da ciò che dico a me stesso.
Se considero il mio sviluppo interiore, mi stupisco ogni volta della sua lentezza. L'espressione giusta è "una maturazione tardiva". Non in ogni senso.
Per ogni uomo che vive solo e non sa a chi debba comunicare i suoi pensieri più intimi - ci vuole, per questo, una disposizione di spirito che per i pensatori è una impareggiabile fortuna, e la cui mancanza porta con sé un'amarezza che nessuno immagina - vi sono giorni nei quali ogni ora è talmente satura di disperazione, disprezzo e scoramento che continuare a vivere pare quasi impossibile. Certamente nessuno ha mai disprezzato tanto le opere d'arte e di filosofia come i loro stessi autori in quei momenti disperati.
Una cosa posso dire: interiormente ho vissuto forse più esperienze di qualsiasi altro uomo del mio tempo. Solo che non ho mai saputo (o osato) farlo capire a qualcuno.
*
Ritorno a Weimar [n° 1]
Ritorno a Weimar
Il 23 aprile 1788 Goethe lasciò Roma. Da tre notti, la luna piena splendeva nel cielo limpidissimo, cancellando tutti i particolari che, di giorno, distraggono e disturbano l’occhio; e le grandi masse della luce e dell’ombra sembravano costituire un mondo più semplice, maestoso ed armonico. L’ultima notte, dopo aver passeggiato per il Corso, Goethe salì fino al Campidoglio, che si ergeva come un palazzo incantato nel deserto. La statua di Marco Aurelio richiamò alla sua memoria quella del Commendatore, nel Don Giovanni di Mozart; più in basso l’Arco di Settimio Severo gettava intorno a sé ombre tenebrose; mentre, nella solitudine della via Sacra, perfino gli oggetti più conosciuti sembravano strani e spettrali. Infine si avvicinò ai resti del Colosseo, gettò uno sguardo attraverso le cancellate nell’interno di quelle rovine venerande; ma un brivido improvviso lo colse e affrettò il suo ritorno.
In ogni grande separazione si nasconde, diceva Goethe, «un germe di follia», che «bisogna guardarsi dal covare e dall’accarezzare con il pensiero» (XI, 531, 12-14). Nelle vetture di posta che lo riconducevano lentamente verso Weimar, egli non si curò di seguire questo consiglio; e con un morbido, voluttuoso piacere si abbandonava alla tristezza dell’ultima separazione. Chiudeva gli occhi: cercava di non guardare attorno a sé, temendo di disturbare i propri «dolci tormenti». Evitava di scrivere, per non far scomparire la tenera nebbia dei suoi dolori. Andava fantasticando; gli pareva d’essere Ovidio mentre, esiliato nelle lontane solitudini del Ponto, ricordava l’ultima notte passata a Roma; paragonava il proprio destino a quello di Tasso, trascinato come lui «verso un bando irrevocabile», costretto a fuggire sotto il nero mantello del pellegrino, come un selvaggio straniero perseguitato dalle furie.
Arrivato a Firenze il primo maggio vi rimase alcuni giorni, ammirando la Venere dei Medici e le tele degli Urväter dell’arte italiana. Ma trascorse la maggior parte del tempo nei giardini medicei; e l’ombra di quegli alberi sempre verdi, il mormorio delle fontane, le serre piene di limoni e di aranci richiamavano alla sua mente le delizie estensi di Belriguardo, dove il Tasso avrebbe voluto finire la vita come giardiniere, coprendo ogni autunno i limoni di tavole e di canne intrecciate, e curando i fiori delle aiuole. In quei parchi meravigliosi la bellezza del mondo tornò a colpire i suoi sensi commossi: la fonte inaridita dei versi riprese a gorgogliare liberamente. Aveva portato con sé l’abbozzo del Tasso, e cominciò a rielaborare quei luoghi che sentiva più vicini al suo animo: ormai poteva attribuire alla sua poetica controfigura i sentimenti che l’affliggevano, senza timore di perdersi nella follia di tutte le separazioni.
*
Racconto di vita
Racconto di vita
Nella luce che declina, assisto senza rimpianti alla scomparsa della specie. Un ultimo raggio di sole sfiora la pianura, passa sopra la catena montuosa che sbarra l’orizzonte verso est, tinge il paesaggio desertico di un alone rossastro. I reticolati metallici della barriera di protezione che circonda la casa scintillano. Fox ringhia piano; percepisce probabilmente la presenza dei selvaggi. Per loro non provo alcuna pietà né alcun sentimento di appartenenza comune. Li considero semplicemente come scimmie un po’ più intelligenti, e di conseguenza più pericolose. Mi capita di aprire la barriera per soccorrere un coniglio o un cane randagio; mai per soccorrere un uomo.
Non mi verrebbe mai in mente, nemmeno, di accoppiarmi con una femmina della loro specie. Spesso territoriale negli invertebrati e nelle piante, la barriera interspecifica diventa principalmente comportamentale nei vertebrati superiori.
La prima legge di Pierce identifica la personalità con la memoria. Nella personalità esiste solo ciò che è memorizzabile (sia tale memoria cognitiva, procedurale o affettiva). È grazie alla memoria, per esempio, che il sonno non dissolve affatto la sensazione di identità.
La seconda legge di Pierce afferma che la memoria cognitiva ha come supporto adeguato il linguaggio.
La terza legge di Pierce definisce le condizioni di un linguaggio diretto.
Le tre leggi di Pierce avrebbero posto fine ai tentativi rischiosi di downloading memoriale tramite un supporto informatico, a beneficio da una parte del trasferimento molecolare diretto, e dall’altra di ciò che conosciamo oggi sotto il nome di racconto di vita, inizialmente concepito come semplice complemento, una soluzione di attesa, ma che in seguito ai lavori di Pierce avrebbe assunto un’importanza considerevole. Così, questa avanzata logica fondamentale avrebbe curiosamente riportato in auge una forma antica, in fondo abbastanza vicina a quella che si chiamava un tempo autobiografia.
Riguardo al racconto di vita, non ci sono prospettive precise. L’inizio può avere luogo in qualunque punto della temporalità, come il primo sguardo può cadere su qualunque punto dello spazio di un quadro; l’importante è che, a poco a poco, l’insieme ricompaia.
*
Dati biografici [giovinezza n° 1]
Dati biografici per una focalizzazione di alcuni importanti problemi esistenziali
Un giorno o l’altro racconterò la storia della mia vita, storia commovente e istruttiva nei dieci anni della mia prima giovinezza. Penso che molti, moltissimi abbiano passato le stesse prove. Io con tutta l’anima desideravo essere buono; ma ero giovane, preda delle passioni, ed ero solo, completamente solo quando cercavo il bene. Ogni volta, quando tentavo di manifestare quello che formava il mio più intimo desiderio: cioè che volevo essere moralmente buono, io incontravo disprezzo e canzonature; ma non appena mi abbandonavo a ripugnanti passioni, mi lodavano e mi incoraggiavano. L’ambizione, l’amore del potere, la cupidigia, la lussuria, la superbia, l’ira, la vendetta: tutto questo veniva rispettato. Quando mi abbandonavo a queste passioni diventavo simile a un grande e sentivo che erano contenti di me.
Nel frattempo mi misi a scrivere per vanagloria, per cupidigia e per superbia. Nei miei scritti facevo ciò che facevo nella vita. Per avere la gloria e i denari in vista dei quali scrivevo, bisognava nascondere il bene e mostrare il male. E io facevo proprio così. Quante volte mi sono ingegnato di nascondere nei miei scritti, sotto una patina di indifferenza e perfino di leggera ironia, le aspirazioni al bene che costituivano il senso della mia vita. E questo io raggiunsi, che mi lodarono.
A diciott’anni, dopo il diploma, andai a Bologna e mi legai con gli studiosi e gli scrittori. Dopo qualche anno mi accolsero come uno di loro e mi adularono. Non feci in tempo a guardarmi intorno che le opinioni sulla vita di quegli uomini con i quali mi ero legato – proprie al ceto degli scrittori – si erano impadronite di me e avevano già completamente cancellato in me tutti i precedenti tentativi di diventare migliore. Quelle opinioni fornirono alla dissolutezza della mia vita la teoria che la giustificava.
L’opinione sulla vita di quegli uomini, miei consoci nello scrivere, era questa: che la vita in generale va avanti e si sviluppa e che in questo sviluppo la parte principale è quella di noi, uomini di pensiero, ma tra gli uomini di pensiero l’influenza maggiore l’abbiamo noi artisti, poeti. La nostra vocazione è quella di insegnare agli uomini. Affinché a ognuno di noi non si presentasse questa naturale domanda: che cosa so io e che cosa devo insegnare?, in tale teoria veniva spiegato che ciò non era necessario saperlo e che l’artista e il poeta insegnano inconsciamente. Io venivo considerato un poeta e un artista meraviglioso, e perciò era per me molto naturale adottare tale teoria. Io – artista, poeta – scrivevo, insegnavo senza sapere io stesso che cosa. Per questo mi pagavano, ed io avevo un buonissimo mangiare, alloggio, donne, società, e avevo la gloria. Di conseguenza quello che insegnavo andava molto bene.
Tale fede nell’importanza della poesia e nello sviluppo della vita era un vero culto ed io ero uno dei suoi sacerdoti. Essere un suo sacerdote era molto vantaggioso e piacevole. Ed io abbastanza a lungo vissi in tale fede senza dubitare della sua verità. Ma durante il secondo e particolarmente durante il terzo anno di quella vita, cominciai a dubitare dell’infallibilità di quella fede e cominciai ad analizzarla.
*
La giovinezza del mondo »
Questo testo è in formato DOC (24 KByte)
*
Caccia tra la neve Ch 1
Caccia tra la neve
I tiratori si erano schierati lungo la pista. Dietro di loro si profilavano, dentellati di nero, gli abeti abbattuti; i rami toccavano ancora il suolo. Intrecciata ad essi, l’erba ingiallita del sottobosco li teneva stretti alla terra. L’impressione era che fossero state montate delle tende scure, ricoveri contro la tempesta e il gelo in quella contrada copiosamente innevata. Una cinta di pallide canne rivelava la fossa nascosta sotto la neve.
Il bosco era di uno splendore principesco. L’atmosfera, d’estate, era afosa e opprimente con nugoli di tafani che brulicavano attorno alle radure. D’autunno, quando svolazzavano filamenti e ragnatele, i funghi a legioni coprivano il terreno muscoso. Le bacche luccicavano come coralli nelle zone disboscate.
Aveva appena smesso di nevicare. L’aria era deliziosa, quasi l’avessero filtrata i fiocchi di neve; era più leggera al respiro e trasmetteva i suoni a grande distanza, sicché senza volerlo si era indotti a sussurrare. La coltre caduta di fresco superava in bianchezza ogni immaginazione; si intuiva la presenza di misteri grandiosi, ma intangibili.
I posti migliori erano là dove, nel bosco, una nuova piantagione fiancheggiava la pista. Le cime verdi sbucavano appena dalla neve. Quello era il campo di tiro ideale. Riccardo stava accanto a Bruno, l’allievo tiratore, in una galleria di rami che si lambivano, tanto da rendere assai precaria la visuale. Un punto certo non bello, un posto per principianti. Ma l’attesa si era fatta per lui così forte che non pensava più ai dettagli, anzi persino il suo rovello veniva meno. Fino all’ultimo aveva sperato che il padre lo munisse di un fucile: questo era l’obiettivo di tutte le sue aspirazioni. Non conosceva desiderio più ardente, più pressante. Sognava l’acciaio azzurro dell’arma, il fusto in legno di noce, il rametto di agrifoglio inciso nel metallo. Com’era leggero, com’era maneggevole e meraviglioso, più di qualsiasi giocattolo. Nell’oscurità della sua canna, le scanalature scintillavano in spirali argentee. Quando lo si caricava, emetteva uno schiocco secco, quasi fosse l’affidabilità stessa a prendere la parola per rallegrare il cuore. Al grilletto si poteva abbinare un guardamano, che lo perfezionava, e allora era come se bastasse un pensiero per far partire il colpo. Che questo gioiello, questa meraviglia racchiudesse in sé anche il destino, anche la morte: ciò naturalmente travalicava la fantasia. Riccardo sentiva che il suo possesso avrebbe significato per lui un perfezionamento, una trasformazione totale. Prima di addormentarsi – ed era una specie di sogno ad occhi aperti – si vedeva talvolta nel bosco con il fucile; ma non per sparare, no, solo per andare a passeggio insieme nel verde, come in compagnia di un’innamorata. Allora gli tornava alla mente un adagio che aveva letto su una vecchia brocca, dalla quale talvolta suo padre versava il vino: «Tu ed io, fedeli amici / Questo ci basta ad esser felici».
*
Arte e vita [parafrasando Mishima]
Arte e vita. Parafrasando Mishima
Generalmente si inizia a dedicarsi all’arte dopo aver vissuto. Ho l’impressione che a me sia accaduto il contrario, che io mi sia dedicato alla vita dopo avere gustato il dolceamaro pomo dell’attività artistica. Di norma comunque ci si dedica prima alla vita per poi volgersi all’arte. L’esempio di due scrittori come Stendhal e Casanova potrà chiarire il significato del passaggio dalla vita all’arte. Stendhal, insoddisfatto di non riuscire a piacere alle donne, dopo ripetuti fallimenti si rese conto che soltanto la letteratura poteva realizzare i suoi sogni. Al contrario Casanova, dopo aver folleggiato di donna in donna in virtù delle sue – invero portentose – doti naturali, dopo aver gustato a sazietà le dolcezze della vita, quando non ebbe più nulla da sperimentare volle scrivere le proprie memorie.
È dunque una contesa, una lotta tra l’arte e la vita. Ci culliamo nell’illusione di poter apprendere cosa sia la vita degli scrittori, che invece, il più delle volte, fiaccamente vegetano inetti, mentre ben più numerosi sono gli uomini che conducono esistenze meravigliosamente ricche e intense. Ma è probabile che soltanto uno su cento di loro proverà il desiderio di scrivere la propria biografia. D’altronde anche per scrivere sono necessari talento, tecnica e un lungo esercizio, come per ogni disciplina sportiva. E non si può godere la vita e contemporaneamente – con mirabolante soddisfazione e compiacimento – esercitarsi in una disciplina, come non è possibile scrivere mentre si vive un’avventura. Pertanto, quando un uomo decide di stendere le proprie memorie, di trasformare ciò che ha vissuto in una narrazione interessante da tramandare ai posteri, il più delle volte è ormai troppo tardi. E «troppo tardi» è spesso il motto di chi vive e scrive, o meglio di chi, in su l’occaso, trascrive su carta le sue esperienze di vita. Rari sono gli esempi di chi, come Casanova, riesce ad attuare in tempo un tale progetto, né a tal fine vale l’innalzamento dell’età media, ché a vecchiaia e decrepit age (Milton) si arriva oggi spesso, ma tanto malati da essere improduttivi. Sull’altro versante ci sono coloro che, come Stendhal, essendo stati delusi dalla vita, concentrano in un romanzo tutta l’insoddisfazione, la rabbia, i sogni e la poesia di cui sono capaci: ma anche in questo caso è necessario un magnifico talento, assolutamente eccezionale e raro. È necessario infatti creare quasi dal nulla e costruire con la fantasia un intero universo. La fantasia è il più delle volte suscitata dall’insoddisfazione e dal bramoso tedio. Quando ci concentriamo nell’azione affrontando un pericolo, quando riversiamo tutte le nostre energie nel vivere, non rimane quasi spazio per la fantasia. Se è vero che la fantasia favorisce la nevrosi, si può affermare che in Italia durante la guerra si stabilirono le condizioni meno propizie all’insorgenza di disturbi psichici. A quell’epoca persino i furti erano rari, i delitti quasi inesistenti, e le fantasie quotidiane della gente si concentravano essenzialmente sulla guerra, un’impresa che non può aver successo se in essa non si riversa tutta l’energia di un popolo.
Ho affermato che la mia vita ebbe inizio dopo essermi dedicato all’arte: come accade a molti autentici scrittori, chi comincia a scrivere a vent’anni non può far altro che fondarsi sulle esperienze e sui sentimenti accumulati in precedenza, e far lavorare su di essi la fantasia. Più che di esperienze si tratta, in realtà, di capacità ricettive: la nostra vulnerabile, delicata sensibilità scopre la disarmonia della nostra vita; giochiamo allora nel mondo delle parole, così da poter superare l’abisso scavato da una tale disarmonia. È questo il modo in cui si formano molti scrittori: l’energia della volontà, la capacità di resistere, la forza che altri esseri umani utilizzano nel tentativo di mostrarsi uomini, vengono profuse nella stesura, ad esempio, di un romanzo: tutte le doti indispensabili per vivere vengono sacrificate all’attività letteraria. Sì, lo scrittore diviene ineluttabilmente un mestierante, che può cercare le esperienze più intense solo nel ricordo della vita fervida di sensibilità anteriore all’adolescenza. Si dice sovente che uno scrittore può maturare se ha lo sguardo sempre rivolto alla sua prima opera, il che significa semplicemente che per lo scrittore la prima opera, un’opera non ben definita, costruita su esperienze imperfette e sulla più acuta sensibilità, è l’essenziale, l’insostituibile paese natale, a cui far ritorno più volte nel corso della propria esistenza.
Per chi scrive non solo la fanciullezza, ma anche l’infanzia è un prezioso paese natale. In quei periodi la vita non è esperienza, ma sogno, non è raziocinio, ma sensibilità. E poi non si hanno ancora le responsabilità degli adulti.
*
Enrico IV e il regno di Francia [n° 1]
Enrico IV e il regno di Francia
Il re ha vinto. Questa volta infine ha ributtato e umiliato il nemico. Non ne ha annientato né arrestato in modo decisivo la preminenza. Il suo regno è sempre minacciato da un pericolo mortale, anzi non gli appartiene ancora per nulla. Appartiene finora alla “Lega”, giacché la sfrenatezza degli uomini, la loro renitenza all’ordine e alla ragione, dopo decenni di lotte intestine, sono ormai cresciute fino alla follia. O, peggio ancora che l’aperta follia, l’inerte assuefarsi a una condizione senza ragione e senza freno ha afferrato gli uomini; lo squallido adagiarsi in quell’obbrobrio è diventato in loro una seconda natura.
Quest’unica vittoria del re non può certo mutare tutto ciò. Un successo incompleto e isolato: quanta parte vi ha il caso, quanta il destino? Non basta, per convincere una maggioranza del suo torto. E come? Codesto protestante del mezzogiorno non sarebbe un capo di masnadieri, sarebbe il vero re? Che dovrebbero mai essere, tutti i grandi capi della Lega: essi, di cui ciascuno signoreggia una provincia o guida una regione, e ciò con un’effettiva presenza, con pienezza di potere? Il re comanda quasi soltanto là dove si trova il suo esercito. Il re ha dalla sua l’idea del regno: parecchi se ne rendono conto, e non senza inquietudine o tristezza. Un’idea è meno del potere effettivo, ed è anche di più. Il regno è più che un territorio e un dominio; è la stessa cosa che la libertà e fa tutt’uno con il diritto.
Se l’eterna Giustizia cala lo sguardo su di noi, non può non vedere che siamo tremendamente umiliati; peggio ancora, che siamo un putridume, sepolcri imbiancati. Stretti dalle necessità quotidiane, ci siamo assoggettati ai peggio traditori e per opera loro dobbiamo darci in braccio alla potenza spagnola. Per mera paura sopportiamo in casa nostra la servitù, la miseria morale, e rinunciamo al più prezioso dei beni: la libertà di coscienza. Noialtri poveri gentiluomini, che serviamo nelle file della Lega o rivestiamo cariche dello Stato, e noi gente dabbene che li riforniamo di merci, e noi povera plebe che li seguiamo: non siamo sempre sciocchi né, talvolta, senza onore. Ma come fare? Una parola mormorata in confidenza, una segreta preghiera a Dio, e, dopo l’insperata vittoria del re ad Arques, per un momento sorge in noi la speranza che il gran giorno si avvicini!
Singolarissimo è che da molto lontano si vedono, di solito, gli avvenimenti più in grande che da presso. La vittoria del re ebbe luogo vicino alla costa del mare del Nord. In un raggio di due o tre giornate di viaggio avrebbe dovuto destare stupore. A Parigi, soprattutto, avrebbero dovuto riflettere e correggere finalmente i loro ostinati errori. Niente affatto. Lassù nel nord furono bensì molti a vedere con i propri occhi come l’immenso esercito sconfitto dalla Lega, con le sue bande disperse, rendesse malsicuro il paese; ma non se ne rendevano ragione. Per loro la Lega restava invitta; il re, grazie alla fitta nebbia diffusa dal mare e ad altri propizi fattori bellici, aveva mantenuto in suo possesso un territorio insignificante: ecco tutto.
*
La versione di Ponzio Pilato
La versione di Ponzio Pilato
Chi avesse chiesto all’anziano Ponzio Pilato, già prefetto della Giudea ritiratosi, in un vero e proprio – ma non spettacolare – secessus, a vita privata nelle avite, vastissime proprietà in Sicilia, se ricordasse per caso l’uomo di cui aveva permesso la condanna a morte, colui che aveva consegnato ai flagellatori, si sarebbe probailmente sentito rispondere: «Non mi riesce, con tutta la migliore volontà, di ricordare quel caso particolare». A Gerusalemme egli s’era insediato nel palazzo del procuratore, che aveva dovuto dotare di un cortile per poter conferire con i maggiorenti della popolazione locale, aveva stretto amicizia con Erode Antìpa, fin da subito si era dovuto render conto di essere ricattabile e ricattato dal proconsole di Siria, Aulo Porzio, il quale, per invidia e a scopo carrieristico, non gliene lasciava passare una: se Pilato era duro con gli Israeliti, immediatamente Porzio sporgeva denuncia presso l’imperatore per abuso di potere da parte del prefetto, se invece era indulgente e si avvaleva della romana virtù della clementia, riferiva subito “nelle alte sfere” che il prefetto mancava di polso ed era incredibilmente indulgente – per quale ragione, poi? – nei confronti degli Ebrei. Sotto costante ricatto di delazione da parte del suo “amato collega” e superiore, Pilato doveva spiare le mosse di quei Giudei che era stato chiamato a governare, doveva cercare di capire le ragioni che li rendevano così litigiosi e “attaccabrighe”. Un esempio per tutti: i maggiorenti della città rifiutavano di recarsi nel suo palazzo per conferire con lui, per non contaminarsi, poiché lui, il prefetto della Giudea, era “impuro” per il semplice fatto di non appartenere al loro popolo, di non condividere la loro fede – non credenza, ma fede, così la chiamavano –: egli non era della stirpe di Abramo, di Isacco e di Giacobbe – personaggi leggendari, a quanto il prefetto aveva sentito dire da Erode – né gli era concesso salire il tempio e offrire sacrifici al dio della città, segreto, senza statua e innominabile. Impossibile qualsiasi conciliazione. Il popolo giudaico lo chiamava “cane”, per il fatto di non appartenere alla stirpe dei Patriarchi, o al massimo poteva attenuare l’ingiuria con la deliziosa espressione “cagnolino”, non meno discriminante ed aggressiva, ma per giunta anche ironica. E il prefetto doveva tollerare tutto ciò, prestando la massima attenzione a non decidere nulla che potesse essere criticato dal proconsole della Siria, in sostanza qualsiasi cosa. Dunque aveva fatto costruire, adiacente al suo palazzo, il cosiddetto “cortile dei gentili”, dove lui, un gentile, cioè appartenente ad una delle tante gentes non adoranti il dio di Sion, lui, lo scarto e l’abominio poteva conversare con i maggiorenti della città senza che questi si contaminassero e diventassero, a motivo della sua sola presenza, “impuri”. E sì che ne aveva di occasioni di conferire con loro, perché si può dire ogni giorno, quasi, gli portavano un “rivoltoso” che aveva “bestemmiato” contro l’ineffigiata e gelosa loro divinità, spesso attribuendosi un ruolo salvifico nella storia del suo popolo, autopromuovendosi “Messia” – il Cristo, l’Unto, l’Aspettato – contrariamente alle loro previsioni e valutazioni che contemplavano l’ascesa del Salvatore, del riscattatore di Israele solo a determinate condizioni e secondo precisi protocolli. Molti esaltati profeti, spesso di nome Jeshua o Jeoshua, gli erano stati consegnati affinché li giustiziasse e lui, alla fine, pur non avendo trovato in loro che qualche anomalia psichica e un modus cogitandi primitivo e basato su un’assurda contrapposizione tra Bene e Male, li aveva fatti giustiziare, sia per evitare le delazioni di Aulo, sia per esacerbato disprezzo nei confronti di chi pretendeva di parlare in nome della “verità”. “Che cos’è la verità?” – questo lo ricordava con orgoglio, aveva replicato a molti di loro. Già, “cos’è la verità?” – la sua verità, la verità del prefetto Ponzio Pilato era probabilmente consistita nella semplice enunciazione di questa frase, nel crollar di spalle imbarazzato di fronte a tanta esibizione di sicurezza. Da stringersi le spalle, c’era stato, da crollare la testa contrariati, perché così avevano cantato le Parche, e gli dèi si rifiutavano di riconoscere nei figli gli eloquenti tratti degli avi, che parlano muti. “Così cantavano le Parche!”… già già, non c’era scampo. Quegli uomini, quegli esaltati, quei pazzi, quei Jeshua o Jeoshua o come si dice, ce li avevano sulla coscienza i sacerdoti del tempio e gli scribi con le loro ingarbugliate “verità” teologiche. Cose da primitivi cotti dalla canicola. Gente da far pietà.
Paolo Melandri
28 ottobre 2013
*
Le campane del Papa
Le campane del Papa
Suonar di campane, tripudiar di campane super urbem, sopra l’intera città, nell’aria tutta traboccante di suoni! Campane, campane, che si muovono e oscillano, ondeggiano e si slanciano, vanno e vengono vibrando ampie e solenni dalle loro travi, nei loro castelli, con mille voci, in un assordante tumulto. Lente e veloci, rombanti e tintinnanti, in esse non c’è ritmo né accordo; parlano tutte in una volta e la parola dell’una sopraffà la parola dell’altra, sopraffà la sua propria: i battagli cominciano a percuotere il bronzo ma non lasciano tempo all’eccitato metallo di placarsi che già vibrano percotendo all’orlo opposto e sopraffacendo il proprio rombo, così che mentre echeggia ancora “In te Domine speravi”, risuona già: “Beati, quorum tecta sunt peccata”, ma vi si ode anche il tintinnìo chiaro di chiese più piccole, come se il sacrestano agitasse la campanella dell’elevazione.
Suona dall’alto e dal profondo, dai sette sacrosanti luoghi di pellegrinaggio e da tutte le chiese delle sette parrocchie ai lati del Tevere, che in due curve si piega. Suona dall’Aventino, dai santuari del Palatino e da S. Giovanni in Laterano, suona sopra la tomba di colui che detiene le chiavi, sul colle del Vaticano, da S. Maria Maggiore, in Foro, in Domnica, in Cosmedin e in Trastevere, da Ara Coeli, da S. Paolo fuor delle Mura, da S. Pietro in Vincoli e dalla chiesa della Sacrosanta Croce in Gerusalemme. Ma suona anche dalle cappelle dei cimiteri e dai tetti delle chiese e dagli oratori nelle vie. Chi può nominare tutti i nomi, chi sa tutti i titoli? Come quando il vento, anzi la tempesta fa impeto nell’arpa eolia e tutto il mondo dei suoni si desta, suoni vicini e lontani, tutti fusi nel fremito di una sola armonia; così, ma tradotto nel bronzo, avviene nell’aria fremente di suoni, perché tutte le campane suonano per la grande festa, per l’ingresso sublime.
Chi suona le campane? Non i campanari. Anch’essi come tutto il popolo sono accorsi sulla strada chiamati da quello scampanare misterioso e immenso. Persuadetevi: le celle campanarie sono vuote. Inerti pendono le funi, e tuttavia le campane ondeggiano e sbattagliano. Si dirà forse che nessuno le suona? No, solo una testa ignara di grammatica e di logica potrebbe affermare una cosa simile. “Le campane suonano” vuol dire: vengono suonate, anche se tutte le celle campanarie sono vuote. – Chi dunque suona le campane di Roma? – Lo spirito della narrazione. – Può dunque egli essere da per tutto, hic et ubique, può, per esempio, essere nello stesso tempo sulla torre di S. Giorgio in Velabro e lassù a Santa Sabina, che conserva ancora le colonne dell’esecrabile tempio di Diana? Può suonare nello stesso tempo in cento luoghi sacri? – Certo, lo può. È aereo, incorporeo, onnipresente, non legato allo spazio, non soggetto alle differenze del Qui e Là. È lui che dice: «Tutte le campane suonano» e di conseguenza è lui che suona. Così spirituale è questo spirito e così astratto che di lui, grammaticalmente, si può parlare solo nella terza persona e si può dire solo: «Egli è».
Suonar di campane, tripudiar di campane sopra l’intera città, nell’aria tutta traboccante di suoni. Chi suona le campane? Nessuno… altri che lo spirito della narrazione, mentre narra che già tre giorni prima dell’ingresso dell’eletto tutte le campane si misero insieme a suonare e non cessarono che quando in S. Pietro fu compiuta la sua incoronazione. Questo è un fatto della storia… con tutta la sua bellezza di miracolo non è però propriamente e semplicemente gradevole per la populatio urbis. Per tre giorni e tre notti le campane di Roma non poterono venir frenate, suonavano concordi con la più grande potenza in tutti i punti dell’urbe. E pretender dalla gente che per tutto quel tempo avesse negli orecchi uno scampanare così inaudito non era pretendere poco; lo spirito della narrazione ne è consapevole. Era una specie di prova mandata da Dio, una calamità, per la cui cessazione più di una preghiera salì da anime meno forti verso il cielo. Ma, come io ben comprendo, troppo alto, troppo solenne era il tripudio che regnava in cielo perché lassù potesse prestarsi ascolto a una preghiera di così secondaria importanza. Saliva sul seggio di Pietro il figlio della vergogna, l’uomo che era stato marito della propria madre, genero del proprio nonno, cognato del proprio padre, l’orribile fratello dei propri figli, ed il cielo era così commosso dell’inconcepibilità e incommensurabilità stessa dell’evento che la sua commozione si manifestava in un vibrare possente e spontaneo di tutte le campane dei sette colli. Ma da quel sublime tormentoso frastuono, dalla straordinaria richiesta di cotone, e, come succede, dall’occultamento della merce da parte dei mercanti per rialzarne il prezzo, la populatio poteva arguire che un papa di straordinaria santità stava per arrivare.
Egli passò attraverso la cristianità sopra un cavallo bianco coperto di porpora, il volto liberato dalla barba, virilmente bello; e di giorno in giorno cresceva il numero di coloro che si affollavano intorno a lui: molti capi di chiesa, molti capi di popoli e molti semplicemente desiderosi di pellegrinare e di assistere all’incoronazione e all’omaggio, si accompagnarono per via al suo corteggio. La fama di grande peccatore, di un peccatore che aveva passato diciassette anni su una roccia e che Dio aveva elevato al trono dei troni, lo precedeva. Da per tutto sulle strade giacevano in folla malati ed infermi che speravano salute dal suo contatto o soltanto dalla sua parola o dal suo sguardo. La storia racconta che molti furono così liberati dai loro dolori, alcuni forse grazie a una morte serena, quando, essendo la loro infermità troppo avanzata, si erano trascinati dai loro letti e avevano atteso sulla strada il suo passaggio. Ma altri, sfiorando appena l’orlo della sua veste, o ricevuta, sia pure solo da lontano, la sua benedizione, gettavano via grucce e bende e levando alte lodi proclamavano di non essersi mai sentiti così freschi e sani.
La gloriosa Roma l’accolse con giubilo, anche perché, come è umano, si sperava che ora, essendo egli arrivato, quell’indomabile tripudiar di campane presto si placherebbe. Egli si avvicinava, tali erano le notizie da me raccolte, con il suo seguito per la via nomentana dove alla quattordicesima pietra miliare si trova la cittadina chiamata Nomentum, sede episcopale. Già fin là erano state portate incontro croci e bandiere delle basiliche di Roma, e tutte le classi della popolazione, clero, nobiltà, corporazioni dei cittadini con i loro stendardi, le schiere delle milizie, le scuole dei bambini con rami di palma e di olivo nelle mani, tutte egli trovò schierate per dargli il benvenuto. Con le loro laudes si mescolava il lontano rombo dei bronzi nel quale si accordavano senza esser mosse da mano umana, le campane di Nomentum. Gli si dette notizia di questo miracolo, ed egli se ne rallegrò. Poiché già annottava, trascorse la notte nella casa del vescovo e solo la mattina dopo, seguito da una lunga processione, fra ondeggiar di stendardi, echeggiar di preghiere e di canti fece ingresso nell’urbe. Non per porta nomentana, così si legge, ma lungo le mura e poi varcando il ponte Milvio giunse alla sede dell’apostolo. Da migliaia e migliaia di aperte bocche si levò verso il cielo l’inno:
Voi giubilate, o genti,
Giudea, Roma e la Grecia,
Egizi, Persi e Sciti,
su tutti regna un re.
E questo re era lui, il trovatello dell’abate, il lattante della roccia, lui, eletto re su tutte le varie miserie e i dolori di tanti popoli. Mentre saliva su per gli ampi gradini di marmo all’altare della chiesa dove è la tomba dell’apostolo, e una folla innumerevole empiva la piazza delle fontane davanti al santuario, gli si levò incontro il canto dei preti: «Benedictus qui venit in nomine Domini». Davanti a tutto il popolo, sulla piattaforma davanti all’ingresso del Paradisus circondato di colonne, ricevette dalle mani dell’arcidiacono l’imposizione del triregno, il pallio sulle spalle, il pastorale nella mano e l’anello piscatorio al dito. Si dice che durante questa cerimonia, e già al suo ingresso nella città, le statue di bronzo degli apostoli Pietro e Paolo sulle loro colonne abbiano levato in alto con gioia le loro insegne, l’uno la spada della terra, l’altro le chiavi del cielo. Se il fatto sia vero, non so. Io non lo nego, e del credervi non faccio un obbligo a nessuno. Benedictus venne rivestito di molti abiti: la falda di seta bianca, il camice di lino a merletti con il cordone d’oro ai fianchi, drappi umerali tessuti d’oro e di porpora, inoltre pianete, una sopra l’altra, senza contare la stola, il manipolo, il cingolo, ogni cosa di seta bianca ricamata d’oro. Gli misero le calzette papali, di stoffa molto spessa, rigide per ricami d’oro, pesanti come stivali, alla collana d’oro intorno al collo attaccarono la scintillante croce pontificale, sopra il guanto di seta gli infilarono l’anello piscatorio e alla fine sopra tutti i nove vestiti gli misero il più pesante, il mantello con lo strascico rutilante come cielo d’aurora e come sole al tramonto, tanto carico di preziosi ricami che non poteva spiegarsi liberamente. Su una sedia gestatoria, giovani in seta scarlatta lo portarono tutt’intorno attraverso la basilica affollata di fedeli fino all’ultimo riquadro di marmo pagano del suo pavimento. La basilica brulicava di gente: e nella navata centrale, dove sotto l’alto soffitto essa si stende ampia e lunga fino all’abside che da lontano abbaglia con lo splendore dei suoi mosaici, e nelle navate laterali dove sotto lo stesso peso degli alti soffitti allarga fra doppie file di colonne le sue braccia.
Lo portarono all’altare maggiore sopra la tomba dell’apostolo e là egli celebrò la messa dell’incoronazione, cerimonia che egli ben conosceva poiché l’aveva veduta più volte fin da ragazzo celebrare dal suo padre adottivo, l’abate del chiostro di “Agonia Dei”. Molti vescovi e arcivescovi sedevano tutt’intorno e brillavano come stelle; e anche in buon numero altri signori, abati e judices. Grande e varia era la delizia per l’orecchio e per l’occhio. Quindi venne portato, mentre l’inaudito scampanìo durava ancora, in giro per la piazza di S. Pietro, poi, percorso il cammino tradizionale per i vari colli, passando sotto gli archi di trionfo degli imperatori Teodosio, Valentiniano, Graziano, Tito e Vespasiano e infine per il quartiere detto Parione (dove nelle vicinanze del prefetto Cromatio i giudei si erano schierati e dicevano le sue lodi dondolando la testa), attraverso la via santa vicino al Colosseo, lo condussero fino alla sua dimora, al Laterano.
Paolo Melandri
2 marzo 2013
*
Una giornata difficile di Mozart
Una giornata difficile di Mozart
Il 19 agosto 1783 in casa Mozart a Salisburgo l’atmosfera era plumbea. Il piccolo Raimund, primo figlio del compositore, era morto ad appena due mesi d’età: ne era giunta notizia da Vienna, dove i genitori lo avevano lasciato a bàlia. Wolfgang, adagiato mollemente su di un’elegante chaise longue decorata all’italiana, reprimeva a stento i sospiri del rimorso. Aveva deciso la visita al padre e alla sorella in vista dell’esecuzione nella Peterskirche di Salisburgo della sua ultima fiammata d’ingegno: la superba Messa in do minore, di cui andava particolarmente fiero. La scelta della barocca cattedrale del borgo natìo per la première di quel monumento dello spirito era dovuta prevalentemente a inconfessate ragioni sentimentali: lì, nell’allegro splendore dei riti cattolici, aveva avuto la sua prima esperienza del divino. Inoltre per riconciliarsi il padre e cancellare gli antichi rancori quale occasione sarebbe venuta migliore di quella di far cantare la graziosissima mogliettina in una composizione di carattere sacro, dunque altamente morale, e tale da far piazza pulita di tutte le ciancerìe sulla sregolatezza della sua condotta nella capitale?
L’operazione non aveva funzionato: l’accoglienza era stata piuttosto fredda: i rancori, covati a lungo sotto le ceneri di un ambiguo rapporto epistolare, lungi dal chetarsi, erano divampati in rimproveri espliciti. Ben aveva da rimproverare all’audace fratello l’egoismo e la dimenticanza la dolce Nannerl dalle chiome lisce sempre in perfetto ordine; ben aveva da biasimare l’anziano genitore l’ingratitudine del figlio che lo informava delle nuove acquisizioni della sua arte nel tono distaccato del dispaccio militare, con in testa alle lettere sempre quel Mon trés cher père monotono e sussiegoso fino all’ironia! I pasti erano teatro di frasi taglienti e di silenzi imbarazzanti, mentre la cara Konstanze, la dolce mogliettina amica dell’innocenza, non riusciva, nonostante i reiterati sforzi, a legare con la famiglia Mozart. In certi lenti pomeriggi estivi l’orologio a pendolo acquistato da Leopold in Olanda durante una tournée promozionale dei figliuoli scandiva il distacco che si faceva spazio tra loro.
Giorni lontani della gaia innocenza matrimoniale, scampagnate amorose al Prater! I coniugi Mozart erano sembrati inseparabili: a diffondere la voce era stato l’Imperatore stesso, che aveva scorto, durante una delle sue passeggiate in borghese, l’acclamato fortepianista conversare con la fanciulla sotto l’ombra di un tiglio, appoggiato al tronco, mentre lei, adagiata s’una comoda palandrana del marito, raccoglieva anemoni di campo.
Il matrimonio aveva avuto luogo nonostante l’opposizione paterna; dopo la lettera in cui “l’affezionatissimo figlio Wolfgang Amadé Mozart” aveva comunicato al padre il secco resoconto dell’avvenuta cerimonia, l’opposizione di Leopold si era mutata in risentimento, un risentimento che, nonostante l’apparente consenso dettato dalla cortesia e dall’impotenza, perdurava tuttavia e anzi si accresceva conformemente ad un carattere incline alla più esasperata amarezza.
Wolfgang, da parte sua, non vedeva in ciò un serio ostacolo alla propria felicità: giacché la dea Fortuna e la dea Fama, della quale ultima si poteva ammirare un’immagine nell’elegante residenza viennese dei Mozart, sembravano volgersi a lui con rinnovata benevolenza.
E Konstanze era rimasta incinta, ed il 18 giugno aveva scritto Wolfgang al padre: «Mon trés cher Père! Le faccio le congratulazioni, è diventato nonno!».
E il prosieguo della lettera scherzosa informava l’impettito violinista di come in occasione del battesimo al nome del nonno si fosse aggiunto d’obbligo quello del padrino barone von Wetzlar, che aveva espresso il suo compiacente desiderio à propos della faccenda esclamando allegramente: «Ah, adesso abbiamo un piccolo Raymund», e baciando espansivo il florido bambino. Ché Raymund Leopold era stato “un maschietto forte, robusto e grassottello”, e la consolazione di papà.
Ora era morto, e, anche se aveva avuto battesimo, il padre immaginava la sua animuccia vagolante all’ingresso del Limbo: «e s’elli ebber mercedi, non basta…».
Fu distolto dalle sue funebri meditazioni dall’arrivo dell’abate Varesco, che quotidianamente faceva visita alla famiglia musicale per certi contatti che doveva prendere con Wolfgang per la stesura di un’Opera… Aveva preparato il libretto d’una farsa che, quantunque povera drammaticamente, era molto ben allestita in ciò che concerne la scelta delle parole e l’abilità nel verseggiare. In particolare, una citazione dell’ippogrifo ariostesco, benché poco motivata dal contesto, aveva molto divertito Wolfgang, che si era ricordato delle frequenti letture infantili del poema immaginoso nelle carrozze ben riscaldate di cui aveva fatto uso con suo padre per gli spostamenti veloci del suo soggiorno italiano. Ma, quanto al resto, il libretto era pieno di punti deboli, e se Mozart continuava a sostenere che gli “piaceva abbastanza”, ciò era dovuto al carattere di Varesco, uomo da trattarsi con molti riguardi.
Ora stava entrando, col consueto sussiego:
- Buongiorno a lorsignori! Ma che è successo?
- Signor poeta… - si attentò a dire la mite Nannerl.
- Ditemi, carissima…
- Signor Abate – si corresse – è morto il piccolo figliuolo di mio fratello.
L’abate sussurrò con la sua voce melensa un requiem, poi impartì in sovrappiù una benedizione agli astanti, che s’eran messi a pregare con lui: - Benedicat vos Dominus Omnipotens Deus…
Si sistemò l’enorme inamidatissimo colletto, tossicchiò, si asciugò una lacrimuccia, si schiarì la voce, infine aggiunse in tono salmodiante: - Ogni cammino d’uomo ha il proprio fine.
Tutti gli astanti: Nannerl, Konstanze, Leopold e Wolfgang apparivano visibilmente infastiditi da quella che pareva loro retorica misticheggiante da secolo decimosettimo, eppure Wolfgang non riusciva a rimuovere da sé una certa partecipazione emotiva alle parole dell’abate. Ne era turbato.
Si levò, e non percepì un cenno del padre che lo voleva con sé per parlargli. Passò accanto a Konstanze ed i suoi occhi non incontrarono quelli lucidi di lacrime della mogliettina che lo cercavano.
Andò alla finestra e vi rimase a lungo dirigendo i propri sguardi alla mèta dell’orizzonte che i suoi occhi azzurri sempre cercavano. Era completamente indifferente a tutto. E non si accorse neppure che Varesco, dopo aver porte le proprie scuse per l’intempestività della visita, era uscito.
M. Haydn, fratello del celebre compositore e futuro amico di Mozart, aveva ricevuto commissione da parte dell’arcivescovo Colloredo, l’antico aguzzino cordialmente detestato dal Nostro, di due duetti per violino e viola, ma non li aveva potuti comporre a causa di una persistente malattia.
Proprio di essa parlavano ora, seduti sul sofà, la moglie e il padre di Wolfgang, e anzi facevano un poco di maldicenza, convinti com’erano che avesse legami con la nota dedizione dell’organista di corte al vino.
Mozart non udiva ciò, ma una voce più profonda che lo spingeva a intervenire a favore del vecchio amico, memore dell’antica devozione: ed anzi nella sua mente prendevano già fin d’ora forma temi ed armonie di un genere cameristico assai congeniale a lui, che si era fatto le basi di violinismo duettando alla viola col pardre virtuoso e didatta dello strumento principe. Il travestimento era sempre stato la sua passione: nessuno più di lui a Carnevale si calava esteriormente e interiormente nei panni di Arlecchino. Questa volta c’era da celarsi nei panni del “vecchio, ottimo amico Michael Haydn”! – Che passione! – pensò. E sorrise. La moglie guardava a lui come si guarda ad un enigma. – Che divertimento spedire un saluto al gran muftì – così chiamava l’antico aguzzino che gli chiedeva la pagina prima che fosse terminata –, che divertimento recargli l’ultimo omaggio senza che se n’avveda! – I temi gli venivano con grande spontaneità. Sentiva realmente la viola intonare una cantilena tra seria e malinconica. – Sicuramente Michael ne sarà soddisfatto –, pensò. E prese congedo dai suoi.
Nello studio un’enorme congerie di fogli copriva la scrivania.
Da un lato giacevano affastellati in gran disordine i brani già compiuti della grande messa. Essa, ancora lungi dall’essere compiuta, doveva essere eseguita il 25 agosto nella Peterskirche, ed era in programma un’unica prova da tenersi il 23 agosto nel Kapellhaus: era giocoforza che si rimpiazzassero le parti mancanti con brani di messe precedenti: all’esausto artigiano dei suoni spettava anche il compito gravoso e tutt’altro che rapido di trascegliere i passaggi adatti e di ‘cucirli’ in un tutto di passabile unitarietà. Vi era poi la necessità di adattare gli ariosi alle capacità vocali dei cantanti, non tutti, questa volta, di prima risma. La parte di soprano doveva essere cantata da Konstanze e Dio solo sapeva quanta applicazione ancora le bisognasse per pervenire all’agilità necessaria per eseguire gli elettrizzanti vocalizzi del Gloria! Ogni sera le faceva fare esercizi di solfeggio cantato, e a tale scopo aveva composto per lei qualche brano didattico che giaceva per terra sotto il fortepiano a sinistra della scrivania: Mozart se ne ricordò e li rilesse compiaciuto al lume incerto d’una candela di sego: - Se solo giovassero a qualcosa! Lei è così svogliata! Povera, cara Konstanze! – pensò, e starnutì per la soverchia vicinanza alla fiamma. Era piuttosto miope, e non sempre era capace di tenere le distanze debite dai fogli.
Si alzò. Andò a mettere un po’ d’ordine ai fogli della messa: c’erano il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus e il Benedictus dell’Ordinarium. Il Credo era rimasto incompiuto, e l’Agnus Dei mancava ancora del tutto. Alla sonata dopo l’epistola avrebbe supplito con una composizione giovanile. Ma quale? Non v’era nessuna tra esse che, a paragone della nuova sublime acquisizione della sua arte, non suonasse scipìta e leziosa. Era veramente impossibile mettere a contatto il minuscolo mondo rococò della sua ingenua fede infantile con le angosciate interrogazioni dell’attuale rinascita haendeliana. E solo due di esse avevano un vero respiro sinfonico! Ma le conservavano ancora le partiture, in Canonica? All’occorrenza si sarebbero potute raddoppiare le parti dei violini coi flauti in una delle sue sonate per organico da camera. Così l’abisso sarebbe balzato meno agli occhi. Rise: - Non hanno mai capito niente, i miei salisburghesi.
Ma non per questo era venuto in camera, bensì per i duetti. Del primo aveva già composto mentalmente il primo tempo davanti alla finestra: si trattava ora di trascriverlo nella consueta netta elegante grafia mentre la mente sarebbe stata occupata ad elaborare altro… - Bene! – e tamburellò con le dita sul panciotto, quasi percotesse i tasti di un invisibile fortepiano (così era solito fare quand’era di umore eccitato) – ed ora al lavoro! – Ma il pensiero gli tornò al florido infante che aveva lasciato nella culla. Ora un cereo pallore si stendeva sulla pelle liscissima di quelle guance paffutelle. – Raymund! Raymund! – E in un adagio mestissimo profetò egli la discesa della piccola anima agli Inferi.
Paolo Melandri
14 luglio 2012
*
Alla luna
Alla luna
Luna, incantatrice e amica! Amica dei solitarî, amica degli eroi, amica degl’infelici. Amica dei buoni e dei cattivi. Complice di misteri notturni. Dimmi: dove c’è complicità non c’è forse anche qualcosa che va al di là del semplice saperti amica?
Ricordo le ore in cui il tuo volto appariva, grande e terribile, alla finestra. La luce cadeva nella stanza come una spada che, appena sguainata, paralizza spettrale ogni movimento. E noi uomini non siamo per te come creature sperdute negli abissi marini, e ancóra più remote di esse?
Sprofondata in un abisso mi sembrava anche la stanza in cui mi ero alzato sul letto, immerso in una solitudine troppo profonda perché esseri umani potessero spezzarla. Mute e immobili le cose apparivano nella luce estranea come creature marine scorte sul fondo sotto un tappeto di alghe. Non sembravano mutate in enigma? E non è la metamorfosi la maschera dietro cui si nasconde il mistero della vita e della morte? Chi non conosce gli istanti di attesa infinita in cui, sentendone la vicinanza, si tende l’orecchio per cogliere la voce dell’ignoto, e in cui solo a stento le forme trattengono il loro mistero? Uno scricchiolìo nelle travi del tetto, il vibrare di un vetro su cui sembra passare lenta una mano invisibile: lo spazio è carico di una presenza, tesa avidamente verso i sensi in grado di captare i suoi segnali.
La lingua ci ha insegnato a disprezzare troppo le cose. Le grandi parole sono come il retìcolo di meridiani e paralleli che avvolge la carta geografica. Ma un semplice pugno di terra non è forse più dell’intero mondo rappresentato sulla carta? Allora il mormorìo delle cose senza nome aveva un suono più strano, più seducente.
Allora io ti temevo come un essere dalla malefica forza magnetica, e immaginavo che non fosse consentito fissarti in pieno fulgore, se non si voleva essere privati del peso e sentirsi risucchiare irresistibilmente nello spazio vuoto. A volte sognavo di aver trascurato questa precauzione, e mi vedevo allora in camicia e calzoncini, inerte come un sughero sull’acqua buia, sorvolare un paesaggio su cui incombevano minacciosi boschi notturni, mentre i tetti delle case e delle chiese scintillavano come neve: simili a un linguaggio di segni che parlasse direttamente all’anima con la sua geometria minacciosa.
Durante questi viaggi di sogno il corpo era irrigidito. Le dita dei piedi tese verso il basso, i pugni chiusi, la testa inclinata all’indietro. Non provavo paura, solo un senso di fatale solitudine in mezzo a un mondo estinto, misteriosamente dominato da potenze silenziose.
*
Metamorfosi e dolore
Metamorfosi e dolore
La vita organica è perenne metamorfosi. Il dolore abita nel passaggio tra uno stato e l’altro. Ogni giorno nella vita organica avvengono numerosissime metamorfosi: molte reversibili, alcune irreversibili. Le prime si presentano come flussi, e nell’essere umano coinvolgono tanto la sfera fisica quanto quella psichica: perciò, a proposito di quest’ultima è veritiero il detto secondo il quale “i pensieri del mattino fanno a pugni con quelli della sera”. È per questo che gli uomini mettono in atto una percentuale piuttosto bassa dei loro propositi. Quando una persona ci propone qualcosa è quasi sempre da prendere sul serio: il suo invito plausibilmente discende dalla “scrematura” dei propositi cui abbiamo testè accennato. Non per questo il suo appello sarà da accogliere: altrettanto seria sarà la nostra decisione, che si ispirerà a criteri di non contraddittorietà con la situazione che attraversiamo. E proprio nell’attraversamento, nel “guado” di un determinato stato di cose incontriamo il dolore. Poiché il dolore non è nella stasi ma è nella trasformazione: e la vita è trasformazione.
I Pitagorici, che credevano nella metempicosi, sostenevano che tra un’incarnazione e l’altra intercorresse un periodo di violenta sofferenza psichica e di tremendo dolore: per questo Omero, nel Proemio degli Annales di Ennio, piange. Il primo annuncia al secondo di essere lui medesimo, che la sua anima è passata al poeta latino dopo altre incarnazioni, altre sofferenze: in un pavone, simbolo dell’immortalità dell’anima, in Pitagora stesso. Il flusso Omero-pavone-Pitagora-Ennio è caratterizzato dal dolore in ogni sua cesura, in ogni suo passaggio. Nella nostra vita quotidiana, quando constatiamo l’impossibilità di realizzare quanto abbiamo vagheggiato la sera precedente prima di prendere sonno, proviamo dolore, perché entra in crisi la nostra personalità e il nostro stesso concetto di identità. Come posso essere sempre io la persona che ieri sera pensava “x” e che oggi pensa “non x”? Solo ieri ero categoricamente convinto della bontà del mio proposito, ed oggi lo scarto con sdegno, come qualcosa di superato. Dunque tutto questo è sopportabile? Certamente sì, pur che il pensiero “x” sia davvero definitivamente superato. Ed è superato? Dal momento che lo penso, lo è, ma non sempre definitivamente. D’ora in poi “x”, da me superato, si ripresenterà come “non x”, come tentazione. Nella maggior parte dei casi dovrò respingerlo, ripetendo ogni volta il ragionamento che mi ha portato a “metterlo da parte”. Dopo un po’, il processo di respingimento diverrà automatico, e la “tentazione” si riproporrà con voce sempre più fioca, fino a non comparire più. In alcuni casi però sarà prudente accettare il dolore dell’indecisione ancora una volta, come situazione di crisi, dalla quale si uscirà dopo aver riconsiderato il caso.
In ogni caso, nello stato di perenne trasformazione, il dolore è costante. Non tutti si rendono conto che la legge della vita organica è la trasformazione, ma è così. La stessa lotta per l’esistenza altro non è che lotta per il superamento della situazione in cui ci si trova, verso il raggiungimento di uno stato migliore. Ogni miglioramento di se stessi provoca dolore, mentre il lasciarsi andare provoca angoscia. Il primo è decisamente migliore di quest’ultima, la quale altro non è che un prodromo alla “morte dell’anima” e porta all’inaridimento e alla morte. Le lacrime che sgorgano dai nostri occhi innaffiano la nostra pianta, viceversa l’evitamento del dolore comporta la morte per siccità del nostro essere. Beninteso, il dolore non è mai benvenuto, ma è costante, e alla fine lo si accetta pur continuando a percepirlo con estremo acume. Non occorre “anestetizzarsi”: il dolore ha molto da insegnarci, siamo sempre a colloquio con esso. Inoltre più dolore si sopporta più si è capaci di rallegrarsi e di esultare, perché attraverso il dolore si passa continuamente da uno stato inferiore ad un altro superiore, e la catena, la “scala di Giacobbe”, è infinita. Finché siamo vivi, ci trasformiamo, ma anche dopo morti ci trasformeremo: sappiamo per certo che il nostro corpo si convertirà in “qualcosa di nuovo e di strano”, mentre ignoriamo se e come ci trasformeremo nella nostra più intima e riposta essenza.
Paolo Melandri / 29 dicembre 2011 / «ante coenam»
*
Il sonno delle ampullarie
Il sonno delle ampullarie
Credo di aver trovato la ragione per cui le piccole lumache d’acqua, colpite da elemento ostile, entrano in un letargo dal quale non si destano più, finché non muoiono.
L’esperto acquariofilo nota la lumaca assopita su una foglia di echinodoro o ai piedi di una vallisneria: il sonno che l’ha colta all’improvviso dopo la caduta non le ha lasciato il tempo di chiudersi completamente nel guscio.
Il paziente naturalista che si trova per la prima volta a fare esperienza di questo fenomeno irreperibile nei manuali riterrà opportuno aspettare qualche giorno prima di pescare la lumaca e indagare con l’olfatto sulla salute dell’animaletto.
Ma dopo una settimana passata dalla lumaca nella medesima posizione, la afferrerà con le apposite pinzette e la sottoporrà ad un attento esame. La prima cosa che si mostra agli occhi dell’incredulo analizzatore è una melmosità torbida e grigiastra, di consistenza albuminosa e appiccicosa, che avvolge la parte del “piede” sporgente dal guscio. Certo egli sentirà il dovere di ripulire la lumaca da questa rivoltante sostanza che riterrà probabile origine del male.
Quindi riporrà la lumaca in una bacinella fornita di acqua alla stessa temperatura e con lo stesso PH di quella dell’acquario e si proporrà di tenerla sotto attenta osservazione.
Trascorre un’ora prima che il male si palesi completamente. Ecco a destra sulla parte piatta dell’orlo coriaceo del guscio una strana ammaccatura, uno spacco attraverso cui mollemente scivola fuori il corpo del mollusco.
Un senso di repulsione pervade lo stomaco dell’acquariofilo: la sigaretta gli sfugge dalle dita tremanti, le labbra si atteggiano ad una smorfia.
Davanti ai suoi occhi è l’apoteosi della schifezza, del marcio…
Ed ecco si ricorda di avere un giorno osservato lo stesso fenomeno quando, avvicinandosi allo stagno che si apriva nella radura di un bosco di faggi, aveva visto riflessa nell’acqua l’immagine di un cane morto.
L’ampullaria avrà perso il color salmone appena venato di rosso caro ai conoscitori, e avrà assunto un incarnato bruno-verdastro simile a quello delle acciughe sott’olio: il guscio sarà coperto di sottili alghe e di piccole muffe. E tutto questo nel giro di un’ora!
Con vigore, con sdegno e solenne dignità il sacerdote delle acque afferrerà la bestiolina reprimendo vittoriosamente il tremore delle mani, deciso a cestinare per sempre la causa di tanto sconforto. Ma che succederà? Egli si sentirà aderire una ventosa alla mano e buttando gli occhi sull’arto ormai irrefrenabilmente traballante, noterà la bestia completamente uscita dal guscio e repellentemente sbavante.
Ormai spossato si abbandonerà sulla più vicina poltrona e lascerà penzolare la mano col “bubbone” attaccato. Non riesce a distaccare gli occhi dall’essere spudorato. Rimane a lungo teso nell’ansia; alfine si convince che la lumaca ha sconfitto la morte; e, dopo averla di nuovo lavata sotto l’acqua corrente, la ripone nell’acquario. Non sa che la lumaca è prossima a passare dal sonno al letargo.
Pensa rinfrancato di uscire a fare due passi; ma poi cambia idea e getta un’occhiata alla parete dell’acquario su cui suppone che si muova l’ampullaria: i suoi occhi si volgono altrove, e gli è impossibile per il momento rifare quello che ha appena fatto.
L’ampullaria giace offesa nel fondo.
Quali le ragioni di questo misterioso sonno? Il guaio è che non sappiamo nemmeno le ragioni del sonno in generale. In tale campo non si possono che dare risposte, almeno parzialmente, opinabili. Dunque permettete di avanzare la mia ipotesi: soffrono forse anche le lumache di spleen?
Paolo Melandri
16 ottobre 2011
*
Era solo uno scherzo di Dio
Era solo uno scherzo di Dio (Poesia e Grazia)
A Johann Wolfgang Goethe e a
Thomas Mann
Archeologia (Discesa agl’Inferi)
Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?
Insondabile anche, e forse allora più che mai, quando si parla e si discute del passato dell’uomo: di questo essere enigmatico che racchiude in sé la nostra esistenza per natura felice ma oltre natura misera e dolorosa. È ben comprensibile che il suo mistero formi l’alfa e l’omega di tutti i nostri discorsi e di tutte le nostre domande, dia fuoco e tensione a ogni nostra parola, urgenza a ogni nostro problema. Perché appunto in questo caso avviene che quanto più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si pénetri e cerchi, tanto più i primordî dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo discendere a profondità favolose lo scandaglio, via via e sempre più retrocedono verso abissi senza fondo. Giustamente abbiamo usato le espressioni “via via” e “sempre più”, perché l’insondabile si diverte a farsi gioco della nostra passione indagatrice, le offre mete e punti d’arrivo illusorî, dietro cui, appena raggiunti, si aprono nuove vie del passato, come succede a chi, camminando lungo le rive del mare, non trova mai termine al suo cammino, perché dietro ogni sabbiosa quinta di dune, cui voleva giungere, altre ampie distese lo attraggono più avanti, verso altre dune.
Ma ci sono inizî particolari e circoscritti che formano, praticamente e positivamente, l’inizio primo di una determinata comunità o raggruppamento etnico e religioso, cosicché la memoria, pur consapevole di non poter mai scandagliare l’ultima profondità, può acquietarsi presso questo inizio e ivi segnare, personalmente e storicamente, l’estremo limite delle sue ricerche.
E ci sovviene, in questa nostra tentata evocazione del passato, dell’ultima immagine di Roma che rimase impressa nella nostra rétina e nel nostro cuore, quando, a quattordici anni, vi soggiornammo un mese con la nostra famiglia. La nostra partenza da Roma doveva avere un richiamo solenne: già da tre notti la luna splendeva nel cielo cristallino, sì da farci sentire più che mai acuto l’incanto che essa diffondeva sull’immensa città, e che tante volte avevamo provato. Le grandi masse luminose, immerse in un tenue chiarore quasi diurno, coi loro contrasti d’ombre fonde, illuminate a tratti da riflessi in cui balenavano particolari, ci trasportavano in un’altra sfera, quasi al cospetto di un mondo diverso, più semplice, più grande.
Dopo tante giornate piene di distrazioni e non prive di sofferenze, una sera facemmo – la mia famiglia ed io – una passeggiata per la città con un piccolo gruppo d’amici. Dopo aver disceso, forse per l’ultima volta, la lunga via del Corso, salimmo al Campidoglio, che si ergeva come un palazzo fatato nel deserto. La statua di Marco Aurelio ci fece pensare al Commendatore del Don Giovanni: anch’egli pareva annunziare al passante che stava accingendosi a un’eccezionale impresa. Incuranti del monito, scendemmo la scala dietro il palazzo. L’arco di Settimio Severo stava di fronte a noi, cupo nella cupa ombra che proiettava; sopra la solitudine della Via Sacra i monumenti così noti al nostro occhio apparivano in una luce insolita, spettrale. Ma quando, avvicinandoci ai venerandi ruderi del Colosseo, guardammo attraverso l’inferriata entro il chiuso recinto, non posso tacere che un brivido assalì noi tutti e ci spinse a ritornarcene senza indugio.
Ogni grande massa produce uno speciale effetto, di sublimità e insieme di concretezza; e in quel vagabondaggio traemmo, per dir così, una smisurata summa summarum dell’intero soggiorno. Tale sentimento, profondamente, grandiosamente avvertito nell’animo turbato, vi suscitava una propensione che possiamo ben definire eroico-elegiaca, e che tendeva appunto ad assumere la forma poetica dell’elegia.
E come non poteva, in simili istanti, rivivere nella nostra mente l’elegia di Ovidio, che, esiliato lui pure, aveva dovuto lasciare Roma in una notte di plenilunio? «Cum repeto noctem!» Quel suo rimpianto pieno di tristezza e d’angoscia, là dal remoto Mar Nero, ci perseguitava; andavamo ripetendo il carme che a tratti ci riaffiorava preciso nella memoria, ma tuttavia offuscava e intralciava ogni personale espressione; e anche quando più tardi ci piacque ripetere il tentativo, non approdammo ad alcun risultato.
Cum subit illius tristissima noctis imago,
quae mihi supremum tempus in Urbe fuit;
cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui;
labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.
Iamque quiescebant voces hominumque canumque ;
lunaque nocturnos alta regebat equos.
Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens,
quae nostro frustra iuncta fuere Lari.
Una lunga tradizione di pensiero, fondata su un vero sentimento della natura dell’uomo, nata in tempi antichissimi ed entrata come patrimonio ereditario nelle varie religioni, profezie e teorie della conoscenza che di mano in mano si sono succedute in oriente, nell’Avesta, nell’Islamismo, nel Manicheismo, nella Gnosi e nell’Ellenismo, riguarda la figura dell’uomo primo o dell’uomo perfetto, dell’ebraico Adam qadmon. Dobbiamo immaginarci questo essere come un giovinetto creato con pura luce, prima dell’inizio del mondo, modello e quintessenza dell’umanità. Tutte le teorie e i racconti che ad esso si riferiscono, per quanto varî e mutevoli, concordano nell’essenziale.
L’uomo primitivo, così si narra, fu, sin dall’inizio, il combattente eletto da Dio nella lotta contro il male, insinuatosi nel mondo creato da poco. Ma, sconfitto, fu fatto prigioniero dai demoni, chiuso nella materia, straniato dalla sua origine. Venne tuttavia liberato dalle tenebre della sua esistenza terrena e corporea e ricondotto nel regno della luce per opera di un secondo messo di Dio. Questi, per misteriosa identità, non era altri che l’uomo, il suo Io più alto e più puro, che però dovette perdere una parte della sua luce e lasciarla per la formazione del mondo materiale degli uomini terreni. Storie meravigliose, in cui un elemento religioso, già percepibile, di redenzione si nasconde dietro finalità cosmogoniche. Ci viene infatti raccontato che l’uomo primo, figlio di Dio, conteneva nel suo corpo luminoso i sette metalli di cui è costituito il mondo e che corrispondono ai sette pianeti. In un’altra versione si racconta che quell’essere scaturito dalla Causa prima, dal Padre celeste, scese attraverso le sfere dei sette pianeti e da ognuno dei signori di queste sfere ottenne di partecipare alla loro natura. Poi guardando la propria immagine riflessa nella materia, se ne invaghì, scese ad essa e così rimase avvolto nei legami della più bassa natura. In tal modo si spiegherebbe appunto la doppia natura dell’uomo, che unisce indissolubilmente caratteri di origine divina e di libertà sostanziale con quelli di una pesante schiavitù al mondo inferiore.
In questa immagine narcisica, piena di tragica grazia, il senso della tradizione comincia a purificarsi. Tale purificazione avviene infatti nel momento in cui la discesa del figlio di Dio dal suo mondo di luce nella natura cessa di essere un semplice atto di obbedienza a un ordine superiore. Nello stesso momento comincia a rivelarsi il significato di quel “secondo messo” che, identico nel più alto senso all’uomo luminoso, sarebbe venuto per liberarlo di nuovo dai lacci della tenebra e ricondurlo alla sua patria celeste. E la dottrina prosegue distinguendo il mondo nei tre elementi personali della materia, dell’anima e dello spirito, tra i quali, con la partecipazione della Divinità, comincia a intessersi quel romanzo il cui vero protagonista è l’avventurosa anima umana che appunto nell’avventura si rivela creatrice. Questo romanzo, in cui si uniscono il racconto delle prime origini e la profezia delle ultime cose e che è già di per sé tutto un mito, ci informa chiaramente sulla sede del paradiso e sulla storia del peccato originale.
Preludio in Cielo
Nelle sfere e nelle gerarchie celesti regnava allora, come sempre in occasioni simili, una soddisfazione lievemente ironica, una maliziosa gioia che cercava di mostrarsi il meno possibile, espressa, quando s’incontravano gli angeli, solo con rapidi sguardi sotto ciglia pudicamente abbassate, tra un appuntirsi contegnoso di labbra. Ancóra una volta la misura era colma, esaurita era la mitezza, l’ora della giustizia era suonata. Iddio, molto contro voglia e contro i suoi progetti, sotto la pressione del Regno del Rigore (davanti al quale, del resto, il mondo non poteva esistere come, d’altra parte, non si sarebbe potuto nemmeno edificarlo sul troppo molle terreno della semplice mitezza e della lieta misericordia), si vide costretto in regale accoramento, per restituire una volta ancóra l’antico ordine, a intervenire, a radere al suolo e a distruggere: come al tempo del diluvio, come il giorno della pioggia di zolfo, quando il Lago di Sale aveva inghiottito la città del vizio.
La concessione fatta ora alla giustizia non era di quello stile e nemmeno di quelle proporzioni, non arrivava a un grado così terribile come al tempo della grande penitenza, quando tutto il mondo fu sommerso, e nemmeno come quando a due di noi, a causa del depravato senso della bellezza della gente di Sodoma, si voleva imporre un tributo intollerabile. Non tutta l’umanità finiva questa volta nell’inferno e nel carcere, e nemmeno una parte di essa traviata in modo da gridar vendetta al cielo. Quello che ora ci veniva messo davanti agli occhi era solo un singolo rappresentante della specie, un essere grazioso e arrogante, oggetto di predilezione, di sollecitudine e di un vasto disegno. E ciò a causa dell’idea bizzarra e offensiva, anche troppo nota alle sfere e alle gerarchie celesti e sempre fonte di nuova amarezza, non disgiunta però da pur giustificata speranza che l’amarezza sarebbe presto toccata a Colui che tale idea aveva concepito e attuato. E l’idea era appunto questa: «Gli angeli sono creati a nostra immagine, ma non sono fecondi. Gli animali invece, guarda, sono fecondi, ma non sono a immagine nostra. Vogliamo creare l’uomo: a immagine degli angeli, ma fecondo».
Un’idea assurda. Più che superflua, aberrante, capricciosa, e gravida di pentimento e di amarezza. Noi non eravamo “fecondi”, certamente no. Camerlenghi della luce, taciti cortigiani eravamo noi, e la storia di una nostra unione con le figlie degli uomini fu soltanto un pettegolezzo che corse di mondo in mondo, ma privo di fondamento. Tutto considerato, quali che fossero gli interessanti significati, superiori alla sfera animale, che quel privilegio animale, la dote della “fecondità” poteva racchiudere in sé… noi gli “infecondi”, noi comunque, non bevemmo l’iniquità come l’acqua. Egli avrebbe veduto un bel giorno in che situazione verrebbe a trovarsi con la sua specie d’angeli feconda! Forse avrebbe riconosciuto che una onnipotenza capace di unire padronanza di sé e saggia cura della propria tranquillità si sarebbe dovuta contentare eternamente della nostra onorata esistenza.
Questa onnipotenza, questa facoltà assoluta di immaginare e suscitar forme nuove, di dare esistenza con un semplice “fiat” aveva naturalmente i suoi pericoli… Anche la Somma Saggezza poteva non essere pienamente in grado di superarli, poteva non bastare del tutto a prevenire errori e passi inopportuni nell’esercizio di queste sue facoltà assolute. Per puro istinto di agire, puro bisogno di attuazione e di produr-si, ardente desiderio del “dopo questo anche quest’altro”, “dopo gli angeli e gli animali anche l’animale angelico”, la Somma Saggezza si avventurò in impresa non saggia, creò un essere palesemente precario e imbarazzante: un essere al quale, proprio perché creazione innegabilmente sbagliata, Egli, con solenne ostinatezza, restò attaccato e dedicò una premura offensiva per tutti i cieli.
Ma Iddio, era Egli stato tratto da sé, di propria iniziativa, a questa creazione spiacevole? Nelle gerarchie e negli ordini celesti correvano supposizioni che, confidenzialmente e segretamente, negavano questa indipendenza; supposizioni indimostrabili ma con un fondamento di verosimiglianza, secondo le quali tutto era dovuto a un suggerimento del grande Semael, che, prima della folgorante caduta, era stato molto vicino al Trono.
[Paolo Melandri / sabato 6 agosto 2011]
*
La mia gatta
La mia gatta
Ho avuto una gatta per sedici anni, si chiamava Lilì. Altri nomi più altisonanti furono coniati per lei, ma mai utilizzati. In ogni caso, essa aveva molti appellativi, che si usavano a seconda delle circostanze. Innanzitutto, era «la Circassa», e anche «il Principe di Siviglia», per via degli occhi dolcemente obliqui e dell’ossatura fine che sorreggeva gli agili fasci di muscoli del suo corpo atletico. Dalla mia terrazza accedeva ai tetti; e le sue prodezze, là, erano superiori a ogni encomio: era persino spericolata. Quante volte, all’imbrunire, mia madre la richiamava a casa; e da tetti lontani giungevano a noi lo sguardo amichevole del suo capo voltato, e il suono del suo saluto in lingua gattesca, della sua voce che così spesso si rivestiva di un tono flautato e umano. Il suo aspetto era estremamente selvatico, era una soriana non selezionata, e anche la sua natura inclinava all’intrepido e al selvaggio; eppure non s’è mai vista una gatta così umana. Trattava i suoi padroni da pari a pari e con una spontaneità stupefacente sapeva trovare il tono del rimprovero, proprio quel registro tra l’offeso e il sornione di chi pensa: «Non me la fai» – e questo tutte le volte che, per pigrizia o per opportunità, si fingeva di non comprendere il suo intendimento. Era un po’ schiva – come noi uomini del resto, ma se sentiva della musica di suo gradimento – meglio gli adagi che gli allegri, meglio la musica da camera che la sinfonica – univa la sua voce a quella degli strumenti, e cantava, lei che fino ad un attimo prima era stata ferma alla posta di qualche passerotto o pipistrello. Cantava il canto della notte all’imbrunire, e si compiaceva se “quelli di casa” seguivano gli orari fissi e le buone consuetudini della vita regolare. Come tutti i gatti, era amica dell’ordine e del quotidiano, ma lo era in maniera grandiosa, appassionata; se fosse stata una persona, proprio per questo e non per altri indizi, sarebbe stata un’artista. A volte, miagolando in quel suo modo duttile e quasi umano, pareva raccontare una storia, con nella voce l’incanto delle Kinderszenen di Schumann: sì, si sentiva che evocava, doveva per forza essere qualcosa di tenero e di leggendario. A notte fonda, spesso miagolava in pianissimo a un suo piccolino immaginario, lei, la «Circassa», per nulla incline ad indulgere a Venere per via di una tempestiva castrazione, nel silenzio della notte diceva al suo piccolo “i parolini”. Sì “parolini” e non “paroline”: faceva parte del lessico familiare che s’è estinto con lei. Perché la mia gatta è morta: l’ho avuta grave per una settimana, ha finito di scontare sino in fondo il peso della vita. Poi ha proteso le sue zampe, da sotto il sofà dove s’era rintanata, a me e a mia madre: ha voluto consolare i suoi amici della sua perdita, la sua dernière pensée… Di una nobiltà da lasciare ammirati. E non è rimasto che il caro peso del suo corpo senza vita. A lei si addicono le rapsodìe dell’Iliade, non questo misero necrologio di un amico che l’ha voluta ricordare. E che a lei destinerà un altro, più acconcio, canto.
Paolo Melandri
martedì 26 luglio 2011
*
La neve dell’Appennino
La neve dell’Appennino
Romanzo
di Paolo Melandri
in ricordo di Bagno di Romagna
Capitolo I
Molti anni, cioè molte sciagure, sono passati dal giorno in cui bussai a quella porta.
Compivo i ventisette, avevo una valigia in mano e una borsa da viaggio sulle spalle, e un angelo mi guidava – un angelo che adesso chissà dove è andato a nascondersi. Con gioia vedevo e sentivo: splendore di cielo, verde di valli, scroscio di torrenti, belati lontani, l’abbaiare di un cane; tutto brillava, profumava, cantava accogliendomi; pensavo come al solito a quisquilie di arte e di storia, ammirando il paesino cui ero stato destinato per l’insegnamento.
Però quando raggiunsi la prima piazzetta del villaggio, la stanchezza prevalse. Mi sedetti su una panchina di legno. Si fece silenzio.
Il sole tramontava, pensavo a mia madre: due fra le infinite cose da cui germina la nostalgia. Una certa tristezza veniva lentamente impossessandosi di me, ma dolce, quasi piacevole, come quella che conduce alle lacrime di cui parla Virgilio: quaedam flere voluptas.
Non volevo cedere alla stanchezza, mi rialzai. Alla solita strada polverosa, soffice e piana, era seguito un selciato su cui, per non inciampare, giuro che bisognava o avervi camminato i primi passi, o aver compiuto, correndo per il paese, sette anni. Io stesso poi vidi più volte capitombolare su quel selciato bambini e turisti, tra le risate dei villeggianti.
Devo a un certo mio talento atletico se non mi ruppi qualcosa, io che i sette anni non li avevo ancora compiuti quattro volte.
Non è necessario descrivervi il bel paesino di Bagno di Romagna.
Voi lo conoscete già, per poco che abbiate fatto conoscenza con le nostre montagne, in cerca di acque termali o di ottima cucina. I paesi, i villaggi dell’Appennino si assomigliano tutti. Case a due piani, con il muschio a nord; porte basse e larghe, da dove spesso si scorge un cortiletto pulito e ornato di fiori; strani negozi di souvenirs che vendono un po’ di tutto; botteghe di fabbri quali in città non se ne vedono da cinquant’anni; molti bar, ristoranti e tre alberghi, due impianti termali gremiti di turisti in autunno e primavera.
Poi il munumento comunale ai caduti della prima guerra mondiale, proprio dirimpetto alla scuola, bello in quella sera di tardo agosto. Poi la fontana perenne di acqua potabile, sempre ghiacciata da novembre a febbraio, formata da quattro lastre di pietra rustica appena dirozzate, dove talvolta, nella bella stagione, vanno a dissetarsi i bambini che corrono per la piazza, in attesa di attraversare il “sentiero degli gnomi” (una curiosità del luogo che tutti conoscono).
Ero già passato davanti a un buon numero di case, e per quanto avessi guardato e guardassi in su in giù a destra a sinistra non avevo trovato nessuna insegna d’albergo.
Gli abitanti del luogo erano già rientrati, vedevo le finestre illuminate dal di dentro e sognavo di trovarmi in una famiglia di montanari, nella loro vita semplice e ordinata; quattro inglesi (uno con un cane), evidentemente un po’ brilli, scherzavano ad alta voce e mi vennero incontro.
Proseguii tra quelle case dalla faccia ora non più ospitale, un po’ turbato.
Inospitale aveva l’aria di essere il villaggio di Bagno, e quasi deserto, quando, giunto all’inevitabile fontana nella seconda piazzetta, più ampia, mi scontrai finalmente in uno del luogo.
Stava seduto su una panchina vicino alla fontana e, fumando, prendeva il fresco della sera. Canticchiava qualcosa fra sé. Stavo per rivolgergli la parola, quando si sollevò (e mi accorsi che stava malfermo sui piedi) e, prendendo con sé un giornale tutto gualcito, esclamò:
- Un giornale! Qui rubano tutto! Perfino i giornali! Che gente! E che vuole, lei?
- Buonasera, gli dissi io, e mi scusi… saprebbe indicarmi un albergo un po’ economico?
- Di “alberghi economici”, come dice lei, propriamente qui non ce n’è – roba da turisti, mi capisce – no, non ce n’è, e poi son tutti pieni; ma c’è di meglio.
- Che?
- C’è Monsignore!
- Ma che c’entra Monsignore con gli alberghi?
- C’entra molto, vedrà! E poi… non posso star qui a spiegarle tutto… E poi… quando non c’è posto negli alberghi… Don Alessandro lo conosciamo tutti in paese: è un po’ burbero, ma è una buona persona.
A quell’età non ero più da tempo un cattolico fervente; ma mi consideravo pur sempre un cristiano e, accettando l’ospitalità da un uomo di chiesa, non pensavo di derogare ai miei principî e alla mia dignità. Tanto più con l’appetito e la stanchezza che avevo!
Chiesi dunque a quell’uomo in quanto tempo avrei potuto raggiungere la chiesa e, con essa, la canonica.
- Pochi minuti. Sì, fino alla chiesa che è là, a due minuti dal paese; poi si volta per la strada più stretta, a sinistra: quella che scende, costeggiando l’orto di Don Alessandro.
- La ringrazio: buonasera, mi stia bene e… arrivederci!
- Vengo anch’io fino alla chiesa; di là le indicherò meglio.
- Bene.
E ci incamminammo.
Ad un tratto, un rumore di passi accelerati giunse dalla parte della chiesa, e apparve davanti a noi una strana figura umana che gesticolava, venendoci incontro in mezzo alla strada. Quando ci fu a due passi, scoppiò a piangere, e mettendo le mani sulle spalle della mia guida, non accorgendosi forse nemmeno di me:
- Muore, Baccio! Muore! La mia povera Lucia… la mia donna… così buona… così…
Le lacrime lo soffocavano. Il mio amico era lì come impietrito. Poi disse:
- Ma se stava meglio! Il dottore… Anche il Don cominciava a sperare…
- Sono stato adesso a chiamarlo, mentre mangiava, dopo la funzione. Ah Baccio, Baccio, muore!…
E proseguì brancolando verso il villaggio.
Era un giovane sui quaranta, alto e tarchiato. Aveva detto quelle parole con un accento di così profonda desolazione che anch’io me ne sentivo abbattuto. Nulla infatti di più straziante che lo spettacolo del dolore nelle persone sane e robuste.
Ci aveva appena lasciati, che apparve il prete. Sembrava invecchiato anzitempo, era sui sessanta ma, quasi fosse ottantenne, accelerava il passo con visibile stento. Aveva la larga fronte coronata di capelli grigi; illuminati dalla luna, li avresti detti un’aureola opaca. Solennità traspariva da tutta la sua figura. Alla commozione che già mi dominava, si aggiunse, al suo apparire, una specie di vaga dolcezza.
Mi feci da parte e gli fissai gli occhi nel viso.
Ma nella sua mente non esisteva certo, in quel momento, che un’immagine: quella della morte con cui stava per trovarsi a colloquio. Meditava la parola dell’assoluzione; pensava già forse al conforto per gli altri.
Passò in mezzo a noi, diretto al villaggio, senza vederci. Apparve sulla soglia della canonica una donna anziana: come più tardi appresi, la madre del curato.
- Signora, le dissi, mi fermerò qui: dormirò da Monsignore.
La sua faccia bonaria si illuminò:
- Che buona idea, Professore, che bel pensiero, esclamò con una voce strozzata che pareva voler farsi ad ogni costo gentile per ringraziarmi.
E soggiunse, mettendo una mano sulla valigia:
- Dia a me la valigia, Professore, dia tutto a me. Sapevamo che sarebbe venuto, oggi.
Tutti lo sanno in paese. Si metta in libertà; che bella improvvisata per Don Alessandro! Venir proprio qui, da lui! Oh che piacere, che piacere, Professore! Questa sera mio figlio aveva proprio bisogno di un po’ di compagnia. Se sapesse, caro ragazzo, come ritorna depresso quel povero disgraziato dalle visite ai moribondi! perde l’appetito per una settimana… E qui ci son morti, morti e sempre morti… e mai nessuno che nasca!
- Signora, Lei è troppo gentile con me. Non merito tanta gentilezza. Badi, le dissi cedendole il mio bagaglio; badi, Signora, che la prenderò in parola; che senza le informazioni che mi ha fornito, non avrei certo…
- Ma cosa dice! Vedrà che accoglienza le sarà fatta; anch’io avrò la mia parte, per averla guidata.
L’atteggiamento di quella donna rivelava un non so che di tanto sinceramente cortese che arrivato che fui alla porta della canonica, ogni incertezza, ogni riserva mi avevano lasciato: mi pareva quasi che quell’uomo e quella donna e quella casa li avessi conosciuti e frequentati da sempre.
Capitolo II
La prima sensazione che provai, fu di un profumo d’incenso diffuso, misto all’odore senza nome che emana dall’umidità alle pareti delle case poco abitate. La madre del parroco accese tutte le luci per la scala interna; giunta in fondo a un corridoio al piano superiore, si fermò con la valigia; e rivolgendomi la parola:
- Ecco, s’accomodi qui: questa è la sua stanza.
Ciò che l’ingenua signora chiamava la mia stanza, era uno stanzone ampio e alto, così grande che sarebbe stato ottimo per una festa tra amici. Ma amici non ne avevo e mi sedetti sopra un divano coperto di una pelle color caffè, e, alla luce di un abat-jour di foggia ecclesiastica (evidentemente ricavato da un candeliere), mi misi ad osservare. Davanti a me un largo tavolo quadrato, in vecchio noce annerito, appoggiato a quattro gambe solide come colonne, dominava da protagonista la scena. Per metà coperto da un tappeto di panno verde grossolano, sopportava due alte cataste di fogli stampati: capii subito che erano volantini parrocchiali, quelli avanzati da un anno o anche più.
Accanto ad essi un breviario rilegato in cuoio, aperto su una pagina ma coperto di polvere. Poi c’era una pila di fogli di cartoncino azzurrognolo coperti di fitti e grossi caratteri; la grafia mi parve disordinata e confusa. Anche su questi fogli c’era polvere; ma meno che sul breviario. A destra del tavolo nereggiava, gettando un’ombra lunga e tagliente sulla parete, una libreria. Accesi la luce principale: un’alogena alla parete illuminò a giorno la stanza. Notando sul divano un vecchio posacenere di ottone, mi accesi una sigaretta.
Novanta volte su cento si può giudicare il carattere, le abitudini, gli affetti di un uomo dai frontespizi dei volumi schierati nella sua libreria. E ciò soprattutto nelle silenziose case delle persone pensanti, sepolte nella vita monotona della provincia, case bianche che hanno un’aria di modesta aristocrazia, se così mi è lecito dire, in mezzo alle botteghe e ai negozi. Là non si trovano le mille nullità letterarie di cui si nutre ogni giorno la curiosità del mondo globalizzato; il pamphlet, il libercolo del giornalista, l’opuscolo assemblato sull’onda della moda, il volume enciclopedico che pretende di reinterpretare tutto, fornendo solo nuove etichette, il saggio critico di settecento pagine, ultimo portato della speculazione libraria, li cercherete invano sotto i vetri di quegli scaffali che racchiudono le memorie del passato, pane quotidiano di persone che, perlopiù tuffate in un ozio meditativo, non hanno bisogno di nuovi sapori, di spezie piccanti per evadere dalle monotone realtà che le circondano.
La libreria, rispetto la quale non siete né figlio né padre, ma che vi vuol dare tutte le gioie che stanno chiuse in queste due parole, interrogatela quando è patrimonio di un uomo solitario, di un uomo esiliato dalla società che ha creato in essa il suo mondo. Lo conoscerete.
I libri del parroco di Bagno erano molti e quasi tutti di grande valore.
Prescindendo dalle numerose edizioni della Bibbia, dai dizionarî e commenti, dalle opere dei Padri della Chiesa e dai numerosi volumi di diritto ecclesiastico, suppellettile indispensabile, parecchie file di volumi pubblicati più di recente annunciavano nel mio ospite una cultura elevata e raffinata.
Ciò per la scelta come per il numero. I classici greci in edizione commentata, con testo a fronte, da Omero a Menandro, da Tucidide a Plutarco, i più profondi e i più fantasiosi; i poeti latini, in particolare Virgilio in cinque edizioni (una ottocentesca); i poeti più antichi della nostra letteratura, tra cui l’amato Guido Cavalcanti, un’edizione di Dante commentato da Portirelli, rilegata in oro, e l’indice tematico della Divina Commedia, opera di Volpi; Boccaccio – edizione “non purgata”, si leggeva sul frontespizio, anno 1938 – tutti i poeti minori dei secoli XIII e XIV, Ariosto in tre edizioni, due delle quali complete anche delle commedie latine. Notai l’assenza di Messer Francesco Petrarca e di Tasso.
Manzoni chiudeva la gloriosa falange. Seguivano, in disordine, romanzi di Fogazzaro e di Pirandello. Niente D’Annunzio o Svevo; un Pavese; niente Vittorini o Moravia. In fatto di arti figurative il parroco non era né troppo eclettico né troppo aggiornato.
Paolo Melandri 2006-2009