chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Giacomo Coniglione
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
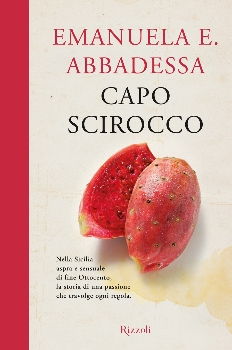 Emanuela E. Abbadessa - Romanzo - Rizzoli
Emanuela E. Abbadessa - Romanzo - Rizzoli
Capo Scirocco
Capo Scirocco (edito Rizzoli) è un libro che si ciba delicatamente del pentagramma della scrittura e che si esplicita attraverso una musica positivamente neoplastica che invade tutto e tutti. Forse non a caso, in questo bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel libro trovano spazio la Traviata e il Rigoletto che, attraverso un’abilissima mise en abîme, si intrecciano con la storia fino a diventare essi stessi espressione e mimesi della fabula.
Il titolo squisitamente rematico e la copertina locativa sono indicativi del contenuto. Lo scirocco infatti è metafora di turbamenti sessuali (“É lo scirocco. Fa impazzire le femmine, pare che cambia tutte cose”; ed ancora: “E la musica, spandendosi sulla platea, risalendo lungo gli ordini di palchi, investiva il pubblico simile ad un ciclone bonario, a un vento caldo di scirocco che mette un fremito languido addosso”). Il fico d’india, invece, è quel frutto di origine messicana che ‘ntuppa, diciamo noi in Sicilia, che riempie lo stomaco perché astringente come quell’amore che toglie spazio e sonno e che, tra l’altro, nel caso specifico, rimanda ad Ercole Patti e al suo romanzo Un bellissimo Novembre, e più precisamente alla scena erotica in cui il nipote Nino offre alla zia Cettina il succulento frutto. E questo è solo il primo dei tanti pastiche che si possono individuare nel romanzo della Abbadessa, quasi che l’autrice abbia voluto richiamare alla memoria la storia della letteratura italiana da Manzoni fin quasi ai nostri giorni.
Il romanzo, a ‘mò di melodramma, è preceduto da un prologo e seguito da 29 quadri (capitoli) e da un epilogo. Il libro si apre con un arrivo, uno sbarco in quella Sicilia da sempre terra centrifuga e qui scelta quasi casualmente dal protagonista, Luigi, per realizzare il proprio slancio vitale della personalità. Luigi è in fuga, è come un novello ‘Ntoni: ha lasciato la sua Subiaco perché si era ritrovato cresciuto in un mondo immobile che procedeva lento come le greggi verso il pascolo (in contrapposizione a quella che Verga proprio nella prefazione del suo primo grande romanzo definisce la fiumana del progresso, vero motivo della sciagura dei Malavoglia).
Luigi non è in preda ad astratti furori come il protagonista di Conversazione in Sicilia ma ha uno scopo ben preciso: desidera cantare, una passione trasmessagli da don Pietro, attività contrastata dal padre tanto da ricevere - come Zeno- uno schiaffo che brucia. È arrivato a Capo Scirocco sotto l’egida di un pianoforte a coda che ritroverà accarezzato dalle mani della giovane Anna, la quale gli concede –sebbene dietro compenso- il suo prezioso aiuto per esercitarsi nel canto e masturbare lentamente il Don Giovanni in erba che si nasconde in lui, finendo per innamorarsene.
Il giovane diciottenne viene notato una mattina da Donna Rita Agnello, una nobildonna ubriaca di musica e di desiderio, vedova al momento dei fatti, che lo prende con sé a casa per adempiere un vecchio voto (“Proprio sotto il vecchio arco con l’immagine della Sacra famiglia chiusa in una graziosa mandorla di pietra bianca, si arrestò davanti ad un ragazzetto che dormiva per terra, appoggiato a una grossa valigia marrone, rannicchiato come un capretto. Restò a guardare il giovane per un istante e poi riprese il cammino verso la matrice”). Essendo figlia di una traviata -giusto per citare l’omonima opera lirica che segna il primo contatto fisico fra i due -(anche se all’epoca in Sicilia si sarebbe detto figlia di una “caduta”), aveva fatto un voto solenne: “giurai a Dio che avrei espiato io la colpa di mia madre. Avrei dato una famiglia a un orfano così come era stata data a me e avrei rimesso a Dio i peccati della mamma”. E così lo fa studiare e lo introduce nell’alta società.
Ma com’è la Sicilia che ci presenta questa romanziera esordiente, fino a ieri solo musicologa? È una terra che parla attraverso l’olfatto, in cui "la frutta si matura al sole, il pane con la crosta coperta di semi di sesamo, la ricotta calda”. Altresì è una terra dalla lingua antica e misteriosa, mitologica, una isola che si muove, in fieri, “perché galleggia sull’acqua”.
L’originalità di Emanuela E. Abbadessa è quella di trasformare la Sicilia in luogo d’approdo, terra centripeta, sul modello della letteratura inglese. È qui, infatti, che il giovane Luigi arriva per dare compimento alla sua formazione di uomo e di cantante operistico. Luigi è presentato come uno scapigliato, è uno che è fuggito per il dolore dell’assenza materna, perché non regge più il rapporto col padre. Il canto diviene strumento di ricordo perché “solo mentre cantava, i tratti di mamma si ricomponevano dietro le palpebre chiuse … allora rivedeva gli occhi verdi come l’acqua dell’Aniene sulle cui pietre Assunta sbatteva le lenzuola mentre gridava gli stornelli della sua terra”.
Luigi ama il canto perché ciò che suona non può avere effetti nocivi e, dopo otto mesi in casa Platania, confessa il suo desiderio di abbracciare questo percorso. Ottenuto un diniego, trova però la donna desiderabile ed anche lei sente per la prima volta dopo la morte del marito la presenza di uomo, ”un odore fragrante di pelle appena sbarbata”, e comincia ad avere paura.
Un giorno, durante la celebrazione della messa, il giovane vince la sua timidezza e, con una vena di orgoglio, si abbandona al canto, con la stessa energia e lo stesso travolgimento con cui si cede alla passione, tanto che per raccontare la scena la scrittrice gioca con l’equivocatio, rimandando ancora una volta alla simbologia sessuale. La paura di aver fatto qualcosa di sbagliato è tradotta infatti come il fallimento non riuscito di un coito interrotto: “per la prima volta dopo tanto tempo si sentiva sicuro di sé e così, quando il Sanctus si levò verso il cielo, il giovane inalò il sentore d’incenso e di fiori quasi appassiti, riempì i polmoni e l’addome d’aria come aveva imparato da don Pietro e decise di aggiungere la sua voce al canto dell’assemblea. L’aria mise in moto le corde vocali, arrivò sulla lingua e divenne tonda nell’alveo delle guance e poi, miracolosamente, vibrò. Alta, possente, precisa. Nel momento in cui venne fuori, Luigi ebbe timore e avrebbe voluto risucchiarla in gola ma quella incurante del suo volere rimase per un attimo immobile nello spazio proprio davanti al suo naso, poi scappò via. Fu come una ventata che scosse i merletti sul capo delle donne, annodò i riccioli ai bambini, giocò a sfiorare i lobi delle orecchie degli astanti e, alla fine, si riverso magnanima sulle sottane del parroco. Fu tutto in un batter di ciglia. Donna Rita si stupì, arrossì e poi subito sorrise. Nascose il volto dietro le mani giunte e si accostò a Luigi sussurrando: <<Vero era, sei un tenore>>”.
Ad un certo punto, però, la nobildonna avverte che per Luigi nutre un amore diverso da quello che aveva realizzato con lo sposo (“il marito, per quanto più grande di lei, era stato un compagno amorevole. L’aveva coperta di ogni tenerezza, aveva fatto ristrutturare alcune stanza a Villabate perché lei potesse possedere tutto ciò che desiderava. Voleva che l’arredamento stesso degli appartamenti si adattasse alla fierezza della padrona di casa. Era stato un buon matrimonio, con la misurata passione che non rende infelici. Ora era diverso, ora sentiva che la stoffa degli abiti le bruciava addosso. Era una sete di mani e di bocca”). Come per la capinera di Verga –in Capo Scirocco espressamente citata per descrivere il turbamento di donna Rita-, è proprio tra le pendici dell’Etna che l’amore si rivela in tutto il suo parossismo, perché “è la donna che fa sapere a tutti di esistere”.
A complicare questo idillio è la trasformazione dello stesso in un triangolo. Luigi ha bisogno di un’accompagnatrice e si rivolge ad Anna, la figlia di don Cucè, un mercante caduto in disgrazia.
Luigi è abile a farsi amare da donna Rita ma capisce che questo non è sufficiente: è bello e libero e può avere il mondo ai suoi piedi. Tuttavia, come mastro don Gesualdo, soffre la contraddizione della posizione mediana: non si sente né contadino, né tantomeno signore.
La serva Cettina- fedele come Stefana dell’Illusione di De Roberto- cerca di avvisare la signora perché ha paura delle conseguenze: “gli uomini dovete tenerli cosi: né troppo stretti per evitare di soffocarli e non troppo lenti sennò scappano. Come gli uccellini”.
Per sfuggire all’amore, Donna Rita si rifugia in quello stesso convento dove era nata e scoprirà tramite la lettura di Sant’Agostino che il vero grande peccato è quello di reputarsi privi di colpe. Ciononostante la fede diventa una mania, una patologia come l’amore (ecco la lezione del naturalismo), tanto da voler beneficiare della sua carità un’opera pia, una sorta di lazzaretto per i poveri, fondata da un uomo il cui unico figlio era stato ucciso da una infezione provocata da un ubriaco, il quale non aveva voluto cedergli il passo come l’inventio manzoniana di fra’ Cristoforo.
Durante l’assenza, Luigi diviene un amministratore oculato e stringe amicizia con un tombeur de femme, Domenico Russo, presentato con le parole della famosissima aria della Boheme (Mi chiamano Mimì). Il giovane è uno che si divertiva a sorprendere le donne e che si era chiesto spesso se in amore l’appagamento non stesse tutto racchiuso nell’attimo in cui il rossore le vinceva. Sarà proprio lui a far avvicinare i due con la scusa di una gita in barca.
Donna Rita e Luigi finiscono per condividere il talamo “perché Dio non condanna coloro che amano”. Luigi si giustifica di questa decisione con Anna parlando della gratitudine come quel sentimento complesso e molto vicino ad un altro ancora più potente.
Dopo il matrimonio inizia l’attività operistica di Luigi in termini professionistici: l’impresario Jacopo Cavallaro lo scrittura infatti per il Rigoletto ed è costretto ad andare a studiare a Palermo insieme ad Anna. La moglie, che vinta dalla gelosia nel frattempo si è ammalata, non può andare e diventa una sua appendice: “dopo la morte del barone, la donna era vissuta nella noia, aspettando una novità, qualcosa che scuotesse la calma delle sue giornate tutte uguali. Adesso però che Luigi aveva portato nella sua vita tanti cambiamenti, qualcosa dentro di lei rifiutava l’idea di un domani diverso da quello che si aspettava, ovvero un tranquillo matrimonio, una vita in due nella quale il massimo dello sconvolgimento poteva consistere nel cambiare la tappezzeria al salotto o rifare il guardaroba. O forse, semplicemente, trovava fastidioso che quanto stava avvenendo, in fondo, non la riguardasse in prima persona”.
Rita si accorge di non essere più lei la regina di quel palcoscenico chiamato vita e di questo soffre amaramente (“la vita dopo un breve ritorno sulla ribalta, la stava ricacciando tra le quinte nere in cui si era ritrovata con la morte del barone. Ora Rita non avrebbe saputo dire se la gelosia fosse pura preoccupazione per gli eventuali tradimenti del marito o, piuttosto, disappunto per aver perduto il ruolo di protagonista appena conquistato”).
Decide pertanto di farsi agnello sacrificale, Norma per l’appunto, ossia l’omonimo melodramma di Bellini. Ed è qui che avviene il colpo di scena che uno non si aspetterebbe quasi: Luigi si trasforma suo malgrado in un personaggio prima sveviano e poi moraviano. La odia e, anziché esserle grato, capisce che quella ottenuta non è vera libertà, proprio come non lo fu per i protagonisti dell’omonima novella verghiana.
Insomma, Capo Scirocco, trasfigurazione di una Catania barocca che non vuole scomparire, romanzo ricco di intertestualità e interartisticità, che fa uso della musica non come un semplice orpello riempitivo e accomodante ma come intreccio, è un libro d’ispirazione romantica che va letto con tutt’e cinque i sensi e che, attraverso una scrittura dolce, sensuale e rassicurante, chiarisce quanto la vita possa (e debba) essere investita da questo vento voluttuoso che soffia anche a porte chiuse.
*
 Sophie Kinsella - Romanzo - Mondadori
Sophie Kinsella - Romanzo - Mondadori
I love shopping in bianco
Conoscevo la scrittrice solo per fama, nel senso che rimanevo colpito dalla pila dei suoi libri che sempre campeggiano in qualunque libreria e centro commerciale. Ma per via di quella puzza pregiudiziale di cui dicevo prima avevo sempre procrastinato l’acquisto:” È un libro troppo leggero, per adolescenti”.
Già dal titolo si capisce il tema dominante (leggasi mania) per lo shopping, una forma non del tutto catartica per liberarsi delle proprie passioni e delle proprie paure. E poco importa se si comprano cose del tutto futili o tre o quattro vestiti per la stessa occasione.
Becky Bloomwood è una ragazza inglese trasferitasi nella grande mela che vive una convivenza felice col fascinoso e ricco Luke. Lavora presso Barneys in veste di personal shopper. È una ragazza solare che ama circondarsi di begli abiti e scarpe costosissime, che cerca di mascherare come “spese per la famiglia” nel conto cointestato col fidanzato.
Questo libro- che si inserisce all’interno di una stessa saga tematica e di cui è uscita in questi giorni una pellicola per opera del regista de "Il matrimonio del mio migliore amico", Paul J. Hogan- gira attorno alla costruzione di una cerimonia di nozze che per la leggerezza della protagonista si biforca in due feste parallele: la prima a New York nello sfarzoso hotel Plaza e la seconda in sobrietà, in Inghilterra.
Il libro si accende subito e spesso ci si deve interrompere per le risate che scaturiscono dalle situazioni esilaranti e ambigue che la protagonista vive, come la possibilità di prenotare dei lotti matrimoniali per il cimitero che in caso di divorzio possono essere spostati in lati opposti o l’esposizione dell’amico e stilista non ancora affermato Danny che mette le sue creazioni nel Barneys a insaputa della direttrice oppure la ricerca di due sosia così da rendere possibili entrambe le cerimonie.
Non mancano nemmeno i momenti forti e di riflessione: “Becky, hai mai pensato alla topografia di Manhattan? È come una metafora della vita. Tu pensi di avere la libertà di andare ovunque desideri ma in realtà hai dei confini molto rigidi. Su o giù. Destra o sinistra. Niente vie di mezzo. Nessuna possibilità intermedia. La luce entra a Manhattan e resta intrappolata. Intrappolata nel suo stesso mondo, costretta a rimbalzare da un edificio all’altro senza una via di fuga”.
La festa in America è organizzata dalla wenning planner Robyn, assunta dalla suocera, una donna eccentricamente aristocratica che più che altro vede nel matrimonio del figlio la sua festa e la celebrazione del proprio successo. Ed è il rapporto con queste due donne ad incidere sull’economia del libro. Forte è il topos per niente idilliaco nuora-suocera. Quest’ultima, per altro, è rea di aver abbandonato il figlio quando era piccolo e sembra cercarlo solo quando questi è diventato qualcuno.
Ma come fare a dire no ad un matrimonio extra-lusso, il matrimonio dell’anno, organizzato in pompa magna e che ha come tema “la bella addormentata nel bosco” e nel frattempo accontentare la mamma che parallelamente per lo stesso giorno sta organizzando un matrimonio più tradizionale? Becky non pare possedere la determinazione di scegliere fra le due feste e nemmeno il coraggio di ammettere, almeno a se stessa, l’ambigua fragilità del suo carattere:
“Ho acceso cinquanta candele nella chiesa di St Thomas e altre cinquanta in quella di St Patrick, ho affisso una supplica sulla lavagna delle preghiere nella sinagoga della Cinquantacinquesima e ho portato dei fiori alla dea indù Ganesh. Inoltre un gruppo di persone che ho scoperto su internet sta pregando intensamente per me”.
Il romanzo va letto tutto d’un fiato e servirà a meglio comprendere il mondo femminile in fatto di acquisti. Inoltre è molto piacevole e avvincente, e sebbene il termine abbia più che altro un’accezione negativa, non è un offesa definirlo “leggero”, nel senso che è adatto a qualsiasi età e che può trovare facilmente spazio nella nostra libreria. In fondo non ha la velleità di assurgere a letteratura. Vuole essere solo un libro di lettura. assai spassoso e capace di spezzare la pedanteria di letture ben più altolocate.
*
 Alberto Moravia - Narrativa - Bompiani
Alberto Moravia - Narrativa - Bompiani
La Romana
La genialità di Alberto Moravia, che ha attraversato sempre sulla cresta del successo le mode e le generazioni, sta tutta nell’aver saputo riproporre un canovaccio rinnovandosi e avendo sempre l’ardire di far parlare i suoi personaggi con una voce borghese o anti-borghese.
La Romana, romanzo scritto tra il 1947 e il 1950, risente della eco dell’inettitudine sveviana e allo stesso tempo del pessimismo così caro al verismo.
La protagonista è Adriana, una ragazza “infaticabile, sottomessa e paziente; e al tempo stesso sempre serena, lieta e tranquilla, l’animo privo di invidia, di rancore e di gelosia” che avverte sin da subito lo status di «esclusa» dal mondo allegro e scintillante della felicità, ben consapevole della differenza sociale e per nulla invidiosa dell’apparente serenità dei borghesi: lei non vuole mettere “il proprio paradiso nell’inferno degli altri”.
La sventurata (prendiamo in prestito un aggettivo dal Verga) perde il padre quando è ancora piccola ed e cresciuta dalla mamma, una donna convinta che la figlia sia la ragazza più bella della città e che vuole far uso di questa bellezza per farle fare il salto di qualità. Una madre che ha solo questa certezza e che, di contro, non crede nemmeno nell’illusione della preghiera: “Si vede che i ricchi sanno pregare meglio di noi”. Per Adriana invece la bellezza è solo una qualità che tutti lodano a parole ma che alla fine non serve che ad accrescere l’infelicità: un’infelicità che è definitiva “quando non si desidera più niente”.
La disgraziata - che per alcune peculiarità sembra riportare alla mente la Gervasia Macquart di Zola - lavora come modella per un pittore ed è proprio recandosi allo studio che conosce Gino, un ragazzo bello e beffardo che sa dire le parole giuste per falsificare la realtà e che riesce ad avvinghiare l’ingenua tra le sue bugie.
Adriana, dopo aver lasciato il lavoro di modella, si dà al marciapiede con aria romantica: ”Anzitutto io non sapevo essere cosi avida e così mercantile come Gisella. Intendevo certo essere pagata perché non andavo con gli uomini per divertimento; ma la mia stessa natura mi portava a darmi di più per una specie di esuberanza fisica che per tornaconto e non pensavo al denaro se non al momento di farmi pagare”. Non se ne vergogna della sua posizione anche se si rende conto che il suo “era un mestiere molto duro” perché bisogna “fingere il trasporto per uomini che, in realtà, mi ispiravano sentimenti opposti”.
Nella seconda parte del romanzo entra preponderante la questione politica, in un neorealismo che si fa fotografia e denuncia. Adriana si innamora di Mino, uno studente di legge dedito alla sovversione e che rimane indifferente ai richiami sessuali di Adriana, a cui “la politica giungeva da un mondo superiore e sconosciuta, più fioca e incomprensibile di quanto giunga la luce del giorno”.
Il romanzo, districandosi nel binomio sesso-potere, si chiude ancora una volta con la disfatta degli ideali finti e negativi della borghesia, così incapace di incarnare il vitalismo e la palingenesi di una società corrotta dal fascismo e dalle sue sovrastrutture e il trionfo della classe suburbana e sottoproletaria che di lì a poco troverà ampio spazio nella riflessione di Pier Paolo Pasolini.
*
 Alberto Moravia - Narrativa - Edizioni Bompiani
Alberto Moravia - Narrativa - Edizioni Bompiani
La noia
Il titolo è sicuramente poco invitante. Ma basterà concedersi a poche righe per restarne completamente avvinti. Il registro è quello del Moravia a cui siamo abituati: una scrittura dessamente teatrale, con ampio spazio ai discorsi diretti e ai soliloqui, il tutto incorniciato dalla smania del sesso e dalla critica antiborghese.
La noia di Alberto Moravia, romanzo del 1960, specie nei primi capitoli, è a metà strada tra una pièce e un saggio, una sorta di «cosmogonia della noia». Non a caso è stata fatta nel 1963 una visitazione cinematografica dal regista Damiano Damiani.
La fenomenologia della noia non è altro che la mancanza di rapporto, una non corrispondance con le cose, con gli altri, con sé: “Per molti la noia è il contrario del divertimento … per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà, quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’ inverno…oppure la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa…oppure la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina”.
Il protagonista del romanzo è Dino, «l’amministratore della noia» per antonomasia, un pittore che inizia a usare i pennelli per sfuggire all’indifferenza (il romanzo a tratti sembra il proseguo dell’omonimo romanzo del 1929), un Dorian Gray ante litteram che cerca di sfuggire al determinismo economico e soprattutto alla noia, al fine di entrare in empatia con il reale che sembra sfuggirgli di mano anche a causa della madre, una donna cristallizzata nella forma di nobildonna e ricca possidente.
La vita di Dino è avvolta nella nebbia, è un continuo confrontarsi con la tela vuota, un oscillare –molto schopenhaueramente- tra noia, disperazione, dubbio e sesso. Una situazione che resta tale anche quando entra nella sua vita Cecilia, una giovane con personalità duplice,che finisce per diventare la sua amante. Cecilia -ora donna, ora bambina, sia nell’espressione che nei gesti- è una ragazza di poche parole che ha solo l’espressione sessuale: la sua unica bocca pare essere quella della vagina. Tra i due si istaura una comunicazione prettamente fisica-tuttavia mai completa- e il loro rapporto è mercenario ed è solo un palliativo di fuga dalla noia, anche quando Dino trasforma il rapporto in sadismo e sarcastica provocazione.
Cecilia acquista materialità, diventa reale, solo nel momento in cui Dino teme di perderla a causa di una relazione che la giovane intrattiene con Luciani, un giovane attore. Fino a questo punto infatti Dino ha una tela vuota perché non riesce “a prendere possesso di una realtà qualsiasi, allo stesso modo che era vuota la mia mente nei confronti di Cecilia che mi sfuggiva e non riuscivo a possedere”.
Il romanzo si chiude con una morale negativa. Moravia ci invita a rassegnarci alla tela bianca perché ogni lotta per dominare il reale è impari, avvilente e inutile. Non rimane che accettarne passivamente le sue non univoche manifestazioni.
*
 Gesualdo Bufalino - Saggio - Sellerio
Gesualdo Bufalino - Saggio - Sellerio
La luce e il lutto
Altro che Touring Club o guide Michelin. Chi vuole prepararsi al viaggio in Sicilia o vuole più semplicemente conoscerne «l’humus», non può fare a meno di affidarsi agli elzeviri del genio di Comiso. Anche il siciliano doc non deve farne a meno e può, oltremodo, verificare la propria sicilianità attraverso un test con cui rendersi conto di come sia un difficile lusso l’essere siciliano.
La luce e il lutto di Gesualdo Bufalino (Edizioni Sellerio) è una lucida fotografia sulla Sicilia e sulla insularità, “un capire, assolvere o condannare”. Il libro, dal punto di vista strutturale, è composto da articoli scritti tra il 1982 e il 1987, tranne due che risalgono al 1947. Nella loro attualità vanno a ricostruire una Sicilia mitica e nostalgica perché, come lo stesso autore sottolinea nella breve introduzione, “a guarire l’analfabetismo morale da cui (non solo noi, non solo noi) siamo afflitti, possano un poco servire, sebbene fatti d’aria, anche le nostalgie, le favole e i sogni”, un paese che è ombelico del mondo e che è avvinto da un fato avverso e nefasto che può, a ragione, essere sintetizzato nel detto popolare:
“Chistu è ‘u paisi d’o scunfuortu:
o cadi acqua o tira ventu o sona ‘a muortu”.
(Questo è il paese dello sconforto:
o diluvia o c’è vento o suona il mortorio).
Ma innanzitutto cos’è il viaggio? Bufalino fa sue le parole di Montaigne: viaggiare è “sfregare il nostro cervello e limarlo contro quello degli altri”. La Sicilia che Bufalino tratteggia è un’isola plurale, al contempo apollinea e dionisiaca, un caleidoscopio di culture, con la coscienza e la lucidità di uno che non soltanto ci è nato ma che soprattutto ci è vissuto: “Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto d’isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razza e costumi, mentre qui è tutto mischiato, cangiante, contradditorio, come nel più composito dei continenti. vero è che le Sicilie sono tante, non finirò di contarle. Vi è la Sicilia del Carrubo, quella bianca delle saline, quella gialla delle zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava… Perché tante Sicilie? Perché la Sicilia ha avuto la sorte di trovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione”.
Pur non chiedendo indulgenze cosmetiche a quelli che sono i pregiudizi del viaggiatore-legati soprattutto all’idea di mafia, omertà, onore, gattopardismo- l’idea della morte (la festa tragica) è il topos dominante. Un’immagine che sovviene già nel momento in cui si attraversa Scilla e Cariddi sul traghetto che porta nome Caronte per quanto oggigiorno “il sentimento di morte, e il codice dei contegni che ne discende, sono in declino”. Morte (Tanatos) e vita (eros) risultano essere facce della stessa medaglia, onnipresenti e complementari.
Bufalino tratteggia l’isola come crocevia di molteplici civiltà che hanno lasciato il segno, un ossimoro geografico e antropologico, una terra che spesso diventa isola nell’isola e che sicuramente col ponte “non perderebbe la sua vocazione claustrofilia e il vizio di fare della solitudine un trono e una tana”. E se per Sciascia è la Sicilia che sta sicilianizzando l’Italia a causa della «linea delle palme» che tende a salire verso Nord, è pur vero “che la linea degli abeti cala sempre più verso il Sud”. Una regione, insomma, che rischia di perdere la sua millenaria identità.
Ma iniziamo il nostro viaggio. Per partire è sufficiente portare seco un vocabolario di greco. Il viaggio sarà un esame e richiede pazienza per le carenze alberghiere, i scarsi (e a volte inesistenti) mezzi di trasporto e vie di comunicazione post-unitarie. Ciò che sicuramente colpirà a prima acchito è la ruralità esiodea e l’Etna, «strumento di purificazione» che si erge sovrana, per quanto “si è riluttanti, da Empedocle in poi, a frequentare i vulcani”. La parte più interessante risulterà essere il calcagno sud-orientale dell’isola, con le ricche province di Siracusa e Ragusa ricostruite dopo il terremoto benevolo del 1693 “che vien quasi voglia di benedire, col cinismo dei posteri” perché “a tante fatiscenze diede la scossa e consentì la fioritura di un’ammirevole e creativa stagione edilizia dell’isola”. Oppure ci si stupirà per la base militare di Comiso, esempio tangibile di turismo militare americano.
Un viaggio alla scoperta del passato e del mito in cui sarà possibile riconoscere le pedate di Plutone nei pressi di Pergusa o veder affiorare dai flutti Nettuno.
Forse il modo migliore è quello di viaggiare a casaccio e affidarsi alla proverbiale ospitalità dei siciliani, senza necessariamente fissare mete precise: perché è perdendosi che si trova il “posto più misterioso e più bello”.
*
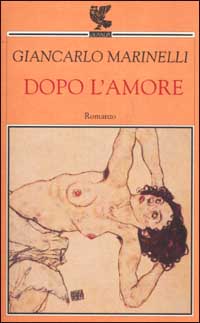 Giancarlo Marinelli - Narrativa - Edizioni Guanda
Giancarlo Marinelli - Narrativa - Edizioni Guanda
Dopo l’amore
Dopo l’amore è la terza creatura dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli, un cortometraggio di quelle che sono le vicende umane che si dipanano nell’attimo in cui i protagonisti si scoprono non più adolescenti. È il 1998, un anno cruciale perché coincide con i mondiali e con gli esami di maturità, con la perdita della verginità e della invisibilità: “Adesso noi non siamo più invisibili, Mattia. Chi si bacia, chi si ama, ritorna a vivere”.
Mattia, Camillo e Franco. Tre amici, tre animi ancora da raffinare al fuoco dell’amore e delle sue subdole contraddizioni. Giovani che, come le onde, vogliono “cercare di superare il mare, staccarsi dal mare, per abitare sulla terra”. Il romanzo inizia con una ampia panoramica su quello che è il proscenio del romanzo: Scardivari, un anonimo paesino che si perde nella immobilità dei gesti e che si apre in due sole strade: l’asfalto e il fiume. Camillo, bullo e dandy allo stesso tempo, “vive” il romanzo solo marginalmente. Egli compare per lo più con le uscite di scena di Franco, che in paese non esiteranno a definire “un rapatus di gelosia o di follia”, ragazzo sensibile, cresciuto dalla sorella che ora sta per morire, consumata dal tumore. Malattia che diventa topos, ricordo del passato, tormento del presente, assenza del futuro.
Il romanzo prende accelerazione non appena Martina, una graziosa ragazza amata da Franco, si mette con Mattia. Non è solo gelosia quella di Franco: è paura, perché sa che per Mattia questa è solo un’avventura, un modo per vivere il sesso e per dimenticare. Mattia chiuderà la storia per non ferire Martina e lo stesso Franco. Ma anche, e soprattutto, per via di Jessica, una spogliarellista che diventa strumento di vendetta e, suo malgrado, il deus ex machina per far uscire Mattia dall’apatia e dal dolore che, nel frattempo, ha travolto come una piena lui e Martina: “Come sento tutto mio un'altra volta, come è incredibile sentirsi innamorati, anche solo di una speranza, per tornare felici. È come se solo la luce di quella speranza abbia un bagliore così forte da far luccicare, profumare, esaltare anche ciò che prima sembrava merda”. Un amore che sembra nascere spontaneamente dalla corrispondenza degli sguardi.
Nel romanzo trovano spazio anche delle piccole storie veramente originali, che vanno ad intrecciarsi con quelle dei protagonisti. C’è il “medico della benzina”, che diventa angelo della morte, che è sicuro che : “Quando dentro la figa c’è l’odore di benzina vuol dire che è finita… Non sono ubriaco e non sono matto… Vi dico che quella ragazza lì ha il tumore perché ha l’odore della benzina dentro il corpo”. C’è il pianista del cimitero chiamato così perché “il suo pubblico erano i morti e la funzione della sua vita era quella di suonare per loro, di accompagnare la loro morte con dolci melodie; le armonie più allegre, più ritmate e giocose, le suonava per gli amici e i parenti che, dopo aver visitato il proprio defunto, uscivano dal cimitero con l’espressione triste e i visi rigati dalle lacrime”.
Il romanzo si chiude in una camera di ospedale, piantonata da un carabiniere. È la numero 64, un numero non a caso. Se il 32 era il numero della camera d’albergo in cui Mattia e Jessica si erano aggrovigliati e riscaldati, il suo doppio sembra rappresentare, dopo l’amore, un ritorno all’amicizia adulta.
Dopo l’amore è un libro adatto al pubblico giovane, perché nella sua leggerezza, si fa leggere e si insinua fino a costringerti a divorarlo come le leccornie della mamma perché “noi non possiamo fare a meno del fiume… senza il fiume siamo condannati ad essere meno di niente”.