chiudi | stampa
Raccolta di saggi di Paolo Melandri
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
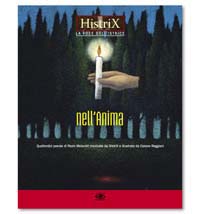
*
- Letteratura
Ecumenismo e identità nazionale in Thomas Mann
Ecumenismo e identità nazionale. «Considerazioni inattuali» sul ruolo della Germania in Europa attraverso una disamina dell’opera di Thomas Mann
Vergleiche dich! Erkenne, was du bist!
Goethe, Torquato Tasso
Dice Dostoevskij, in un suo scritto sulla comparsa dell’«anima slava» nel dissonante «concerto europeo»: «si credeva che l’ideale degli slavofili fosse quello di “mangiare ravanelli e scrivere denunce”. Già, denunce! Così come apparvero, con quel loro modo di vedere le cose, stupirono al punto che i liberali incominciarono a impensierirsi, ad aver paura: che putacaso quella stramba gente volesse alla fin fine denunciare loro?»i.
I contrasti che allentano e rendono problematica l’intima unità e «compattezza spirituale»ii delle grandi comunità europee, sono a un dipresso ovunque gli stessi, in sostanza sono «un fatto europeo»iii. Tuttavia hanno caratteristiche profondamente diverse da popolo a popolo e si amalgamano, nel loro complesso, con l’insieme della propria nazione. Avviene così che un francese politically correct e radical chic sia un francese autentico, schietto, intero e inequivocabile, giusto quanto può esserlo un francese clarical-lefévriano, e un inglese conservator-liberale sia inglese esattamente quanto un suo compatriota social-progressista; tutto sommato, un francese si intende con un francese, un inglese con un inglese meglio che con chiunque altro e comunque benissimo.
Esiste invece un paese, un popolo, dove le cose stanno in un altro modo: un popolo che non è nazione in quel senso sicuro e scontato per cui i francesi o gli inglesi formano una nazione, e forse non lo sarà mai perché la storia della sua formazione, il suo concetto di umanità si oppongono a che lo diventi; un paese la cui intima unità e compattezza, per quei contrasti spirituali e antropologici (non ideologici ma, semmai, post-ideologici), vengono ad essere non solo complicate ma addirittura quasi annullate; un paese in cui quelle contraddizioni si rivelano più impetuose, più radicali e maligne, meno conciliabili che in qualunque altro posto – e questo avviene perché in quel paese esse non sono affatto tenute unite, o solo a mala pena, da un legame nazionale, né le tragiche esperienze del XX secolo sono in qualche modo sussunte in una visione d’insieme, come avviene invece in ogni altro popolo, nell’ampio perimetro delle contrastanti posizioni dell’opinione pubblica. Questo paese è la Germania. I dissidi «spirituali»iv della Germania sono stati – e ancora sono – dissidi assai poco nazionali, quasi puramente europei; privi, o quasi, di una comune ‘tinta’v nazionale, gli elementi in contrasto si fronteggiano senza comporsi in una sintesi. Nell’«anima della Germania»vi vengono gestiti i contrasti spirituali dell’Europa, gestiti nel senso della maternità e in quello della rivalità. Questa è la mission peculiare, nazionale, della Germania, la quale resta sempre il campo di battaglia, anche se non più fisico – questo è riuscita ad impedirlo di recente, a partire dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso – almeno spirituale dell’Europa. E quando diciamo l’«anima tedesca» non intendiamo soltanto l’anima della nazione nel suo insieme; ma, come Thomas Mannvii, intendiamo invece proprio l’anima singola, la testa e il cuore dell’individuo tedesco, sempre in contraddizione con se stesso, come emerge ampiamente dalla letteratura allemande degli ultimi cinque secoli, da Lutero a Paul Celan ed oltre, fino ai nostri giorni. Essere campo di battaglia spirituale per tutte le contraddizioni dell’Europa: questo è propriamente tedesco. Non è tedesco invece prendere le cose alla leggera, i dissidi in maniera cattolicamente conciliante, o banalmente livellante attraverso un malinteso concetto di globalizzazione, denunciare in direzione filantropico-umanitaria la debolezza nazionale, la «segreta infintà», come dice Nietzscheviii, del proprio popolo, assumendo semplicemente un atteggiamento alla francese. Chi aspirasse a fare della Germania una semplice democrazia ‘bipolare’, post-borghese e post-marxista, secondo il senso e lo spirito romano e occidentale, la defrauderebbe di quanto ha di meglio e di più serio, cioè di quella problematica che di fatto costituisce la sua peculiarità nazionale: finirebbe col rendere la Germania noiosa, piatta, balorda e non più tedesca, con l’essere lui un anti-nazionalista per la sua pretesa che la Germania diventi nazione in un senso e in uno spirito che le sono stranieri.
È un’aspirazione, questa, davvero singolare. Eppure esistono tedeschi «di questo tipo»ix, e sarebbe del tutto errato credere che per la Germania le cose siano così semplici come potrebbe sembrare stando alla grande formula dostoevskiana dell’«impero che protesta»x.
In un breve contributo approntato per il centenario manniano del 1975, uno dei più originali e «impegnati» fra i poeti tedeschi della seconda metà del secolo scorso, Peter Rühmkorf, si scagliava con estrema decisione contro la poetica e le opere dell’autore dei Buddenbrook: «Provo per l’opera di Thomas Mann, a vent’anni dalla sua dipartita, il medesimo disinteresse che nutrivo ai tempi della sua permanenza in terra. Qualunque tentativo di avvicinare il maestro attraverso uno dei suoi libri è fallito a causa di una barriera linguistica che – retrospettivamente – mi appare più o meno una barriera di classe. Alla ribalta è qui una cultura grande borghese, spezzata soltanto da interferenze marginali, i cui problemi non ho mai condiviso, delle cui prospettive e retrospettive non mi importa affatto, le cui modalità espressive mi ripugnano quasi fisicamente. Purtroppo, nel corso dell’ultimo quarto di secolo, mi è sempre mancato il tempo necessario per smontare direttamente le posizioni di un autore le cui impettite buone maniere vengono spacciate in modo pressoché unanime per stile; diversamente avrei dovuto prendere in mano troppi libri, ognuno dei quali già dopo trenta pagine mi era inesorabilmente venuto a noia. La cattiva impressione che avevo già ricavato dai vari infelici tentativi di avvicinamento ebbe modo di confermarsi quando, l’8 giugno del 1953 ad Amburgo, ascoltai il cosiddetto mago leggere dal Krull: con quanta soddisfazione degustava a fior di labbra la sua ironia sottile come un’ostia, e come si compiaceva – vorrei dire scimmiescamente – della sua affettata gradevolezza. […] A mio parere, e cioè sulla base delle mie analisi frammentarie, abbiamo a che fare, per quanto riguarda i travestimenti ironici di Thomas Mann, con il gusto prettamente liceale di mettere in bella, artistica mostra quel po’ di cultura che ci si è faticosamente conquistati, inscenando – allo stesso tempo! – la propria soggettiva distanza dai materiali della propria formazione. Con ciò, sottolineo nel mio stesso interesse, non intendo produrre argomenti contro la parodia in generale. Parodia, da ormai un po’ di tempo, non significa altro che tradizione criticamente spezzata, o tradizione problematizzata. Dove però il trattamento dei repertori culturali procede con tanta facile automaticità come in questo autore, e dove la mancanza di resistenza opposta ai modelli è seconda soltanto alla mediocrità della versione stessa, ebbene qui comincia per me una sfera di ispirata musica da casa (Hausmusik) nella quale non ritengo opportuno trattenermi»xi.
Difesa ad oltranza del ceto egemone, dunque, attraverso la stilizzazione di una correttezza linguistica e formale imposta per pura suggestione, attraverso il gesto ampio e “classico” del vegliardo, e per di più mistificata nelle forme cordiali ed amichevoli del mascheramento ironico. L’accusa di Rühmkorf, fondata peraltro su una cospicua tradizione antimanniana (da Alfred Döblin a Bertolt Brecht) e tutt’altro che isolata nel dibattito suscitato dall’anniversario del 1975xii, investe direttamente le strutture culturali e specificamente linguistico-letterarie che preparano e accompagnano la solidificazione di un’opera e di un autore in «classico», in oggetto di tradizione funzionale a determinate strategie di controllo sociale; nella sua icastica estremità, inoltre, riflette con particolare chiarezza gli umori e le tensioni di quella Sprachkritik che, a partire dall’immediato dopoguerra, attraversa con rinnovato vigore vasti settori della produzione letteraria di lingua tedesca.
Al di là del suo ingombrante antinazionalismo gauchista, Rühmkorf, il tedesco «di questo tipo», in molti punti ha ragione. Da un altro versante – da parte italiana – da vent’anni a questa parte è emersa con sempre maggiore evidenza la «sistematica spoliazione» operata da Thomas Mann ai danni del patrimonio museale e letterario «latino-occidentale» e «cattolico», da lui a parole altrettanto sistematicamente disprezzatoxiii; e non a caso usiamo l’espressione «sistematica spoliazione» perché puntualmente, le fonti italiane non sono citate, o il più delle volte trasportate nell’«aere … più respirabile», di antroponimixiv, toponimi e perfino nomi di Musei tedeschi.
Thomas Mann non è però nodo che possa sciogliersi nello spazio di un paio di pagine. Quanto a Rühmkorf, sollecitato circa vent’anni più tardi (1994) da Marcel Reich-Ranicki a pronunciarsi ancora sull’argomento, scrive un saggio molto più ampio e meditato in cui, dopo un’analisi suggestiva e stringente di alcuni motivi dei racconti di Mann, riesamina il punto centrale delle accuse del 1975 – ironia e parodia come strumenti di conservazione e di classicismo – e infine “riabilita” lo scrittore commentandone l’uso dell’ironia in Mario e il magoxv, il racconto di argomento italiano pubblicato nel 1930, che, dietro un singolare spettacolo di ipnosi, lascia intravedere meccanismi tipici della formazione del consenso nella società totalitaria: «Poiché però il diavolo si annida qui nei dettagli, e l’autore – come è facile vedere – si nasconde anche nel ruolo dello spregiudicato manipolatore di uomini, in breve non sappiamo più dire chi sia lo strumento di chi, e quali doti dobbiamo ammirare di più, quelle dell’osservatore seduto in platea, che, nonostante la fascinazione subita, mantiene pur sempre un atteggiamento razionale e superiore, o quelle del burattinaio sul palcoscenico, peraltro abbastanza forzosamente costretto nella sua ossessione di potere. L’incertezza dura fin quando l’individuo ordinario e banale (Mario, l’eroe eponimo) toglie di mezzo lo spettro minaccioso con un colpo di pistola, sicché l’autore-testimone e noi stessi, i suoi lettori-spettatori, possiamo infine, liberati, tornarcene a casa. Ma liberati da cosa? Diciamolo con la massima cautela possibile, data la delicatezza del caso: da un incubo autoritario, di cui già in altri racconti ci era parso di intuire i segni sinistri, e la cui simbolica soppressione accogliamo con sollievo tanto maggiore in quanto va finalmente a colpire il giusto obiettivo. Saranno anche, questi, divertimenti poco incisivi, sorti da attese di rigenerazione tutto sommato primitive, e tuttavia non si possono liquidare tanto semplicemente. E non potrebbe essere così, del resto, lì dove lo strapotere delle ossessioni dirige l’intera opera letteraria e spesso determina lo sviluppo dell’azione, ed è perciò tenuto in scacco dal contropotere dell’ironia, che al dispiegarsi del demoniaco riesce ad opporre anche soltanto una parvenza di libertà. In questa prospettiva l’ironia sarebbe allora da intendere come il tentativo ininterrotto di vedere, di sfuggire alla fascinazione ipnotica e di reagire alle fatalità, collocandosi in una posizione superiore e liberamente prescelta»xvi.
L’ironia, producendo uno scarto nella continuità e nell’unanimità del «pensiero dominante»xvii, scardina il consenso e introduce la polifonia della libertà individuale, svelando la pluralità dei sensi del reale. Rühmkorf si riconcilia così con Thomas Mann scoprendone l’inflessibilità della disposizione umanistica e intuendo nel «classico», tutt’altro che neutralizzato dalla distanza temporale, un potenziale alleato nella battaglia comune del ceto intellettuale, all’alba come al tramonto del XX secolo, contro la deriva tecnologica e per la resistenza del predominio morale contro l’autonomia incontrollata della prassi socio-economica.
Ora, la polemica di Rühmkorf, più che per il suo specifico contenuto, interessa per il valore testimoniale nei confronti di un tema che è in genere di enorme importanza nella biografia intellettuale di Thomas Mann, ma che all’altezza di Geist und Kunstxviii occupa una posizione assolutamente decisiva: ci riferiamo alla rappresentatività dello scrittore rispetto alla vita sociale, politica e culturale della Germania, una questione particolarmente complicata, oltre che dalla molteplicità dei livelli ai quali richiede di essere affrontata e dall’eterogeneità spesso incomponibile delle variabili che devono essere prese in considerazione, anche dall’apparente contraddittorietà di molti dei numerosissimi pronunciamenti dello stesso Mann. Per un rapido, preliminare inquadramento del problema, bastino alcune schematiche evidenze: dall’interventismo nazionalista nel corso della prima guerra mondiale, testimoniato dalle eloquenti Considerazioni di un impolitico, all’adesione alla Repubblica di Weimar, dalla lettera a Korrodixix ai discorsi di guerra rivolti ai Deutsche Hörerxx, Thomas Mann ha partecipato direttamente come nessun altro scrittore alle vicende della Germania del ventesimo secolo, tenendo sempre ben serrati insieme l’artista (Künstler) – il creatore di opere narrative dalla straordinaria compattezza plastica – e lo scrittore (Schriftsteller) – l’intellettuale-saggista disposto a prendere posizione sulle vicende del proprio tempo. Nessun artista, inoltre, ha potuto rappresentare agli occhi del mondo con altrettanta chiarezza, o con altrettanta risonanza, la resistenza di una cultura e di uno spirito tedeschi opposti e alternativi alla dittatura nazista, e ciò non soltanto per il riflesso della produzione letteraria, pur inconfodibilmente orientata a riconvocare il tradizionale spirito umanistico-weimariano (si pensi a Carlotta a Weimar), bensì soprattutto per la personale assunzione, da parte di Thomas Mann, di un ruolo esplicitamente e pubblicamente antagonistico rispetto alla Germania delle camicie brune. Nessuna corrente o stagione della letteratura tedesca, peraltro, ha potuto aggirare, dal secondo dopoguerra in poi, il problema dell’identità della Germania che Thomas Mann, da Fratello Hitlerxxi al Doctor Faustus, ha posto con la massima urgenza possibile. Pare anzi di poter affermare che intorno all’opera di Mann siano addensati motivi a tutt’oggi centrali e determinanti della vita culturale tedesca, nel segno di una vitalità e di una provocatorietà del classico ulteriormente corroborate anche dalle più accese manifestazioni iconoclastiche, sicché, lungo percorsi anche i più tormentati e discontinui, si finisce sempre per non poter in alcun modo prescindere da Thomas Mann, con lo stesso misto di diffidenza e di entusiasmo che, quasi un secolo fa, Walter Benjamin confidava all’amico Scholem: «Sull’ultimo numero della “Neue Rundschau” Thomas Mann pubblica un breve saggio sulle Affinità elettive di Goethe. Non l’ho ancora letto. Ma mi colpisce perché in questi ultimi tempi mi accade spesso d’incontrarmi con questo autore. Non so come fare a dirti che quest’uomo che ho odiato come pochi altri pubblicisti ora lo sento addirittura vicino a me, dopo il suo ultimo grande libro, La montagna incantata, che mi è capitato tra le mani – un libro dove ciò che vi è d’infallibilmente più mio, ciò che mi muove e sempre mi ha mosso, mi ha impressionato in un modo che posso rigorosamente controllare e accettare, anzi, spesso devo ammirare molto»xxii.
La maggior parte delle umanistiche posizioni prese dal «classico» Mann, testé sommariamente esposte, hanno la loro origine e sono presenti in nuce nel celebre saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale di Friedrich Schillerxxiii. Thomas Mann aveva un altissimo concetto del lavoro schilleriano, e non perdeva occasione per celebrarlo come un modello di grande evidenza entro cui definire ed eventualmente stilizzare la propria identità. Più volte lo definì «l’opera più intelligente» che fosse stata mai scritta, l’archetipo perfetto della scrittura saggistica, il «libro» in cui «sono presenti tutti gli altri»; l’originalità di questi ultimi, anzi, si limita ad essere quella di «glosse», commenti e delucidazioni di singoli aspetti e problematiche già compiutamente esposti da Schiller, in questo «libro intelligentissimo», la cui bellissima prosa è parimenti esaltata fino alle stelle. L’atteggiamento di Thomas Mann nei confronti del saggio schilleriano non è però, come ci si potrebbe aspettare dai ricordati toni enfatici e celebrativi, acritico: più volte egli tenta di misurarsi con l’idolatrato modello, e nutre la segreta speranza di scrivere qualcosa di altrettanto significativo sulla letteratura. Nella fictio della Morte a Veneziaxxiv, ad esempio, tra le altre, immaginarie opere di Gustav von Aschenbachxxv, compare anche «l’appassionato saggio Spirito e arte, che per la potenza chiarificatrice e l’eloquenza dialettica era stato affiancato da molti autorevoli giudici al saggio di Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale»xxvi. Un Wunschtraum ironico e rivelatore, che colloca il saggio Spirito e arte, ultimato nella finzione narrativa, a fianco dell’autorevolissimo modello schilleriano e nelle mani di uno dei personaggi più complessi e difficilmente decifrabili, quell’Aschenbach in cui convergono e si intrecciano elementi anche aspramente contraddittori come la dignità rappresentativa dell’artista, il carattere ludico e parodico dell’arte, la consumazione dell’unità classica, l’aspirazione ad una rinnovata classicità. Il brogliaccio di appunti dispersi e disaggregati si trasforma così, nella finzione narrativa, in una composizione unitaria in grado di rivaleggiare con il modello schilleriano, nel culmine, anzi, della produzione di Aschenbach, il quale proprio sul grande trattato fonda la propria prestigiosa rappresentatività: il Litteratur-Essay diventa Geist und Kunst. Il breviario adottato da Mann negli appunti di Spirito e arte, e successivamente nelle Considerazioni di un impolitico, è, come si è visto, il saggio di Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale, il modello elettivo del grande trattato di Aschenbach. Distinguendo la pienezza naturale del poeta ingenuo dallo stato di frammentazione artificiosa del poeta sentimentale, Schiller aveva di fatto elaborato una mitologia del classico di enorme influenza sulla formazione della struttura e del gusto della letteratura tedesca successiva, e aveva dato un apporto fondamentale al dibattito culturale europeo del diciannovesimo, ma anche del ventesimo secolo. Ad oggi, la provocatorietà classica di Sulla poesia ingenua e sentimentale non ha smesso di interrogare e di chiamare in campo gli scrittori e gli intellettuali europei più colti ed accorti.
Pubblicato tra il 1795 e il 1796, il saggio-trattato Sulla poesia ingenua e sentimentale traccia il destino di tutta la letteratura contemporanea. La poesia è certezza dell’impossibilità di realizzazione dei propri ideali; la sua provocatoria «inattualità» è vita di un’utopia che le consente di ritrovare nella luce del sogno e del desiderio il suo vero e autentico fondamento. «Tutti i poeti che siano realmente tali, apparterranno o agli ingenui o ai sentimentali». L’ingenuo è natura; il sentimentale aspira alla natura. Con questa distinzione Schiller compie una decisiva analisi sulle relazioni tra arte, natura e antropologia che inaugura ogni nostra riflessione sull’estetica filosofica. Nell’ingenuo c’è integrità armonica con la natura; essa non è conquista ma spontaneità: è la forma della classicità. Nel sentimentale c’è la visione dell’assenza, la cancellazione di un equilibrio, l’aspirazione alla totalità: è la forma della modernità. Ma queste grandi figure simboliche sono solo in apparenza contrastanti perché la poesia se esprime le due diverse condizioni della realtà umana e della sua storia, tende tuttavia a confonderne i piani. Ingenuo e sentimentale non appaiono più, nello sviluppo dell’argomentazione schilleriana, come concetti che contengono una visione della natura in riferimento ad un’epoca storica; essi rappresentano il problema di un rapporto ideale, adombrato dal rapporto reale tra Goethe e Schiller: qual è il modo d’essere dell’artista ingenuo nel mondo moderno sentimentale? Per Schiller rispondere a questo interrogativo significa poter dare alla parola della poesia la forza di essere anima del mondo, l’intelligenza per essere significato della realtà.
«Vi sono istanti della nostra vita», dice Schiller, «in cui dedichiamo una sorta di amore e commosso rispetto alla natura nelle piante, nei minerali, negli animali, nei paesaggi, così come alla natura umana nei bambini, nei costumi del popolo contadino e del mondo primitivo, e non perché essa ristori i nostri sensi, e neppure perché appaghi il nostro intelletto o il nostro gusto (anzi, spesso può accadere il contrario dell’una e dell’altra cosa), ma unicamente perché essa è natura»xxvii. Riassumendo, la catena concettuale prosegue a un dipresso così. Ogni uomo che sia pur minimamente raffinato e non difetti totalmente di sensibilità, può farne esperienza passeggiando all’aperto, vivendo in campagna o indugiando presso i monumenti dei tempi antichi; in breve, quando in condizioni e situazioni di artificio rimane stupito dalla visione della natura nella sua semplicità. E «questo interesse, non di rado elevato a bisogno, sta al fondo della nostra passione per i fiori e per gli animali, per i semplici giardini, per le passeggiate, per la campagna e i suoi abitanti, per i molteplici prodotti della lontana antichità e per altre cose ad esse simili, a patto che non entrino in gioco affettazione e altri casuali interessi»xxviii.
La prima impressione che ci colpisce nel leggere questa bellissima prosa di Schiller riguarda il livello d’esattezza, in seguito ineguagliato nella letteratura critica, con cui egli sa trattare dei temi spirituali più sfumati e inafferrabili attraverso uno stile sobrio e denotativo e tramite scelte lessicali che circoscrivono e analizzano il problema via via affrontato in maniera al contempo intuitivamente profonda e sorprendentemente chiara ed evidente; così come appare evidente che nel parlare del poeta sentimentale egli discorre di sé, l’«eroe dello Spirito», mentre nel trattare del poeta ingenuo, figlio prediletto di madre natura, egli allude a Goethe, il «beniamino degli dèi», il «favorito della sorte», la cui spesso inattingibile grandezza è riassumibile nella famosa formula dei «meriti innati», ultima, ludica trasformazione dell’opprimente dottrina agostiniano-protestante della predestinazione. In particolare, è presente a Schiller saggista e filosofo di forte ascendenza kantiana, il Goethe naturalista-scienziato degli studi sull’ottica e sulla evoluzione di tutte le specie delle piante da un unico archetipo remoto e preistorico (la cosiddetta Urpflanze). Il vero e proprio ‘connubio’ tra Goethe e Schiller non era ancora iniziato, ma lo Schiller editore delle «Hören» non nascondeva il proprio interesse a coinvolgere l’«Olimpico» in una comune battaglia culturale per il rinnovamento della cultura tedesca. E gli studi scientifici di Goethe, specie quelli riguardanti l’ottica, destinati a chiamare in causa e a coinvolgere anche il giovane Schopenhauer, costituirono davvero il necessario tramite e il naturale ‘collante’ per il progressivo avvicinamento dei futuri «Diòscuri di Weimar». Riteniamo dunque opportuno fronire al lettore qualche ragguaglio sull’epica fatica goethiana attorno alla «storia dei colori», il cui finale approdo è l’epocale Teoria dei colori dello stesso Goethe, il quale, sebbene consapevole del rischio di un naufragio in sì vasto e periglioso mare, comprese infine di aver scritto, attraverso queste opere, il «romanzo del divenire della scienza umana». Veniamo dunque alla genesi della goethiana «storia del colore».
I Materiali per una storia della teoria del colore, che Goethe raccolse in pluriennale fatica, costituirono poi il secondo volume della sua opera intitolata Zur Farbenlehre, apparsa nel 1810xxix. Nel 1806 ne era cominciata la composizione tipografica, che venne però interrotta dalle circostanze che accompagnarono la battaglia di Jena. Come Goethe infatti annotò nei suoi diari, nel 1806: «La stampa era arrivata fino al tredicesimo fascicolo della prima parte, e fino al quarto della seconda, allorché il 14 ottobre gli avvenimenti ci investirono con le loro tristi conseguenze e con la minaccia di cancellare il lavoro fin lì fatto»xxx. Nel 1808 era comunque terminata la composizione del primo volume, contenente la parte didattica e quella polemica, e nel 1810, finalmente, quella dell’intera opera, alla quale si era aggiunta la parte contenente il testo della Storia dei colori. È così che, in data 8.V.1810, Goethe può annotare: «Revisione dell’ultimo fascicolo»xxxi. Ma cos’è la Storia del colore di Goethe?
La Farbenlehre, nella sua Parte storica, ha un raro e insostituibile valore manualistico e documentario. Essa procede dai trattati d’arte e dalle speculazioni ottico-psicologiche, talvolta fisiche o chimiche, per toccare quindi le poetiche, le riflessioni centrate sul problema del colore quale problema compositivo in pittura, ma anche le filosofie della natura, le visioni globali del rapporto Arte e Natura, Arte e Scienza, Uomo e Natura, ecc. È questo lo sfondo sul quale i fenomeni che Goethe discuteva nella Parte didattica, anzitutto le diverse questioni di psicologia del colore, ma anche le diverse questioni relative al numero e al nome dei colori, agli orizzonti fisiologici, fisici e chimici della loro evenienza, agli usi pittorici e simbolici del colore, al colorito, alla loro possibilità di classificazione e distribuzione nello spazio o sulla superficie, vengono ora rivisitati attraverso e nella forma di un’evoluzione delle dottrinexxxii.
Da Goethe a Mann il passo non è breve, né tantomeno lineare; eppure vale la pena soffermarvi un poco la nostra attenzione, soprattutto per l’alto valore simbolico che il rapporto Goethe-Mann ha assunto dal dopoguerra ad oggi, nella cultura tedesca, ma anche nella più vasta compagine europea. Goethe non è stato il padre spirituale di Thomas Mann. Gli è divenuto più tardi, nel corso della vita, esempio, guida, conforto, compagno e maestro, attraverso una lunga e meditata amicizia virile. Ci si può chiedere del resto se Thomas, orfano di padre dalla prima adolescenza, estremamente solo con se stesso allo sbocciare della precocissima genialità – prima cioè di conquistarsi con una propria e già sicura affermazione letteraria nel lungo e fecondo soggiorno romano la sodalitas del fratello maggiore Heinrich – abbia mai cercato con candido bisogno di dedizione e di obbedienza l’autorità e la guida di un qualunque “padre spirituale”. Thomas Mann ha sùbito e sempre sentito meglio la satira che l’entusiasmo, la parodia che la prona imitazione. Certo da studente avrà letto e respirato Goethe, in quanto Goethe era e rimane pur sempre componente essenziale di ogni atmosfera culturale tedesca, però ad altri idoli si volsero i suoi primi e sempre dominati fervori. Sintomo indiretto e caratteristico: nella novella di debutto, Gefallen (Perduta)xxxiii, scritta a diciotto anni e mai accolta fra le “Opere”, parecchi narratori francesi e tedeschi gli possono essere stati prossimi o remoti modelli, e Heinexxxiv fu l’ispiratore evidente dell’intermezzo lirico in quel racconto, ma di Goethe ivi ricorre, unico richiamo, il cinico ghigno di Mefistofele, con relativo gesto osceno. Goethe è assente in sostanza da tutta la produzione narrativa giovanile, anche se molto più tardi, quando la grande alleanza spirituale sarà in atto, l’acribìa dei critici potrà vedere in Tonio Krögerxxxv il Werther thomasmanniano. Soltanto con la complessa crisi della prima guerra mondiale e del penoso dopoguerra tedesco, soltanto nel decennio che va dai Pensieri di guerra (1914) alla Montagna incantata (1925)xxxvi, il non più interrompibile colloquio inizia e si attua. È ben vero che Thomas Mann medesimo ha ceduto una volta, per rara eccezione, al dolce inganno di pseudoricordi, parlando nel 1932 (all’inaugurazione del Museo Goethe di Francoforte, in pagine poi pubblicate in un Calendario Goethiano, ma da lui non riprese nelle “Opere”) di un suo «amore sin dalla prima giovinezza», di una «super-esaltazione della simpatia», di una «immagine esemplare» – Urbild e Über-Bild – sempre vagheggiata.Ma questo amore di sempre è un’autoillusione, o almeno un’aspirazione subcosciente divenuta soltanto dopo il 1930 una meta verso la quale poi ininterrottamente procede. Egli stesso del resto si è corretto quando ha dichiarato altrove «di aver preso visione soltanto in anni maturi della prosa goethiana», la sola, è chiaro, che nel profondo potesse agire su di lui narratore e saggista.
Indiziale anche, forse, la risposta data nel 1948 a una inchiesta sulla “lirica preferita”, di dove non risulta affatto che Goethe poeta sia sangue del suo sangue sin dalla giovinezza. Molto oggettivo e fedele, il celebre saggio autobiografico del 1930 ricorda l’adorazione dell’adolescente per Heine, le lunghe letture (con panini imburrati accanto!) di Schiller, ma ignora del tutto Goethe, insistendo invece quanto alla prima formazione artistica sugli influssi della “triplice costellazione”, costituita da Schopenhauer, Nietzsche e Wagner.
In quei tre astri, Schopenhauer, Nietzsche e Wagner, che furono definiti da Bernhard Blumexxxvii il «consiglio tutorio» della sua orfana solitudine, Mann aveva allora trovato i grandi motivi conduttori della propria arte: la simpatia con la morte, la dionisiaca esaltazione musicale, la trasparenza critica dell’arte. Durò quindi oltre il miracoloso sbocciare dei Buddenbrook, del debutto-capolavoro, questa Goethe-Ferne, questa lontananza da Goethe che in quel primo decennio del Novecento distanzia sostanzialmente Thomas Mann dai suoi più vicini contemporanei, anzi coetanei, di Austria e Germania: lo stacca da George, Hofmannsthal, Rilke, Hesse, Carossa e Albert Schweizer, nonché da Ernst Jünger, i quali tutti, sia pure con disparatissime forze e sotto ben differenti aspetti, già dalla loro giovinezza, di Goethe si nutrirono e si accrebbero.
Le prime novelle – che si direbbero non esitante affacciarsi di un’aurora, ma amara conclusione di un disincantato tramonto – danno a Thomas Mann la coscienza dei suoi «meriti innati»xxxviii, dei suoi doni di scrittore. Al trionfo del poema borghese di Lubecca l’autore reagisce con cauta e conscia umiltà di fronte ai valori eterni della letteratura; però dalle incomprensioni e dai malintesi di alcuni critici è spinto sin da allora a quell’esasperante autoanalisi, per autoaccusa o per autodifesa, cui non saprà mai più rinunciare e che è volta in certo modo a precedere, a prevenire e a circoscrivere ogni giudizio dei contemporanei su di lui. Lo assillano intanto – e forse ancor più vivamente perché non era del tutto completa e organica a quel tempo la sua cultura di autodidatta – alcuni problemi estetici fondamentali. Schiller gli viene ad essere molto vicino piuttosto come vittima che come vincitore, piuttosto quale teorico del già citato saggio Sulla poesia ingenua e sentimentalexxxix, cioè come esempio doloroso di un genio non intuitivo, che non quale potente drammaturgo e poeta entusiasmante. Mentre Thomas Mann tiene con se stesso e con i propri infrangibili limiti artistici tormentosi colloqui, li traspone anche letterariamente. Per la celebrazione schilleriana del 1905 scrive il racconto-monologo Ora difficilexl che può apparire oggi incrinato di vecchiaia nella sua forma iperletteraria, ma che rimane estremamente significativo nel suo sofferto accento autobiografico. È in esso che si affaccia per la prima volta l’appena iniziata chiarificazione, la intima Auseinandersetzung con Goethe. In quel racconto-soliloquio non ricorre mai il nome del «beniamino degli dèi», del fortunato rivale: Goethe è per Schiller «quell’altro», quello di Weimar, il creatore che non conosce il sanguinante cammino di uno scrittore non-ingenuo e che Schiller pur ama «con nostalgica inimicizia».
Una indistinta Hassliebe antigoethiana sembra dunque annidarsi allora anche nel cuore di Thomas Mann trentenne, considerato il più valido, ma il meno facile e meno spontaneo e inventivo fra gli scrittori celebri del momento. Quando però, nel corso di una polemica oggi dimenticatissima, vorrà difendersi dall’accusa di essere stato troppo prosaico e discreto fotografo per il mondo dei suoi padri a Lubecca, Thomas Mann (in Bilse und ich, 1906) invocherà Goethe quale illustre precedente nell’audacia di rappresentare senza troppi scrupoli ambienti e personaggi ben vivi. L’opera goethiana chiamata a raffronto, il Werther, è stata scritta a ventiquattro anni, l’età che Mann aveva ai tempi dei Buddenbrookxli. Naturalmente Mann si compiace di sottolinearlo.
Sono anni di fama meno rumorosa, ma di non scarsa fecondità, giacché comprendono Tonio Kröger, Fiorenza e Altezza Realexlii. Le letture goethiane debbono in quel periodo essersi approfondite e anche molto estese al difuori delle opere, nell’immenso campo dei carteggi e delle testimonianze dei contemporanei di Weimar, che Thomas Mann comincia ad accumulare entro la sua prodigiosa memoria, per usarne poi con stupefacente perizia.
Un motto di Goethe, lo stesso che abbiamo citato in esergo al nostro contributo, un incoraggiamento all’autoanalisi (Vergleiche dich, erkenne was du bist!)xliii accompagna per la prima volta nel 1919 un suo libro. Sono le Considerazioni di un impolitico, su cui ci siamo già tanto arrovellatixliv, la «creatura dolorosa» di dolorosi anni, la cui materia e le cui finalità sono peraltro troppo politiche e contingenti perché la vena goethiana in esse non rimanga sotterranea e pressoché involontaria. Intorno a quello stesso anno usciva a Monaco (tradotto dall’unico testo inglese allora in circolazione) il prezioso libretto dei ricordi di Gorkij su Tolstoj (il «libro migliore di Gorkij», lo chiama Thomas Mann) ed è questa forse la scintilla che lo spinge a scrivere Goethe und Tolstoj (poi raccolto in Adel des Geistes), il primo saggio che ci testimoni il deciso assalto di Thomas Mann alla poliedrica personalità poetica di Wolfgang Goethe. Questo lavoro fu segnalato subito in Italia dalla vedetta della «Ronda», ma tradotto per intero solo trent’anni dopo nel volume Nobiltà dello spirito (Adel des Geistes, il titolo che Mann diede alla sua più ampia raccolta di saggi critici). È, più che un dialogo, una complessa conversazione a più voci. È un arpeggiare vagamente disordinato, e anche un abile punctum contra punctum, un insistere di variazioni su temi fissi che troviamo più tardi ordinati e messi in valore nei saggi successivi. Accanto alle figure dominanti del colosso russo e del sapiente di Weimar sono in scena Dostoevskijxlv e Schillerxlvi in una dialettica discussione su arte ingenua e sentimentale, su spirito e poesia. Quel lungo studio, un vero piccolo libro, rappresenta la conquista da parte di Thomas Mann della complessa personalità di Goethe attraverso testi relativamente rari e al difuori dei logori schemi ufficiali. Nell’insieme l’ininterrotto sovrapporsi di due, anzi di quattro grandi immagini, con vivo gioco di affinità e contrasti, fa pensare alla suggestione dei più avanzati ‘trucchi cinematografici’ e lascia a lettura finita un senso di gradevole confuso smarrimento. Quel saggio accoglieva anche per ragioni esteriori note che non gli sono pertinenti. Non va dimenticato che Goethe e Tolstoj nacque nel tempo cruciale della “conversione” politica di Thomas Mann, e di essa serba traccia, per esempio dove, poco prima della marcia su Roma, si proclama «il fascismo italiano perfetto parallelo del bolscevismo russo», o dove si lancia l’anatema contro la «rabbiosa idolatria dei singoli popoli», quale «simbolo del decadimento dell’Europa come un tutto unitario». Insomma: Goethe, Schiller, Tolstoj e Dostoevskij sono ancora più che altro un incentivo e un fomento alle geometriche capacità combinatorie della ‘immaginazione esatta’ di Mann; Goethe è ancora massa fluida e fluente nello spirito di Thomas Mann, il quale però, dopo questo primo approccio, non desisterà mai più dal proseguirne la conquista. Thomas Mann ha parlato di questa a lui familiare «metamorfosi dello spirito»xlvii, la quale ha al suo inizio la simpatia per la morte e alla sua meta la risoluzione di servire invece la vita. È nel lungo viaggio intrapreso dopo il mezzo del cammino di sua vita che Mann ha trovato in Goethe il suo Virgilio.
Il colloquio definitivo si avvia dunque quando Thomas Mann è in piena maturità e solidità di vita, temprato dalle esperienze e dagli errori delle Guerre Mondiali, oltre che dalle «fatiche erculee» delle tre successive e quasi consecutive stesure dei romanzi I Buddenbrook, Altezza Reale e La montagna incantata. Tra questi, Altezza Realexlviii è oggi il meno conosciuto, ma certamente non è il meno importante per l’evoluzione spirituale di Mann e per il suo asintotico accostarsi a Goethe all’infinito. Sempre più, lo stile di Mann si fa classico e decantato; e sempre più il suo atteggiamento spirituale nei confronti della cultura tedesca prende le movenze olimpiche di Goethe.
«A quanto pare, finirò per diventare l’uomo dei tre romanzi» constata presago Thomas Mann nella prefazione alla nuova versione americana di Altezza Reale del 1939, alludendo ai Buddenbrook, alla Montagna incantata e ai volumi dedicati a Giuseppexlix; e aggiunge con un sospiro: «Eccone qui un quarto, che si presenta meno ampolloso, meno epico di quelli: la storia di un principe». Una storia che per lungo tempo ha conosciuto un’«esistenza trascurata»: «Talvolta provavo un sentimento di pena per lei». Le obiezioni all’opera che Mann va rievocando sono coeve all’uscita del romanzo stesso: «Quando apparve, fu trovato troppo leggero, sia in termini assoluti che relativi: troppo leggero nel senso delle pretese che in Germania si avanzano nei confronti di un libro quanto a serietà e ponderosità, ma troppo leggero anche rispetto all’autore». Quasi nessuno, prosegue, ha riconosciuto il valore peculiare della storia del principel. Ogniqualvolta gli capitava di parlare della recezione del suo secondo romanzo, questa lamentela tornava a echeggiare, e continuerà a farlo fino agli ultimi giorni di vita dello scrittore.
Sino a oggi le certezze della critica – sia per quel che attiene ai dati di fatto sia per quel che attiene ai giudizi – stanno in singolare contrasto con la grande considerazione che proprio a questo romanzo riservava lo stesso Mann. Contrastano inoltre con la delusione durata decenni nei riguardi di una ricezione che nella sua unanimità a lui appariva come un grande (per quanto non del tutto immotivato) malinteso. Ma, si noti bene, contrastano anche con una ricezione contemporanea che – basti pensare alla vivacità dei suoi dibattiti letterari e politici, al rango e al nome dei critici e degli scrittori, scesi in campo e schierati in prima linea e soprattutto al riconoscimento tributato al romanzo da ben pochi recensori di fama – non avrebbe dato adito in realtà che a un’ulteriore delusione. Eppure Altezza Reale, anche in questo caso fin dal suo apparire, ha rappresentato in primo luogo uno dei grandi successi di pubblico nella carriera letteraria dello scrittore; nella misura in cui lo si può stimare in base alle copie vendute, fu un successo addirittura travolgente. Il secondo, attesissimo libro dell’autore che con i Buddenbrook era divenuto famoso in tutto il mondo, fu dato alle stampe nell’ottobre del 1909; due settimane dopo Thomas Mann espresse all’editore Samuel Fischer il suo entusiasmo per la seconda ristampa. «Sono emozionatissimo e compiaciuto. In quattordici giorni: tutto ciò supera di gran lunga le mie aspettative. C’è da augurarsi che prosegua così»li. Proseguì così. Prima della fine dell’anno si contarono altre nove ristampe, nel 1910 complessivamente quindici e nel 1911 altre cinque ancora. Se i Buddenbrook impiegarono dieci anni per giungere alla sessantesima ristampa, Altezza Reale a soli nove anni dalla prima edizione toccò il traguardo della sessantaquattresima (con una tiratura di 64.000 copie). Nel 1922 il romanzo era ormai alla settantasettesima ristampa – il nome di Thomas Mann risultava a tal punto legato al successo del libro che, non c’è da stupirsene, in un’intervista apparsa sul viennese «Neues 8-Uhr-Blatt» lo scrittore veniva presentato sbrigativamente (ed esclusivamente) come «l’autore di Altezza Reale»lii. Uno scosso Ernst Bertram – in seguito intimo amico e consigliere dello scrittore – ravvisava nel romanzo la «commedia tragica di una solitudine rappresentativa», l’apologo di «un potere vuoto, ormai solo rappresentativo e simbolico»liii. Dopo che sul «Vorwärts» e altri periodoci socialdemocratici era stata elogiata la spregiudicatezza politica del libro, Hermann Bahr lo celebrò come un baleno che squarcia l’oscurità e preannuncia una nuova era. E persino il giudizio riduttivo, che Thomas Mann menziona con amarezza, dell’autorevole critico Josef Hofmiller, il quale aveva «soppesato» il romanzo e l’aveva trovato «troppo leggero», si limita a relativizzare senza intaccarla la grande «ammirazione per questo romanzo che è il più geniale e spiritoso, semmai troppo spiritoso, fra tutti i romanzi apparsi di recente nel nostro paese»liv. Dapprima esitanti, le voci degli avversari di Mann finiscono per spuntarla e inizia così il graduale declino del libro, degradato a presunta triviale «operetta»lv, che studiosi e ricercatori leggono a stento e per lungo tempo non prendono sul serio.
L’ambizione con cui Thomas Mann lavorò al suo secondo romanzo, gli sforzi cui con teutonica ostinazione si assoggettò, la delusione per una ricezione in àmbito nazionale che gli parve un grande fraintendimento, la caparbietà con cui lo difese fino all’ultimo: tutto è inversamente proporzionale alla fama postuma dell’opera. Altezza Reale non è soltanto il romanzo meno conosciuto di Mann, ma è anche, salvo rare eccezioni, il più sottovalutato. Le osservazioni dell’autore a proposito di questo testo e della sua collocazione nell’àmbito complessivo della sua opera ben difficilmente possono accordarsi con l’idea diffusa a tutt’oggi che si tratti di un lavoro secondario, di uno “scherzo” frivolo. Di contro alla communis opinio invalsa già fra i critici a lui contemporanei, lo scrittore insiste nel ribadire ogni volta che questo «prodotto eccentrico», questo «libro curioso» cui è toccato sempre «il ruolo di Cenerentola» ha rappresentato, seppure soltanto a livello di presagio, un antesignano, una tappa preliminare a quanto si veniva preparando, tappa preliminare inconsapevole e tuttavia indispensabile alle grandi opere dell’epoca successiva: «Quale che fosse il peso specifico della storia del principe», è indubbio che «senza di essa non sono pensabili né La montagna incantata né Giuseppe e i suoi fratelli»lvi. Lo scrittore sessantaquattrenne che scriveva queste parole nella prefazione alla versione americana di Altezza Reale [Royal Highness] sapeva bene quale peso avesse questa sua dichiarazione e cosa gettava sul piatto della bilancia. E ancora un anno prima di morire annotava questa lapidaria asserzione: «Altezza Reale è uno degli esperimenti della mia vita»lvii.
Da allora, così parrebbe, tutto è già stato detto su di lui, e in parte anche molto bene. Nel mezzo secolo che è seguito alla sua morte nessun altro autore tedesco ha suscitato un’eco comparabile tra i suoi connazionali. La crescente e generalizzata predilezione per Thomas Mann negli ultimi decenni del ventesimo secolo, e ancor più in questi tredici anni del ventunesimo, è legata a un avvenimento che nessuno poteva prevedere, meno che mai i suoi numerosi e tanto alacri detrattori. Davanti agli occhi di tutti lui, Thomas Mann, è stato sbalzato dal suo piedistallo. E ad opera di chi?
La pubblicazione dei dieci volumi dei Diari, iniziata nel 1977, è stata portata a compimento negli anni 1986-1995. Un diario, di norma, offre una prosa monologica senza pretese artistiche, un succedersi indisciplinato, spesso incontrollato – cui l’autore si abbandona senza sforzo – di pensieri e sentimenti, osservazioni e descrizioni. Ciò che un diario consente, tuttavia, è immediatezza e soggettività. Entrabe producono spesso, com’è ovvio, l’impressione di un certo dilettantismo. Anche i Diari di Mann non possiedono in fondo alcun pregio letterario. Ma fin da subito, sia da parte dei suoi ammiratori e sostenitori, sia da parte di coloro che lo disprezzavano e biasimavanolviii, sono stati riconosciuti come dei documenti fuori del comune. I Diari consistono in massima parte di annotazioni relative alla quotidianità. Thomas Mann va a passeggio e scrive, fra parentesi, «senza panciotto», la mattina consuma a colazione «due uova ma un solo albume», registra di aver «scherzato con il barboncino». E così via. Ma ciò che affascina il lettore dei Diari discende da un’altra circostanza: è mai esistito un grande scrittore tedesco che per tutta la vita abbia profuso tante energie al fine di trasmettere, se non imporre, al mondo l’auspicata immagine della propria esistenza? Un maestro dell’autostilizzazione, un magnifico regista della propria messinscena, un principe delle lettere borghese sempre attento alle forme e alquanto sussiegoso nelle sue apparizioni in pubblico, avvezzo ad ammantarsi di dignità e ironia, uno scrittore che già negli anni Venti dominava incontrastato il mondo della letteratura europea e che più tardi venne considerato, non in via ufficiale ma incontestabilmente, l’esponente sommo dell’emigrazione tedesca e nel pieno della guerra incarnò per l’ecumene civile l’altra Germania; lui, Thomas Mann, ventura della Germania nella sventura tedesca, decise di rinunciare, e per sempre, all’immagine solenne e ricca di pathos che era andato costruendo nel corso dei decenni: di più, decise di distruggerla sistematicamente.
A essere toccata dal processo di revisione pensato per i posteri era tuttavia solo la personalità, non l’opera. In primo piano appare un’immagine di Thomas Mann affatto diversa: l’autoritratto di un nevrotico e ipocondriaco tormentato dall’insicurezza e dalla paura che, sofferente e ingenerante compassione, al mondo non vuole dare ad intendere assolutamente più nulla. Quello che l’immagine tramandata perdeva in classicità, solennità e pathos, lo guadagnava in termini di veridicità e nuda umanità. In origine il diario era un monologo senza ascoltatori, un nascondiglio in cui rifugiarsi in assenza di testimoni. E poiché le annotazioni erano riservate a lui soltanto, non vi è traccia della dizione che conosciamo nella sua epica, non vi è traccia della sua bravura né del suo virtuosismo stilistico. In tutta la sua vita Thomas Mann non ha scritto una sola lettera con la trascuratezza che caratterizza i Diari. Non aveva tempo né voglia di riesaminare neppure una frase, neppure un rigo appena di quel che vi stava scritto. Negli ultimi anni aveva deciso a un certo punto di lasciare i Diari così com’erano, senza rivederli né correggerli. Di sua iniziativa ha portato da venticinque, come aveva dapprima stabilito in via cautelativa, a venti gli anni che dovevano trascorrere dopo la sua morte prima che venissero resi noti. Una tale concessione equivaleva naturalmente a un invito perentorio: non c’è dubbio che Thomas Mann voleva che fossero dati alle stampe. Ha avuto la forza, il coraggio e la grandezza di smantellare senza remore la leggenda, che lui stesso aveva forgiato, del proprio percorso esistenziale. I posteri dovevano sapere chi era realmente Thomas Mann, dovevano comprendere, o per lo meno intuire, la sua vita caratterizzata da un costante isolamento. Amava ripetere un verso di Platen: «Mi conosca il mondo, e mi perdonerà!». Che fosse troppo egocentrico e autocompiaciuto per risultare simpatico o addirittura amabile, era cosa risaputa da sempre. Ma in quale misura lo fosse e quanto la sua famiglia, il suo entourage e lui stesso in primo luogo abbiano patito di questo, solo i diari l’hanno rivelato. Per tutta la vita egli ha tentato di difendere e giustificare la sua ambizione e la sua vanità. Già nella novella Ora difficile, omaggio a Schiller di cui ci siamo occupatilix, aveva scritto: «Egoista è tutto quel che è fuori del comune, in quanto soffre». Il mondo vedeva l’egotismo di Mann ma, comprensibilmente, non si curava delle sue sofferenze. Il suo fortissimo, palese e peraltro mai dissimulato bisogno di rappresentanza, e la sua, come è detto nella novella summenzionata, «gelosia che nessuno diventasse più grande di lui» facevano di Thomas Mann, per chi l’ha conosciuto di persona, un essere insopportabile. L’atteggiamento di riprovazione che tanto spesso suscitava negli altri si riverberava – non si stenta a crederlo – anche nei giudizi sulla sua opera.
Dopo la pubblicazione dei Diari e di numerosi altri documenti noi leggiamo i romanzi e i racconti di Thomas Mann in modo diverso da prima. Certo, la sua epica non è stata per nulla fraintesa quando lo scrittore era in vita. È stato lui personalmente a premurarsi che non lo fosse. Il fatto che dalla fanciullezza fino alla vecchiaia egli sia stato dominato dall’eros e che i motivi tematici sessuali svolgano un ruolo chiave nella sua opera, è qualcosa che i suoi contemporanei non avevano misconosciuto, anche se, certamente, l’avevano sottovalutato. Parecchi degli scrittori che avevano proclamato – con la voce tremante per l’ira – che nessuno era loro più indifferente dell’autore della Montagna incantata, si mostrarono colpiti e quasi sopraffatti dai Diari. Nel 1985 Peter Rühmkorf parlò, non solo a suo nome, della «rivalutazione dell’arte di un prosatore finora colpevolmente trascurato».
I Diari hanno fatto conoscere anche il carattere esemplare della famiglia Mann. Ma non è stato un libro, bensì il film di Heinrich Breloerlx a far capire a un pubblico di milioni di spettatori che la storia di questa famiglia è un vero e proprio dramma didascalico per i tedeschi. La conseguenza di tutto ciò è che molti lettori hanno preso in mano per la prima volta, o sono tornati a farlo, i romanzi e i racconti di Thomas Mann, in Germania e in tutto il mondo.
Paolo Melandri
i F.M. Dostoevskij, Pridirka k slučaju, in Dnevnik pisatelja (agosto 1880). Cfr. anche la traduzione italiana, Un cavallo per l’occasione. Quattro lezioni si temi diversi a proposito di una lezione datami dal signor Gradovskij. Con una allocuzione al signor Gradovskij, in Diario di uno scrittore, a cura di Ettore Lo Gatto, Firenze, Sansoni, 1963, nuova ediz. 1981, p. 1292.
ii Così Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin, Fischer Verlag, 1918, trad. it. Considerazioni di un impolitico, Milano, Adelphi, 1997, p. 73.
iii Ibidem.
iv Davvero grande è la portata che il sostantivo Geist (“spirito”) e l’aggettivo geistlich (“spirituale”) hanno nella letteratura e nella cultura tedesche, spesso privi di qualsivoglia connotazione prettamente religiosa. Nelle altre lingue europee, invece, di solito la connotazione religiosa (o para-religiosa) è predominante. Ci preme sottolineare questa differenza, per mettere maggiormente in luce l’eccellenza e la modernità della cultura tedesca nell’àmbito delle culture europee. Da noi, filosofi quali Benedetto Croce e antroposofi quali Lamberto Caffarelli hanno spesso usato l’aggettivo “spirituale” nel senso tedesco del termine.
v Uso il sostantivo nel significato che ad esso attribuiva Giuseppe Verdi, per designare l’‘atmosfera’ complessiva di un melodramma, o quella di una singola scena.
vi Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 74.
vii Ibidem.
viii F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (1886), viii, 241, in Werke in drei Bänden, a cura di Karl Schlechta, München, Hauser, 1954-1956, edizione integrata nel 1965 da un volume di indici, vol. II, p. 707.
ix Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 75.
x F.M. Dostoevskij, Germanskij mirovoj vopros. Germanija – strana protestujuščaja, in Dnevnik pisatelja (maggio-giugno 1877). Cfr. anche la traduzione italiana, Il problema mondiale germanico. La Germania paese che protesta, in Diario di uno scrittore, cit., p. 937. Di questo passo dostoevskiano mi sono già occupato nel mio contributo Steiner e Kandinsky nella produzione di Lamberto Caffarelli. Una storia locale ed europea, «Studi e ricerche del Liceo Torricelli», vol. XI, Faenza, 2013.
xi P. Rühmdorf, Gestelzte Manierlichkeiten, in Was halten Sie von Thomas Mann? Achtzehn Autoren Antworten, Frankfurt a.M., Hrsg. von M. Reich-Ranicki, 1994, pp. 69-70.
xii Si veda almeno M. Walser, Ironie als höchstes Lebensmittel oder: Lebensmittel der Höchsten, in Thomas Mann. Sonderband aus der Reihe Text+Kritik, Frankfurt a.M., S. Fischer, 1976, pp. 5-26.
xiii Si vedano le parole-macigni che Mann riserva ai Welsche, e in particolare a Mazzini e a D’Annunzio, nelle Considerazioni di un impoltico, cit., pp. 397-398 (Mazzini) e pp. 573-574 (D’Annunzio). Il veleno di tali vere e proprie ingiurie è diretto non tanto contro le pur sempre discutibili qualità culturali e artistiche dei due scrittori, quanto piuttosto contro il loro essere «italiani», che per Mann è tutt’uno con l’essere «ciarlatani», «bajazzi» e simili, con, in sovrappiù, la squisitezza dovita al fatto che l’Autore inserisce le parole in italiano nel testo. Del resto, lo stesso personaggio di Settembrini nella Montagna incantata non è immune da tali connotazioni. Un vezzo davvero tutto «tedesco», presente ad esempio anche nelle Lettere di Mozart e in molti scritti dello stesso Lutero (die Walen), che palesa con corriva faciloneria un evidente pregiudizio etnico. La parola disprezzo, in tali scritti, compare puntualmente riferita agli italiani. Al contrario noi (e con «noi» intendo in primo luogo me stesso), pur consapevoli di così biasimevoli atteggiamenti, riteniamo sinceramente eccellente e centrale la cultura allemande nel contesto europeo.
xiv Ad esempio il dannunziano Sperelli diventa Spinell nel racconto Tristano e lo stesso, detestato Gabriele D’Annunzio diventa un ben più nobile Gustav Von Aschenbach nella Morte a Venezia, che, a sua volta, come è emerso recentemente da serrate analisi, è una meditata ri-scrittura del Fuoco dannunziano. Lusinghiera allusività? Ma allora perché quell’ambiguità, quel ribrezzo nei confronti dell’Italia, presenti in racconti come Il pagliaccio e Mario e il mago (in quest’ultimo, l’aristocratico disgusto non va solo alla «malattia» del ventennio fascista, il che sarebbe moralmente impeccabile e anzi tollerante e financo eccessivamente mite nei toni, ma anche al «volgarissimo», «osceno» timbro delle popolane italiane, così palesandosi come disgusto epidermico e pregiudiziale).
xv Th. Mann, Mario e il mago, in Id., Racconti, trad. it. di Lavinia Mazzucchetti, Milano, Mondadori, 1983.
xvi P. Rühmdorf, Die neugewonnene Wertschätzung des Prosaartisten, in Was halten Sie von Thomas Mann?, cit., pp. 134-135.
xvii L’espressione è tolta, sebbene in affatto diverso senso, da G. Leopardi, Il pensiero dominante, xxvi dei Canti, Milano, Mondadori, 1987, pp. 177-183, di cui vogliamo qui rammentare il celebre, sublime incipit: «Dolcissimo, possente / dominator di mia profonda mente; / terribile, ma caro / dono del ciel; consorte / ai lúgubri miei giorni, / pensier che innanzi a me sì spesso torni».
xviii H. Wysling, «Geist und Kunst». Thomas Manns Notizen zu einem «Litteratur-Essay», in P. Scherrer-H. Wysling, Quellenkritische Studien zum Werk Thomas Manns, Bern-München, 1967, pp. 123-233. Cfr. anche la traduzione italiana, Spirito e arte, a cura di Maurizio Pirro, Bari, Palomar, 1997. Notiamo qui solo di sfuggita come il titolo manniano Spirito e arte somigli a quello di Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, Milano, SE, 1989 e a quello Lamberto Caffarelli, L’arte nel mondo spirituale, Faenza, Montanari, 1925. Né le somiglianze, imputabili in gran parte al medesimo contesto culturale, si limitano ai soli titoli, anche se un influsso diretto di Kandinsky su Thomas Mann non è documentabile. È certo, invece, e documentato, che Lamberto Caffarelli conoscesse benissimo l’opera di Kandinsky e che avesse Thomas Mann tra le sue letture préferées.
xix La lettera a Eduard Korrodi pubblicata sulla «Neue Zürcher Zeitung» del 3 febbraio 1936 contiene la definitiva presa di posizione di Thomas Mann sulla situazione della Germania Nazista. Vedi la traduzione italiana in Th. Mann, Lettere, a cura di I.A. Chiusano, Milano, 1986, pp. 301-307.
xx Con il titolo Deutsche Hörer! sono raccolti i discorsi radiofonici tenuti da Thomas Mann per la BBC a partire dall’ottobre 1940. In essi Mann esorta continuamente i tedeschi a prendere le distanze dal regime hitleriano e a lottare per il successo della democrazia.
xxi Nel saggio, scritto nell’aprile del 1938, Thomas Mann nega che si possa parlare di due Germanie radicalmente distinte, una buona, l’altra perversa. Con Hitler sarebbero al potere, al contrario, elementi da sempre presenti nel disegno generale dell’anima tedesca, non ricomposti in senso umanistico. V. Th. Mann, Fratello Hitler e altri scritti sulla questione ebraica, Milano, Mondadori, 2005, pp. 93-104.
xxii Lettera del 6.4.1925, in W. Benjamin, Lettere 1913-1940, trad. it. di A. Marietti e G. Backhaus, Torino, 1978, pp. 114-115.
xxiii F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Milano, SE, 1986.
xxiv Th. Mann, Morte a Venezia, trad. it. di Anita Rho, Torino, Einaudi, 1990.
xxv Come ha dimostrato H. Wysling, tutte le opere attribuite ad Aschenbach corrispondono a lavori di Mann progettati, ma mai portati a compimento (cfr. H. Wysling, Aschenbachs Werke. Archivalische Untersuchungen an einem Thomas-Manns-Satz, in «Euphorion», 59, 1965, pp. 272-314).
xxvi Th. Mann, La morte a Venezia, trad. it. di E. Filippini, Milano, 1991, p. 10.
xxvii F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, cit., p. 11.
xxviii Ibidem.
xxix Nel 1979 è apparsa la traduzione italiana della «Parte didattica» della Farbenlehre con il seguente titolo: Jh.W.v. Goethe, La teoria dei colori, a cura di R. Tronconi e con un’introduzione di C.G. Argan, Milano, Il Saggiatore, 1979.
xxx Jh.W.v. Goethe, Tag und Jahreshelfte, 1830, in Id., Poetische Werke, Berlin 1981, vol. IV, p. 180.
xxxi La Farbenlehre di Goethe si articola in due volumi e in tre parti.
xxxii Cfr. D. Kuhn, Goethes Geschichte der Farbenlehre als Werk und Form, in «Deutsche Viertelsjahrschrift», 34, 1960, pp. 369-387. «La Farbenlehre di Goethe è l’unico tentativo di rilevanti dimensioni fino ad oggi intrapreso, e in buona parte riuscito, di dar luogo a una Geistesgeschichte della teoria della Natura e della scienza su di essa fondata. Il suo concentrarsi sui colori le dona profilo e forza a un tempo: la quantità di materiale viene produttivamente circoscritta, il nesso all’occhio quale il senso più nobile mai lascia dimenticare l’uomo il quale, come sempre accade in Goethe, anche qui emerge dalla storia. In questo modo la parte è più generosa che il tutto». Così ebbero ad osservare più di cinquant’anni fa gli stessi curatori dell’edizione delle opere scientifiche di Goethe. Cfr. Jh.W.v. Goethe, Zur Farbenlehre. Historischer Teil, Ergänzungen und Erläuterungen, a cura di D. Kuhn e K.L. Wolf, in Id., Die Schriften zur Naturwissenschaft, Weimar, 1959, vol. 6 (II), p. IX.
xxxiii Th. Mann, Perduta, in Id., Padrone e cane e altri racconti, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 88-93.
xxxiv Cui pure è dedicato il primo saggio critico di Mann, Heinrich Heine il Buono, in Th. Mann, Fratello Hitler e altri scritti sulla questione ebraica, cit., pp. 3-7.
xxxv Th. Mann, Tonio Kröger, trad. it. a cura di Anna Rosa Azzone Zweifel, Milano, Rizzoli, 2009.
xxxvi Th. Mann, La montagna incantata, traduzione e introduzione di Ervino Pocar, Milano, Corbaccio, 2011.
xxxvii Bernhard Blume, Thomas Manns Goethe-Bild, in «Publications of the Modern Language Association of America», 1944; poi in volume, Bern, Franke, 1949.
xxxviii Secondo la celebre – e sconvolgente – affermazione goethiana, olimpica intuizione sulla “genetica del genio”.
xxxix F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Milano, SE, 1986. Vide supra.
xl Th. Mann, Ora difficile, in Id., Racconti, a cura di Italo Alighiero Chiusano, Milano, Bompiani, 1986, pp. 431-442.
xli Th. Mann, I Buddenbrook, trad. it. di Anna Rho, Torino, Einaudi, 1992.
xlii Th. Mann, Altezza reale, in Id., Romanzi, vol. I, trad. it. di Margherita Carbonaro, Milano, Mondadori, 2007, pp. 889-1258.
xliii Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 29.
xliv In apertura del nostro contributo. Vd. supra.
xlv Che abbiamo richiamato in apertura del presente contributo. Vd. supra.
xlvi Vd. supra l’‘idolo critico’ di Thomas Mann, Sulla poesia ingenua e sentimentale di Schiller, op. cit.
xlvii Che richiama la goethiana idea della «metamorfosi delle piante» e della loro comune derivazione dall’Urpflanze.
xlviii Th. Mann, Altezza Reale, op. cit.
xlix Th. Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, IV voll., trad. it. di Bruno Arzeni, Milano, Mondadori, 2006.
l Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, a cura di Peter de Mendelssohn, 20 voll., Frankfurt a.M., 1980-86, XI, pp. 572-577.
li Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, cit., XIV, 2, p. 157.
lii Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann 1909-1955, a cura di Volkmar Hansen e Gert Heine, Hamburg, Knaus, 1983, p. 49. Cfr. l’Introduzione di H. Detering ad Altezza Reale, ed. cit., p. 842.
liii Ernst Bertram, Thomas Mann. Zum Roman «Königlische Hoheit», «Mitteilungen der Literaturhistorischen Gesellschaft Bonn» IV, 8 (1909), pp. 195-217; si veda anche Th. Mann, Gesammelte Werke – Frankfurter Ausgabe, cit., IV, 2, pp. 174-178.
liv Josef Hofmiller, Thomas Mann, «Süddeutsche Monatshefte» VII (1910), pp. 137-149. Cfr. l’Introduzione di H. Detering ad Altezza Reale, cit., p. 882.
lv Così Walter Killy in un articolo dedicato a Thomas Mann, che si può leggere nel Deutsches Literatur-Lexicon, vol. VII, Gütersloh-München, Berthelsmann, 1990, p. 449.
lvi Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, cit., XI, p. 574.
lvii Th. Mann, ibidem, XI, p. 579.
lviii Cfr. P. Rühmkorf, Gestelzte Manierlichkeiten, cit., e Id., Die neugewonnene Wertschätzung des Prosaartisten, cit., articoli da noi discussi supra e richiamati alle note 11 e 16.
lix Th. Mann, Ora difficile, op. cit.
lx Die Manns. Ein Jahrhundertroman. Film del 2001 con Armin Müller-Stahl, Sebastian Koch, Veronica Ferres, regia di Heinrich Breloer.
*
- Filosofia
La mano
La mano
In maniera ben diversa si formerebbero le nostre parole, i nostri concetti e i nostri pensieri se il nostro corpo, invece di essere tagliato secondo una simmetria bilaterale, avesse cinque punte come la stella marina o sei petali come il giglio. Con un cervello articolato in modo conforme e con organi di struttura corrispondente, accoglieremmo in noi il mondo con un numero assai maggiore di percezioni e saremmo in grado di rispecchiarlo con più sottile fedeltà.
Come perderebbero valore le parole, se così fosse! Lungo le cinque direzioni della nostra conoscenza sensibile, diverrebbero insufficienti, ottuse, piatte. Ma come strani specchi possono raddrizzare oggetti in posizione sghemba, così fra tutte le nostre parole riacquisterebbe e rafforzerebbe il proprio significato una vecchia espressione, d'ogni mano: oggi diremmo d'ogni sorta. Mano è parola d'uso antico per significare “lato”, e poi fu anche usata per indicare i diversi generi o le diverse specie e categorie delle cose. Secondo natura, la scelta è sempre fra tra due. Così il compratore osserva la merce i cui diversi articoli sono esposti dinanzi a lui a man dritta e a mano manca. La locuzione d'ogni mano o d'ogni sorta, di significato collettivo, indica una quantità di cose e di forme indeterminate sulla cui genericità il linguaggio affila le proprie armi traendo da esse una parte della sua forza.
Del resto, anche la preposizione tra, che abbiamo appena citato, è spesso usata in maniera imprecisa e illogica, in luogo di fra. In senso proprio, ci si può trovare tra due oggetti, non tra più oggetti. Usiamo maggiore attenzione con i sostantivi intervallo (latino inter = tra) e distanza, i quali implicano sempre due limiti estremi. Ma cadiamo in un'altra imprecisione quando parliamo di intervallo tra diversi punti: il linguaggio della geometria esige chiarezza, e useremo più esattamente la parola distanza.
Certo, se volessimo misurare il linguaggio al centimetro, con il regolo calcolatore degli ingegneri e dei geometri, e se intendessimo usare il rigore e l'esattezza di cui abbiamo dato mostra poco fa, non riusciremmo a formare neppure una frase. La logica non è la dominatrice del linguaggio; gli è subordinata. Essa tiene insieme le parole come il cane da pastore tiene unito il gregge: non con rigore matematico, ma secondo la necessità richiesta dalla situazione. Il parlante è più o meno vigile nell'uso delle parole, a seconda del compito che gli è affidato. Così, in una semplice conversazione o in una lettera, descrivendo un viaggio o scrivendo una poesia, egli può benissimo parlare di distanza per indicare qualcosa che separa due punti qualsiasi: per esempio, una valle posta tra due cime montane. Il medesimo parlante sarà molto più rigoroso se userà la parola distanza nella sua professione di geometra, o di stratega, o di architetto.
Lasciamo dunque fluire la logica secondo l'impulso delle necessità; altrimenti, potremmo essere ascritti alla setta dei pedanti e degli iperscrupolosi, e facciamo bene a evitarlo. Ognuno conosce le sgradevolissime controversie in cui finiamo implicati quando ci imbattiamo in un interlocutore avversario che non ci lascia passare una sola delle nostre parole senza aver qualcosa su cui ridire. L'artificio prediletto da simili querulomani è il loro aggrapparsi alle parole non in vista del loro significato, ma secondo i meccanismi logici. In tal modo, essi raccolgono una messe inesauribile di possibili contestazioni, e sbattono sotto gli occhi dell'interlocutore le imprecisioni che in quanto tali si nascondono nel linguaggio. Ci si accorge che stratagemmi di tal sorta vengono usati per lo più da persone di per sé alquanto deboli nell'esercizio della logica; eppure, servono loro come puntelli di argomentazioni pericolanti. Sono giochi e trabocchetti che invece possiamo apprezzare in pazzi di alto lignaggio, in personaggi come Till Eulenspiegel; costoro, infatti, non se ne servono a proprio vantaggio, ma soltanto per dare evidenza alla sproporzione tra parole e cose.
E ritorniamo al punto di partenza, all'espressione d'ogni mano o d'ogni sorta. Ancora più vistosa del difetto logico di simile locuzione è la mancanza di autetica simmetria. Eppure la mano, fra tutti i nostri organi, è assunta a simbolo della simmetria. L'orientamento verso destra o verso sinistra è collegato senz'altro alle funzioni della mano, benché il piede, l'occhio, gli organi sessuali siano non meno simmetrici. Forse il rapporto di queste parti del corpo con l'immagine riflessa nello specchio è addirittura più profondo, per quanto più nascosto. Più che dalle mani, quel rapporto è realizzato dagli occhi: mentre essi, appaiati, si dividono in parti uguali la sensazione visiva, quest'ultima assume contemporaneamente un rilievo stereoscopico. La relazione con la specularità è accentuata in pari misura nella sessualità, per quel tanto che essa possiede di simmetrico. Ciò è spiegato con grande bellezza nel Simposio di Platone, che fa risalire l'origine dei sessi a un essere di massima compiutezza e unità, il quale è stato tagliato in due parti. Dopo tale separazione, le due metà divenute uomo e donna si cercano, nell'intento di riunificarsi. Per rimanere nel paragone con l'occhio, possiamo concepire l'amplesso amoroso come un atto stereoscopico – come fusione in unità secondo una dimensione superiore. Ciò che nell'ambito di quel paragone è il fenomeno della corporeità che si rende visibile grazie all'azione regolatrice della simmetria, nell'atto sessuale è il cancellarsi dell'esistenza individuale che entra nel dominio della creazione e dell'origine. La sospinge l'anelito alla felicità del Primo Giorno.
© Paolo Melandri (20. 1. 2019)
*
- Storia/Mitologia
Filemone e Bauci
Essere sacerdoti, aver cura in qualità di custodi della vostra sacra dimora,
è il nostro desiderio, e come abbiamo vissuto i nostri anni in armonia,
così ci sorprenda la stessa ora, affinché mai io veda l'urna
della mia consorte, né lei debba seppellirmi sulla collina…
Questo è il desiderio che Filemone esprime rivolgendosi alla divinità dopo essersi consultato con Bauci.
«Cum Baucide pauca locutus.» Ovidio intende dire che non ci fu bisogno di molte parole per prendere una decisione: egli presuppone l'accordo tra gli sposi. E ha ragione, perché il lungo e felice amore dell'anziana coppia ha fatto maturare le stesse inclinazioni, e la prospettiva di essere un giorno divisi l'uno dall'altra è ormai più dolorosa del pensiero stesso della morte.
Allora gli dèi entrarono nella capanna dal tetto di paglia dei mortali: Giove, il Saturnide, accompagnato da Mercurio, l'Atlantide. Erano dèi, certo non immortali come crediamo oggi, però dotati di un grande potere sul tempo e sulle sue trasformazioni. Erano in grado di conferire alla fugace apparizione una più lunga durata, o di concentrarne la temporalità, così da farle guadagnare la gloria dell'origine.
Lelege, cui Ovidio fa raccontare della visita degli dèi e dell'ospitalità con cui furono accolti, informa perciò il dubbioso Piritoo:
È immensamente grande e non conosce confini la potenza del cielo,
tutto ciò che gli dèi vogliono
è già fatto compiuto.
2.
L'età e l'origine di questa mitica ospitalità non dovrebbero essere sottovalutate; già per Ovidio, e per lo stesso Esiodo, si situavano entrambe nel passato più remoto, ai confini dell'età dell'oro, là dove le datazioni sfumano nella nebbia.
Ci sarebbe perfino da chiedersi se la parola «mitico» sia impiegata a buon diritto, o se già il mito non attinga invece a materiali antichissimi. La fonte stessa di Ovidio, la leggenda sacra di un tempo frigio, vi fa cenno. Su quei regni che fiorirono prima di trasformarsi nelle satrapie persiane e poi negli stati dei diadochi ci sono pervenuti pochissimi dati, ne abbiamo però notizie più intense e commoventi di qualsiasi emanazione misurabile. Erodoto guarda indietro verso di essi come al crinale di un monte, sul cui versante occidentale brilla un mondo nuovo. Ai tempi di Ovidio erano divenuti province romane, tuttavia, in questa regione e nei suoi dintorni, il suolo era considerato particolarmente fertile per la nascita e la morte degli dèi, come per il risveglio delle civiltà e il loro tramonto. Perfino il beffardo Luciano, che viaggiò per l'Asia Minore cento anni dopo l'apostolo Paolo, non poté sottrarvisi.
© Paolo Melandri (30. 12. 2018)
*
- Mitologia
Giuda
Per due millenni il cristianesimo si è occupato del grande problema apologetico di Giuda, il più complesso fra tutti i problemi relativi alla giustificazione; perché fu necessaria la figura di Giuda e come fu possibile il suo tradimento? Secondo solo al gesto e al destino di Adamo, il caso di Giuda rappresentò per i cristiani senz'altro la più diretta incarnazione dell'eterno problema del senso del male, del rapporto tra libertà e necessità; ogni tipo di interpretazione ha trascurato la figura di Giuda. L'imperioso giudizio di Dante lo condanna al più profondo baratro dell'inferno tra le fauci stritolanti di Lucifero; il patrimonio delle leggende e dei Misteri popolari e di tradizione monacale, alterandone l'immagine con umorismo, rappresentano Giuda, al pari dell'archetipo che trapela dalla sua figura, il male stesso, in dimensioni umanamente accettabili; oppure, raffigurando il suo tradimento con soggetti farseschi, riescono ad allentare momentaneamente la tensione dello spettrale di fronte all'atmosfera opprimente della Passione. L'interpretazione di Klopstock considera l'azione di Giuda dettata dal sentimento di vendetta del segreto amore per Cristo, dalla grande gelosia disperata per il discepolo prediletto Giovanni. (Anche la vita di Gesù di Renan motiva il tradimento di Giuda con la gelosia per Giovanni). Tutte dirette all'interpretazione, all'umanizzazione e alla giustificazione del suo tradimento, sono le apologie poetiche di Giuda (tra i progetti postumi di Hebbel c'è anche un dramma dedicato a Giuda); alcune di queste opere però, credendo alla sincerità delle sue motivazioni, riducono la sua figura a dimensioni realistiche e, quasi sulla scia di quella tecnica dei Misteri, trasformano Giuda in simbolo di un quotidiano comico, trasformandolo in simbolo del più volgare fraintendimento di una presenza divina; altre, ne fanno un personaggio che da sempre è consapevole del proprio destino di traditore e attribuiscono la colpa del suo deicidio non tanto ad un Hödur che agisce con cieca inconsapevolezza e che si pente troppo tardi, quanto invece a un Loki chiaroveggente, a un demone consumato dal malvagio fuoco originario, la cui grandezza consiste nel vedere il tremendo spettacolo della sua azione e delle sue conseguenze e nel sopportarlo con la fierezza di un'infelicità opprimente ma fatale. Vi è infine la leggenda poetica nella quale Giuda nella grande opera della redenzione appare addirittura come il secondo piatto della bilancia, come seconda, più oscura vittima della nuova alleanza. Giuda si sacrifica sapendo che la scrittura deve essere adempiuta e che se egli non compie ciò che è stato prestabilito, l'opera della redenzione non potrà avverarsi e tutta la creazione sarà condannata ad essere un'azione insensata; egli si sacrifica, e prendendo su di sé la più grave maledizione del mondo si appresta a tradire colui che qualcuno deve tradire. In questa leggenda Gesù riconosce il sacrificio compiuto da Giuda per lui e per la sua opera di redenzione, sa che per un istante il destino del mondo è nelle mani di Giuda; se esse rifiuteranno di fare ciò che sta scritto, se si ritireranno impaurite dinanzi al «guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito!», non si compirà neppure il sacrificio sulla croce. Così Gesù l'ultima sera vede in Giuda l'oscuro compagno della sua via crucis; ne parla con parole che gli altri discepoli non comprendono e ringrazia il traditore con un gesto d'amore, che Giuda ricambia solo nel giardino di Getsemani. (Nel Vangelo secondo Giovanni, dove la figura di Giuda ha altrimenti tratti particolarmente odiosi, vi sono tracce di questa specifica comunanza, di un segreto accordo tra Gesù e Giuda; il boccone di pane che Gesù offre proprio a Giuda durante l'ultima cena, e accompagna con amare parole: quello che devi fare, fallo presto, appare come un simbolo del destino comune). Quando dopo il tradimento Giuda si uccide nella stessa ora in cui nel calvario si compie l'opera, non è spinto da un qualsivoglia pentimento, quanto piuttosto dal sentimento di estrema comunanza che lega i loro destini fino all'ultimo, dal sentimento di imitazione e dalla consapevolezza di una dipendenza più forte di tutti coloro che nell'istante del tradimento abbandonano e fuggono non solo il maestro ma soprattutto se stessi e la propria missione di discepoli, mentre lui, Giuda, in questo momento ha ubbidito al Signore e a se stesso. Anche la sua ultima ora avverte un oscuro «è compiuto».
Quest'ultima leggenda di Giuda, la cui lettura è stata già iperinterpretata, concentra forse il senso più segreto di tutte le interpretazioni che in venti secoli di cristianesimo hanno stilizzato la figura di Giuda. Come in così numerosi altri simboli di redenzione dei più diversi ambiti mitologici, nella figura di Giuda si compie l'antichissima scissione del redentore in natura angelica e in natura demoniaca, che solo unite possono compiere l'opera di rinnovamento e di redenzione del mondo. In ogni azione che scuote e rinnova l'umanità dio e demonio cooperano – questo il significato di tutti questi miti – e senza il reciproco aiuto non sono in grado di rinnovare le acque stagnanti. Il mito illustra semplicemente sdoppiandolo in due figure quello che riconosce e vuol far comprendere come unità; solo nell'antitesi simbolizza l'inesorabile legge in base alla quale chi crea necessariamente annienta, chi genera uccide, chi redime tradisce, che in ogni grande uomo simbolico Cristo e Giuda debbono nuovamente scambiare l'oscuro bacio.
© Paolo Melandri (19. 7. 2018)
*
- Letteratura
Sul tragico nelle odi corali antiche
L'ode tragica comincia nel fuoco più alto. Lo spirito puro, la pura interiorità ha varcato i suoi limiti e non ha mantenuto sufficientemente moderate quelle relazioni della vita – la coscienza, la riflessione, oppure la sensibilità fisica – che necessariamente, e quindi quasi già da sé, sono inclini al contatto e per quello stato di completa interiorità lo diventano eccessivamente; sicché per eccesso è sorto il dissidio che l'ode tragica finge fin dall'inizio per rappresentare ciò che è puro. Essa poi, per un atto naturale, dall'estremo della distinzione e della necessità passa all'estremo della non distinzione di ciò che è puro, del soprasensibile che non sembra riconoscere alcuna necessità, di là quindi cade in una sensibilità pura, in una interiorità più moderata, giacché l'interiorità originariamente più alta, divina, ardita, le è apparsa come un estremo, e non può più neppure cadere in quel grado di interiorità eccessiva da cui ha preso le mosse nel suo tono iniziale, giacché, per così dire, ha sperimentato ciò a cui esso portava; dagli estremi della distinzione e non distinzione essa deve passare in quella riflessività e in quel sentimento tranquilli in cui certo deve necessariamente sentire la lotta di quella strenua riflessività, e quindi il suo tono iniziale e il proprio carattere come opposizione, e passare in esso, se non vuole finire tragicamente in questa moderatezza; ma poiché essa sente tale carattere come opposizione, l'ideale che concilia queste due opposizioni risulta in modo più puro, il tono originario è ritrovato, e con riflessività, e così di qui (cioè dall'esperienza e dalla conoscenza di ciò che è eterogeneo) – mediante un moderato e più libero riflettere o sentimento –, essa ritorna più sicura, più libera e più radicale al tono iniziale.
© Paolo Melandri (4. 7. 2018)
*
- Filosofia
Filosofia della natura e natura della filosofia
Il concetto del soggettivo non è contenuto nel concetto dell'oggettivo, anzi tutti e due si escludono a vicenda. Nel concetto della natura non è incluso che esista anche un'intelligenza, la quale se la rappresenti. La natura, così sembra, esisterebbe anche se non esistesse quello che se la rappresenta. La questione pertanto si può enunciare anche così: in che modo alla natura si aggiunge il principio intelligente, o in che modo la natura perviene ad essere rappresentata?
È ammessa come primo la natura o l'oggettivo. Ora questo è indubbiamente il compito della scienza della natura, che così appunto procede. – Qui possiamo soltanto indicare brevemente come la scienza della natura effettivamente – e senza saperlo – si avvicini almeno alla soluzione di un tale compito.
Se tutto il sapere ha come due poli, che si presuppongono ed esigono a vicenda, essi devono rintracciarsi in tutte le scienze; devono perciò esserci necessariamente due scienze fondamentali, e deve tornare impossibile muovere da un polo, senza essere spinti verso l'altro. La tendenza necessaria di tutte le scienze naturali è dunque di andare dalla natura al principio intelligente. Questo e non altro vi è in fondo ad ogni tentativo diretto a introdurre una teoria nei fenomeni naturali. La scienza della natura toccherebbe il sommo della perfezione se giungesse a spiritualizzare perfettamente tutte le leggi naturali in leggi dell'intuizione e del pensiero. I fenomeni (il materiale) devono scomparire interamente, e rimanere soltanto le leggi (il formale). Accade perciò che, quanto più nel campo della natura stessa balza fuori la legge, tanto più si dissipi il velo che la avvolge, gli stessi fenomeni si rendano più spirituali, e infine cessino del tutto. I fenomeni ottici non sono altro che una geometria, le cui linee sono tracciate per mezzo della luce, e questa luce stessa è già materialità dubbia. Nei fenomeni del magnetismo scompare già ogni traccia materiale, e dei fenomeni della gravitazione, che gli stessi naturalisti credevano di poter concepire solo come un'immediata influenza spirituale, non rimane altro che la loro legge, la cui estrinsecazione in grande è il meccanismo dei movimenti celesti. Una teoria perfetta della natura sarebbe quella per cui la natura tutta si risolvesse in una intelligenza. I morti e inconsci prodotti della natura non sono se non dei conati falliti della natura per riflettere sé medesima; la cosiddetta natura morta è soprattutto un'intelligenza immatura; perciò nei suoi fenomeni già traluce, ancora allo stato inconscio, il carattere intelligente. La natura attinge il suo più alto fine, che è quello di divenire interamente oggetto di sé medesima, con l'ultima e la più alta riflessione, che non è altro se non l'uomo, o, più generalmente, ciò che chiamiamo ragione; in tal modo per la prima volta si ha un completo ritorno della natura a se stessa, e appare evidente che la natura è originariamente identica a ciò che in noi viene riconosciuto come principio intelligente e cosciente.
Questo può bastare a mostrare che la scienza naturale ha la tendenza necessaria a rendere intelligente la natura; appunto per questa tendenza, essa diviene filosofia della natura, che è una delle due necessarie scienze fondamentali della filosofia.
© Paolo Melandri (10. 6. 2018)
*
- Letteratura
Gufi e poeti [un topos tra otto e novecento]
Gufi e poeti: un tòpos fra otto- e novecento
La Favola Lxii di C. E. Gadda1 costituisce, a parere unanime della critica2, una condanna del romanticismo di consumo: «Il gufo dimorava le rovine: e ivi attendeva il poeta, che a suspirar vi andasse. Discesa la notte, udì sospirare lungamente. Verso l’alba, che si moriva dal sonno, scorse il poeta allontanarsi. Con la ragazza».
Presso i classici latini – costante polo di riferimento del Gadda favolista – il gufo non è mai accostato al poeta, con cui non ha nulla a che fare; il gufo non canta, ma emette un lugubre gemito: cfr. Plin. nat. hist. X 34: nec cantu aliquo uocalis, sed gemitu; Calp. ecl. 6, 8: uocalem superet si dirus aedona bubo; Enn. ann. 15 V.2 (=11 Sk. [=7 Valm. =13 Tr.]): memini me fiere pauom: in Ennio l’anima di Omero, il poeta per eccellenza, è trasmigrata in un pavone; in Hor. carm. II 20 è il cigno ad essere allegoria del poeta.
Il gufo è notoriamente, per la tradizione classica, una creatura funesta, un noctis monstrum: cfr., ad es., Verg., Aen. IV 462-463: ferali carmine bubo / saepe queri et longas in fletum ducere uoces, punto di partenza di una serie infinita di riecheggiamenti; Ouid. met.V 550: ignauus bubo, dirum mortalibus omen; Stat. Theb. III 467: nocturnaeque gemunt striges et feralia bubo / damna canens3; è un animale sinistro anche perché abita luoghi solitari: cfr. ancora Plin. nat. hist. X 34: deserta incolit nec tantum desolata, sed dira etiam et inaccessa.
Un legame tra il gufo e il poeta è invece dichiarato – cosa, a quanto ci risulta, unica nella letteratura italiana4 – da G. Carducci in Maggiolata (da Rime nuove, III 50). Rileggiamo insieme la lirica, elaborata secondo il ben noto schema oppositivo, mondo esterno vs. interiorità del poeta, attestato, tra l’altro, in modo particolarmente icastico, dal celeberrimo son. CCCX (‘Zephiro torna…’) di Petrarca:
Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l’usignol.
Schiamazzano i fanciulli
in terra, e in ciel li augelli:
le donne han ne i capelli
rose, ne gli occhi il sol.
Tra colli prati e monti
di fior tutto è una trama:
canta germoglia ed ama
l’acqua la terra il ciel.
E a me germoglia in cuore
di spine un bel boschetto;
tre vipere ho nel petto
e un gufo entro il cervel.
Questa poesia, che ben rappresenta il tono lirico della raccolta Rime nuove – permeata di malinconia e di rimpianto e ricca di accenti pre-pascoliani –, è caratterizzata da una disposizione elegiaca che dal modello petrarchesco trae vibrazioni sentimentalmente intenerite, e in essa – come nei migliori sonetti del Ça ira, collana appartenente allo stesso libro – il poeta si abbandona con trasporto alla contemplazione della natura.
Entro questo contesto, il ‘gufo’ fulmineamente evocato nell’ultimo verso simboleggia uno stato d’animo di malinconia cupa e triste, vera musa ispiratrice dell’ultimo dei nostri grandi ‘bardi’ ottocenteschi5.
Un legame di altro tipo fra il gufo e il poeta è in Posthumous Letter to Gilbert White di W. H. Auden:
nothing
the pitches owls hoot on, comparing
the echo-response of dactyls and spondees
(vv. 18-20).
In Dialogo su poesie Hugo von Hofmannsthal così commenta la celebre ode goethiana della falena presso la candela (da West-östlicher Divan): «Senti questo accento, che sembra il canto di un fatato uccello notturno presso la stanza di un morente? Si dice che l’abbia composta nella notte in cui morì Christiane Vulpius. La vera avventura dell’anima, quali parole potrebbero esprimerla se non incantate?»6.
In Gadda, il gufo attende il malinconico poeta (topico), questi però è degradato al rango di amans ephebus e il suo sospiro non è poesia, ma – come il lettore attento s’avvede – espressione del piacere carnale raggiunto, come spiega la finale battuta a sorpresa «con la ragazza». Una connessione tra il gufo e la relazione sessuale si trova anche negli Oneirokritiká di Apollodoro (IV 56) in cui il gufo, in quanto uccello notturno, è simbolo dell’adultero. Non escludiamo una beffarda allusione di Gadda, lettore attentissimo di testi anche peregrini, a questo testo ‘prefreudiano’, dotato, a tratti, di un’inquietante modernità.
Ma il precedente più immediato e forse più rilevante del bestiario favolistico di Gadda è una raccolta poetica, intitolata Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, opera di Guillaume Apollinaire, composta nel 1908 – in séguito, pare, a una conversazione con Picasso, e pubblicata solo nel 1911, una raccolta poetica, se si vuole, ‘minore’ rispetto al resto dell’opera dell’autore, conformemente al destino del genere favolistico, di solito – come la satira – considerato marginale, in quanto interlocutorio e colloquiale (e talvolta provocatorio), rispetto alla letteratura ‘alta’. In questo singolarissimo Bestiaire la base antiquaria, la scrupolosa erudizione (che si rivela nei frequenti riecheggiamenti dei bestiari medievali) e l’influsso del simbolismo si coniugano con le forme nuove dell’Art Nouveau e del cubismo, rasentando talvolta il nonsense; anche qui – come in Gadda – il modello freudiano non è mai richiamato esplicitamente: domina invece la memoria di Orfeo e dei culti misterici connessi con la figura del cantore tracio, come appare fin dal carme incipitario:
Admirez le pouvoir insigne
et la noblesse de la ligne:
elle est la voix que la lumière fit entendre
et dont parle Hermès Trismégiste en son Pimandre7.
Nel Bestiaire di Apollinaire il gufo è – come in Carducci – una metafora per il cuore del poeta:
Mon pauvre coeur est un hibou
qu’on cloue, qu’on décloue, qu’on recloue.
De sang, d’ardeur, il est à bout.
Tous ceux qui m’aiment, je les loue8.
Si potrebbe pensare che Gadda abbia voluto suggerire – con il consueto spirito di acre malignità – una sorta di analogico accostamento tra il canto dell’uccello del malaugurio e il canto, in questo caso banalmente sentimentale, del poeta.
I poeti, infatti, vengono attaccati frequentemente in queste Favole di Gadda. Feroce, ad es., è la pointe contro i poeti della f. 104: «Un vaso da notte, stanco di essere intronato gli orecchi, si volse per aiuto al poeta. Peggio che ‘andar’ di notte».
Tra i malcapitati di turno, non solo poeti ma anche personaggi famosi, oggetto dei temibili strali dell’«Ingegnere» inferocito, si trova naturalmente – accanto all’odiatissimo Foscolo (favole 92, 94), a Poliziano (ff. 108, 155 e IV – con un’implicita allusione all’omosessualità), a Raffaello Sanzio (ff. 75, 76, 106, 109) e a Giuseppe Verdi (ff. 87, 88, 95 e I) – anche Carducci, che registra il massimo delle stigmatizzazioni (ff. 60, 98, 114, 117, 157, 158). Carducci, come Foscolo e D’Annunzio, era odiato – ma anche, dialetticamente, molto ‘studiato’ – da Gadda, come ‘Vate’ rappresentante della cultura ufficiale e anche nascostamente – ma non troppo – per il suo ben noto ‘successo con le donne’9. Tra i personaggi satireggiati non manca neppure Cristoforo Colombo (ff. 84 e III).
Un acre attacco contro il ben noto ‘topos’ dell’investitura poetica si trova nella Nota bibliografica:
Et era, la notturna consumazione, dopo a’ prestati offici del raccor le mélodi ’l dì, quali per le festevoli úpupe o melodiose pilomele soglionsi al dolce tempo isbernare, o per l’attiche progne, sopr’a’ tetti di lor ville o castella o ne le selve pimplée, o ne l’amenissima eliconia valle innov’ è la fontana che del bono incostro è nomata Aganippe, o ’n sul poggio alto a mattino, ov’ è Ippocréne: e del darne in tromba a l’Italia: da chetar de’ più bramosi la santa voglia d’intendere, per musical favola, ciò che le nove musiche sirocchie vi van soffiando d’Elicona tuttodì, ne l’úvola dei detti uccelli.
I richiami eruditi occulti si spingono – ad es. nella celebre f. 180 – fino ai poeti greci. La favola è dedicata ad una spassosissima altercatio fra passeri che si esprimono, ciascuno, in un dialetto diverso: «Un pigolio furibondo, per tanto, fumava fuore dall’olmo: ch’era linguacciuto da mille lingue a dire per mille voci una sol rabbia». I dialetti usati nella parte dialogata sono, nell’ordine: bolognese, veneziano, napoletano e fiorentino.
C. Vela nel commento ad loc. indica il ‘pretesto parodico’ di quest’ultima favola nell’Elogio degli uccelli delle Operette morali di Leopardi; Manzotti10, recensendo Vela, trova una «fonte meno remota e linguisticamente […] più pertinente» nei Passeri a sera dei Canti di Castelvecchio pascoliani. Ma modelli meno immediati del passo possono essere rintracciati nel coro degli uccelli, pervaso da un alto lirismo, in Aristoph. Aves 737-751 e 769-784, in Apul. flor. 13 e in uno degli Adagia di Erasmo, Scarabeus aquilam quaerit: «Cumque tam multae sint aues non ineloquentes, tam multae canorae, tamque uariae sint uoces ac modulatus qui uel saxa possint flectere»11; ma cfr. anche, di Callimaco, il Giambo IV, fr. 194 Pf., vv. 61-92 (la contesa dell’alloro e dell’olivo sul monte Tmolo è intervallata dai cinguettii di due uccellini tra le fronde) e l’Ecale, fr. 260 Pf., con un singolare colloquio tra una cornacchia e una civetta12.
Molti, dunque, sono gli autori che si affastellano sullo scrittoio di Gadda favolista; ma, alla luce delle osservazioni appena esposte, riteniamo che tra i testi satiricamente richiamati all’altezza della f. 62 primo per importanza – pur non escludendo altri più sotterranei riecheggiamenti – sia proprio la Maggiolata di Carducci che abbiamo poc’anzi richiamato; essa costituisce infatti, a nostro avviso, una delle massime realizzazioni del tardivo e contraddittorio romanticismo nostrano, sulla scorta di Heine e di Hölderlin, di quel romanticismo che è bersaglio esplicito della favola gaddiana.
© Paolo Melandri
RSVP: e-mail: melandripaolo@libero.it
1 In C. E. Gadda, Il primo libro delle favole, Venezia (Neri Pozza), 1952. Le citazioni e i riferimenti ai testi gaddiani si intendono conformi all’edizione delle Opere di C. E. Gadda a c. di D. Isella, 5 voll., Milano (Garzanti), 1988-93. Sulla produzione favolistica di Gadda, costituita da opere criptiche per densità di simboli, dove il modello letterario è attualizzato nella direzione di una critica ai mores della borghesia, particolarmente di quella milanese, e ad atteggiamenti deteriori della cultura dominante, vd. C. Vela, Gadda favolista, in AA. VV., Gadda. Progettualità e scrittura, a c. di M. Carlino, A. Mastropasqua e F. Muzzioli, Roma (Editori Riuniti), 1987, pp. 157-168, ripreso, con qualche modifica, come Guida alla lettura, nella recente edizione de Il primo libro delle favole, a c. di C. Vela, Milano (Mondadori), 1990, pp. 107-120; id., Favole inedite di Carlo Emilio Gadda, in AA. VV., Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella, Napoli (Bibliopolis), 1983, pp. 567-613.
2 Cfr. Maria Grazia Bajoni, L’impronta di Fedro nell’opera di Carlo Emilio Gadda, «Testo», 37, n. s., Roma (Bulzoni), 1999, pp. 87-104, e la variegata rassegna di giudizi ivi contenuta.
3 Sulla presenza del gufo negli autori classici, vd. D’Arcy W. Thompson, A Glossary of Greek Birds, Oxford (Oxford University Press), 1936 [e rist., Hildesheim (G. Olms), 1966], pp. 66-67, e F. Capponi, Ornithologia Latina, Ist. di Fil. Class. e Mediev., Univ. di Genova, n. 58, Genova 1979, pp. 119-121.
4 Eccezion fatta per l’esempio gaddiano sopra riportato, dove, più che di identificazione o di legame genericamente, si può parlare di rapporto ‘mediato’ tra l’animale e l’uomo. Nei Sepolcri di Foscolo c’è, ai vv. 78 sgg., questa macabra descrizione, popolata da sinistri voli di uccelli notturni: «Senti raspar fra le macerie e i bronchi / la derelitta cagna ramigando / su le fosse e famelica ululando; / e uscir del teschio, ove fuggia la luna, / l’úpupa, e svolazzar su per le croci / sparse per la funerëa campagna / e l’immonda accusar col luttüoso / singulto i rai di che son pie le stelle / alle obblïate sepolture». Cfr. anche i componimenti di E. Montale, appartenenti agli Ossi di seppia, che hanno come incipit «Arremba su la strinata proda» e «Upupa, ilare uccello»: nel primo in particolare i vv. 1-6 («Arremba su la strinata proda / le navi di cartone, e dormi, / fanciulletto padrone: che non oda / tu i malevoli spiriti che veleggiano a stormi. // Nel chiuso dell’ortino svolacchia il gufo / e i fumacchi dei tetti sono pesi») instaurano una relazione gufo – poeta (quest’ultimo ammantato di enigmi simbolisti nella figura del ‘fanciulletto padrone’).
5 Si veda, ad es., nella medesima, articolata raccolta, l’odicina Pianto antico, che si snoda con il ritmo cadenzato di una nenia popolare, dove il ricordo del figlioletto morto in tenera età diventa rimpianto della fanciullezza, constatazione e accettazione dell’ineluttabile destino dell’uomo, Funere mersit acerbo, dedicata al fratello morto, che ha il tono quasi distaccato di un’antica iscrizione funeraria, Notte d’inverno, dove campeggia tragicamente l’interrogativo finale: «Che fanno giù ne le lor tombe i morti?»; si vedano anche le frequenti meditazioni sulla morte nelle Odi barbare (ad es. in Fuori alla Certosa di Bologna, in Davanti al Castel Vecchio di Verona, in Nevicata, ecc.) con le apocalittiche meditazioni della lirica Su Monte Mauro: «Diman morremo, come ier moriro / quelli che amammo: via da le memorie, / via da gli affetti, tenui ombre lievi / dilegueremo».
6 Cfr. H. von Hofmannsthal, L’ignoto che appare, scritti 1891-1914, a c. di Gabriella Bemporad, trad. di L. Traverso, Milano (Adelphi), 1991, p. 190. Che il «fatato uccello» (non presente nella lirica di Goethe in questione, quella famosa intitolata Selige Sehnsucht [dalla sezione Buch des Sängers], che incomincia con il verso Sagt es niemand, nur den Weisen [«Non ditelo a nessuno, solo ai saggi…»]), di cui parla Hofmannsthal sia, in realtà, un semplice ‘gufo’, si può asserire con certezza confrontando il componimento evocato in modo così suggestivo dall’«estetizzante» recensore con quello, tratto sempre dal West-östlicher Divan, intitolato Sommernacht (dalla sezione Das Schenkenbuch), vv. 29-32: Eule will ich deinetwegen / Kauzen hier auf der Terrasse, / Bis ich erst des Nordgestirnes / Zwillingswendung wohl erpasse («Gufo per te, mi annido sulla terrazza e aspetto la rotazione duplice dei Carri»).
7 «Ammirate il potere insigne e la nobiltà della linea: è la voce che la luce fece udire e di cui parla Ermete Trismegisto nel suo Pimandro».
8 «Il mio povero cuore è un gufo che s’inchioda, si schioda, si richioda. Sangue ed ardore non ha quasi più. Tutti quelli che m’amano, li lodo».
9 Cfr. P. Gibellini, Gadda e Foscolo, «Giornale storico della Letteratura Italiana», CLIX, 505 (1982), pp. 26-63; A. Turolo, Teoria e prassi linguistica nel primo Gadda, Pisa (Giardini), 1995, pp. 83-90. Vd. anche C. E. Gadda, Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo – Conversazione a tre voci (= Opere IV, Saggi Giornali Favole, II, pp. 375-429).
10 E. Manzotti, recensione all’ed. di Vela in «Rivista di Letteratura Italiana» IX, 3 (1991), pp. 626-627.
11 Cfr. Erasmo da Rotterdam, Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi, a c. di S. Seidel Menchi, Torino (Einaudi), 1980, p. 134.
12 Cfr. C. Corbato, La funzione delle «fabulae» in Callimaco, in AA. VV., La struttura della fabulazione antica, Ist. Filol. Class. e Mediev., Univ. di Genova, n. 54, Genova 1979, pp. 45-64. Sulle memorie classiche di Gadda vd. E. Flores, Risonanze classiche ovvero il latino come componente linguistica ne «La cognizione del dolore» di C. E. Gadda, «Filologia e letteratura», X (1964), pp. 381-398.
*
- Filosofia
Due Tesi e uno Scolio sulla Verità
Tesi I
Verità è correlativo di essere. Conoscenza senza una realtà corrispondente non è conoscenza; se conosciamo, ci deve essere qualcosa da noi conosciuto. Conoscere è, proprio nella sua essenza, un verbo attivo.
Tesi II
Tutta la verità è o mediata, ossia derivata da una o più altre verità; o immediata e originaria. Quest'ultima è assoluta, e la sua formula è A. A.; la prima è di certezza dipendente o condizionale, e si rappresenta nella formula B. A. La certezza, che inerisce ad A, è attribuibile a B.
Scolio.
Una catena mancante di una fermatura dalla quale tutti gli anelli derivassero la loro stabilità, o una serie mancante di un primo modulo, è stata non inadeguatamente allegorizzata nella figura di una fila di cerchi estesa a perdita d'occhio, nella quale ciascuno tiene il lembo della veste di quello che ha davanti, ma tutti si muovono senza la minima deviazione in un'unica linea retta. Si darebbe naturalmente per scontata la presenza in cima alla fila di una guida: come si potrebbe rispondere, No! Signore, il numero degli uomini è forse infinito, e l'infinita cecità tiene il luogo della vista?
Ugualmente inconcepibile è un ciclo di verità di pari grado, prive di un principio comune e centrale che prescriva a ciascuna la sua sfera propria nel sistema della scienza. Il fatto che l'assurdità non ci colpisca altrettanto immediatamente, che ci appaia ugualmente inimmaginabile, lo si deve all'azione surrettizia dell'immaginazione che, istintivamente e senza che ce ne accorgiamo, non soltanto riempie gli spazi intermedi, e contempla il ciclo (di B. C. D. E. F. ecc.) come un circolo continuo (A.) che dà a tutti collettivamente l'unità dell'orbita comune; ma, grazie a una sorta di subintelligitur, fornisce anche la forza unitaria centrale, che rende il movimento armonioso e ciclico.
© Paolo Melandri (1. 3. 2018)
*
- Storia
Antropologia schilleriana e radici cristiane europee
Autocoscienza e capacità di giudizio. Elementi di antropologia kantiana e schilleriana
What is difficult, is also beautiful, and good.
Beethoven
Coscienza di sé
Come sostiene Immanuel Kant[i], che l’uomo possa avere una rappresentazione del proprio io, lo innalza incommensurabilmente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla terra. Perciò egli è una persona e, grazie all’unità della coscienza in tutti i mutamenti che subisce, una sola e stessa persona, cioè un essere del tutto diverso, per dignità, dalle cose, quali sono gli animali privi di ragione e di cui si può disporre ad arbitrio; tale è anche quando non può ancora dire «io», perché lo ha nel pensiero: così tutte le lingue, quando parlano in prima persona, debbono pensare l’io, anche se non lo esprimono con una particolare parola. «Infatti questa facoltà di pensare è l’intelligenza»[ii].
È però importante osservare che il bambino che si esprime già abbastanza correttamente non comincia che relativamente tardi (forse un anno dopo) a usare il termine «io», mentre prima si serve, ovviamente, della terza persona («Carlo vuol mangiare, andare, ecc.»); quando incomincia a dire «io» sembra che una luce si accenda in lui e da quel giorno non tornerà mai più al precedente modo di esprimersi. Prima si limitava a sentire se stesso, ora pensa se stesso. La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere tutt’altro che facile per l’antropologo.
Si osservi che il bambino, prima del terzo mese, non si esprime né col pianto né col riso; sembra che ciò dipenda dallo sviluppo di certe rappresentazioni di offesa e di ingiustizia che presuppongono la ragione. Il fatto che in questo periodo egli cerchi di seguire con gli occhi gli oggetti luminosi che gli sono presentati attesta il rozzo inizio del processo che comincia con le percezioni (apprensione della rappresentazione sensibile) per ampliarsi fino alla conoscenza degli oggetti sensibili, cioè all’esperienza.
Più tardi, quando cerca di parlare storpiando le parole, egli intenerisce la madre e l’educatrice che continuamente lo vezzeggiano e lo baciano, ne soddisfano ogni desiderio e capriccio fino a trasformarlo in un piccolo tiranno. Questa amabilità della creatura umana nel periodo del suo farsi uomo è certamente dovuta alla sua innocenza e al candore anche delle sue espressioni manchevoli, prive di ogni infingimento e malignità, ma vi ha parte anche la tendenza naturale delle baby-sitter a vezzeggiare una creatura che si abbandona così amabilmente alla volontà altrui; questa è l’età dei giochi, la più felice di tutte, in cui l’educatore si fa, per così dire, egli stesso bambino e gode ancora di tanta piacevolezza.
Ma il ricordo della propria infanzia non va molto in là in quel periodo; non è infatti l’età delle esperienze, ma soltanto delle percezioni disunite, non ancora raccolte sotto il concetto dell’oggetto.
Educazione e capacità di giudizio – l’ingenuo e il sentimentale
Vi sono istanti nella nostra vita in cui dedichiamo una sorta di amore e di commosso rispetto alla natura nelle piante, nei minerali, negli animali, nei paesaggi, così come alla natura umana nei bambini, nei costumi del popolo contadino e del mondo primitivo, e non perché essa ristori i nostri sensi, e neppure perché appaghi il nostro intelletto o il nostro gusto (anzi, spesso può accadere il contrario dell’una e dell’altra cosa), ma unicamente perché essa è natura. Ogni uomo che sia minimamente raffinato e non difetti totalmente di sensibilità può farne esperienza passeggiando all’aperto, vivendo in campagna o indugiando presso i monumenti dei tempi antichi; in breve, quando in condizioni e situazioni di artificio rimane stupito dalla visione della natura nella sua semplicità. E questo interesse, non di rado elevato a bisogno, sta al fondo della nostra passione per i fiori e per gli animali, per i semplici giardini, per le passeggiate, per la campagna e i suoi abitanti, per i molteplici prodotti della lontana antichità e per altre cose ad esse simili, a patto che non entrino in gioco affettazione o altri casuali interessi. Un simile interesse per la natura si manifesta però solamente a due condizioni. È in primo luogo assolutamente necessario che l’oggetto che ce lo infonde sia natura, o almeno sia da noi considerato tale, e in secondo luogo che sia ingenuo (nel significato più ampio della parola), vale a dire che la natura stia in contrasto con l’arte e la vinca. Solo quando quest’ultima condizione si combina alla precedente, e non prima, la natura diviene l’ingenuo.
Da questo punto di vista la natura non è altro per noi se non la vita spontanea, il sussistere delle cose per se stesse, l’esistenza secondo leggi proprie e immutabili.
Questa «rappresentazione» è assolutamente necessaria per avvertire interesse verso simili fenomeni. Se si potesse conferire a un fiore artificiale l’apparenza della natura con il più perfetto inganno, se si potesse spingere l’imitazione dell’ingenuo nei costumi fino all’illusione più perfetta, la scoperta che è un’imitazione annienterebbe del tutto il sentimento di cui si sta parlando[iii]. Da ciò risulta chiaro che un simile compiacimento verso la natura non è estetico, bensì morale, essendo mediato attraverso un’idea, e non generato immediatamente dall’osservazione; inoltre non si rivolge alla bellezza delle forme. Che cosa avrebbero di così piacevole per noi anche un semplice fiore, una fonte, una pietra ricoperta di muschio, il cinguettio degli uccelli, il ronzio delle api e altre cose simili a queste? Che cosa potrebbe dar loro diritto al nostro amore? Non sono questi oggetti, bensì l’idea da essi rappresentata ciò che noi amiamo in loro. Noi amiamo in loro la silenziosa vita creatrice, il sereno operare per se stessi, l’esistenza secondo leggi proprie, l’intima necessità, l’eterna unità con se stessi.
Essi sono ciò che noi eravamo; sono ciò che noi dovremo tornare ad essere. Come loro noi eravamo natura, e ad essa la nostra cultura deve ricondurci attraverso la via della ragione e della libertà. Sono dunque rappresentazioni della nostra infanzia perduta, che rimane in eterno per noi la cosa più cara, e per questo ci colmano di una vaga tristezza. E sono al contempo rappresentazione della nostra perfezione più alta nell’ideale, e per questo ci donano una sublime commozione.
Ma la loro perfezione non è merito loro, non essendo frutto della loro scelta. Ci donano quindi il piacere tutto particolare di essere nostri modelli senza umiliarci. Ci circondano come una perenne apparizione divina, ma ristorandoci più che abbagliandoci. Quel che costituisce il loro carattere è proprio ciò che manca al nostro per raggiungere la sua perfezione; ciò che ci differenzia da essi è proprio quel che loro manca per innalzarsi al divino. Noi siamo liberi, essi sono necessari; noi mutiamo, essi rimangono identici. Ma solo quando i due caratteri si congiungono tra loro, quando la volontà segue libera la legge della necessità e in tutti i mutamenti della fantasia la ragione afferma la sua regola, si ha il divino e l’ideale. In essi scorgiamo dunque eternamente quel che manca, ma verso cui tendiamo, e a cui, pur senza mai raggiungerlo, possiamo sperare di avvicinarci in un progresso infinito. Individuiamo in noi una superiorità che a loro manca e di cui o non potranno mai partecipare, come gli esseri privi di ragione, o potranno farlo solo percorrendo, come la fanciullezza, la nostra stessa strada. Ci donano quindi il più dolce godimento della nostra umanità in quanto idea, sebbene debbano necessariamente umiliarci rispetto a ogni stato determinato della nostra umanità.
Essendo questo interesse per la natura fondato su un’idea, può manifestarsi soltanto in anime che siano sensibili alle idee, cioè in anime morali. Per la maggior parte degli uomini è una pura affettazione, e l’universalità di questo gusto sentimentale nella nostra epoca, in particolare dopo la pubblicazione di certi scritti, si manifesta in viaggi sentimentali, giardini dello stesso genere, passeggiate e altre simili inclinazioni, ma non è per nulla una prova della universalità di questo modo di sentire. Tuttavia anche all’uomo più insensibile la natura procurerà sempre qualcosa di questo effetto, poiché la disposizione alla moralità, comune a tutti gli uomini, è già sufficiente per questo e noi tutti, senza eccezione, per quanto grande possa essere la distanza dei nostri atti dalla semplicità e dalla verità della natura, nell’idea siamo sospinti verso di essa. Questa sensibilità per la natura si manifesta particolarmente forte e più universale nel rapporto con quegli oggetti che stanno in unione più intima con noi e ci consentono di gettare uno sguardo retrospettivo su noi stessi e su quanto di non naturale è in noi, come per esempio i bambini e i popoli bambini. Si è in errore quando si pensa che sia solo l’idea del loro essere privi di difese a far sì che a volte ci si soffermi a contemplare con tanta attenzione i fanciulli. Questo può forse essere il caso di coloro che di fronte alla debolezza umana sentono soltanto la propria superiorità. Ma il sentimento di cui stiamo parlando (e che si verifica solo in stati d’animo del tutto particolari e non va confuso con quello suscitato in noi dall’allegra attività dei bambini), è più umiliante che incoraggiante per l’amor proprio; e se si presentasse qui un vantaggio, non è perlomeno dalla nostra parte. Noi finiamo per commuoverci non perché contempliamo il bambino dall’alto della nostra forza e perfezione, bensì perché dalla finitezza del nostro stato, che è inseparabile dalla determinazione che abbiamo già realizzato, solleviamo lo sguardo alla sconfinata determinabilità del bambino e alla sua pura innocenza, e il nostro sentimento in una simile circostanza è troppo apertamente mescolato a una certa tristezza, per poterne disconoscere la fonte. Nel bambino sono rappresentate la disposizione e la determinazione, in noi il compimento, che resta sempre infinitamente inferiore a quelle. Il bambino è quindi per noi una viva presenza dell’ideale, non già dell’ideale compiuto, ma di quello proposto, e non è certo l’idea della sua debolezza e dei suoi limiti a commuoverci, bensì quella della sua pura e libera forza, della sua integrità, della sua infinità. Per l’uomo sufficientemente dotato di moralità e di sentimento, il bambino rappresenterà quindi un oggetto sacro, vale a dire un oggetto che attraverso la grandezza di un’idea annulla ogni grandezza dell’esperienza e che, qualsiasi cosa possa perdere nella valutazione dell’intelletto, riguadagna in misura superiore in quella della ragione.
Proprio in questo contrasto fra il giudizio della ragione e quello dell’intelletto ha origine il fenomeno tutto particolare del sentimento misto, che fa nascere in noi l’ingenuità nel modo di pensare. Esso congiunge la semplicità infantile con quella puerile; mediante quest’ultima mostra all’intelletto il suo lato debole e suscita quel sorriso con cui esprimiamo la nostra superiorità (teoretica). Ma non appena abbiamo motivo di credere che la semplicità puerile è al tempo stesso una semplicità infantile, che la sua origine non è nella carenza d’intelletto, non è incapacità, ma una più elevata forza (pratica), un cuore colmo d’innocenza e di verità, che per intima grandezza disdegnò l’aiuto dell’arte, ecco che allora si dilegua il trionfo dell’intelletto e la derisione della puerilità si trasforma in ammirazione della semplicità. Ci sentiamo costretti ad apprezzare l’oggetto di cui prima abbiamo riso e, gettando nello stesso tempo uno sguardo in noi stessi, a rammaricarci di non essergli simili. Così nasce il fenomeno davvero particolare di un sentimento in cui convergono allegra derisone, rispetto e mestizia[iv].
Idealismo tedesco e scetticismo italiano – Sulla educazione
In questo secolo presente, sia per l’incremento del commercio scambievole e dell’uso dei viaggi, sia per quello della letteratura, e per l’enciclopedismo che ora è in uso, così che ciascuna nazione vuole conoscere più a fondo che può le lingue, le letterature e i costumi degli altri popoli, sia per la scambievole comunione di sventure che è stata fra i popoli civili, sia perché la Francia abbassata dalle sue perdite, e le altre nazioni parte per le vittorie, parte per l’aumento della cultura e letteratura di ciascheduna, sollevandosi, si è introdotta fra le nazioni d’Europa una specie di uguaglianza di reputazione sia letteraria e civile che militare, laddove per il passato dai tempi di Luigi XIV, cioè dall’epoca della diffusa e stabilita civiltà europea, tutte le nazioni avevano spontaneamente ceduto di onore alla Francia che tutte le disprezzava; per qualcuna o per tutte queste ragioni le nazioni civili d’Europa, cioè principalmente la Germania, l’Inghilterra e la Francia stessa hanno deposto (forse anche per il progresso delle scienze e dello spirito filosofico e ragionatore che accresce la razionalità e calma le passioni e introduce un abito di moderazione; e altresì per l’affievolimento stesso dell’amore e fervore nazionale, e in generale di tutte le passioni degli uomini)[v], hanno, dico, deposto gran parte degli antichi pregiudizi nazionali sfavorevoli agli stranieri, dell’animosità, dell’avversione verso di essi, e soprattutto del disprezzo verso i medesimi e verso le loro letterature civiltà e costumi, quantunque si voglia differenti dai propri.
Le radici cristiane dell’Europa
Erano tempi belli, splendidi, quelli dell’Europa cristiana, quando un’unica cristianità abitava questo continente di forma umana, e un grande e comune disegno univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale. Privo di grandi possedimenti secolari, un solo capo supremo governava e teneva unite le grandi forze politiche. Una numerosa corporazione, accessibile a tutti, era direttamente soggetta a lui, eseguiva le sue direttive e cercava con zelo di consolidare il suo benefico potere. Ogni membro di questa associazione era onorato ovunque, e le persone comuni gli chiedevano conforto o soccorso, protezione e consiglio, e in cambio provvedevano spontaneamente e generosamente ad appagare i suoi molteplici bisogni, e trovava anche nei potenti protezione, considerazione e ascolto, e tutti avevano cura di questi uomini eletti, dotati di meravigliose energie, come fossero «figli del Cielo», la cui presenza e la cui amicizia procuravano vantaggi molteplici. Un’infantile fiducia univa gli uomini alle loro manifestazioni. Con quanta serenità ognuno poteva compiere il proprio quotidiano lavoro terreno, giacché questi santi uomini gli preparavano un avvenire sicuro, e ogni errore era da loro perdonato, ogni imperfezione della vita era da loro cancellata e chiarita. Essi erano gli esperti timonieri nel «gran mare ignoto»; sotto la loro vigilanza era lecito disprezzare tutte le burrasche e sperare fiduciosamente in un sicuro approdo, in uno sbarco sulla costa del patrio suolo[vi].
Le più selvagge e voraci tendenze dovevano cedere al rispetto e all’obbedienza. Da loro emanava la pace. Non predicavano altro che l’amore per la santa e bellissima «Signora della Cristianità» che, dotata di forze divine, era pronta a salvare ogni credente dai più paurosi pericoli. Parlavano di uomini celestiali morti da tempo, i quali con la fedeltà e l’amore a quella beata Madre e al suo divino e gentile Bambino avevano resistito alla tentazione del mondo terreno, avevano ottenuto onori divini sino a divenire potenze benefiche e protettrici dei loro fratelli viventi, compiacenti soccorritori nel bisogno, avvocati delle mancanze umane ed efficaci amici dell’umanità davanti al trono celeste. Con quale serenità si usciva dalle belle riunioni nelle chiese misteriose, ornate di dipinti suggestivi, piene di dolci profumi, animate da musiche sacre e commoventi. Là si conservavano con animo riverente, in preziose custodie, le spoglie consacrate di antichi uomini timorati di Dio. Erano testimoni della bontà e dell’onnipotenza divina, della misericordia di uomini eletti, attraverso miracoli e simboli stupendi. Nello stesso modo certe anime amanti conservano ciocche o ritratti dei loro cari defunti e alimentano il dolce fuoco fino al ricongiungimento nella morte. Si custodiva con intimo fervore ciò che era appartenuto a quelle anime care, e tutti si dichiaravano felici quando riuscivano a ottenere o magari soltanto a toccare una reliquia così confortante. Di quando in quando appariva evidente che la grazia divina si era posata di preferenza sopra un quadro o un tumulo. Da tutte le regioni affluivano allora moltitudini con magnifici doni e lucravano a loro volta doni divini: la pace dell’anima e la salute del corpo. Questa pacifica e potente società cercava assiduamente di rendere tutti gli uomini partecipi della fede e inviava suoi emissari in ogni continente per annunciare il vangelo della vita e per fare del «regno dei cieli» l’unico regno di questo mondo. Giustamente il saggio capo supremo della Chiesa si opponeva a insolenti sviluppi delle capacità umane a scapito della mentalità sacra e a intempestive, pericolose scoperte nel mondo del sapere. Così vietava a audaci pensatori[vii] di dichiarare che la terra è un pianeta insignificante, sapendo bene che in tal modo gli uomini avrebbero perduto ogni stima non soltanto per la loro dimora e per la «patria terrena» ma anche per la «patria celeste» e per l’intera stirpe, e avrebbero preferito il sapere limitato alla fede infinita e si sarebbero abituati a spregiare tutto ciò che è grande e degno di ammirazione. Alla sua corte si adunavano tutte le persone savie e onorevoli d’Europa. Tutti i tesori affluivano là, la distrutta Gerusalemme si era vendicata e Roma stessa era Gerusalemme, la sacra residenza del governo di Dio in terra. Sovrani sottoponevano le loro controversie al padre della cristianità, ai suoi piedi deponevano le corone e la loro magnificenza, e persino si gloriavano, quali membri di quest’alta congregazione, di conchiudere la sera della loro vita tra le solitarie muraglie dei conventi. Quanto benefico, quanto adeguato all’intima natura dell’uomo fosse questo governo, questa istituzione, appare dall’enorme potenziamento di tutte le umane energie, dall’armoniosa evoluzione di tutte le attitudini, dall’immensa altezza raggiunta da singoli uomini in tutti i rami delle scienze della vita e delle arti e del commercio ovunque fiorente di merci spirituali e terrene, entro i confini dell’Europa e oltre, fino alla remotissima India.
Ecco, questi erano i magnifici tratti essenziali dei tempi realmente cattolici o realmente cristiani. L’umanità non era ancora matura, non sufficientemente colta per questo splendido regno. Era un primo amore che si assopì sotto la pressione della vita economica; il suo ricordo venne soppiantato da apprensioni egoistiche; l’antico legame fu in seguito tacciato di imbroglio e follia e giudicato secondo posteriori esperienze; un primo amore dilacerato per sempre in gran parte d’Europa. Questa grande scissione interiore, accompagnata da guerre rovinose, fu uno strano indizio di come la cultura risultasse dannosa, almeno temporaneamente, al pensiero dell’invisibile, a una più alta cultura. Quel pensiero immortale non lo si può distruggere, ma si può turbarlo, paralizzarlo, sopraffarlo con pensieri diversi. La comunità umana, quando abbia una certa durata, attenua le inclinazioni, la fede nella propria stirpe, e si abitua ad assegnare tutti i suoi pensieri e le sue aspirazioni soltanto ai mezzi per ottenere benessere; i bisogni e le arti per soddisfarli si fanno più complessi e l’uomo nella sua cupidigia ha bisogno di così gran tempo per conoscerli e acquisire l’abilità necessaria a soddisfarli, che non gli rimane più tempo per il tranquillo raccoglimento dell’animo, per l’attento esame del mondo interiore.
[i] Immanuel Kant, Critica della ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Bari, Laterza, 1910 (7a ediz. riveduta da V. Mathieu, 1958); a cura di G. Colli, Torino, UTET, 1957, p. 187.
[ii] Id., Congetture sull’origine dell’umanità, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant, tradotti da Gioele Solari e Giovanni Vidari, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Torino, UTET, 1965, p. 167.
[iii] Kant, il primo, per quanto io sappia, che abbia iniziato a riflettere su questo fenomeno, ricorda che se noi udissimo il canto dell’usignolo imitato fino al più alto grado di illusione e ci abbandonassimo a questa impressione con la commozione più profonda, con il dissolversi di questa illusione tutto il nostro piacere svanirebbe. Si veda il capitolo sull’interesse intellettuale per il bello nella Critica del giudizio estetico. Chi ha imparato ad ammirare l’autore solamente come grande pensatore, sarà lieto di incontrare qui una traccia del suo “cuore” e di convincersi personalmente, grazie a questa scoperta, dell’elevatissimo talento filosofico che ebbe quest’uomo (talento che esige nel modo più assoluto il connubio delle due qualità), molto al di là di qualsiasi rivalutazione à la page.
[iv] In una nota all’Analitica del Sublime (Critica del Giudizio estetico) Kant già distingue queste tre diverse componenti nel sentimento dell’ingenuo, dandone però un’altra spiegazione. «Qualcosa che somiglia alla connessione di entrambi (del sentimento animale del piacere e del sentimento spirituale di stima) si scopre nell’ingenuità, che è l’erompere dell’originaria sincerità naturale dell’umanità contro l’arte della finzione divenuta una seconda natura. Si ride della semplicità che non sa ancora dissimularsi, ma si gioisce anche della semplicità della natura, che gioca qui a quell’arte un tiro mancino. Si attendeva l’abituale ripetersi dell’espressione artificiosa e cautamente diretta alla bella apparenza, e invece è la natura incorrotta e innocente a mostrarsi, totalmente inattesa, e che anche colui che l’ha manifestata non intendeva rivelare. Che l’apparenza bella, ma falsa, che solitamente ha una grandissima importanza nel nostro giudizio, all’improvviso si muti qui in nulla e che ugualmente l’astuzia presente in noi stessi venga compromessa, suscita il moto dell’animo in due opposte direzioni consecutivamente, moto che al contempo scuote l’animo in modo salutare.
[v] Oltre a tutto il resto, la vita, l’immaginazione, e nella letteratura l’originalità e novità, insomma tutto quello che serve a nutrire la vita umana e a scacciare la noia, e ad occupare in qualche modo chi non ha bisogni, benché sia disugualmente distribuito, è però così scarso anche presso le nazioni che più ne abbondano, che tutte sono ora rivolte a raccogliere sarmenti per così dire da ogni parte per riparare alla freddezza che occupa di solito la vita moderna civile, e a formare delle poche fiamme sparse qua e là e insufficienti a ciascuno, come un fuoco comune che sia meno inferiore al bisogno che tutti hanno di calore, e a riunire insieme tutto quel po’ di vita che si trova in tutte le parti.
[vi] Alludiamo al tema, noto e consueto, della cosiddetta «patria celeste».
[vii] Come Giordano Bruno, Galilei e Copernico.
*
- Musica
Più che mai la unica Le Ouvertures del Fidelio
Più che mai l’unica. Le Ouvertures del Fidelio
Unica nel senso dei numeri che intendeva Newman, l’Opera di Beethoven presenta un’altra singolarità nei confronti del teatro musicale: quell’abbondanza di Ouvertures che il pettegolezzo musicologico ha sempre interpretato come dubbiosa coscienza, confessione d’inadeguatezza e cattiva riuscita. Tutto ciò si definirebbe, semmai, ossessione della perfezione assoluta. Ma non basta. Le quattro Ouvertures rivelano quanto acuto fosse in Beethoven il sentimento del confine tra sinfonia e teatro, che tentava di mettere allo stesso passo. E come la ricerca del confine facesse più sinfonico il teatro e non più teatrale la sinfonia.
La manovra dei mezzi adoperati, l’enunciazione dei temi o la rinuncia, le allusioni e citazioni, gli espedienti, le astuzie, le sorprese, rivelano come lo sforzo cui lo costringe quel che per lui è il dovere di appropriarsi anche il terreno teatrale si trasformi in suprema indagine di semantica sinfonica. Bach e Brahms sentirono la tentazione teatrale, e se ne ritrassero. Bruckner, con quella sua strana adorazione per il «maestro dei maestri», non fu mai attratto dall’idea di seguire Wagner sul suo terreno. Beethoven se lo appropria in quel suo «unico» modo, senza mai diventare un operista. Resta, come gli altri tre, un assoluto.
Un esame e confronto delle quattro Ouvertures di Fidelio si trasforma in una indagine di lingustica sinfonica. Il doppio confronto che ci attende, tra la Prima e la Seconda, in do maggiore, e tra la Seconda e la Terza, lasciando la Quarta abbandonata nella sua solitudine, è un labirinto di ermeneutica sulla funzione dell’Ouverture, annuncio, commento figurativo e riassunto interno, e infine collegamento dell’Opera col paesaggio sinfonico che l’attornia. Vi entrerò proprio col mistero della solitaria Prima che, perduta di vista durante la vita dell’Autore, ricomparve dopo che l’editore Tobias Haslinger ne ebbe comprato la sola copia rimasta (non l’autografo, già allora scomparso) con altri manoscritti che non erano passati per l’asta del 5 Novembre 1827. Con indebito prolungamento della numerazione dell’Autore che termina al 135 del Quartetto in fa maggiore, Haslinger numerò 136 la Cantata Der glorreiche Augenblick del 1814, e 137 una Fuga per quintetto d’archi del 1817, coronando l’abuso col numero 138 di questa Ouverture, che probabilmente entrò in suo possesso nel 1828, e per qualche ragione che non conosco preferì far credere acquistata nell’asta dell’anno avanti. La «Münchener Allgemeine Musikalische Zeitung» l’annunciò come «una non ancor conosciuta grande Ouverture caratteristica per orchestra, Opus 138», ma Haslinger, o perché temesse rivendicazioni per noi misteriose, o che contasse di accrescere l’interesse con l’attesa, tardò a pubblicarla fino al 1838. Permise, tuttavia, che la eseguissero: la prima volta fu nel 1828, in un concerto di Bernhard Romberg, poi nel Marzo successivo, diretta da Ferdinand Piringer. Nella primavera del 1836, Felix Mendelssohn la diresse con grandissimo successo al 18° Festival del Basso Reno, a Düsseldorf. Fanny Hensel ne scrisse l’entusiastica relazione a sua sorella Rebekka Dirichlet: «Ah! Beckchen! Abbiamo fatto conoscenza di una Ouverture della Leonora di Beethoven. È noto che non fu mai suonata, a Beethoven non piaceva e la mise da parte…». A quei tempi non c’era ancora la biografia di Schindler che ne fissa la data al 1805 e racconta come il Maestro «avesse perduto fiducia nel pezzo, e dopo averlo provato con una piccola orchestra in casa Lichnowsky, la mettesse via senza neppur numerarla tra le opere, come troppo leggera e poco significativa». Willy Hess, dal cui Fidelio-Buch prendo le notizie, suppone che sulle sorti di questa Ouverture, scartata prima d’essere adoperata, esistesse «una tradizione orale che gl’intenditori conoscevano».
Joseph Braunstein, il cui Beethovens Leonore-Ouvertüren del 1927 contiene la discussione più approfondita, esclude per ragioni stilistiche la supposizione, a lungo accettata, di Gustav Nottebohm, che l’Opus 138 fosse composta nel 1807 per una rappresentazione del Fidelio a Praga. Riproposta nel 1975 da Alan Tyson[i] dopo studî sulle filigrane delle carte e conseguenti nuove datazioni dei Taccuini degli abbozzi, continua a non sostenere l’obiezione di Braunstein: «Il passaggio dalla Prima alla Seconda delle Ouvertures di Leonore è paragonabile a quelli che vanno dalla Seconda Sinfonia alla Terza e dai Quartetti dell’Opus 18 all’Opus 59». «Possiamo davvero credere», incalza Hess, «che Beethoven, dopo le grandiose gettate delle altre due Ouvertures in do maggiore, tornasse a comporre un pezzo tanto più debole, quale introduzione alla sua Opera?».
Tale «debolezza» non riguarda il materiale tematico, che è sostanzialmente lo stesso, e nel cui impiego la prima Ouverture appare, in complesso, preannuncio di quella che immediatamente la seguì. E neppure la struttura, simile a quella di Prometheus, rimpianta dalla rivista lipsiense: introduzione lenta, esposizione di sonata, ripresa, coda. Come in quella di Prometheus, manca una vera e propria sezione di sviluppo, al cui posto si trova una citazione dell’aria di Florestan che, come nelle successive, costituisce il legame tematico con l’Opera, qui ancora privo del peso e del brivido drammatico che in quella assumerà.
[i] The Problem of Beethoven’s «first» Leonore-Ouverture, in «Journal of the American musicological Society», XXVIII, Summer 1975, N. 2, pp. 292-333.
*
- Letteratura
Il poeta e i giganti
Il poeta e i giganti
(Allegoria ideologica ne I giganti della montagna)
Il carattere allegorico de I giganti della montagna (1937), l’ultima opera di Pirandello, sembra ormai, a quasi un secolo di distanza dal suo concepimento e dalla sua incompiuta elaborazione, del tutto scontato. Anzi, l’approdo alla forma dell’allegoria, da parte dell’Autore, sembra raccogliere in unità la complessa e, sotto molti aspetti, perfino all’apparenza disarticolata, per motivi e percorsi, multiformità di esperienze della sua attività teatrale e letteraria.
Si tratta comunque di un’allegoria strutturata secondo diversi strati di significati, che la critica e la pratica dello spettacolo hanno puntualmente individuato, magari seguendo diverse gerarchie di giudizio nell’ordinare di volta in volta gli elementi di valutazione del «mito».
Il campo allegorico di senso che la pièce presenta preliminarmente è però quello indicato dallo stesso significato finale cui allude il soggetto del titolo, poi tradotto nel testo d’approdo formulato da Stefano Pirandello sulla base delle estreme confidenze del padre. Si tratta della rappresentazione della condizione dei prometèici costruttori della società della tecnica e del potere del denaro – appunto i giganti della montagna – i quali affermano le loro ragioni pragmatiche e brutalmente distruttive nei confronti del mondo sognante e superfluo dell’arte: «L’opera a cui si sono messi lassù, l’esercizio continuo della forza, il coraggio che han dovuto farsi contro tutti i rischi e pericoli d’una immane impresa, scavi e fondazioni, deduzioni d’acque per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole, non hanno solo sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po’ bestiali»[i].
Tale condizione, che così tratteggia Cotrone, ottiene i suoi prodigiosi effetti in virtù peraltro della passiva acquiescenza dei fanatici «servi della vita» (le maschere operaie della moderna società di massa, così sociologicamente precisate dall’autore), impegnati a seguire ciecamente e quasi per inerzia le ragioni materiali dell’esistenza, e perciò a disconoscere ogni chimera salvifica estranea a logiche puramente utilitaristiche e produttivistiche (nella ricostruzione del terzo atto, o IV «momento» che dir si voglia, il compilatore postumo così ne riassume i comportamenti: «Cotrone vede e cerca di far notare quale incolmabile distanza separi quei due mondi venuti così bizzarramente a contatto; quello degli attori da una parte, per i quali la voce del poeta è non soltanto l’espressione più alta della vita, ma addirittura la sola realtà certa in cui e di cui sia possibile vivere, e dall’altra parte quella del popolo, tutto inteso, sotto la guida dei “giganti”, a opere grandiose per il possesso delle forze e delle ricchezze della Terra, e che in questa incessante e vasta fatica corale trova la norma, e in ogni conquista sulla materia raggiunge uno scopo della sua stessa vita di cui ciascun individuo, insieme con tutti gli altri, ma anche detro di sé si gloria»[ii]).
*
La morte di Mozart [file doc ultima versione] »
Questo testo è in formato DOC (45 KByte)
*
La morte di Mozart [nn 1 2 3 file doc] »
Questo testo è in formato DOC (38 KByte)
*
- Musica
La morte di Mozart Un imbroglio malriuscito [nn 1 e 2]
La morte di Mozart. Un imbroglio malriuscito
Mi sembra superfluo tornare a raccontare la favola dell’omicidio, cui un’invidia d’artista. Meglio precisare che la commediola in versi di Puskin venne a coronare il paio di decenni in cui s’era operata, nell’opinione viennese e tedesca, la intronizzazione di Salieri quale avvelenatore immaginario al posto di una figura reale, nel frattempo cancellata. La realtà e gradualità della sostituzione è una delle verità realmente inattese che ho scoperto rovistando storie e leggende intorno a quella che poi è divenuta La morte di Mozart.
C’è, nell’Epistolario di Goethe, una frase che i biografi hanno sempre fatto finta di non conoscere: «Mozart è nato due anni prima di me (1756), e noi ricordiamo fin troppo bene le circostanze del suo decesso. Mozart, dico, grazie alla sua buona scuola, aveva nel comporre una tal sicurezza di mano, che gli restava un sacco di tempo, e lui lo consumava tra donne e simili[i] e così arrivò a sciupare il suo buon carattere».
Se il 19 Agosto 1827 un musicista dell’autorità di Carl Friedrich Zelter poteva scrivere questo passo all’amico Goethe, con la naturalezza di chi rammemora enormità risapute, vuol dire che il morboso e lo scandalo dominavano la scena di quella morte, così ricordata non solo in Germania, ma perfino in una cultura periferica come quella di Puskin. Il suo Salieri si giustifica col dire che Mozart era un dissoluto. Non serve ritorcere che Salieri lo era molto di più, il dissoluto punito era ormai Mozart. Prova evidente della restaurazione poi avvenuta nella sua immagine è che la lettera di un autorevole testimone della trasgressione ad altro testimone, consenziente e ancor più autorevole, è ancora omessa dalle raccolte di documenti cui si affida l’immagine mozartiana[ii].
L’immagine del Mozart dissoluto non era nata dal nulla, ma da un vero boato, la risonanza del suicidio che un certo signor Franz Hofdemel commise, convinto di avere ucciso la moglie, appena si seppe che Mozart era morto. L’impressione fu immensa a Vienna e di riflesso in Germania, il governo, la polizia, la Zensur, funzionari e poi biografi e scrittori docili all’autorità impiegarono tutt’i mezzi, leciti e illeciti, per farla dimenticare.
Il «caso Hofdemel» è una delle innumerevoli prove di come la biografia di Mozart fosse passata al bucato, a più bucati, e ridotta a cencio incolore, poi lasciato bianco e qua e là ricolorato in fretta con altre tinte. Rimettere al loro posto gli sventurati coniugi nella drammaturgia di quella morte multipla e della successiva leggenda significa ricercare una dinamica stravolta e tuttavia, sotto lacune alterazioni e falsificazioni, ancora qua e là leggibile.
Figlia di un maestro di scuola e Kapellmeister a Brünn, Moravia, Maria Magdalena Pokorny aveva sposato un cancelliere di tribunale, Franz Hofdemel, cui Mozart, profittando d’una raccomandazione che gli aveva promesso per farlo entrare nella sua loggia di massoni, chiese in prestito (era ormai la sua regola) prima del viaggio a Berlino col principe Lichnowsky, nel 1789, cento fiorini. Il 2ten Aprill gli firmò una cambiale a quattro mesi, che Hofdemel girò a un merciaio che la mise all’incasso, costringendo il maestro, appena tornato, a una disperata supplica, che pure ci resta, all’amico Puchberg. Nonostante il brutto scherzo, i rapporti erano rimasti cordiali, non ne era seguita alcuna rottura, Mozart non voleva perdere Magdalena, venticinquenne e, si disse, assai graziosa.
Hofdemel prendeva uno stipendio di 400 Gulden, l’esatta metà degli 800 che la Corte dava a Mozart e che i biografi ci hanno insegnato a disprezzare come la pagnotta del povero. Com’era regola per ufficiali e funzionari, disponeva di un patrimonio personale, e quando Mozart fece girare la voce che prendeva Scholaren, gli mandò o lasciò andare a lui la moglietta, senza temere gli alti suoi onorari. Nei dieci anni di Vienna, sempre Mozart chiese a prestito denari ai mariti delle giovani e leggiadre allieve che (forse) corteggiava, con quanti successi nessuno può indovinare perché stava diventando un ometto pingue e assai brutto.
Ecco la premessa, autentica e più volte cancellata, del Mozart dissoluto. Fantastica e arbitraria è la sostituzione di Salieri a Hofdemel quale possibile avvelenatore. Una volta soppressi dal rasoio, dalla censura e dai biografi gli sfortunati coniugi, la leggenda dell’avvelenamento era rimasta priva di connotati, di movente e di agente.
Che Mozart morisse, dopo due settimane, di una emorragia cerebrale cagionata da un colpo di bastone o d’altra simile arma, infertogli da Hofdemel, si è raccontato per due secoli a Vienna; a Piero Buscaroli lo confidò, come un segreto da non scrivere e non cedere ad alcuno, Bernhard Paumgartner ottantatreenne nel suo ufficio al Mozarts Wohnhaus di Makartplatz, l’antica Hannibalplatz. Simile fine, brutale e impoetica, spiegherebbe la riluttanza a rievocarla, e il diffuso proposito di cancellarla. Se risultasse vera, metterebbe a posto, letteralmente, ogni quesito, ogni lacuna. Ma nessuna vera prova l’ha mai confortata. Il mistero della morte si chiude, per me, a questo punto. Non così il più piccolo mistero, lì dentro ancor incartocciato, delle origini del Requiem.
Mozart lasciò questo mondo nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1791. Gridata dalle finestre, commentata in numerosi capannelli dalla prima mattina, la notizia si diffuse prestissimo nel quartiere, la piccola Rauhensteingasse sfocia nella Singerstrasse dov’era, ed è, tuttora, intatto, con l’identico nome di Deutsches Haus, la Casa Tedesca, l’ospizio dell’Ordine Teutonico.
Amadé vi aveva alloggiato, col séguito del suo Arcivescovo, dieci anni prima. Pochi passi, giri l’angolo a destra, e sei nella Piazza del Duomo. Prestissimo la notizia s’irradiò nel quartiere, raggiunse la polizia e il ministero dell’Interno, salì gli scaloni della Hofburg, bussò discreta ai fratelli massoni, entrò nell’alloggio al primo piano della Grünangerstrasse, due strade di lì, dove i coniugi Hofdemel vivevano con la bambina di un anno.
Non ebbero il tempo di aspettare il servizio funebre in Santo Stefano, le cui relazioni furono poi falsificate (è incerto perfino se si tenesse, se il 6 o il 7 Dicembre). Quel poco che avanza d’una cronaca approssimativa comincia quando un tizio udì dalle scale, il pomeriggio del 5 Dicembre, gli strepiti di un alterco, gli urli di una donna esasperata poi terrorizzata, di un uomo furioso dall’ira, i gridi d’una bambina. Era Magdalena, di nuovo incinta, che la morte appena avvenuta del suo maestro e forse amante, collegava alla notizia, che nessuna cronaca registra, di un’aggressione violenta seguita da commozione cerebrale, e ne incolpava, in appassionata disperazione, il marito; e poi lui, che le ritorceva l’adulterio con strepiti raddoppiati, seguiti da forti colpi.
Giunte altre due persone, tutt’insieme forzarono la porta e trovarono Hofdemel morto nel suo sangue, la gola tagliata dal rasoio che ancora teneva in mano.
S’era ucciso in quel modo, convinto di aver ucciso Magdalena che, con un tremendo sfregio nel viso e altre ferite, era invece ancor viva. Due dottori si presero cura di lei.
Secondo la legge, il boia doveva cucire il cadavere del suicida dentro una pelle di vacca e gettarlo in una fossa segreta. Ma un chirurgo, Sartori, risparmiò alla vedova quel supplemento d’orrore e gli fece dare sepoltura cristiana, il 10 Dicembre. Questa data la «Wiener Zeitung» assegnò al delitto e al suicidio. Obbediva alla Zensur e alla polizia, che subito si erano messe all’opera per cancellare le «circostanze» e allontanare i due decessi, così da rendere difficile qualsiasi collegamento. Due vedove avrebbero potuto confermare o smentire le voci che correvano e lamentavano l’amara fine dell’amore di Amadé e Magdalena: lei stessa, e Constanze. Ma entrambe avevano interesse a tacere. E, in ogni caso, il silenzio fu imposto.
I nomi delle due vedove apparvero appaiati in una corrispondenza della «Pressburger Zeitung». Tra il vero e il falso, la censura austriaca sceglieva docili giornali di provincia a pubblicare ciò che a Vienna doveva tacersi. La «Grätzer Zeitung» dette la notizia il 13 Dicembre coi nomi dei coniugi e la «gelosia» per movente, ma il 18 Dicembre ancora la gazzetta di Pressburg precisava: «Il suicida, ora si apprende, si tolse la vita per depressione, e non per gelosia». I sottili distinguo dell’absburgica tranquillità.
Così rimosso lo scandalo, s’apriva la via all’absburgico benvolere: «Non solo molte dame, ma anche Sua Maestà l’Imperatrice in persona hanno promesso assistenza a questa signora, la cui condotta è riconosciuta irreprensibile. Si è provveduto anche per la vedova del defunto Kapellmeister Mozart. L’Imperatore le ha lasciato l’intero salario del marito, e il barone Van Swieten si è assunto la cura di suo figlio». Né l’una, né l’altra notizia era vera. L’interesse dell’articolo sta nella stupenda coerenza che rivela. I disperati tentativi di rendere reciprocamente estranei i due decessi trovavano insieme la stessa catastrofe e smentita grazie alla diligenza, magnificamente absburgica, dell’automatismo burocratico. In quell’oceano di prudenti bugie, splende il nome del barone Van Swieten, esibito quale esecutore, fino alla «cura del figlio» (ch’eran poi due), del «progetto Mozart» elaborato in gran fretta tra la Hofburg imperiale e le diverse polizie, censure e assistenze.
[i] A questa traduzione fu più volte osservato che «donne e simili» è poco chiaro, con la deprimente ovvietà: «Dobbiamo considerare un Mozart pederasta?», ecc. e il paragone con la traduzione, «molto più bella e pungente, in F. Carr, Mozart & Constanze». Che, poi, non era una traduzione sola, ma doppia, dal tedesco di Zelter all’inglese di Carr, all’italiano d’ignoto traduttore o traduttrice. Il che non dovrebbe farsi. Anche a me l’espressione fa uno strano effetto, ma Zelter scrive che Zeit blieb, gli rimase tempo, die er mit Weibern u.dergl., addirittura con l’abbreviazione di dergleichen, come un ecc. qualsiasi. Vedi il Briefwechsel zwischen Zelter und Goethe in den Jahren 1799 bis 1832, 3 Bände[...]herausg. von Ludwig Geiger, Leipzig, Reclam, 1902, vol. 2, p. 505.
[ii] La lettera è omessa dalla raccolta Goethes Briefe und Briefe an Goethe, Hamburger Ausgabe in 6 Bänden, Herausg. von Karl Robert Mandelkow, Münich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.
*
- Musica
La morte di Mozart Un imbroglio malriuscito [n° 1]
La morte di Mozart. Un imbroglio malriuscito
Mi sembra superfluo tornare a raccontare la favola dell’omicidio, cui un’invidia d’artista. Meglio precisare che la commediola in versi di Puskin venne a coronare il paio di decenni in cui s’era operata, nell’opinione viennese e tedesca, la intronizzazione di Salieri quale avvelenatore immaginario al posto di una figura reale, nel frattempo cancellata. La realtà e gradualità della sostituzione è una delle verità realmente inattese che ho scoperto rovistando storie e leggende intorno a quella che poi è divenuta La morte di Mozart.
C’è, nell’Epistolario di Goethe, una frase che i biografi hanno sempre fatto finta di non conoscere: «Mozart è nato due anni prima di me (1756), e noi ricordiamo fin troppo bene le circostanze del suo decesso. Mozart, dico, grazie alla sua buona scuola, aveva nel comporre una tal sicurezza di mano, che gli restava un sacco di tempo, e lui lo consumava tra donne e simili[i] e così arrivò a sciupare il suo buon carattere».
Se il 19 Agosto 1827 un musicista dell’autorità di Carl Friedrich Zelter poteva scrivere questo passo all’amico Goethe, con la naturalezza di chi rammemora enormità risapute, vuol dire che il morboso e lo scandalo dominavano la scena di quella morte, così ricordata non solo in Germania, ma perfino in una cultura periferica come quella di Puskin. Il suo Salieri si giustifica col dire che Mozart era un dissoluto. Non serve ritorcere che Salieri lo era molto di più, il dissoluto punito era ormai Mozart. Prova evidente della restaurazione poi avvenuta nella sua immagine è che la lettera di un autorevole testimone della trasgressione ad altro testimone, consenziente e ancor più autorevole, è ancora omessa dalle raccolte di documenti cui si affida l’immagine mozartiana[ii].
L’immagine del Mozart dissoluto non era nata dal nulla, ma da un vero boato, la risonanza del suicidio che un certo signor Franz Hofdemel commise, convinto di avere ucciso la moglie, appena si seppe che Mozart era morto. L’impressione fu immensa a Vienna e di riflesso in Germania, il governo, la polizia, la Zensur, funzionari e poi biografi e scrittori docili all’autorità impiegarono tutt’i mezzi, leciti e illeciti, per farla dimenticare.
Il «caso Hofdemel» è una delle innumerevoli prove di come la biografia di Mozart fosse passata al bucato, a più bucati, e ridotta a cencio incolore, poi lasciato bianco e qua e là ricolorato in fretta con altre tinte. Rimettere al loro posto gli sventurati coniugi nella drammaturgia di quella morte multipla e della successiva leggenda significa ricercare una dinamica stravolta e tuttavia, sotto lacune alterazioni e falsificazioni, ancora qua e là leggibile.
Figlia di un maestro di scuola e Kapellmeister a Brünn, Moravia, Maria Magdalena Pokorny aveva sposato un cancelliere di tribunale, Franz Hofdemel, cui Mozart, profittando d’una raccomandazione che gli aveva promesso per farlo entrare nella sua loggia di massoni, chiese in prestito (era ormai la sua regola) prima del viaggio a Berlino col principe Lichnowsky, nel 1789, cento fiorini. Il 2ten Aprill gli firmò una cambiale a quattro mesi, che Hofdemel girò a un merciaio che la mise all’incasso, costringendo il maestro, appena tornato, a una disperata supplica, che pure ci resta, all’amico Puchberg. Nonostante il brutto scherzo, i rapporti erano rimasti cordiali, non ne era seguita alcuna rottura, Mozart non voleva perdere Magdalena, venticinquenne e, si disse, assai graziosa.
Hofdemel prendeva uno stipendio di 400 Gulden, l’esatta metà degli 800 che la Corte dava a Mozart e che i biografi ci hanno insegnato a disprezzare come la pagnotta del povero. Com’era regola per ufficiali e funzionari, disponeva di un patrimonio personale, e quando Mozart fece girare la voce che prendeva Scholaren, gli mandò o lasciò andare a lui la moglietta, senza temere gli alti suoi onorari. Nei dieci anni di Vienna, sempre Mozart chiese a prestito denari ai mariti delle giovani e leggiadre allieve che (forse) corteggiava, con quanti successi nessuno può indovinare perché stava diventando un ometto pingue e assai brutto.
Ecco la premessa, autentica e più volte cancellata, del Mozart dissoluto. Fantastica e arbitraria è la sostituzione di Salieri a Hofdemel quale possibile avvelenatore. Una volta soppressi dal rasoio, dalla censura e dai biografi gli sfortunati coniugi, la leggenda dell’avvelenamento era rimasta priva di connotati, di movente e di agente.
Che Mozart morisse, dopo due settimane, di una emorragia cerebrale cagionata da un colpo di bastone o d’altra simile arma, infertogli da Hofdemel, si è raccontato per due secoli a Vienna; a Piero Buscaroli lo confidò, come un segreto da non scrivere e non cedere ad alcuno, Bernhard Paumgartner ottantatreenne nel suo ufficio al Mozarts Wohnhaus di Makartplatz, l’antica Hannibalplatz. Simile fine, brutale e impoetica, spiegherebbe la riluttanza a rievocarla, e il diffuso proposito di cancellarla. Se risultasse vera, metterebbe a posto, letteralmente, ogni quesito, ogni lacuna. Ma nessuna vera prova l’ha mai confortata. Il mistero della morte si chiude, per me, a questo punto. Non così il più piccolo mistero, lì dentro ancor incartocciato, delle origini del Requiem.
[i] A questa traduzione fu più volte osservato che «donne e simili» è poco chiaro, con la deprimente ovvietà: «Dobbiamo considerare un Mozart pederasta?», ecc. e il paragone con la traduzione, «molto più bella e pungente, in F. Carr, Mozart & Constanze». Che, poi, non era una traduzione sola, ma doppia, dal tedesco di Zelter all’inglese di Carr, all’italiano d’ignoto traduttore o traduttrice. Il che non dovrebbe farsi. Anche a me l’espressione fa uno strano effetto, ma Zelter scrive che Zeit blieb, gli rimase tempo, die er mit Weibern u.dergl., addirittura con l’abbreviazione di dergleichen, come un ecc. qualsiasi. Vedi il Briefwechsel zwischen Zelter und Goethe in den Jahren 1799 bis 1832, 3 Bände[...]herausg. von Ludwig Geiger, Leipzig, Reclam, 1902, vol. 2, p. 505.
[ii] La lettera è omessa dalla raccolta Goethes Briefe und Briefe an Goethe, Hamburger Ausgabe in 6 Bänden, Herausg. von Karl Robert Mandelkow, Münich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.
*
- Letteratura
La poesia ironica del Faust di Goethe
La figura di Mephistopheles nel Faust di Goethe
Con gran piacere si parla ai giovani, agli studenti, del poema scenico di Goethe, perché appartiene a loro, è della loro età, fu concepito da un loro coetaneo. All’inizio non altro era che il geniale ghiribizzo di un goliardo che si divertiva a portare in giro tutte le facoltà e i professori e che provava un gran gusto sotto le mentite spoglie del diavolo a far da mentore saputo a uno studentello di primo pelo, a una matricola, a un novellino della vita universitaria, che stava a pensione dalla signora Spritzbierlein. Un critico contemporaneo, che si chiamava Pustkuchen, scrisse indispettito: «In verità la critica di tutto l’umano sapere fatta da Faust non è quella di un uomo che come Alessandro in India è arrivato ai confini del mondo e anela l’impossibile, ma di uno studente che si beffa dei suoi professori, compiacendo con ciò al gusto e alle esigenze dei più». E il molto bisognevole giudice aggiunge: «Ma, in seguito, lo svolgimento della poesia segue il modo solito di Goethe. Questo Faust, quest’uomo di così straordinaria empietà, che con uno spirito di gigante superò per la sfrenata energia perfino il diavolo, quest’uomo terribile… diventa nel nostro poeta un personaggio come gli altri. Un intrigo d’amore si allaccia, come mille altri, una ragazza borghese d’indole buona, ma limitata, sul genere di Chiarina nell’Egmont…».
Così è: questo critico nella sua maniera bonaria e ristretta ha pienamente ragione protestando contro una realtà poetica che deve sembrargli impicciolire e familiarizzare, con caratteri troppo personali, un grande soggetto. La critica è sempre l’avvocato della materia, del soggetto, contro il poeta che li tratta invece audacemente, come mezzi e pretesti dei suoi fini personali. Ma quel che siffatta critica trascura è lo strano fenomeno che, nel Faust, lo spirito della gioventù goliardica si arroga il compito di rappresentare l’umanità e che un mondo, il mondo occidentale, ha accettato questa rappresentanza e ha riconosciuto nella simbolica figura di Faust la sua essenza più profonda. Grande onore si fa alla giovinezza con quest’opera e con il celebrare la grandezza a cui essa si elevò. Nel disdegno di ogni freno, nel “bisogno di assoluto”, nello spirito di rivolta, nel suo odio per il limite, la tranquillità, la comodità, nelle indomite aspirazioni, nel suo desiderio di scalare il cielo si manifesta compiutamente quel fenomeno dello spirito umano che l’età matura e pacata suol definire «immaturità giovanile». Ma grazie al genio questa immaturità diventa esemplare: il giovane rappresenta tutto l’uomo, e ciò che era Sturm und Drang e giovanile titanismo diventa un tipo umano di eterna validità.
Vero è che, secondo la finzione scenica, non è un giovanotto, ma un molto attempato magister e dottore colui che noi vediamo all’inizio della tragedia curvo sul suo leggio, sotto una volta umida e sorda. Poiché gli intrugli della cucina delle streghe gli devono aver tolto di dosso trent’anni e poiché, quando si rivolge a Margherita, ci appare su per giù come un uomo sui trenta, dovrà, all’inizio dell’azione, avere avuto giusti giusti sessant’anni e in tale età appunto lo vediamo comparire sulla scena. Ma è di questo sessantenne che Mefistofele dice al Signore: Fürwahr, er dient Euch auf besondre Weise. / Nicht irdich ist des Toren Trank und Speise. / Ihn treibt die Gärung in die Ferne, / Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst; / Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne / Und von der Erde jede höchste Lust, / Und alle Näh und alle Ferne / Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust[i].
Parole che naturalmente non possono riferirsi a un uomo sulla soglia della vecchiezza. Goethe trasporta il suo impeto giovanile in un uomo che si trova nella stessa età di lui quando scriverà le Affinità elettive. Faust è una specie di figliol prodigo, una spina nel cuore del Signore e oggetto di tutte le brame delle potenze tenebrose, è l’uomo stesso. Ma il poeta che disegnò con facile mano questa figura cosmica gli dette i suoi tratti e il carattere di un giovanotto; e così il giovanotto divenne l’uomo e l’uomo il giovanotto.
Ma qui agisce un giovane che cerca di distanziarsi criticamente dal proprio io e mantenere un distacco – distacco che si chiama ironia – dalla sua giovanile natura, dal suo indomito anelito di libertà, dal suo impeto sovrumano, dalla sua esigenza di assoluto. E questa ironia non gli è meno cara e non cerca meno di esprimersi poeticamente che quella sua aspirazione infinita. Si tratta anche qui di due anime, non altrimenti nel monologo in cui Faust parla delle due anime che abitano nel suo petto: quella della voglia grossolanamente erotica, della sensualità, che s’aggrappa alla vita e quella dell’aspirazione nostalgica verso la purezza e lo spirito. Come si rammarica di aver due anime, così potrebbe deplorare con un “ah” questa duplicità del suo spirito, diviso fra entusiasmo e ironia; deplorazione tuttavia non pienamente sincera, perché egli sa molto bene che proprio questa duplicità è il segreto della sua fecondità creativa, il nativo terreno da cui s’alimenta. Entusiasmo, ciò etimologicamente significa: sentirsi pieni di Dio; ma ironia, che cosa significa questa parola? Il poeta del Faust è giovane abbastanza per vedere nell’impulso verso l’infinito un segno del divino e nell’ironia invece una manifestazione di quel che vi è di diabolico nell’uomo.
[i] «Davvero, in modo strano egli vi serve. / Non son terrestri i cibi e le bevande / di questo pazzo. Lungi lo trascina / del suo cuore il fermento. Ed è cosciente / solo a metà di sua pazzia. Dal cielo / chiede gli astri più belli e dalla terra / ogni più eccelsa voluttà. Ma in terra / e in cielo non v’è cosa che il tumulto / acquieti mai del suo petto sconvolto».
*
- Antropologia
I tre significati di cultura [n° 1]
I tre significati di «cultura»
Al termine “cultura” si connettono diverse associazioni di idee, a seconda che ci riferisca allo sviluppo di un individuo, di un gruppo o classe, o della società intera. Fa parte della tesi che intendiamo sostenere che la cultura dell’individuo è fondata su quella del gruppo o classe, e questa su quella della società intera, cui appartiene quel gruppo, o quella classe. Il fondamento, dunque, sarà la cultura della società, ed il significato del termine andrebbe esaminato in primo luogo in relazione all’intera società. Quando il termine “cultura” è applicato al trattamento degli organismi inferiori – all’opera del batteriologo o del tecnico agrario – il significato è abbastanza chiaro, poiché possiamo raggiungere l’unanimità su quali siano i fini da conseguirsi, e possiamo essere d’accordo su quando li abbiamo, o meno, conseguiti. Quando tale termine invece è applicato al progresso dello spirito e della mente dell’uomo, è meno probabile che ci accordiamo su quel che sia la cultura. L’uso del termine stesso, a significare qualcosa cui coscientemente mirare nelle cose umane, non ha una storia lunga. Sotto tale punto di vista, la “cultura” è relativamente comprensibile se ci riferiamo all’opera che su di sé compie l’individuo, la cui cultura appare sullo sfondo di quella del gruppo o della società. La cultura del gruppo ha essa pure un senso definito, in contrasto a quella, presumibilmente meno sviluppata, della massa della società. La differenza fra i tre modi di usare il termine può essere meglio afferrata se ci chiediamo fino a che punto, riferendoci all’individuo, al gruppo e alla società nel suo insieme, abbia un senso parlare dello scopo cosciente di conseguire una cultura. Si eviterebbe molta confusione se ci rifiutassimo di proporre al gruppo quel che può essere lo scopo solamente dell’individuo; o alla società nel suo insieme, quel che può essere lo scopo solamente del gruppo.
Il senso generico, o antropologico, del termine, come è usato per esempio da E. B. Taylor, nel titolo del suo libro Primitive Culture, ha prosperato indipendentemente dagli altri significati: ma se consideriamo società altamente sviluppate, e specialmente la nostra contemporanea, dobbiamo prendere in esame la relazione fra i tre significati. A questo punto l’antropologia trapassa in sociologia. Fra uomini di lettere e filosofi della morale è stata cosa consueta discutere nel primo, senza relazione con il terzo. L’esempio di questa esclusione più facile a ricordarsi, è Cultura e anarchia di Matthew Arnold[i]. Arnold si interessa innanzi tutto dell’individuo e della “perfezione” cui questo dovrebbe mirare. È vero che nella sua famosa classificazione della società in “Barbari, Filistei, Plebe” egli si spinge fino ad una critica delle classi; ma questa si limita ad una accusa rivolta a quelle classi per le loro insufficienze, e non si spinge a considerare quale dovrebbe essere la funzione, o “perfezione”, conveniente a ciascuna di esse (eccettuata la celebre, vaga indicazione per la prima). Il risultato – di un soggettivismo francamente sconcertante – è quindi di esortare l’individuo che vorrebbe raggiungere quel particolare genere di “perfezione” da Arnold chiamato “cultura”, a porsi al di sopra dei limiti di qualsiasi classe, piuttosto che a realzzarne i più alti ideali raggiungibili.
L’impressione di alcunché di esile che la “cultura” di Arnold comunica al lettore moderno è in parte dovuta all’assenza di uno sfondo sociale nel suo quadro. Ma è altresì dovuta, si può pensare, alla sua incapacità di tener conto di un altro modo in cui usiamo questo termine, oltre ai tre già menzionati. Possiamo riferirlo a parecchie e distinte qualità: possiamo pensare alla raffinatezza dei modi o all’urbanità ed alla civiltà: in tal caso ci riferiremo in primo luogo ad una classe sociale, e l’individuo “superiore” sarà il rappresentante del meglio di quella classe; possiamo riferirci alla dottrina, ad una conoscenza precisa della saggezza accumulata nel passato, ed allora il nostro uomo di cultura sarà un dotto; oppure alla filosofia nel senso più ampio – un interesse per le idee astratte ed una certa abilità nel maneggiarle –: ed allora potremo alludere all’intellettuale (quantunque questo termine sia ora usato molto approssimativamente, così da includere molte persone non eminenti per vigore d’intelletto); o possiamo considerare le arti: ed allora intenderemo l’artista, o l’amatore, o il dilettante. Ma di rado tutto ciò ci è presente in uno stesso tempo. Non troviamo, ad esempio, che l’intelligenza della musica o della pittura appaia esplicitamente nella descrizione che Arnold ci dà dell’uomo colto: e tuttavia nessuno vorrà negare che a queste qualità spetti una parte della cultura.
Se esaminiamo le diverse attività culturali elencate nel paragrafo precedente, dobbiamo concludere che la perfezione in una qualsiasi di esse, ad esclusione delle altre, non può conferire cultura ad alcuno. Sappiamo che le cosiddette “buone maniere”, quando non siano accompagnate da educazione, intelligenza o sensibilità per le arti, tendono al puro automatismo; che la dottrina, senza le buone maniere o la sensibilità, è pedanteria; che l’abilità intellettuale senza altri e più umani attributi è ammirevole solo alla stessa guisa delle splendide qualità di un enfant prodige giocatore di scacchi; e che le arti senza un tessuto intellettuale sono vanità. E se riconosciamo che in nessuna di queste qualità singolarmente prese sta la cultura, neppure potremo pretendere che vi sia chi le possiede tutte, senza eccezione, ed in sommo grado: ne dedurremo che l’individuo integralmente colto è un fantasma; e cercheremo la cultura non in un individuo, o in gruppi di individui, ma in zone sempre più vaste; e alla fine saremo indotti a riconoscerla nello schema della società considerata nel suo insieme. Ci pare che questa sia una osservazione del tutto ovvia: ma è frequentemente trascurata. Vi è chi è sempre disposto a considerarsi persona di cultura in grazia di un’unica qualità, mentre non solamente manca delle altre, ma è insensibile alle proprie carenze. Un artista di qualsiasi genere, anche un grande artista, non è per questa unica ragione uomo di cultura; gli artisti sono spesso non solamente insensibili alle arti che non professano, ma hanno talora maniere pessime (com’è ben noto), e ben scarsi doni intellettuali. La persona che contribuisce alla cultura, per quanto importante possa essere il suo contributo, non sempre è persona di cultura.
Non viene da ciò che non vi sia senso nel parlare della cultura di un individuo, o di un gruppo, o di una classe. Intendiamo dire solamente che né può la cultura dell’individuo isolarsi da quella del gruppo, né quest’ultimo astrarsi da quella dell’intera società; e che il nostro concetto di “perfezione” deve tener conto nello stesso tempo dei tre sensi della parola “cultura”. Neppure ne segue che in una società, di qualsivoglia grado di cultura, i gruppi interessati a ciascuna attività culturale debbano essere distinti e privi di reciproci rapporti. Al contrario, solo per una sovrapposizione e compartecipazione d’interessi, per la stima ed interessamento reciproci, può conseguirsi la coesione necessaria alla cultura. Una religione non richiede solamente sacerdoti consci degli atti che essi compiono, ma altresì dei fedeli capaci di intenderli.
È cosa ovvia che, tra le comunità più primitive, le diverse attività culturali sono inestricabilmente intrecciate. Il Daiaco che dedica la maggior parte di una stagione a costruire, incidere e dipingere la sua barca, secondo il particolare disegno richiesto dal rito annuale della caccia alle teste, esercita parecchie attività culturali in una volta: arte e religione, e anche abilità militare nel condurre una guerra anfibia. Allorché una società si fa più complessa, si manifesta una maggiore specializzazione: nelle nuove Ebridi dell’età della pietra, a quel che dice John Layard, certe isole si specializzano in arti particolari, scambiandosi le loro merci e sfoggiando le loro qualità con reciproca soddisfazione dei membri dell’arcipelago. Ma mentre i membri di una tribù, o di un gruppo di isole e di villaggi, possono avere funzioni distinte – tra le quali le più specifiche sono quelle del re e del medico stregone – solamente ad uno stadio più avanzato la religione, la scienza, la politica e l’arte giungono ad essere astrattamente concepite come separate le une dalle altre. E proprio come le funzioni degli individui diventano ereditarie, e la funzione ereditaria si irrigidisce nella divisione in classi o caste, e questa conduce al conflitto, così tra religione, politica, scienza ed arte vi sarà ad un certo punto una lotta cosciente per la conquista dell’autonomia e del predominio. Questa frizione, in taluni stadi e in certe situazioni, è sommamente creativa: in quale misura sia conseguenza, e in quale misura causa dell’accresciuta consapevolezza, non occorre qui indagare. La tensione entro la società può anche farsi tensione nello spirito dell’individuo più cosciente: il contrasto dei doveri nell’Antigone, che non è semplicemente contrasto tra la pietà e l’obbedienza civile, o tra la religione e la politica, ma tra le leggi opposte entro ciò che è ancora un complesso religioso-politico, rappresenta uno stadio assai progredito di civiltà: poiché il conflitto deve avere un significato nell’esperienza del pubblico prima che possa essere espresso dal drammaturgo e ricevere dal pubblico la risposta che la sua arte esige.
[i] Matthew Arnold (1822-1888). Una delle più lucide intelligenze dell’Inghilterra dell’800, spirito classico, antivittoriano, coltivò un sottile spirito critico in una ricca produzione saggisitca, della quale Cultura e anarchia (1869) è uno degli esempi più notevoli. In esso, come vedremo, si trova la classificazione della società in filistei (i borghesi dell’età vittoriana), barbari (gli aristocratici), e plebe. Alla prima classe Arnold propone l’ideale di una “fede nella retta ragione” che vuole essere anche maturità critica ed etica.
*
- Filosofia
La dissimulazione creatrice
La dissimulazione creatrice nella storia artistica occidentale
Sì, come si deve mai cominciare! Lo storico – e tanto più lo storico occasionale – è sempre esposto alla tentazione alla quale soggiacque Wagner in maniera eccezionale quando, teso in verità soltanto a descrivere il declino del suo eroe, si lasciò attirare da una pedanteria entusiasta sempre più indietro nel passato, nel mito, finché si trovò costretto ad accettare una parte sempre più grande di “preistoria”, finché, alla fine, si fermò necessariamente all’inizio e all’origine di tutte le cose, alla più profonda essenza dell’antefatto dell’antefatto; da qui poi incominciò a narrare in maniera solenne e graduale. Poiché però tempo e spazio protestano a gran voce che noi, in questo saggio sulla storia di un procedimento retorico di cui oggi viviamo il rinnovamento e la continuazione, vogliamo incomiciare dalle più profonde origini, diamoci una scrollatina e iniziamo dalla «grande diffidenza», la profondamente radicata e, se vogliamo esser giusti, abbastanza fondata diffidenza del mondo nei confronti di Nietzsche, Goethe e Dostoevskij.
Scrive Benjamin che la fruizione di un’opera d’arte, sia essa figurativo-pittorica, plastica, letteraria o musicale, risulterebbe impossibile se l’amico delle muse non riuscisse ad avvertire in essa, fin dal primo istante, l’«aura» che la caratterizza. Ad esempio, la lettura delle Affinità elettive, dei Fratelli Karamazov, di Guerra e pace o del Canzoniere di Petrarca è quantomai laboriosa e sterile se non si intuisce subito il proprium dell’autore con cui si sta parlando, o meglio, che si sta ascoltando. Un fruitore che si limitasse alla «lettera morta» dei segni musicali, o che ascoltasse non empaticamente una pur meritoria incisione, sarebbe indotto a considerare le prime misure (o i primi minuti) del Concerto per pianoforte K 450 di Mozart un ottimo esempio di incoerenza e attenderebbe con ansia che lo sviluppo rendesse più ‘mozartiana’ la partitura. Che cosa significa quello strano attacco di oboi e fagotti? Non è forse un tempo di valzer? Attraverso le note trattenute alla fine delle due frasette incipitarie non si imita forse in modo fin troppo palmare un’orchestrina di fiati che intoni una musica popolare tirolese? Quel procedere baldanzoso e il quasi-sguaiato di quelle note trattenute non ci richiamano alla memoria addirittura procedimenti tipici del liscio romagnolo? Cosa succede? La risposta ci viene, rassicurante, dal pronto intervento degli archi, che disegnano un grandioso tema introduttivo, fanno “sul serio”, suonano “in grande”, preparano con stile magistrale l’entrata del protagonista. E se le battute introduttive fossero state assegnate, parimenti, agli archi? O se almeno si fosse evitato quel “fuori luogo” delle note trattenute, che suona così simile ai valzer popolari o al liscio romagnolo? L’ascoltatore ingenuo è interdetto. Potrebbe apprezzare il ricorso all’ironia in una sezione più avanzata della composizione, dove il “tono di fondo” fosse stato già impostato, ma, così, all’inizio? Ah, quel birbante di Mozart! Eppure, davvero, non si tratta, qui, di un “tiro mancino”, ma di quella che amiamo definire “dissimulazione creatrice”. Il tono basso-popolare delle battute introduttive serve a sbigottire, a sviare l’ascoltatore, che, plausibilmente, reagirà in due modi: o crederà che la composizione vera e propria non sia ancora iniziata, e farà silenzio, perché avvertirà come imminente tale inizio, o pronuncerà un affascinato – sst! – subodorando una qualche astuzia tattico-retorica. Il secondo ascoltatore avrà colto nel segno, ma l’effetto della composizione sul pubblico sarà raggiunto in ogni modo, perché anche il primo, più sprovveduto, ascoltatore, farà silenzio, e va da sé che l’ingresso trionfale degli archi sarà accompagnato da un applauso o, comunque, da entusiasmo.
Diverso, apparentemente diverso, è il caso della torpedine-Nietzsche all’inizio del Caso Wagner: si tratta, in realtà del medesimo procedimento retorico, quello della “dissimulazione creatrice”, sebbene qui esso appaia assai più marcato. Nel noto pamphlet antiwagneriano, Nietzsche comincia subito a disporre le sue truppe: esalta a lungo, per quattro dense pagine, la Carmen di Bizet. Fin qui, niente di strano, se non si trattasse di Nietzsche, quest’uomo dal “cervello doppio”, questo partigiano “dialettico del sentimento”, e se l’opera in questione non fosse una requisitoria contro Wagner. Anziché attaccare direttamente colui che in quest’opera si è eletto a nemico – nell’Anticristo sarà “il Nazareno” stesso, ogni opera del tardo Nietzsche ha un bersaglio polemico –, Nietzsche sceglie di aprire la straordinaria palinodia, l’autodafé, la parodia feroce, con un’apparentemente ingenua esaltazione dei pregi artistici e più propriamente musicali della Carmen di Bizet. Non a caso abbiamo definito “apparentemente ingenua” la celebrazione della Carmen, ché ingenua fino al risibile essa appare al lettore, non preparato a quello che verrà dopo, la più circostanziata stroncatura del Parsifal di Wagner che sia stata mai scritta. In un certo senso, però, il lettore è già stato messo sull’avviso dal titolo: Il caso Wagner, anche se non sa in che modo questo caso verrà trattato; dalla lettura della Nascita della tragedia potrà essere indotto, anzi, a credere che si tratterà di una celebrazione. Eppure che Wagner venga definito un caso artistico, allo stesso modo con cui si discorre di un “caso clinico”, allo stesso modo con cui si parla di un “caso fortuito” o di un “caso giudiziario” dovrebbe preparare la tela, nonché il sullodato candidus lector. Ogni musicologo che legga per la prima volta questo scritto, e sia dotato di un minimo di ‘olfatto’, sta sulle difensive; legge, e non crede ai suoi occhi (o alle sue orecchie): perché Nietzsche se la prende tanto comoda, da abbozzare un insipido “saggio a parte” su Bizet? Non sa forse che pesci pigliare, cosa scrivere? Intende forse, l’Autore, esaltare ancora una volta quella mediterraneità neogreca e böckliniana ben altrimenti celebrata nelle già trascese pagine di Aurora e della Gaia scienza? Niente di tutto questo, o meglio (non si dimentichi la dissimulazione!), non crediamo. In Nietzsche l’interprete non trova certezze, è ben noto. Eppure la corrispondenza nietzscheana del periodo ci illumina su questo punto: l’apoteosi della Carmen è una cattiveria (così, sottolinando, scrive Nietzsche), una cattiveria bella e buona, malvagia perché gratuita, contro Wagner. Nietzsche si sente irritato dall’apostasia wagneriana del Parsifal, col suo ritorno all’immaginario cristiano dopo l’epica pagana della tetralogia, e a sua volta sceglie l’apostasia dal suo ruolo di divulgatore ed esplicatore del verbo wagneriano. Ma le cose non sono così semplici. Ciò che asserisce Nietzsche è, preso alla lettera, quasi sempre il contrario di quello che pensa. La dissimulazione creatrice all’ennesima potenza. Nietzsche ha una sorta di “doppio cervello” che, quando nega, afferma negando e, quando afferma, nega affermando. Insomma, nega ed afferma allo stesso tempo. Nel Caso Wagner la polemica è portata, attraverso Wagner, contro la décadence, uno dei più terribili mostri dell’«attuale», che il filosofo «inattuale» combatte, a celata abbassata, con la coerenza e la lealtà dei «cavalieri antiqui». Per un poco, come in una giostra, “si mostra” al suo avversario con la celata alzata, poi, compiuto il cerimoniale, parte all’attacco. Ma chi è, questo Wagner del Parsifal? C’è poi tanta urgenza di combatterlo? In fondo, il cristianesimo del tardo Wagner non è cristianesimo: il kérygma cristiano è trattato come un mito, e vistosamente arianizzato. Il Salvatore, anzi il Redentore, qui esaltato, non è Cristo, è Parsifal, un Cristo in terra tedesca, un Cristo – non solo per così dire, ma effettivamente – arianizzato. Trattare il cristianesimo come un mito è il miglior modo di negarlo, di distruggerlo. Dove sta mai questa ‘conversione’, contro cui Nietzsche polemizza? Quello di Wagner è un post-cristianesimo, il culto di un mondo il cui Dio è il Nulla, e al contempo, i mille aspetti della Maya. Né mancavano, nel Wagner ‘pagano’ della tetralogia, numerosi elementi epico-magici letteralmente derivati dalla mitologia cristiana, cioè da aspetti mitologico-caratteristici e folklorici del cristianesimo. Ma mai la parodia del cristianesimo era stata più evidente e irridente che nel Parsifal. Questi fatti artistici, che ognuno non manca di sentire, sarebbero sfuggiti a Nietzsche? Niente affatto. Ma, attraverso Wagner, Nietzsche combatte contro se stesso: se Wagner è preso a campione della décadence, Nietzsche corre il rischio di esserne l’ispitatore e il massimo esponente, come poi, storicamente, sia pure per fraintendimento, è stato, effettivamente è stato, nei suoi ammiratori e nei suoi sedicenti ‘epigoni’ (va da sé che Nietzsche non ha epigoni, né potrebbe averli). Da dove deriva D’Annunzio il suo superomismo? e Stefan George, il campione della décadence austriaca, non ha dedicato a Nietzsche una delle sue più azzardate poesie, un evanescente e caleidoscopico elogio funebre in cui rivolge un’impossibile esortazione al filosofo, di farsi poeta, esclusivamente poeta? (Né, d’altro canto, se s’intende poeta come poietés, cioè giusta l’etimo, George ha tutti i torti.)
Creare una ‘partitura’ così difficile, complessa, ricca di nuances come quella del Caso Wagner non è cosa d’un momento: Nietzsche aggiusta i carichi nella stiva, sposta sacchi ed anfore, regola il ritmo dei rematori, predispone gli arcieri, studia, insomma, a lungo la tattica, e questo differimento, questo piano d’assalto, costutuisce appunto l’exordium del mirabile artificium philosophicum. Cerca l’empatia con il lettore, ma non gli fa sconti: Nietzsche deve negare se stesso, operazione spirituale sommamente ‘sospetta’ e ai confini, ci si consenta l’espressione, della follia. Né lue né sifilide sono all’orgine di questa volontà, di questa promessa: un ultimo tagliare i ponti, un vento di mare, un levar l’ancora… una navigazione pericolosa verso l’ignoto, ciò che si deve ad ogni patto invenire, cioè trovare. Ed ecco il perché della strana dispositio, del recider gli ormeggi: la “dissimulazione creatrice”, che solo il lettore più accorto può cogliere – del resto Nietzsche avverte: «quest’opera si conviene a pochissimi». Saremo noi parte del ristretto insieme?
*
Symphonia extra tempora [file doc definitivo] »
Questo testo è in formato DOC (56 KByte)
*
- Musica
Symphonia extra tempora [pagina larecherche]
Symphonia extra tempora: Austria felix e «caso Mahler»
Esamineremo, qui, il “caso Mahler” e il problema del rapporto del compositore-direttore con l’establishment viennese, venato di forti tendenze antisemite. Mahler era infatti ebreo e boemo.
Per inquadrare meglio il tema, partiremo dalle osservazioni della moglie Alma Maria Schindler-Mahler, una delle massime luci nel firmamento dell’alta società austriaca, di cui peraltro condivideva non pochi snobismi e pregiudizî. Al suo fianco, Gustav Mahler non poteva che apparire un pervenu, uno sradicato insomma, un outsider; una sofferenza che, come del resto ogni sofferenza, portò frutti eccellenti sul piano artistico. E, alla fine forse della breve indagine, l’uomo Mahler diventerà indistinguibile dalla musica che ha prodotto.
Un giorno dell’estate 1910, di ritorno da una passeggiata nei dintorni di Toblach, Alma si fermò impietrita a poca distanza da casa: Gustav stava suonando i Lieder di lei, verso i quali egli aveva sempre manifestato indifferenza. Dieci anni prima, le aveva ordinato di non comporre più, ed ella si era sempre portata dietro quelle sue creature in una cartella, “come in una bara”, non rassegnandosi a distruggerle. Ora Gustav sostenne che erano eccellenti e meritevoli di pubblicazione, ed ostentò uno zelo elogiativo tanto esagerato che la stessa Alma riconobbe, onestamente, di esser stata sopravvalutata. Gustav gliene pubblicò cinque, quell’anno stesso. Vi era, tra di loro, un forte desiderio di perfetta armonia, che non dava, però, né all’uno né all’altra un po’ di felicità.
«Urgentissimo! Caro Fritz» scriveva Gustav da Toblach il 21 giugno 1910 a Fritz Löhr «traduci con me: Qui paraclitus diceris / donum Dei altissimi / fons vivus ignis caritas / et spiritalis unctio. Come si accenta e si scandisce paraclitus diceris?… Rispondi a giro di posta, per favore! Ne ho bisogno come creatore e come creatura». E il 18 luglio, sempre da Toblach: «per te sciamus da Patrem / noscamus atque Filium. È così, il testo? Come lo ordini, tu, secondo la sintassi?». E, sempre a Fritz Löhr, in una cartolina postale dal lago di Misurina: «Moltissime grazie per l’assistenza filologica. Il sanctus spiritus trasmetta a te la sua gratitudine». Così nasceva l’Ottava Sinfonia, la cui stesura era già ultimata il 18 agosto. Nell’estate del 1910, Mahler fu infaticabile nel lavoro, e ossessivo nel difendere la propria tranquillità da ogni disturbo esterno. Nei ricordi di Alma, anche nei più dolenti, c’è sempre quella strana acrimonia, ma è credibile il ritratto che ella dà dell’egocentrismo di Gustav. Guai ai rumori! Nessuno in circolazione, le bambine ridotte al mutismo, tutti chiusi nelle proprie stanze col permesso di sussurrare. Ed ecco Gustav, un pomeriggio, rientrare dal bosco, sudato e fuori di sé: «La calura estiva! Il silenzio! Il timor pànico!… La sensazione di essere fissato dall’occhio liquido, orribile del grande Pan». Quando egli lavorava in casa anziché nella casupola del bosco, Alma non poteva muoversi, cantare, suonare il pianoforte: “Le mie esperienze erano di questo genere. Non ne avevo più di mie proprie. Di questa mia rinuncia a una vita personale non s’accorgeva… Lavoro – lavoro, esistenza coraggiosa – rinuncia alla gioia personale – aspirazione all’infinito: questa era la sua vita… Interiormente mi andavo allontanando da lui, serbandogli il massimo rispetto, e speravo in qualche miracolo”. Qualcuno una volta le disse: “Alma, tu hai un essere astratto per marito, non un uomo”. E infatti, il miracolo che ella attendeva era quella “pura astrazione” accanto a lei; “ma io ero rimasta una bambina accanto a lui, nonostante le figlie e le gravidanze. E lui vedeva in me solo la camerata, la madre delle bambine, la donna di casa, e doveva capire troppo tardi quel che aveva perduto”. Amarissima, la beffa reciproca, la trappola che si erano tesi l’un l’altro. Entrambi avevano cercato nell’altro, consapevolmente, una realtà visibile in piena luce; lui, l’ascetico e scarno, la tenera bellezza e la calda vitalità, lei, morbidamente ambiziosa ed esigente, il genio e il grande amore. Lui e lei avevano trovato quel che cercavano o, almeno, avevano trovato questo. Ma entrambi, senza saperlo prima, avevano cercato nell’altro una seconda realtà, inesistente o impossibile; lui, in lei, la forza di essere come lui, lei, in lui, la possibilità di riassumere in sé tutti gli uomini da lei sognati. Non parlerei, tuttavia, di un fallimento del loro matrimonio, poiché le forze che li univano erano più durevoli di ciò che li allontanava, e le memorie di Alma restano, malgrado tutto, un documento indimenticabile.
Il 12 settembre 1910, nel Palazzo delle Esposizioni di Monaco, Mahler diresse la prima esecuzione assoluta dell’Ottava Sinfonia. Il grande numero degli esecutori, schierati nella Neue Musik-Festhalle, ispirò all’impresario Emil Gutmann la famosa definizione: Symphonie der Tausend, sinfonia dei mille. Gutmann fu ottimo mecenate della nuova creazione di Gustav tanto nella scelta della location quanto nell’invenzione del “nome di battesimo” della sinfonia, titolo che sopravvive ancor oggi e contribuisce, con il suo “effetto alone”, a sponsorizzare tutta l’attività artistica di Mahler, dove gli organici previsti sono spesso mastodontici, minotaurici. Nel padiglione trovarono posto, oltre all’orchestra del Konzertverein di Monaco, i 250 coristi del Singverein dei Musikfreunde di Vienna, i 250 del Riedel-Verein di Lipsia, i 350 ragazzi del Kinderchor della Zentral-Singschule di Monaco. Vi erano poi gli 8 solisti, tutti ottimi cantanti. L’organista era Adolf Hempel. Componevano l’orchestra 24 primi violini, 20 secondi violini, 16 viole, 14 violoncelli, 12 contrabbassi, 4 arpe, celesta, harmonium, mandolino, ottavino, 4 flauti, 4 oboi, corno inglese, 3 clarinetti, clarinetto in mi bemolle, clarinetto basso, 4 fagotti, controfagotto, 8 corni, 4 trombe, 4 tromboni, basso tuba, 3 timpani, grancassa, piatti, tam-tam, triangolo, campanelle, campanelle basse; isolati dall’orchestra, 4 trombe e 3 tromboni. La buona organizzazione del vastissimo insieme era frutto delle amorose cure di Bruno Walter. Il grande concorso di pubblico nasceva in parte dall’attrazione esercitata da tanta vastità, ed era in armonia con il clima intellettuale e culturale della città, la sfolgorante Monaco del racconto giovanile Gladius Dei di Thomas Mann, quella stessa Monaco che 129 anni prima (1781) aveva accolto trionfalmente la première dell’Idomeneo di Mozart. La cronaca cittadina di quel giorno riporta un eccezionale concorso di intelligenze venute al concerto da tutto il mondo culturale tedesco e mitteleuropeo: Hermann Bahr, Anna von Mildenburg, Richard Strauss, Lilli Lehmann, le solite presenzialiste principesse Thurn und Taxis e Hohenlohe, Paul Clemenceau, Claude Debussy, Alfred Roller, Gustav Klimt, Kolo Moser, Thomas Mann, Stefan Zweig, Hugo von Hofmannstal, Stefan George, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Willhelm Mengelberg, Arnold Shönberg, Anton von Webern, Alban Berg, Alfredo Casella, Angelo Conti, Ottorino Respighi, Siegfried Wagner, Leopold Stokowski, Max Reinhardt, Walter Gropius, Arnold Berliner, Bruno Walter, Paul Stefan.
Mai Gustav Mahler aveva presentato una sua nuova opera a un pubblico così importante e curioso. Il successo si delineò già durante l’esecuzione, nella contenuta emozione del pubblico. Fra i pochi commenti ostili, il più malevolo fu quello di Eduard Wahl, il quale concluse la sua velenosa recensione osservando: se Mahler fosse grande come compositore così com’è grande direttore d’orchestra, sarebbe il musicista che il mondo esige. Ma le reazioni furono in maggioranza molto favorevoli o addirittura ammirative, e dopo l’esecuzione il pubblico si raccolse con gratitudine attorno all’autore. Durante il ricevimento seguìto al concerto, Gustav fu commovente nel preoccuparsi che omaggi e congratulazioni toccassero anche Alma. Rimasti soli, passarono quella tiepida notte di fine estate parlando, finalmente appagati e riconciliati, mentre il diletto hund Gucki dormiva accanto a loro nella stanza d’albergo.
Fu la più grande e forse l’unica grande affermazione ottenuta da un’opera mahleriana per la prima volta eseguita in concerto. Lo stesso agio con cui gli esecutori prepararono l’Ottava, i loro buoni rapporti con l’autore, sono il rovescio del disagio con cui gli orchestrali di Praga avevano affrontato la Settima. Dopo una prova, un ragazzo del Kinderchor aveva gridato al direttore: «Signor Mahler, il canto è bello»[1]. Il caldissimo consenso del pubblico si spiega abbastanza facilmente con l’inaudito splendore sonoro della sinfonia e con il significato che ne emergeva: una fortissima affermazione della musica, un fluire ininterrotto di essere, un credo nell’inesauribile energia dell’arte. Forse il successo fu tanto più caldo quanto più si equivocò sul senso da dare a quel linguaggio affermativo: la maggior parte di quel pubblico colto credette che Mahler si affermasse nella tradizione, mentre egli si affermava contro la crisi, il che a dire il vero è quasi lo stesso, ma non proprio lo stesso. Nelle eccellenti intenzioni degli uditori, che si alzarono in piedi in lungimirante silenzio quando Mahler comparve sul podio prima dell’esecuzione, c’era forse un cattivo presagio: quel trionfo ebbe qualcosa di conclusivo, e non solo per l’autore ma per l’intera cultura occidentale, il monumento all’artista vivente si colorò di bianca luce tombale, il giubileo parve anticipare l’omaggio postumo, il tombeau. L’Ottava fu l’ultima opera che Mahler abbia offerto, sua creatura, in prima esecuzione al pubblico, l’ultima sua composizione che egli abbia potuto udire in pienezza di suono, la sua ultima e forse unica grande festa.
L’Ottava provoca e disorienta l’ascoltatore con la sua luminosità di suono, che giunge inattesa, al mahleròfilo, dopo le vaste zone d’ombra, dopo l’esplorazione d’ombra, direi quasi, delle tre sinfonie precedenti, ma anche dopo lo sfolgorìo tutto terrestre che rischiara a giorno il Finale della Settima. Tutto negativo, malgrado i travestimenti, è il sembiante delle tre sinfonie di mezzo, in cui il male di vivere filtra di qua dallo schermo delle metafore. Il negativo coinvolge le intenzioni dell’autore: l’envoi sarcastico della Quinta, solo apparentemente affermativo, con la sua rude presa in giro dei critici, di quella irsuta Quinta, opera maledetta che nessuno avrebbe capìto mai, gli annuncianti, araldici enigmi della Sesta, l’ancora più enigmatica reticenza intorno alla Settima, con i suoi continui differimenti, le sue preterizioni, le sue spiazzanti illusioni ottiche. Sacrificio, martirio e redenzione, vie di riscatto dal negativo, consumano inutilmente la loro forza di sopportazione: non si trovano mai vie d’uscita nella Quinta, sacrificio martirio e redenzione falliscono nella Sesta poiché il balzo non raggiunge la meta, si umiliano nella sardonica irrisione della Settima.
La disposizione “religiosa” che il riscatto dal negativo ha in Mahler va definita accuratamente. La religione mahleriana non può mantenersi fedele ad alcuna ortodossia, né ebraica né cattolica, poiché al suo intento di puntellare con frammenti le rovine di una tradizione, o di trapiantarne la vegetazione, è necessario l’eclettismo. È singolare la convergenza tra il modus operandi musicale di Mahler e quello filosofico di Emanuele Severino. Il Veni Creator dell’Ottava Sinfonia trova analogie finissime nel Paradiesgärtlein terrestre e tardo-gotico della Quarta Sinfonia, alla maniera di Martino di Bartolomeo senese o dell’Oberrheinischer Meister nello Städelsche Institut di Francoforte, così come il santo della Predica ai pesci (Fischpredigt) è figura di fiaba, non di paradiso. Un tema che merita sviluppo, all’interno dei confini di questa trattazione, è la bivalenza dei modelli sonori e di quelli visivi nelle sinfonie mahleriane e, più in generale, nella produzione musicale della belle époque di area mitteleuropea. I modelli visivi sono meno “cattolici” o addirittura più “protestanti” dei modelli sonori; in termini meno approssimativi, sono più germanici e meno europei. L’eccesso di Eros è frenato in castità. Nell’opera mahleriana, l’eros si scompone su diversi piani: il völkisch tardoromantico in Hans und Grethe, il crepuscolare con presagi espressionistici nei Gesellenlieder, l’allucinato nella Sesta, il delirante nelle parole, fantastiche e sognanti, annotate sul tormentatissimo manoscritto della Decima.
Così le tre sinfonie “di mezzo” (Quinta, Sesta e Settima) ci aiutano a indagare la natura religiosa di Mahler, tema tanto più spinoso quanto più lo si districa. Mahler, facendosi cattolico (la sua “conversione” non è atto machiavellico), vuole inserirsi in una tradizione sicura: la metafisica cristiana lo affascina attraverso la cultura letteraria e musicale austro-tedesca: Arnim e Brentano, Eichendorff, Goethe, Novalis, il Dante germanizzato da Friedrich Schlegel. In questo territorio, il Mahler religioso percorre con moto pendolare la distanza tra i due poli: il paradiso e la fiaba, entrambi rifugi per il suo cuore di poeta, non-luoghi dove trovare finalmente comprensione e appoggio, e in Dio Creatore un ispiratore e un promotore delle arti. I due termini riassumono, in Mahler, il bene e l’affermazione; il negativo è in mezzo, ed è un percorso, un continuo allontanarsi da qualcosa. Ernest Ansermet osserva che le sinfonie di Mahler ci conducono attraverso sentieri interrotti, viziosi, senza apparente via d’uscita, veri desolation rows (per citare un altro grande ebreo, Bob Dylan), quando all’improvviso si sente una voce profetica che interrompe il cammino, secondo una modalité juive. Partendo da premesse lontane, ma convergendo nel giudizio con l’intuizione di Ansermet, Adorno scriveva nello stesso anno: “Mahler appartiene a una civiltà musicale di cui ha assorbito profondamente il linguaggio pur contrastando con essa, e questo costituisce lo spazio immenso del suo linguaggio, banale ed estraneo ad un tempo: e la sua estraneità si è rafforzata proprio mediante l’eccessiva familiarità… In Mahler elementi correnti ed empirici si presentano in una configurazione analoga alla lingua di uno Heine”. Mahler, ebreo, porta con sé la schiacciante eredità delle vittime. Heine, nel romanzo Il rabbi di Bacharach, assume la tragedia presente nella storia ebraica e la incorpora nell’àlveo della tradizione austro-tedesca, da dove non è più possibile rimuoverla. L’ebraismo ha trovato nella cultura mitteleuropea una casa e la concreta possibilità di una propria promozione e di un rilancio su scala mondiale, grazie alla capacità di assorbirne il linguaggio senza sottomissione. Heine è avvocato eloquente della nobiltà e insieme dell’abilità della vittima. In Mahler, la heiniana denuncia della vittima diventa il vittimismo dell’eroe che lotta senza alleati, il quale però scongiura l’indifferente e il banale a prezzo della propria infelicità. Eroismo in contesto di antimecenatismo. L’opera di Mahler si chiude con la persuasione che è arduo all’artista moderno essere eroe senza essere vittima.
Quello che ho appena detto smentisce in gran parte il possibile schema secondo cui Mahler sarebbe “ebraico” nella Quinta, Sesta e Settima, e “cattolico” nell’Ottava. Resta viva una serie di questioni, cui qui accennerò soltanto, la prima delle quali è il forte contrasto tra l’Ottava e le sinfonie precedenti. L’Ottava non fa parte dell’“ultimo stile” mahleriano, che comprende soltanto Das Lied von der Erde, Nona e Decima; è un’inserzione eterogenea rispetto ai due gruppi confinanti, e riassume e amplifica tendenze apparse nella Seconda e nella Terza. Molto meglio è dire che il volto inatteso dell’Ottava, e il suo contrasto con la trilogia in ultimo stile, quella dell’“addio al mondo”, mostrano la totale indipendenza di Mahler dall’ideologia della musica. Sì, perché anche in musica c’è (c’è stata) ideologia (troppa), ed essa ha spesso condizionato l’accettazione o la non accettazione di ogni nuova opera. Sino agli anni ’50 del secolo scorso chi non era “ideologizzato” (e nella fattispecie sposato con il partito progressivo e “progressista” della musica di Schönberg), non solo rischiava di rimanere ostracizzato, ma era senza dubbio e in ogni senso “tagliato fuori”, brancolando nell’ombra, nella totale impossibilità di trovare impresarî, sponsor, editori importanti, recensori benevoli, sottoscrittori, finanziatori, insomma, mecenati. La frase di Schönberg, on revient toujours, esige un senso più temerario di quello, quasi esclusivamente nostalgico, dichiarato dall’autore dei Gurrelieder: deve, una buona volta, significare che ogni linguaggio è lecito, se la possibilità o la necessità o la felicità della musica, ed esse soltanto, lo rendono legittimo. Dopo la Settima, dopo la scoperta che la musica non è esaurita e può continuare, dopo la disillusione del procedere rettilineo, le ultime opere di Mahler sperimentano tutto ciò che la storia della musica svilupperà: il tonalismo ad oltranza, il primitivismo in direzione esotica, il bruitisme, persino la Neue Musik… L’esperimento si compie entro il tonalismo, malgrado scatti di dirompente tensione: ciò ha senso proprio rispetto all’audacia della sperimentazione, che deve scegliere un linguaggio riconoscibile se vuole provocare.
La volontà di affermarsi contro la crisi sostiene in Mahler un forte desiderio di potenza di comporre, che è tutt’altro dal potere nell’«ambiente» musicale, privilegio che a lui non fu concesso o fu concesso ad altissimo e insopportabile prezzo. Contraltare di quel desiderio è un austero ed egocentrico mea culpa. Ma come la versione moderna dell’assoluto e dell’infinito è un gigantesco accumulo, così la versione moderna della rinuncia e dell’umiltà è la disperazione e lo smembramento di sé. Risultato musicale è il frammento, e non stupisca che esso abbia rapporto con l’Ottava, trionfo dell’organico e dell’unitario. Già Paul Bekker osservò che l’Ottava è tutta costruita di venature tematiche le quali non derivano l’una dall’altra, né sono variazioni o filiazioni di un gruppo di motivi-guida, ma sono ciascuna una famiglia a sé. Non meno che in altre opere tarde, nell’Ottava il procedere delle parti in autonomia urta sovente contro i limiti della tonalità, facendo forza. Il coesistente desiderio di unità organica, di unitarietà inscindibile tende a porre in forte rilievo gli elementi della tradizione, ostentandoli e talora enfatizzandoli[2]. Il rapporto con la tradizione diviene pericoloso, per Mahler, quando investe il sistema culturale cristiano, la sua metafisica, i suoi dogmi.
È inevitabile la domanda se l’Ottava, fra le opere mahleriane, Symphonia extra tempora, sia una sorta di “messa” disguisata, rappresentando, sia pure nel modo più eterodosso pensabile, un genere musicale che in Mahler è assente e in cui Bruckner aveva raggiunto esiti gloriosi. Sappiamo che Alfred Roller sollecitò più volte Mahler a comporre una messa, e che ne ebbe in cambio la domanda: «E il Credo?». Di fronte agli oggetti della fede, Mahler era più sradicato di Verdi, che volle essere “italiano” nel Requiem e finì, contro voglia, “cattolico”; più di Brahms, che nella sua eterodossia di ateo protestante (appassionato lettore della Bibbia) ebbe un modello ortodosso nell’Actus tragicus di Bach. Composta in appena otto settimane, l’Ottava era stata ideata da Mahler in quattro parti: a) Inno Veni Creator Spiritus; b) Scherzo; c) Adagio Charitas (un’antica predilezione, fin dai tempi della Quarta); d) Inno La nascita di Eros. È notevole il fatto che l’idea delle ultime tre parti, in cui s’indovina un progetto dionisiaco e progressivamente non cristiano, sia stata cancellata e sostituita, mentre sopravvive il sublime testo attribuito a Hrabanus Magnentius Maurus, discepolo di Alcuino, nato a Magonza nel 784 e morto arcivescovo della sua città nell’856. È probabile che il Veni creator spiritus abbia attratto Mahler soprattutto con ciò che a lui era misterioso e sfuggente alle sue deboli conoscenze del dogma cristiano (in una lettera a Zelter del 1821, il non cristiano Goethe scrisse che il Veni creator è fatto apposta per interessare un compositore di musica. Beethoven, tra il marzo 1825 e il maggio 1826, abbozzò un Veni creator in fa maggiore, la cui prima battuta mostra un motivo curiosamente costruito sullo stesso intervallo di quarta discendente che apre il tema mahleriano), e ne fanno fede le impazienti perplessità dinanzi alle parole latine, e i lumi chiesti a Fritz Löhr (che ho citato sopra). Più che mai eterodosso è l’accostamento dell’inno medievale (dove è citata la Charitas, forma medievale per il lemma classico Caritas) con la seconda, immensa parte della sinfonia, composta sulla scena finale del Faust di Goethe. Secondo Jean Matter, il Veni creator è l’elemento maschile, il Padre, mentre il finale del Faust, con il richiamo all’ewig Weibliches, è l’elemento femminile, la Madre; secondo Egon Gartenberg, straordinario esegeta e primo promotore della “riscoperta” della sinfonia, l’eterogeneità tra i due testi nasce dalla volontà di armonizzare l’elemento latino con quello tedesco, il cattolico con il protestante: ancora una volta, i due elementi associati che per Mahler, nato ebreo e boemo, sono la tradizione.
La necessità di tradizione si accompagna all’angoscia della fine: ciò che molto è costato acquistare, diviene il possesso più prezioso, e più tragica è la sua perdita. Di qui il desiderio di consumare fino in fondo, prolungandolo, il momento finale. Già mi capitò di interpretare questo stato d’animo in una mia poesia, Il giardino è intristito, pubblicata nel 2006: «a lungo si sofferma fra le rose – / ardentemente aspira alla sua morte. / E lenta chiude gli occhi affaticati»[3]. In quella prolungata fine, Mahler immette l’inesauribile energia della musica, e ne è annuncio la lettera a Mengelberg del 18 agosto da Maiernigg: «Ho appena finito la mia Ottava: è la cosa più grande che io abbia fatto finora, così fuori dal comune, nel contenuto e nella forma, che è impossibile darne notizia qui per iscritto. Immaginiamo che l’intero universo cominci a ruotare con clangore di suoni e di echi. Non sono più voci umane, ma pianeti e soli ruotanti». Costruita con pienezza di fiducia nell’energia musicale, l’Ottava pare collocarsi al termine della via tracciata dalla Nona di Beethoven: non più una sinfonia con cori, bensì per cori. Più estesamente, essa è al termine di un processo che parte da Giovanni e Andrea Gabrieli e attraversa Palestrina, Orlando di Lasso, Victoria, senza trascurare possenti suggestioni bachiane. Ciò che nella grande tradizione liturgica, ispiratrice di Mahler, è circolare, nell’Ottava è a spirale, come nelle intuizioni del vorticismo poundiano. Qui Mahler confina con Bruckner, il sinfonista d’insuccesso privo di mecenati ma non di modelli, o addirittura ne invade il territorio, ma il sembiante bruckneriano della melodia e del ritmo si assoggetta sempre a volute, ondulazioni, linee spezzate.
Le due parti in cui si articola l’Ottava sono asimmetriche: la seconda ha 1574 battute contro le 581 della prima, e dura 55 minuti contro 23 (ca.). Il primato dei più lunghi tempi sinfonici mahleriani spetta al primo tempo della Terza e all’ultimo della Sesta, poiché la scena conclusiva del Faust non è un tempo di sinfonia, né l’Ottava, propriamente parlando, è una sinfonia. È notevole la diversità timbrica: nella prima parte, il contrappunto è sviluppato nelle voci soliste e nei cori, lo è meno negli strumenti, i temi sono affidati spesso ai legni; nella seconda prevale il melos nell’orchestra e nelle voci, e gli ottoni assumono una decisa funzione tematica. Nell’edizione della sinfonia, l’autore aggiunse all’organico della prima esecuzione un pianoforte, un Glockenspiel e un secondo clarinetto in mi bemolle. Il Glockenspiel ha una parte breve (seconda parte, sez. 81-88) ma intensamente espressiva; il pianoforte entra nella battuta 778, all’unisono con le arpe, e poi con arpeggi, ottave e tremoli fino alla bt. 869 (il Bei der Liebe della Magna Peccatrix), e ritorna all’unisono con le arpe, più a completarne la sonorità che a rafforzarla, nelle btt. 1386-1450. In una sinfonia così ardua è onnipresente l’ossessivo scrupolo direttoriale di Mahler. Valga come esempio il nicht eilen! su un tremolo dei flauti (seconda parte, bt. 476) fin troppo simile a un noto passo nel Finale della Settima, uno straniante tremolo dei flauti (btt. 335-336) che molto piacque a Schönberg. La consapevole autocitazione e la volontà di allontanarla nel tempo mutando la sua qualità spiegano l’annotazione in partitura, tutt’altro che superflua.
La prima parte comincia (Allegro impetuoso) e conclude in mi bemolle maggiore. Dopo l’accordo pieno dell’orchestra, di cui l’organo accentua le profondità, la ripetizione della parola Veni è il modello melodico del primo grande tema, e contiene anche una generale indicazione di lavorìo tematico: «Costruire!». Il lavorio, grado a grado, s’intensifica e culmina con la tempesta contrappuntistica che muove dalla bt. 367 (Accende lumen sensibus). In tutto l’inno, l’energia si brucia e si rinnova continuamente, nell’ossessione di un sempre rinnovato ritorno all’accordo perfetto. L’ossessione di Mahler non sembra avere per limite, per punto di deflagrazione, un “delirio interpretativo della realtà” o un sogno gratuito alla don Quijote: nasce e discende invece “dagli altri”, procede dagli altrui errori di giudizio e dalle altrui, singole e collettive, carenze di contenuto culturale-religioso. Ha per origine, ed elegge quindi a sua cifra polemica, la follia e la cretineria “degli altri”. Ciò non toglie che egli stesso abbia potuto errare: e ai propri errori non chiede lacrimando clemenza. Quando l’energia si placa la prima volta (btt. 141 ss.), si entra in un’atmosfera mahleriana vecchio stile, e pare che brandelli di nuvole salgano, dalla zona delle sinfonie mediane, ad intristire per breve tratto tanta luminosità. In tutto il Veni creator si alternano, a rappresentare musicalmente da un lato la soggettività dell’autore e della sua grande autobiografia sinfonica, dall’altro l’assoluta oggettività dell’inno medievale e della teologia che lo percorre, elementi “mahleriani” ed elementi “diversi”, felicemente (ma non facilmente) fusi, poiché anche la soggettività mahleriana è sempre in comunicazione con l’esterno – e mai solipsistica. Niente faciloneria, ma un felicissimo lavorio incessante. Esempio dei primi elementi, peregrini in partitura, son taluni acutissimi richiami, come le terzine “brahmsiane” dei violini alla bt. 83, il souvenir della Quarta nella bt. 141, le campanelle basse nelle btt. 174-211. Gli altri elementi, dominanti per frequenza e compiutezza, si ritrovano nei momenti cruciali del discorso e nei nodi centrali dell’architettura: tale è il tema “chopiniano” in re bemolle maggiore, affidato a oboi e corno inglese, sulle parole Imple superna gratia, o la rara melodia “straussiana” del baritono, Infirma nostri corporis (del tutto irregolare nella distribuzione degli accenti). Chiave di volta dell’inno è il Gloria, gloria cantato dal Kinderchor: il suo sembiante infantile si fonda su un’elementare e insolita scrittura melodica, che parte dalla tonica, re bemolle, tocca il fa inferiore, raggiunge il fa all’ottava superiore, torna alla tonica. In tutta la prima parte dell’Ottava, la materia tematica non sfugge alla fortissima influenza del testo e della sua regolarissima prosodia tradotta accentuativamente nei versi latini medievali. La linea ascendente o discendente della melodia, e soprattutto il ritmo degl’incisi e delle frasi musicali, si adattano mirabilmente alle parole sdrucciole con cui ogni verso termina: spiritus, corporis, gratia, sensibus. Il ritmo proparossìtono e la scandita regolarità delle parti (talvolta con effetto di declamato, per es. nel sublime e reiterato Superna… Superna… Superna Gratia) sono il nesso qualitativo che caratterizza il Veni creator mahleriano. Invece dei vuoti angosciosi delle altre sinfonie, qui domina il pieno, ma la materia è leggera, poiché il volume di suono tende ad essere tenue, malgrado la traboccante ricchezza orchestrale, l’esuberante gioco cameristico dei timbri esotici e sensuali.
La scena finale del Faust comincia in mi bemolle minore (Poco adagio), e il rapporto di questa tonalità con quella iniziale rievoca, in dimensioni ingigantite, il celebre stilema «originario» nato in Mahler con le sue primissime composizioni, e dipoi sempre seguìto, in maniera quasi autocitazionistica, nello sdipanarsi, via via, delle varie sinfonie. Altri rapporti vengono alla luce. Sul tremolo iniziale, segno di attesa e di tensione, il motivo dei flauti e dei clarinetti, dopo la studiata esitazione della prima semifrase, indica la direzione col suo moto ascendente: l’ascesa non è ancora compiuta. Il Veni creator, con il suo fiammante svettante ardore liturgico, è più terrestre di questo finale goethiano. Infatti, nell’inno medievale la musica mahleriana non sale in cielo: è l’apoteosi pagana dello splendido mecenatismo cattolico, è una cattedrale affollata e altissima (colonne d’incenso s’alzano di tra le navate…), ma pur sempre terrena, luogo della Chiesa militante, dell’Ecclesia triumphans. È una singolare commistione di religiosità ed estetismo. L’ascensione a spirale avviene soltanto nella seconda parte dell’Ottava, e i burroni montani (prescritti da Goethe) da cui essa parte sono il punto da cui si spicca il volo, come alla fine del Purgatorio dantesco. Nessuno, credo, ha notato che il motivo dei flauti e dei clarinetti sul tremolo degli archi (btt. 4-6) ha forti ascendenze in Das klagende Lied. È assai più che una reminescenza. È l’ingresso in un mondo nordico, slavo, fiabesco, diverso da quello della prima parte. Il richiamo alla partitura giovanile («Il mio opus 1!» come ebbe a dire Mahler) è anche una reintroduzione dell’ascoltatore nel mondo slavo-germanico, e sembra dire: «Ecco… ecco come quel mondo è incominciato». Questo è un primo e sicuro elemento nella seconda parte dell’Ottava. Altri vanno cercati di tra le venature di cui parlò Paul Bekker: se sono frammenti, hanno un’immensa profondità allusiva, e protendono le radici verso referenti tanto lontani quanto illustri. La scoperta (inventio) degl’ipotesti è lavoro lungo e insidioso, né pretendo di esaurirla, qui, con pochi riferimenti piuttosto sicuri, né la materia della mia trattazione mi consente di dilungarmi oltre: che se ne parli, ancora, in futuro, se ne discuta, se ne scriva; «tempo perso non sarà». Quelli che ho chiamato “referenti” sono, in realtà, ampie zone di stile e di cultura musicale riemergenti… Nelle btt. 30-60 è citato il Finale della Seconda, e la sua eco persiste fino alla bt. 96, intrecciata, contesta con alterni richiami a Das klagende Lied. Dalla bt. 147, il discorso musicale ripropone ritmi e melodie della Terza, rievocando col timbro dei flauti il breve coro infantile (Bimm! bamm!) del quinto tempo. Il motivo dei flauti è cellula del grande tema, il più importante della seconda parte, disegnato ampiamente in mi bemolle maggiore dalla voce del Pater extaticus (Ewiger Wonnebrand). Lo sviluppo di questo tema, nel vero e proprio Lied Ewiger Wonnebrand, forse la pagina più ispirata dell’intera sinfonia, ha lineamenti schumanniani, stile da oratorio romantico (Il Paradiso e la Peri), e una concezione autenticamente drammatica e scenica, del resto condivisa da numerosi altri passi dell’Ottava. Rimangono nella partitura le didascalìe del poema drammatico, e ciò è poeticamente giusto e necessario soprattutto là dove le parole Mater gloriosa schwebt einher (“la Mater gloriosa viene avanti, librandosi in volo”) definiscono tutta una zona strumentale, e lasciano, come nella tragedia antica, alla fantasia visiva dell’ascoltatore la comparsa dell’altissima femminilità sovrastante il nobile e “lisztiano” tema in mi maggiore cantato schwebend dai primi violini. I due ultimi temi citati sono dunque svianti rispetto alla consueta fisionomia mahleriana; per contrasto, ha l’effetto di una rivelazione o di un’agnizione l’entrata del Pater profundus (Wie Felsen), che anticipa, nell’invenzione melodica e timbrica, nell’armonia e nel ritmo, la prima parte di Das Lied von der Erde. Questo dualismo di caratteri, proiettati verso il passato e verso il futuro (il “futuro passato”, già vissuto, nell’estasi dell’intuizione), corrisponde ad uno dei più consapevoli intenti seguiti da Mahler nell’Ottava, e nella seconda parte, intimamente sua, più che nella prima: ri-conoscersi e individuarsi nella propria personale storia (nel vissuto) di pubbliche angosce e di crisi universale, per ottenere e aver poi la libertà di rappresentare una sfera trionfante e immune da crisi e angosce. Di fronte a questa verità, suona splendido nella forma e commovente nel suono ma assai meno necessario il richiamo da ultimo, affidato ai tromboni, di un inciso già comparso nel Veni creator: un tentativo di rinnovare, con una sorpresa in extremis, la struttura ciclica già presente nella Settima. L’intenzione si accorda con la tonalità conclusiva, la stessa da cui muove l’intera sinfonia: mi bemolle maggiore. L’accordo perfetto corona (finis coronat opus) il grande disegno in cui Mahler, sincero ammiratore della confessione sacramentale cattolica, si «confessa», nel sogno di sussistere perennemente, immune da ogni consunzione terrena, in un cielo metafisico. Il disegno è bello e non finito, ma effimero. Videant doctiores.
Paolo Melandri
1 giugno 2014
[1] L’armonia di rapporti appare più notevole in relazione all’eterogenea quantità degli esecutori, la cui somma, grazie all’aumento delle percussioni avvenuto all’ultimo momento, fu di 1030.
[2] Nell’Ottava, si direbbe quasi che Mahler voglia escludersi dalla cultura musicale d’avanguardia del primo Novecento. Si pensi alle sue discussioni con Schönberg, alla sua negazione della Klangfarbenmelodie in teoria; sappiamo che, in pratica, ne fece uso nelle ultime sue musiche.
[3] Paolo Melandri, Novellette, Faenza (Casanova Editore) 2006, p. 21.
*
Symphonia extra tempora Austria felix e caso Mahler »
Questo testo è in formato DOC (55 KByte)
*
- Musica
Il contesto musicale del Requiem di Mozart
Il contesto musicale del Requiem di Mozart
È possibile che la commissione del Requiem, come tale, fosse stata di secondaria importanza per Mozart, a parte la sempre benvenuta prospettiva di guadagno. Essendogli giunta avvolta nell’anonimato, egli non poteva conoscere l’impiego del suo lavoro come messa in suffragio della contessa Walsegg, e tantomeno dunque porsi in rapporto con particolari esigenze dell’ambiente di destinazione. Nondimeno, anche in vista del progetto concepito sin dal maggio 1791 di puntare alla nomina di Kapellmeister della cattedrale di Santo Stefano, gli sarà parso importante scrivere un’opera per il repertorio liturgico che gli permettesse di tornare felicemente a un “genere di composizione che prediligeva”, la musica sacra, oltre che di rinnovare e ampliare la conoscenza che aveva accumulato nello stile da chiesa[i]. Tanto più credibile risulta la testimonianza di Constanze Mozart secondo cui suo marito «le raccontò di questa strana commissione [di comporre il Requiem], manifestandole il desiderio di cimentarsi per una volta in questo genere di composizione, tanto più che lo stile patetico elevato della musica sacra era sempre stato nelle sue corde».
Cosa intendesse Mozart per “stile patetico” lo spiegano le fonti letterarie del tempo. Johann Christoph Adelung, ad esempio, proprio per definire lo stile patetico scrive che “esso intesifica ogni idea potenziando gli affetti”[ii]. E sul concetto di ‘patetico’ Johann Georg Sulzer scrive: «In un’opera d’arte c’è pathos quando si trattano argomenti che riempiono lo spirito con quelle fosche passioni [elencate sopra: il timore, lo sgomento e la cupa malinconia] […] in musica il pathos prevale in modo particolare nei brani sacri e nell’opera tragica, sebbene quest’ultima raramente arrivi a tali altezze. Il coro funebre dell’Ifigenia di Graun è molto patetico; e si dice che ci sia molto pathos anche nell’Alceste del Cavalier Gluck»[iii]. Considerata l’esperienza di Mozart in campo operistico, e in vista delle molteplici e marcate espressioni patetiche che il soggetto di un Requiem poteva fornirgli, è facile comprendere il suo desiderio “di cimentarsi per una volta con questo genere”[iv].
Nella maggior parte dei generi musicali in cui operò, spesso per la prima volta, nell’ultima decade della sua vita, Mozart apportò nuovi e fondamentali impulsi che, in molti casi, cambiarono il corso della storia della musica.
Negli anni 1790-91 questa tendenza, tutt’altro che in declino, si stava semmai accentuando. In particolare Così fan tutte (K 588), la sua ultima opera buffa (completata nel gennaio 1790) rivela, di contro a una maggiore economia di mezzi (ci sono per esempio solamente sei ruoli da solista, rispetto agli otto del Don Giovanni e agli undici delle Nozze di Figaro), un più intenso sfruttamento inventivo di tutte le possibilità musicali. Analogamente, nei Quintetti d’archi in re maggiore K 593 e in mi bemolle maggiore K 614, nel Concerto per fortepiano K 595 (l’ultimo di Mozart), e nel Concerto per clarinetto K 622 si manifesta un’intensificazione dell’elaborazione motivica accompagnata da una crescente semplificazione ritmico-melodica. Ma allo stesso modo vanno intese l’evidente sfrondatura dell’opera seria tradizionale in La clemenza di Tito (K 621)[v] e la concezione del Flauto magico come una grosse Oper malgrado la rinuncia al recitativo secco (in omaggio alla tradizione del Singspiel)[vi].
[i] Cfr. Franz Xavier Niemetschek, Leben des K. K. Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Originalquellen beschrieben, Prag, 1798; 2a ed. Ampliata, 1808. Trad. it. in Mozart, a cura di G. Pugliaro, Torino, edt, 1990, pp. 50-51: “La musica sacra era il genere di composizione che Mozart prediligeva. Ma era anche quello che aveva meno occasione di praticare […]. Mozart avrebbe mostrato le sue piene potenzialità in questo genere musicale, di fatto, solo se avesse ottenuto il posto alla chiesa di Santo Stefano; ne era impaziente. Quanto sarebbe stato fertile il suo talento applicato allo stile alto della musica severa da chiesa è provato dal suo ultimo lavoro, la messa da requiem, che certamente supera ogni altra precedente realizzazione in questa sfera”.
[ii] Johann Christoph Adelung, Über den deutschen Styl, Leipzig, 1785, 2, §396.
[iii] Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, 4 voll., Leipzig, 1771-1774, 4a ed., 1792-1799, ristampa Hildesheim, 1967.
[iv] F. Xa. Niemetschek, op. cit., pp. 32-37 [trad. it. pp. 45-48]. Vd. supra.
[v] “Ridotta à vera opera” scrive Mozart stesso nel suo catalogo delle proprie opere, per caratterizzare il vecchio libretto di Metastasio revisionato e riscritto da Caterino Mazzolà.
[vi] Il sottotitolo originale del libretto del 1791 recita: “Eine grosse Oper in zwey Aufzüngen”.
*
- Cultura
Due vie per gli studi
Due vie per gli studi. Un saggio storico-pedagogico
Diverso è il piano di studi che si propone chi mira al solo guadagno, unicamente al proprio «riscatto sociale», alla propria immissione nella «società che conta» (scopi in sé rispettabilissimi, ma non motivanti autenticamente), da quello che liberamente sceglie una “testa pensante”. Chi mira esclusivamente con la sua assiduità ad adempiere le condizioni in cui potrà rivestire una carica e partecipare ai suoi relativi vantaggi, che mette in moto le energie della mente soltanto per migliorare la propria condizione materiale e soddisfare una meschina vanità, entrando nella carriera degli studi non avrà preoccupazione maggiore che scindere quelle scienze che egli chiama «sgobbo per il pane», cioè erudizione per campare, da tutte le altre che allietano invece lo spirito in sé, «in quanto spirito». Egli crederebbe di sottrarre alla sua professione futura il tempo dedicato a queste ultime e non si perdonerebbe mai questo furto. Egli indirizzerà ogni sua assiduità a seconda delle esigenze impostegli dal futuro padrone della sua sorte, e crederà di aver fatto tutto rendendosi capace di non temere quel giudice. Quando ha percorso i suoi studi e, non senza difficoltà, raggiunto la mèta dei suoi desideri, abbandona le proprie guide: perché infatti continuare a curarsene? Primo suo compito è ormai mettere in mostra i tesori raccolti nella memoria, per evitare che essi possano diminuire di valore. Ogni ampliamento del suo “sapere per il pane” lo inquieta, imponendogli un lavoro o portandolo a non utilizzare quello già fatto; ogni importante innovazione lo turba infrangendo l’antica forma scolastica di cui si era così faticosamente appropriato, lo mette in pericolo di perdere l’intera fatica della sua vita di ieri. Chi ha inveito contro i riformatori più della schiera di questi “studiosi a fini pratici”? Chi ritarda la marcia delle utili rivoluzioni nel campo del sapere più di costoro? Ogni luce accesa, in qualunque scienza, da un genio produttivo e felice, rende evidente la loro miseria; essi lottano con accanimento, con perfidia, con disperazione, perché, difendendo un dato sistema scolastico, combattono insieme per la loro esistenza. Non vi è quindi un nemico più inconciliabile, un burocrate più invidioso, un istigatore più intransigente di questo tipo di erudito. Quanto meno le sue cognizioni gli sono compenso in se stesso, tanto maggior remunerazione cercherà dal di fuori; per il profitto degli imprenditori, come per quello degli studiosi, egli non ha che una misura: la fatica. Perciò nessuno tanto si lagna dell’ingratitudine quanto questo tipo di “studioso… a fini pratici”; egli non cerca la sua ricompensa nei tesori del pensiero (non crede, infatti, in ciò che studia), ma la attende dal riconoscimento altrui, dalle cariche onorifiche, dalla carriera. Se questa fallisce, chi più infelice di lui? Egli ha inutilmente vissuto, vegliato, lavorato; ha cercato invano la verità, perché la verità non si è trasformata per lui in denaro, in lodi pubbliche, in favori da parte dei politici di turno.
Quanto è degno di pietà l’uomo che con il più nobile degli strumenti, con la scienza e con l’arte, non cerca e non ottiene nient’altro di più di quanto ottenga il commesso o il “badante” con i più rozzi, che serba dentro di sé nel regno della più alta libertà un’anima da schiavo. Ma ancor più degno di pietà e di pensosa commiserazione è il giovane di genio, il cui cammino, bello per «meriti innati», vien fatto così pietosamente deviare da convinzioni e da insegnamenti dannosi, che si è lasciato convincere a far provviste soltanto per la professione futura con meschina pedanteria. Ben presto il sapere professionale, in quanto frammentario, gli darà disgusto; si desteranno in lui desideri che quel sapere non può soddisfare, il suo ingegno si ribellerà al suo destino. Frammentario gli sembra ormai tutto quanto egli compie, non vede scopo alcuno al suo lavoro né sa sopportarne l’inutilità. È oppresso dalla fatica e da quella che gli appare la futilità della sua professione, così macchinalmente pianificata che chiunque potrebbe svolgerla in vece sua, non potendo opporvi quell’animo sereno che si accompagna soltanto alla matura riflessione, all’entusiasmo per la totalità intuìta. Egli si sente strappato dal nesso delle cose, e a ragione, perché ha trascurato di inserire la sua attività nella grande unità politica e sociale del mondo. Il giurista perde amore alla sua scienza giuridica appena la luce di una più ampia cultura gliene illumina le lacune, invece di aspirare ad esserne un nuovo creatore ed a correggerne con la propria passione i difetti scoperti: quale «potenziale umano» e culturale si perde così – purtroppo tutti lo abbiamo sotto gli occhi.
*
- Letteratura
La Germania in Thomas Mann
Ecumenismo e identità nazionale. «Considerazioni inattuali» sul ruolo della Germania in Europa attraverso una disamina dell’opera di Thomas Mann
Vergleiche dich! Erkenne, was du bist!
Goethe, Torquato Tasso
Dice Dostoevskij, in un suo scritto sulla comparsa dell’«anima slava» nel dissonante «concerto europeo»: «si credeva che l’ideale degli slavofili fosse quello di “mangiare ravanelli e scrivere denunce”. Già, denunce! Così come apparvero, con quel loro modo di vedere le cose, stupirono al punto che i liberali incominciarono a impensierirsi, ad aver paura: che putacaso quella stramba gente volesse alla fin fine denunciare loro?»[i].
I contrasti che allentano e rendono problematica l’intima unità e «compattezza spirituale»[ii] delle grandi comunità europee, sono a un dipresso ovunque gli stessi, in sostanza sono «un fatto europeo»[iii]. Tuttavia hanno caratteristiche profondamente diverse da popolo a popolo e si amalgamano, nel loro complesso, con l’insieme della propria nazione. Avviene così che un francese politically correct e radical chic sia un francese autentico, schietto, intero e inequivocabile, giusto quanto può esserlo un francese clarical-lefévriano, e un inglese conservator-liberale sia inglese esattamente quanto un suo compatriota social-progressista; tutto sommato, un francese si intende con un francese, un inglese con un inglese meglio che con chiunque altro e comunque benissimo.
Esiste invece un paese, un popolo, dove le cose stanno in un altro modo: un popolo che non è nazione in quel senso sicuro e scontato per cui i francesi o gli inglesi formano una nazione, e forse non lo sarà mai perché la storia della sua formazione, il suo concetto di umanità si oppongono a che lo diventi; un paese la cui intima unità e compattezza, per quei contrasti spirituali e antropologici (non ideologici ma, semmai, post-ideologici), vengono ad essere non solo complicate ma addirittura quasi annullate; un paese in cui quelle contraddizioni si rivelano più impetuose, più radicali e maligne, meno conciliabili che in qualunque altro posto – e questo avviene perché in quel paese esse non sono affatto tenute unite, o solo a mala pena, da un legame nazionale, né le tragiche esperienze del XX secolo sono in qualche modo sussunte in una visione d’insieme, come avviene invece in ogni altro popolo, nell’ampio perimetro delle contrastanti posizioni dell’opinione pubblica. Questo paese è la Germania. I dissidi «spirituali»[iv] della Germania sono stati – e ancora sono – dissidi assai poco nazionali, quasi puramente europei; privi, o quasi, di una comune ‘tinta’[v] nazionale, gli elementi in contrasto si fronteggiano senza comporsi in una sintesi. Nell’«anima della Germania»[vi] vengono gestiti i contrasti spirituali dell’Europa, gestiti nel senso della maternità e in quello della rivalità. Questa è la mission peculiare, nazionale, della Germania, la quale resta sempre il campo di battaglia, anche se non più fisico – questo è riuscita ad impedirlo di recente, a partire dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso – almeno spirituale dell’Europa. E quando diciamo l’«anima tedesca» non intendiamo soltanto l’anima della nazione nel suo insieme; ma, come Thomas Mann[vii], intendiamo invece proprio l’anima singola, la testa e il cuore dell’individuo tedesco, sempre in contraddizione con se stesso, come emerge ampiamente dalla letteratura allemande degli ultimi cinque secoli, da Lutero a Paul Celan ed oltre, fino ai nostri giorni. Essere campo di battaglia spirituale per tutte le contraddizioni dell’Europa: questo è propriamente tedesco. Non è tedesco invece prendere le cose alla leggera, i dissidi in maniera cattolicamente conciliante, o banalmente livellante attraverso un malinteso concetto di globalizzazione, denunciare in direzione filantropico-umanitaria la debolezza nazionale, la «segreta infintà», come dice Nietzsche[viii], del proprio popolo, assumendo semplicemente un atteggiamento alla francese. Chi aspirasse a fare della Germania una semplice democrazia ‘bipolare’, post-borghese e post-marxista, secondo il senso e lo spirito romano e occidentale, la defrauderebbe di quanto ha di meglio e di più serio, cioè di quella problematica che di fatto costituisce la sua peculiarità nazionale: finirebbe col rendere la Germania noiosa, piatta, balorda e non più tedesca, con l’essere lui un anti-nazionalista per la sua pretesa che la Germania diventi nazione in un senso e in uno spirito che le sono stranieri.
È un’aspirazione, questa, davvero singolare. Eppure esistono tedeschi «di questo tipo»[ix], e sarebbe del tutto errato credere che per la Germania le cose siano così semplici come potrebbe sembrare stando alla grande formula dostoevskiana dell’«impero che protesta»[x].
In un breve contributo approntato per il centenario manniano del 1975, uno dei più originali e «impegnati» fra i poeti tedeschi della seconda metà del secolo scorso, Peter Rühmkorf, si scagliava con estrema decisione contro la poetica e le opere dell’autore dei Buddenbrook: «Provo per l’opera di Thomas Mann, a vent’anni dalla sua dipartita, il medesimo disinteresse che nutrivo ai tempi della sua permanenza in terra. Qualunque tentativo di avvicinare il maestro attraverso uno dei suoi libri è fallito a causa di una barriera linguistica che – retrospettivamente – mi appare più o meno una barriera di classe. Alla ribalta è qui una cultura grande borghese, spezzata soltanto da interferenze marginali, i cui problemi non ho mai condiviso, delle cui prospettive e retrospettive non mi importa affatto, le cui modalità espressive mi ripugnano quasi fisicamente. Purtroppo, nel corso dell’ultimo quarto di secolo, mi è sempre mancato il tempo necessario per smontare direttamente le posizioni di un autore le cui impettite buone maniere vengono spacciate in modo pressoché unanime per stile; diversamente avrei dovuto prendere in mano troppi libri, ognuno dei quali già dopo trenta pagine mi era inesorabilmente venuto a noia. La cattiva impressione che avevo già ricavato dai vari infelici tentativi di avvicinamento ebbe modo di confermarsi quando, l’8 giugno del 1953 ad Amburgo, ascoltai il cosiddetto mago leggere dal Krull: con quanta soddisfazione degustava a fior di labbra la sua ironia sottile come un’ostia, e come si compiaceva – vorrei dire scimmiescamente – della sua affettata gradevolezza. […] A mio parere, e cioè sulla base delle mie analisi frammentarie, abbiamo a che fare, per quanto riguarda i travestimenti ironici di Thomas Mann, con il gusto prettamente liceale di mettere in bella, artistica mostra quel po’ di cultura che ci si è faticosamente conquistati, inscenando – allo stesso tempo! – la propria soggettiva distanza dai materiali della propria formazione. Con ciò, sottolineo nel mio stesso interesse, non intendo produrre argomenti contro la parodia in generale. Parodia, da ormai un po’ di tempo, non significa altro che tradizione criticamente spezzata, o tradizione problematizzata. Dove però il trattamento dei repertori culturali procede con tanta facile automaticità come in questo autore, e dove la mancanza di resistenza opposta ai modelli è seconda soltanto alla mediocrità della versione stessa, ebbene qui comincia per me una sfera di ispirata musica da casa (Hausmusik) nella quale non ritengo opportuno trattenermi»[xi].
Difesa ad oltranza del ceto egemone, dunque, attraverso la stilizzazione di una correttezza linguistica e formale imposta per pura suggestione, attraverso il gesto ampio e “classico” del vegliardo, e per di più mistificata nelle forme cordiali ed amichevoli del mascheramento ironico. L’accusa di Rühmkorf, fondata peraltro su una cospicua tradizione antimanniana (da Alfred Döblin a Bertolt Brecht) e tutt’altro che isolata nel dibattito suscitato dall’anniversario del 1975[xii], investe direttamente le strutture culturali e specificamente linguistico-letterarie che preparano e accompagnano la solidificazione di un’opera e di un autore in «classico», in oggetto di tradizione funzionale a determinate strategie di controllo sociale; nella sua icastica estremità, inoltre, riflette con particolare chiarezza gli umori e le tensioni di quella Sprachkritik che, a partire dall’immediato dopoguerra, attraversa con rinnovato vigore vasti settori della produzione letteraria di lingua tedesca.
Al di là del suo ingombrante antinazionalismo gauchista, Rühmkorf, il tedesco «di questo tipo», in molti punti ha ragione. Da un altro versante – da parte italiana – da vent’anni a questa parte è emersa con sempre maggiore evidenza la «sistematica spoliazione» operata da Thomas Mann ai danni del patrimonio museale e letterario «latino-occidentale» e «cattolico», da lui a parole altrettanto sistematicamente disprezzato[xiii]; e non a caso usiamo l’espressione «sistematica spoliazione» perché puntualmente, le fonti italiane non sono citate, o il più delle volte trasportate nell’«aere … più respirabile», di antroponimi[xiv], toponimi e perfino nomi di Musei tedeschi.
Thomas Mann non è però nodo che possa sciogliersi nello spazio di un paio di pagine. Quanto a Rühmkorf, sollecitato circa vent’anni più tardi (1994) da Marcel Reich-Ranicki a pronunciarsi ancora sull’argomento, scrive un saggio molto più ampio e meditato in cui, dopo un’analisi suggestiva e stringente di alcuni motivi dei racconti di Mann, riesamina il punto centrale delle accuse del 1975 – ironia e parodia come strumenti di conservazione e di classicismo – e infine “riabilita” lo scrittore commentandone l’uso dell’ironia in Mario e il mago[xv], il racconto di argomento italiano pubblicato nel 1930, che, dietro un singolare spettacolo di ipnosi, lascia intravedere meccanismi tipici della formazione del consenso nella società totalitaria: «Poiché però il diavolo si annida qui nei dettagli, e l’autore – come è facile vedere – si nasconde anche nel ruolo dello spregiudicato manipolatore di uomini, in breve non sappiamo più dire chi sia lo strumento di chi, e quali doti dobbiamo ammirare di più, quelle dell’osservatore seduto in platea, che, nonostante la fascinazione subita, mantiene pur sempre un atteggiamento razionale e superiore, o quelle del burattinaio sul palcoscenico, peraltro abbastanza forzosamente costretto nella sua ossessione di potere. L’incertezza dura fin quando l’individuo ordinario e banale (Mario, l’eroe eponimo) toglie di mezzo lo spettro minaccioso con un colpo di pistola, sicché l’autore-testimone e noi stessi, i suoi lettori-spettatori, possiamo infine, liberati, tornarcene a casa. Ma liberati da cosa? Diciamolo con la massima cautela possibile, data la delicatezza del caso: da un incubo autoritario, di cui già in altri racconti ci era parso di intuire i segni sinistri, e la cui simbolica soppressione accogliamo con sollievo tanto maggiore in quanto va finalmente a colpire il giusto obiettivo. Saranno anche, questi, divertimenti poco incisivi, sorti da attese di rigenerazione tutto sommato primitive, e tuttavia non si possono liquidare tanto semplicemente. E non potrebbe essere così, del resto, lì dove lo strapotere delle ossessioni dirige l’intera opera letteraria e spesso determina lo sviluppo dell’azione, ed è perciò tenuto in scacco dal contropotere dell’ironia, che al dispiegarsi del demoniaco riesce ad opporre anche soltanto una parvenza di libertà. In questa prospettiva l’ironia sarebbe allora da intendere come il tentativo ininterrotto di vedere, di sfuggire alla fascinazione ipnotica e di reagire alle fatalità, collocandosi in una posizione superiore e liberamente prescelta»[xvi].
L’ironia, producendo uno scarto nella continuità e nell’unanimità del «pensiero dominante»[xvii], scardina il consenso e introduce la polifonia della libertà individuale, svelando la pluralità dei sensi del reale. Rühmkorf si riconcilia così con Thomas Mann scoprendone l’inflessibilità della disposizione umanistica e intuendo nel «classico», tutt’altro che neutralizzato dalla distanza temporale, un potenziale alleato nella battaglia comune del ceto intellettuale, all’alba come al tramonto del XX secolo, contro la deriva tecnologica e per la resistenza del predominio morale contro l’autonomia incontrollata della prassi socio-economica.
Ora, la polemica di Rühmkorf, più che per il suo specifico contenuto, interessa per il valore testimoniale nei confronti di un tema che è in genere di enorme importanza nella biografia intellettuale di Thomas Mann, ma che all’altezza di Geist und Kunst[xviii] occupa una posizione assolutamente decisiva: ci riferiamo alla rappresentatività dello scrittore rispetto alla vita sociale, politica e culturale della Germania, una questione particolarmente complicata, oltre che dalla molteplicità dei livelli ai quali richiede di essere affrontata e dall’etereogeneità spesso incomponibile delle variabili che devono essere prese in considerazione, anche dall’apparente contraddittorietà di molti dei numerosissimi pronunciamenti dello stesso Mann. Per un rapido, preliminare inquadramento del problema, bastino alcune schematiche evidenze: dall’interventismo nazionalista nel corso della prima guerra mondiale, testimoniato dalle eloquenti Considerazioni di un impolitico, all’adesione alla Repubblica di Weimar, dalla lettera a Korrodi[xix] ai discorsi di guerra rivolti ai Deutsche Hörer[xx], Thomas Mann ha partecipato direttamente come nessun altro scrittore alle vicende della Germania del ventesimo secolo, tenendo sempre ben serrati insieme l’artista (Künstler) – il creatore di opere narrative dalla straordinaria compattezza plastica – e lo scrittore (Schriftsteller) – l’intellettuale-saggista disposto a prendere posizione sulle vicende del proprio tempo. Nessun artista, inoltre, ha potuto rappresentare agli occhi del mondo con altrettanta chiarezza, o con altrettanta risonanza, la resistenza di una cultura e di uno spirito tedeschi opposti e alternativi alla dittatura nazista, e ciò non soltanto per il riflesso della produzione letteraria, pur inconfodibilmente orientata a riconvocare il tradizionale spirito umanistico-weimariano (si pensi a Carlotta a Weimar), bensì soprattutto per la personale assunzione, da parte di Thomas Mann, di un ruolo esplicitamente e pubblicamente antagonistico rispetto alla Germania delle camicie brune. Nessuna corrente o stagione della letteratura tedesca, peraltro, ha potuto aggirare, dal secondo dopoguerra in poi, il problema dell’identità della Germania che Thomas Mann, da Fratello Hitler[xxi] al Doctor Faustus, ha posto con la massima urgenza possibile. Pare anzi di poter affermare che intorno all’opera di Mann siano addensati motivi a tutt’oggi centrali e determinanti della vita culturale tedesca, nel segno di una vitalità e di una provocatorietà del classico ulteriormente corroborate anche dalle più accese manifestazioni iconoclastiche, sicché, lungo percorsi anche i più tormentati e discontinui, si finisce sempre per non poter in alcun modo prescindere da Thomas Mann, con lo stesso misto di diffidenza e di entusiasmo che, quasi un secolo fa, Walter Benjamin confidava all’amico Scholem: «Sull’ultimo numero della “Neue Rundschau” Thomas Mann pubblica un breve saggio sulle Affinità elettive di Goethe. Non l’ho ancora letto. Ma mi colpisce perché in questi ultimi tempi mi accade spesso d’incontrarmi con questo autore. Non so come fare a dirti che quest’uomo che ho odiato come pochi altri pubblicisti ora lo sento addirittura vicino a me, dopo il suo ultimo grande libro, La montagna incantata, che mi è capitato tra le mani – un libro dove ciò che vi è d’infallibilmente più mio, ciò che mi muove e sempre mi ha mosso, mi ha impressionato in un modo che posso rigorosamente controllare e accettare, anzi, spesso devo ammirare molto»[xxii].
La maggior parte delle umanistiche posizioni prese dal «classico» Mann, testé sommariamente esposte, hanno la loro origine e sono presenti in nuce nel celebre saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale di Friedrich Schiller[xxiii]. Thomas Mann aveva un altissimo concetto del lavoro schilleriano, e non perdeva occasione per celebrarlo come un modello di grande evidenza entro cui definire ed eventualmente stilizzare la propria identità. Più volte lo definì «l’opera più intelligente» che fosse stata mai scritta, l’archetipo perfetto della scrittura saggistica, il «libro» in cui «sono presenti tutti gli altri»; l’originalità di questi ultimi, anzi, si limita ad essere quella di «glosse», commenti e delucidazioni di singoli aspetti e problematiche già compiutamente esposti da Schiller, in questo «libro intelligentissimo», la cui bellissima prosa è parimenti esaltata fino alle stelle. L’atteggiamento di Thomas Mann nei confronti del saggio schilleriano non è però, come ci si potrebbe aspettare dai ricordati toni enfatici e celebrativi, acritico: più volte egli tenta di misurarsi con l’idolatrato modello, e nutre la segreta speranza di scrivere qualcosa di altrettanto significativo sulla letteratura. Nella fictio della Morte a Venezia[xxiv], ad esempio, tra le altre, immaginarie opere di Gustav von Aschenbach[xxv], compare anche «l’appassionato saggio Spirito e arte, che per la potenza chiarificatrice e l’eloquenza dialettica era stato affiancato da molti autorevoli giudici al saggio di Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale»[xxvi]. Un Wunschtraum ironico e rivelatore, che colloca il saggio Spirito e arte, ultimato nella finzione narrativa, a fianco dell’autorevolissimo modello schilleriano e nelle mani di uno dei personaggi più complessi e difficilmente decifrabili, quell’Aschenbach in cui convergono e si intrecciano elementi anche aspramente contraddittori come la dignità rappresentativa dell’artista, il carattere ludico e parodico dell’arte, la consumazione dell’unità classica, l’aspirazione ad una rinnovata classicità. Il brogliaccio di appunti dispersi e disaggregati si trasforma così, nella finzione narrativa, in una composizione unitaria in grado di rivaleggiare con il modello schilleriano, nel culmine, anzi, della produzione di Aschenbach, il quale proprio sul grande trattato fonda la propria prestigiosa rappresentatività: il Litteratur-Essay diventa Geist und Kunst. Il breviario adottato da Mann negli appunti di Spirito e arte, e successivamente nelle Considerazioni di un impolitico, è, come si è visto, il saggio di Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale, il modello elettivo del grande trattato di Aschenbach. Distinguendo la pienezza naturale del poeta ingenuo dallo stato di frammentazione artificiosa del poeta sentimentale, Schiller aveva di fatto elaborato una mitologia del classico di enorme influenza sulla formazione della struttura e del gusto della letteratura tedesca successiva, e aveva dato un apporto fondamentale al dibattito culturale europeo del diciannovesimo, ma anche del ventesimo secolo. Ad oggi, la provocatorietà classica di Sulla poesia ingenua e sentimentale non ha smesso di interrogare e di chiamare in campo gli scrittori e gli intellettuali europei più colti ed accorti.
Pubblicato tra il 1795 e il 1796, il saggio-trattato Sulla poesia ingenua e sentimentale traccia il destino di tutta la letteratura contemporanea. La poesia è certezza dell’impossibilità di realizzazione dei propri ideali; la sua provocatoria «inattualità» è vita di un’utopia che le consente di ritrovare nella luce del sogno e del desiderio il suo vero e autentico fondamento. «Tutti i poeti che siano realmente tali, apparterranno o agli ingenui o ai sentimentali». L’ingenuo è natura; il sentimentale aspira alla natura. Con questa distinzione Schiller compie una decisiva analisi sulle relazioni tra arte, natura e antropologia che inaugura ogni nostra riflessione sull’estetica filosofica. Nell’ingenuo c’è integrità armonica con la natura; essa non è conquista ma spontaneità: è la forma della classicità. Nel sentimentale c’è la visione dell’assenza, la cancellazione di un equilibrio, l’aspirazione alla totalità: è la forma della modernità. Ma queste grandi figure simboliche sono solo in apparenza contrastanti perché la poesia se esprime le due diverse condizioni della realtà umana e della sua storia, tende tuttavia a confonderne i piani. Ingenuo e sentimentale non appaiono più, nello sviluppo dell’argomentazione schilleriana, come concetti che contengono una visione della natura in riferimento ad un’epoca storica; essi rappresentano il problema di un rapporto ideale, adombrato dal rapporto reale tra Goethe e Schiller: qual è il modo d’essere dell’artista ingenuo nel mondo moderno sentimentale? Per Schiller rispondere a questo interrogativo significa poter dare alla parola della poesia la forza di essere anima del mondo, l’intelligenza per essere significato della realtà.
«Vi sono istanti della nostra vita», dice Schiller, «in cui dedichiamo una sorta di amore e commosso rispetto alla natura nelle piante, nei minerali, negli animali, nei paesaggi, così come alla natura umana nei bambini, nei costumi del popolo contadino e del mondo primitivo, e non perché essa ristori i nostri sensi, e neppure perché appaghi il nostro intelletto o il nostro gusto (anzi, spesso può accadere il contrario dell’una e dell’altra cosa), ma unicamente perché essa è natura»[xxvii]. Riassumendo, la catena concettuale prosegue a un dipresso così. Ogni uomo che sia pur minimamente raffinato e non difetti totalmente di sensibilità, può farne esperienza passeggiando all’aperto, vivendo in campagna o indugiando presso i monumenti dei tempi antichi; in breve, quando in condizioni e situazioni di artificio rimane stupito dalla visione della natura nella sua semplicità. E «questo interesse, non di rado elevato a bisogno, sta al fondo della nostra passione per i fiori e per gli animali, per i semplici giardini, per le passeggiate, per la campagna e i suoi abitanti, per i molteplici prodotti della lontana antichità e per altre cose ad esse simili, a patto che non entrino in gioco affettazione e altri casuali interessi»[xxviii].
La prima impressione che ci colpisce nel leggere questa bellissima prosa di Schiller riguarda il livello d’esattezza, in seguito ineguagliato nella letteratura critica, con cui egli sa trattare dei temi spirituali più sfumati e inafferrabili attraverso uno stile sobrio e denotativo e tramite scelte lessicali che circoscrivono e analizzano il problema via via affrontato in maniera al contempo intuitivamente profonda e sorprendentemente chiara ed evidente; così come appare evidente che nel parlare del poeta sentimentale egli discorre di sé, l’«eroe dello Spirito», mentre nel trattare del poeta ingenuo, figlio prediletto di madre natura, egli allude a Goethe, il «beniamino degli dèi», il «favorito della sorte», la cui spesso inattingibile grandezza è riassumibile nella famosa formula dei «meriti innati», ultima, ludica trasformazione dell’opprimente dottrina agostiniano-protestante della predestinazione. In particolare, è presente a Schiller saggista e filosofo di forte ascendenza kantiana, il Goethe naturalista-scienziato degli studi sull’ottica e sulla evoluzione di tutte le specie delle piante da un unico archetipo remoto e preistorico (la cosiddetta Urpflanze). Il vero e proprio ‘connubio’ tra Goethe e Schiller non era ancora iniziato, ma lo Schiller editore delle «Hören» non nascondeva il proprio interesse a coinvolgere l’«Olimpico» in una comune battaglia culturale per il rinnovamento della cultura tedesca. E gli studi scientifici di Goethe, specie quelli riguardanti l’ottica, destinati a chiamare in causa e a coinvolgere anche il giovane Schopenhauer, costituirono davvero il necessario tramite e il naturale ‘collante’ per il progressivo avvicinamento dei futuri «Diòscuri di Weimar». Riteniamo dunque opportuno fronire al lettore qualche ragguaglio sull’epica fatica goethiana attorno alla «storia dei colori», il cui finale approdo è l’epocale Teoria dei colori dello stesso Goethe, il quale, sebbene consapevole del rischio di un naufragio in sì vasto e periglioso mare, comprese infine di aver scritto, attraverso queste opere, il «romanzo del divenire della scienza umana». Veniamo dunque alla genesi della goethiana «storia del colore».
I Materiali per una storia della teoria del colore, che Goethe raccolse in pluriennale fatica, costituirono poi il secondo volume della sua opera intitolata Zur Farbenlehre, apparsa nel 1810[xxix]. Nel 1806 ne era cominciata la composizione tipografica, che venne però interrotta dalle circostanze che accompagnarono la battaglia di Jena. Come Goethe infatti annotò nei suoi diari, nel 1806: «La stampa era arrivata fino al tredicesimo fascicolo della prima parte, e fino al quarto della seconda, allorché il 14 ottobre gli avvenimenti ci investirono con le loro tristi conseguenze e con la minaccia di cancellare il lavoro fin lì fatto»[xxx]. Nel 1808 era comunque terminata la composizione del primo volume, contenente la parte didattica e quella polemica, e nel 1810, finalmente, quella dell’intera opera, alla quale si era aggiunta la parte contenente il testo della Storia dei colori. È così che, in data 8.V.1810, Goethe può annotare: «Revisione dell’ultimo fascicolo»[xxxi]. Ma cos’è la Storia del colore di Goethe?
La Farbenlehre, nella sua Parte storica, ha un raro e insostituibile valore manualistico e documentario. Essa procede dai trattati d’arte e dalle speculazioni ottico-psicologiche, talvolta fisiche o chimiche, per toccare quindi le poetiche, le riflessioni centrate sul problema del colore quale problema compositivo in pittura, ma anche le filosofie della natura, le visioni globali del rapporto Arte e Natura, Arte e Scienza, Uomo e Natura, ecc. È questo lo sfondo sul quale i fenomeni che Goethe discuteva nella Parte didattica, anzitutto le diverse questioni di psicologia del colore, ma anche le diverse questioni relative al numero e al nome dei colori, agli orizzonti fisiologici, fisici e chimici della loro evenienza, agli usi pittorici e simbolici del colore, al colorito, alla loro possibilità di classificazione e distribuzione nello spazio o sulla superficie, vengono ora rivisitati attraverso e nella forma di un’evoluzione delle dottrine[xxxii].
Da Goethe a Mann il passo non è breve, né tantomeno lineare; eppure vale la pena soffermarvi un poco la nostra attenzione, soprattutto per l’alto valore simbolico che il rapporto Goethe-Mann ha assunto dal dopoguerra ad oggi, nella cultura tedesca, ma anche nella più vasta compagine europea. Goethe non è stato il padre spirituale di Thomas Mann. Gli è divenuto più tardi, nel corso della vita, esempio, guida, conforto, compagno e maestro, attraverso una lunga e meditata amicizia virile. Ci si può chiedere del resto se Thomas, orfano di padre dalla prima adolescenza, estremamente solo con se stesso allo sbocciare della precocissima genialità – prima cioè di conquistarsi con una propria e già sicura affermazione letteraria nel lungo e fecondo soggiorno romano la sodalitas del fratello maggiore Heinrich – abbia mai cercato con candido bisogno di dedizione e di obbedienza l’autorità e la guida di un qualunque “padre spirituale”. Thomas Mann ha sùbito e sempre sentito meglio la satira che l’entusiasmo, la parodia che la prona imitazione. Certo da studente avrà letto e respirato Goethe, in quanto Goethe era e rimane pur sempre componente essenziale di ogni atmosfera culturale tedesca, però ad altri idoli si volsero i suoi primi e sempre dominati fervori. Sintomo indiretto e caratteristico: nella novella di debutto, Gefallen (Perduta)[xxxiii], scritta a diciotto anni e mai accolta fra le “Opere”, parecchi narratori francesi e tedeschi gli possono essere stati prossimi o remoti modelli, e Heine[xxxiv] fu l’ispiratore evidente dell’intermezzo lirico in quel racconto, ma di Goethe ivi ricorre, unico richiamo, il cinico ghigno di Mefistofele, con relativo gesto osceno. Goethe è assente in sostanza da tutta la produzione narrativa giovanile, anche se molto più tardi, quando la grande alleanza spirituale sarà in atto, l’acribìa dei critici potrà vedere in Tonio Kröger[xxxv] il Werther thomasmanniano. Soltanto con la complessa crisi della prima guerra mondiale e del penoso dopoguerra tedesco, soltanto nel decennio che va dai Pensieri di guerra (1914) alla Montagna incantata (1925)[xxxvi], il non più interrompibile colloquio inizia e si attua. È ben vero che Thomas Mann medesimo ha ceduto una volta, per rara eccezione, al dolce inganno di pseudoricordi, parlando nel 1932 (all’inaugurazione del Museo Goethe di Francoforte, in pagine poi pubblicate in un Calendario Goethiano, ma da lui non riprese nelle “Opere”) di un suo «amore sin dalla prima giovinezza», di una «super-esaltazione della simpatia», di una «immagine esemplare» – Urbild e Über-Bild – sempre vagheggiata.Ma questo amore di sempre è un’autoillusione, o almeno un’aspirazione subcosciente divenuta soltanto dopo il 1930 una meta verso la quale poi ininterrottamente procede. Egli stesso del resto si è corretto quando ha dichiarato altrove «di aver preso visione soltanto in anni maturi della prosa goethiana», la sola, è chiaro, che nel profondo potesse agire su di lui narratore e saggista.
Indiziale anche, forse, la risposta data nel 1948 a una inchiesta sulla “lirica preferita”, di dove non risulta affatto che Goethe poeta sia sangue del suo sangue sin dalla giovinezza. Molto oggettivo e fedele, il celebre saggio autobiografico del 1930 ricorda l’adorazione dell’adolescente per Heine, le lunghe letture (con panini imburrati accanto!) di Schiller, ma ignora del tutto Goethe, insistendo invece quanto alla prima formazione artistica sugli influssi della “triplice costellazione”, costituita da Schopenhauer, Nietzsche e Wagner.
In quei tre astri, Schopenhauer, Nietzsche e Wagner, che furono definiti da Bernhard Blume[xxxvii] il «consiglio tutorio» della sua orfana solitudine, Mann aveva allora trovato i grandi motivi conduttori della propria arte: la simpatia con la morte, la dionisiaca esaltazione musicale, la trasparenza critica dell’arte. Durò quindi oltre il miracoloso sbocciare dei Buddenbrook, del debutto-capolavoro, questa Goethe-Ferne, questa lontananza da Goethe che in quel primo decennio del Novecento distanzia sostanzialmente Thomas Mann dai suoi più vicini contemporanei, anzi coetanei, di Austria e Germania: lo stacca da George, Hofmannsthal, Rilke, Hesse, Carossa e Albert Schweizer, nonché da Ernst Jünger, i quali tutti, sia pure con disparatissime forze e sotto ben differenti aspetti, già dalla loro giovinezza, di Goethe si nutrirono e si accrebbero.
Le prime novelle – che si direbbero non esitante affacciarsi di un’aurora, ma amara conclusione di un disincantato tramonto – danno a Thomas Mann la coscienza dei suoi «meriti innati»[xxxviii], dei suoi doni di scrittore. Al trionfo del poema borghese di Lubecca l’autore reagisce con cauta e conscia umiltà di fronte ai valori eterni della letteratura; però dalle incomprensioni e dai malintesi di alcuni critici è spinto sin da allora a quell’esasperante autoanalisi, per autoaccusa o per autodifesa, cui non saprà mai più rinunciare e che è volta in certo modo a precedere, a prevenire e a circoscrivere ogni giudizio dei contemporanei su di lui. Lo assillano intanto – e forse ancor più vivamente perché non era del tutto completa e organica a quel tempo la sua cultura di autodidatta – alcuni problemi estetici fondamentali.Schiller gli viene ad essere molto vicino piuttosto come vittima che come vincitore, piuttosto quale teorico del già citato saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale[xxxix], cioè come esempio doloroso di un genio non intuitivo, che non quale potente drammaturgo e poeta entusiasmante. Mentre Thomas Mann tiene con se stesso e con i propri infrangibili limiti artistici tormentosi colloqui, egli li traspone anche letterariamente. Per la celebrazione schilleriana del 1905 scrive il racconto-monologo Ora difficile[xl] che può apparire oggi incrinato di vecchiaia nella sua forma iperletteraria, ma che rimane estremamente significativo nel suo sofferto accento autobiografico. È in esso che si affaccia per la prima volta l’appena iniziata chiarificazione, la intima Auseinandersetzung con Goethe. In quel racconto-soliloquio non ricorre mai il nome del «beniamino degli dèi», del fortunato rivale: Goethe è per Schiller «quell’altro», quello di Weimar, il creatore che non conosce il sanguinante cammino di uno scrittore non-ingenuo e che Schiller pur ama «con nostalgica inimicizia».
Una indistinta Hassliebe antigoethiana sembra dunque annidarsi allora anche nel cuore di Thomas Mann trentenne, considerato il più valido, ma il meno facile e meno spontaneo e inventivo fra gli scrittori celebri del momento. Quando però, nel corso di una polemica oggi dimenticatissima, vorrà difendersi dall’accusa di essere stato troppo prosaico e discreto fotografo per il mondo dei suoi padri a Lubecca, Thomas Mann (in Bilse und ich, 1906) invocherà Goethe quale illustre precedente nell’audacia di rappresentare senza troppi scrupoli ambienti e personaggi ben vivi. L’opera goethiana chiamata a raffronto, il Werther, è stata scritta a ventiquattro anni, l’età che Mann aveva ai tempi dei Buddenbrook[xli]. Naturalmente Mann si compiace di sottolinearlo.
Sono anni di fama meno rumorosa, ma di non scarsa fecondità, giacché comprendono Tonio Kröger, Fiorenza e Altezza Reale[xlii]. Le letture goethiane debbono in quel periodo essersi approfondite e anche molto estese al difuori delle opere, nell’immenso campo dei carteggi e delle testimonianze dei contemporanei di Weimar, che Thomas Mann comincia ad accumulare entro la sua prodigiosa memoria, per usarne poi con stupefacente perizia.
Un motto di Goethe, lo stesso che abbiamo citato in esergo al nostro contributo, un incoraggiamento all’autoanalisi (Vergleiche dich, erkenne was du bist!)[xliii] accompagna per la prima volta nel 1919 un suo libro. Sono le Considerazioni di un impolitico, su cui ci siamo già tanto arrovellati[xliv], la «creatura dolorosa» di dolorosi anni, la cui materia e le cui finalità sono peraltro troppo politiche e contingenti perché la vena goethiana in esse non rimanga sotterranea e pressoché involontaria. Intorno a quello stesso anno usciva a Monaco (tradotto dall’unico testo inglese allora in circolazione) il prezioso libretto dei ricordi di Gorkij su Tolstoj (il «libro migliore di Gorkij», lo chiama Thomas Mann) ed è questa forse la scintilla che lo spinge a scrivere Goethe und Tolstoj (poi raccolto in Adel des Geistes), il primo saggio che ci testimoni il deciso assalto di Thomas Mann alla poliedrica personalità poetica di Wolfgang Goethe. Questo lavoro fu segnalato subito in Italia dalla vedetta della «Ronda», ma tradotto per intero solo trent’anni dopo nel volume Nobiltà dello spirito (Adel des Geistes, il titolo che Mann diede alla sua più ampia raccolta di saggi critici). È, più che un dialogo, una complessa conversazione a più voci. È un arpeggiare vagamente disordinato, e anche un abile punctum contra punctum, un insistere di variazioni su temi fissi che troviamo più tardi ordinati e messi in valore nei saggi successivi. Accanto alle figure dominanti del colosso russo e del sapiente di Weimar sono in scena Dostoevskij[xlv] e Schiller[xlvi] in una dialettica discussione su arte ingenua e sentimentale, su spirito e poesia. Quel lungo studio, un vero piccolo libro, rappresenta la conquista da parte di Thomas Mann della complessa personalità di Goethe attraverso testi relativamente rari e al difuori dei logori schemi ufficiali. Nell’insieme l’ininterrotto sovrapporsi di due, anzi di quattro grandi immagini, con vivo gioco di affinità e contrasti, fa pensare alla suggestione dei più avanzati ‘trucchi cinematografici’ e lascia a lettura finita un senso di gradevole confuso smarrimento. Quel saggio accoglieva anche per ragioni esteriori note che non gli sono pertinenti. Non va dimenticato che Goethe e Tolstoj nacque nel tempo cruciale della “conversione” politica di Thomas Mann, e di essa serba traccia, per esempio dove, poco prima della marcia su Roma, si proclama «il fascismo italiano perfetto parallelo del bolscevismo russo», o dove si lancia l’anatema contro la «rabbiosa idolatria dei singoli popoli», quale «simbolo del decadimento dell’Europa come un tutto unitario». Insomma: Goethe, Schiller, Tolstoj e Dostoevskij sono ancora più che altro un incentivo e un fomento alle geometriche capacità combinatorie della ‘immaginazione esatta’ di Mann; Goethe è ancora massa fluida e fluente nello spirito di Thomas Mann, il quale però, dopo questo primo approccio, non desisterà mai più dal proseguirne la conquista. Thomas Mann ha parlato di questa a lui familiare «metamorfosi dello spirito»[xlvii], la quale ha al suo inizio la simpatia per la morte e alla sua meta la risoluzione di servire invece la vita. È nel lungo viaggio intrapreso dopo il mezzo del cammino di sua vita che Mann ha trovato in Goethe il suo Virgilio.
Il colloquio definitivo si avvia dunque quando Thomas Mann è in piena maturità e solidità di vita, temprato dalle esperienze e dagli errori delle Guerre Mondiali, oltre che dalle «fatiche erculee» delle tre successive e quasi consecutive stesure dei romanzi I Buddenbrook, Altezza Reale e La montagna incantata. Tra questi, Altezza Reale[xlviii] è oggi il meno conosciuto, ma certamente non è il meno importante per l’evoluzione spirituale di Mann e per il suo asintotico accostarsi a Goethe all’infinito. Sempre più, lo stile di Mann si fa classico e decantato; e sempre più il suo atteggiamento spirituale nei confronti della cultura tedesca prende le movenze olimpiche di Goethe.
«A quanto pare, finirò per diventare l’uomo dei tre romanzi» constata presago Thomas Mann nella prefazione alla nuova versione americana di Altezza Reale del 1939, alludendo ai Buddenbrook, alla Montagna incantata e ai volumi dedicati a Giuseppe[xlix]; e aggiunge con un sospiro: «Eccone qui un quarto, che si presenta meno ampolloso, meno epico di quelli: la storia di un principe». Una storia che per lungo tempo ha conosciuto un’«esistenza trascurata»: «Talvolta provavo un sentimento di pena per lei». Le obiezioni all’opera che Mann va rievocando sono coeve all’uscita del romanzo stesso: «Quando apparve, fu trovato troppo leggero, sia in termini assoluti che relativi: troppo leggero nel senso delle pretese che in Germania si avanzano nei confronti di un libro quanto a serietà e ponderosità, ma troppo leggero anche rispetto all’autore». Quasi nessuno, prosegue, ha riconosciuto il valore peculiare della storia del principe[l]. Ogniqualvolta gli capitava di parlare della recezione del suo secondo romanzo, questa lamentela tornava a echeggiare, e continuerà a farlo fino agli ultimi giorni di vita dello scrittore.
Sino a oggi le certezze della critica – sia per quel che attiene ai dati di fatto sia per quel che attiene ai giudizi – stanno in singolare contrasto con la grande considerazione che proprio a questo romanzo riservava lo stesso Mann. Contrastano inoltre con la delusione durata decenni nei riguardi di una ricezione che nella sua unanimità a lui appariva come un grande (per quanto non del tutto immotivato) malinteso. Ma, si noti bene, contrastano anche con una ricezione contemporanea che – basti pensare alla vivacità dei suoi dibattiti letterari e politici, al rango e al nome dei critici e degli scrittori, scesi in campo e schierati in prima linea e soprattutto al riconoscimento tributato al romanzo da ben pochi recensori di fama – non avrebbe dato adito in realtà che a un’ulteriore delusione. Eppure Altezza Reale, anche in questo caso fin dal suo apparire, ha rappresentato in primo luogo uno dei grandi successi di pubblico nella carriera letteraria dello scrittore; nella misura in cui lo si può stimare in base alle copie vendute, fu un successo addirittura travolgente. Il secondo, attesissimo libro dell’autore che con i Buddenbrook era divenuto famoso in tutto il mondo, fu dato alle stampe nell’ottobre del 1909; due settimane dopo Thomas Mann espresse all’editore Samuel Fischer il suo entusiasmo per la seconda ristampa. «Sono emozionatissimo e compiaciuto. In quattordici giorni: tutto ciò supera di gran lunga le mie aspettative. C’è da augurarsi che prosegua così»[li]. Proseguì così. Prima della fine dell’anno si contarono altre nove ristampe, nel 1910 complessivamente quindici e nel 1911 altre cinque ancora. Se i Buddenbrook impiegarono dieci anni per giungere alla sessantesima ristampa, Altezza Reale a soli nove anni dalla prima edizione toccò il traguardo della sessantaquattresima (con una tiratura di 64.000 copie). Nel 1922 il romanzo era ormai alla settantasettesima ristampa – il nome di Thomas Mann risultava a tal punto legato al successo del libro che, non c’è da stupirsene, in un’intervista apparsa sul viennese «Neues 8-Uhr-Blatt» lo scrittore veniva presentato sbrigativamente (ed esclusivamente) come «l’autore di Altezza Reale»[lii]. Uno scosso Ernst Bertram – in seguito intimo amico e consigliere dello scrittore – ravvisava nel romanzo la «commedia tragica di una solitudine rappresentativa», l’apologo di «un potere vuoto, ormai solo rappresentativo e simbolico»[liii]. Dopo che sul «Vorwärts» e altri periodoci socialdemocratici era stata elogiata la spregiudicatezza politica del libro, Hermann Bahr lo celebrò come un baleno che squarcia l’oscurità e preannuncia una nuova era. E persino il giudizio riduttivo, che Thomas Mann menziona con amarezza, dell’autorevole critico Josef Hofmiller, il quale aveva «soppesato» il romanzo e l’aveva trovato «troppo leggero», si limita a relativizzare senza intaccarla la grande «ammirazione per questo romanzo che è il più geniale e spiritoso, semmai troppo spiritoso, fra tutti i romanzi apparsi di recente nel nostro paese»[liv]. Dapprima esitanti, le voci degli avversari di Mann finiscono per spuntarla e inizia così il graduale declino del libro, degradato a presunta triviale «operetta»[lv], che studiosi e ricercatori leggono a stento e per lungo tempo non prendono sul serio.
L’ambizione con cui Thomas Mann lavorò al suo secondo romanzo, gli sforzi cui con teutonica ostinazione si assoggettò, la delusione per una ricezione in àmbito nazionale che gli parve un grande fraintendimento, la caparbietà con cui lo difese fino all’ultimo: tutto è inversamente proporzionale alla fama postuma dell’opera. Altezza Reale non è soltanto il romanzo meno conosciuto di Mann, ma è anche, salvo rare eccezioni, il più sottovalutato. Le osservazioni dell’autore a proposito di questo testo e della sua collocazione nell’àmbito complessivo della sua opera ben difficilmente possono accordarsi con l’idea diffusa a tutt’oggi che si tratti di un lavoro secondario, di uno “scherzo” frivolo. Di contro alla communis opinio invalsa già fra i critici a lui contemporanei, lo scrittore insiste nel ribadire ogni volta che questo «prodotto eccentrico», questo «libro curioso» cui è toccato sempre «il ruolo di Cenerentola» ha rappresentato, seppure soltanto a livello di presagio, un antesignano, una tappa preliminare a quanto si veniva preparando, tappa preliminare inconsapevole e tuttavia indispensabile alle grandi opere dell’epoca successiva: «Quale che fosse il peso specifico della storia del principe», è indubbio che «senza di essa non sono pensabili né La montagna incantata né Giuseppe e i suoi fratelli»[lvi]. Lo scrittore sessantaquattrenne che scriveva queste parole nella prefazione alla versione americana di Altezza Reale [Royal Highness] sapeva bene quale peso avesse questa sua dichiarazione e cosa gettava sul piatto della bilancia. E ancora un anno prima di morire annotava questa lapidaria asserzione: «Altezza Reale è uno degli esperimenti della mia vita»[lvii].
Da allora, così parrebbe, tutto è già stato detto su di lui, e in parte anche molto bene. Nel mezzo secolo che è seguito alla sua morte nessun altro autore tedesco ha suscitato un’eco comparabile tra i suoi connazionali. La crescente e generalizzata predilezione per Thomas Mann negli ultimi decenni del ventesimo secolo, e ancor più in questi tredici anni del ventunesimo, è legata a un avvenimento che nessuno poteva prevedere, meno che mai i suoi numerosi e tanto alacri detrattori. Davanti agli occhi di tutti lui, Thomas Mann, è stato sbalzato dal suo piedistallo. E ad opera di chi?
La pubblicazione dei dieci volumi dei Diari, iniziata nel 1977, è stata portata a compimento negli anni 1986-1995. Un diario, di norma, offre una prosa monologica senza pretese artistiche, un succedersi indisciplinato, spesso incontrollato – cui l’autore si abbandona senza sforzo – di pensieri e sentimenti, osservazioni e descrizioni. Ciò che un diario consente, tuttavia, è immediatezza e soggettività. Entrabe producono spesso, com’è ovvio, l’impressione di un certo dilettantismo. Anche i Diari di Mann non possiedono in fondo alcun pregio letterario. Ma fin da subito, sia da parte dei suoi ammiratori e sostenitori, sia da parte di coloro che lo disprezzavano e biasimavano[lviii], sono stati riconosciuti come dei documenti fuori del comune. I Diari consistono in massima parte di annotazioni relative alla quotidianità. Thomas Mann va a passeggio e scrive, fra parentesi, «senza panciotto», la mattina consuma a colazione «due uova ma un solo albume», registra di aver «scherzato con il barboncino». E così via. Ma ciò che affascina il lettore dei Diari discende da un’altra circostanza: è mai esistito un grande scrittore tedesco che per tutta la vita abbia profuso tante energie al fine di trasmettere, se non imporre, al mondo l’auspicata immagine della propria esistenza? Un maestro dell’autostilizzazione, un magnifico regista della propria messinscena, un principe delle lettere borghese sempre attento alle forme e alquanto sussiegoso nelle sue apparizioni in pubblico, avvezzo ad ammantarsi di dignità e ironia, uno scrittore che già negli anni Venti dominava incontrastato il mondo della letteratura europea e che più tardi venne considerato, non in via ufficiale ma incontestabilmente, l’esponente sommo dell’emigrazione tedesca e nel pieno della guerra incarnò per l’ecumene civile l’altra Germania; lui, Thomas Mann, ventura della Germania nella sventura tedesca, decise di rinunciare, e per sempre, all’immagine solenne e ricca di pathos che era andato costruendo nel corso dei decenni: di più, decise di distruggerla sistematicamente.
A essere toccata dal processo di revisione pensato per i posteri era tuttavia solo la personalità, non l’opera. In primo piano appare un’immagine di Thomas Mann affatto diversa: l’autoritratto di un nevrotico e ipocondriaco tormentato dall’insicurezza e dalla paura che, sofferente e ingenerante compassione, al mondo non vuole dare ad intendere assolutamente più nulla. Quello che l’immagine tramandata perdeva in classicità, solennità e pathos, lo guadagnava in termini di veridicità e nuda umanità. In origine il diario era un monologo senza ascoltatori, un nascondiglio in cui rifugiarsi in assenza di testimoni. E poiché le annotazioni erano riservate a lui soltanto, non vi è traccia della dizione che conosciamo nella sua epica, non vi è traccia della sua bravura né del suo virtuosismo stilistico. In tutta la sua vita Thomas Mann non ha scritto una sola lettera con la trascuratezza che caratterizza i Diari. Non aveva tempo né voglia di riesaminare neppure una frase, neppure un rigo appena di quel che vi stava scritto. Negli ultimi anni aveva deciso a un certo punto di lasciare i Diari così com’erano, senza rivederli né correggerli. Di sua iniziativa ha portato da venticinque, come aveva dapprima stabilito in via cautelativa, a venti gli anni che dovevano trascorrere dopo la sua morte prima che venissero resi noti. Una tale concessione equivaleva naturalmente a un invito perentorio: non c’è dubbio che Thomas Mann voleva che fossero dati alle stampe. Ha avuto la forza, il coraggio e la grandezza di smantellare senza remore la leggenda, che lui stesso aveva forgiato, del proprio percorso esistenziale. I posteri dovevano sapere chi era realmente Thomas Mann, dovevano comprendere, o per lo meno intuire, la sua vita caratterizzata da un costante isolamento. Amava ripetere un verso di Platen: «Mi conosca il mondo, e mi perdonerà!». Che fosse troppo egocentrico e autocompiaciuto per risultare simpatico o addirittura amabile, era cosa risaputa da sempre. Ma in quale misura lo fosse e quanto la sua famiglia, il suo entourage e lui stesso in primo luogo abbiano patito di questo, solo i diari l’hanno rivelato. Per tutta la vita egli ha tentato di difendere e giustificare la sua ambizione e la sua vanità. Già nella novella Ora difficile, omaggio a Schiller di cui ci siamo occupati[lix], aveva scritto: «Egoista è tutto quel che è fuori del comune, in quanto soffre». Il mondo vedeva l’egotismo di Mann ma, comprensibilmente, non si curava delle sue sofferenze. Il suo fortissimo, palese e peraltro mai dissimulato bisogno di rappresentanza, e la sua, come è detto nella novella summenzionata, «gelosia che nessuno diventasse più grande di lui» facevano di Thomas Mann, per chi l’ha conosciuto di persona, un essere insopportabile. L’atteggiamento di riprovazione che tanto spesso suscitava negli altri si riverberava – non si stenta a crederlo – anche nei giudizi sulla sua opera.
Dopo la pubblicazione dei Diari e di numerosi altri documenti noi leggiamo i romanzi e i racconti di Thomas Mann in modo diverso da prima. Certo, la sua epica non è stata per nulla fraintesa quando lo scrittore era in vita. È stato lui personalmente a premurarsi che non lo fosse. Il fatto che dalla fanciullezza fino alla vecchiaia egli sia stato dominato dall’eros e che i motivi tematici sessuali svolgano un ruolo chiave nella sua opera, è qualcosa che i suoi contemporanei non avevano misconosciuto, anche se, certamente, l’avevano sottovalutato. Parecchi degli scrittori che avevano proclamato – con la voce tremante per l’ira – che nessuno era loro più indifferente dell’autore della Montagna incantata, si mostrarono colpiti e quasi sopraffatti dai Diari. Nel 1985 Peter Rühmkorf parlò, non solo a suo nome, della «rivalutazione dell’arte di un prosatore finora colpevolmente trascurato».
I Diari hanno fatto conoscere anche il carattere esemplare della famiglia Mann. Ma non è stato un libro, bensì il film di Heinrich Breloer[lx] a far capire a un pubblico di milioni di spettatori che la storia di questa famiglia è un vero e proprio dramma didascalico per i tedeschi. La conseguenza di tutto ciò è che molti lettori hanno preso in mano per la prima volta, o sono tornati a farlo, i romanzi e i racconti di Thomas Mann, in Germania e in tutto il mondo.
Paolo Melandri
[i] F.M. Dostoevskij, Pridirka k slučaju, in Dnevnik pisatelja (agosto 1880). Cfr. anche la traduzione italiana, Un cavallo per l’occasione. Quattro lezioni si temi diversi a proposito di una lezione datami dal signor Gradovskij. Con una allocuzione al signor Gradovskij, in Diario di uno scrittore, a cura di Ettore Lo Gatto, Firenze, Sansoni, 1963, nuova ediz. 1981, p. 1292.
[ii] Così Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin, Fischer Verlag, 1918, trad. it. Considerazioni di un impolitico, Milano, Adelphi, 1997, p. 73.
[iii] Ibidem.
[iv] Davvero grande è la portata che il sostantivo Geist (“spirito”) e l’aggettivo geistlich (“spirituale”) hanno nella letteratura e nella cultura tedesche, spesso privi di qualsivoglia connotazione prettamente religiosa. Nelle altre lingue europee, invece, di solito la connotazione religiosa (o para-religiosa) è predominante. Ci preme sottolineare questa differenza, per mettere maggiormente in luce l’eccellenza e la modernità della cultura tedesca nell’àmbito delle culture europee. Da noi, filosofi quali Benedetto Croce e antroposofi quali Lamberto Caffarelli hanno spesso usato l’aggettivo “spirituale” nel senso tedesco del termine.
[v] Uso il sostantivo nel significato che ad esso attribuiva Giuseppe Verdi, per designare l’‘atmosfera’ complessiva di un melodramma, o quella di una singola scena.
[vi] Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 74.
[vii] Ibidem.
[viii] F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (1886), viii, 241, in Werke in drei Bänden, a cura di Karl Schlechta, München, Hauser, 1954-1956, edizione integrata nel 1965 da un volume di indici, vol. II, p. 707.
[ix] Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 75.
[x] F.M. Dostoevskij, Germanskij mirovoj vopros. Germanija – strana protestujuščaja, in Dnevnik pisatelja (maggio-giugno 1877). Cfr. anche la traduzione italiana, Il problema mondiale germanico. La Germania paese che protesta, in Diario di uno scrittore, cit., p. 937. Di questo passo dostoevskiano mi sono già occupato nel mio contributo Steiner e Kandinsky nella produzione di Lamberto Caffarelli. Una storia locale ed europea, «Studi e ricerche del Liceo Torricelli», vol. XI, Faenza, 2013.
[xi] P. Rühmdorf, Gestelzte Manierlichkeiten, in Was halten Sie von Thomas Mann? Achtzehn Autoren Antworten, Frankfurt a.M., Hrsg. von M. Reich-Ranicki, 1994, pp. 69-70.
[xii] Si veda almeno M. Walser, Ironie als höchstes Lebensmittel oder: Lebensmittel der Höchsten, in Thomas Mann. Sonderband aus der Reihe Text+Kritik, Frankfurt a.M., S. Fischer, 1976, pp. 5-26.
[xiii] Si vedano le parole-macigni che Mann riserva ai Welsche, e in particolare a Mazzini e a D’Annunzio, nelle Considerazioni di un impoltico, cit., pp. 397-398 (Mazzini) e pp. 573-574 (D’Annunzio). Il veleno di tali vere e proprie ingiurie è diretto non tanto contro le pur sempre discutibili qualità culturali e artistiche dei due scrittori, quanto piuttosto contro il loro essere «italiani», che per Mann è tutt’uno con l’essere «ciarlatani», «bajazzi» e simili, con, in sovrappiù, la squisitezza dovita al fatto che l’Autore inserisce le parole in italiano nel testo. Del resto, lo stesso personaggio di Settembrini nella Montagna incantata non è immune da tali connotazioni. Un vezzo davvero tutto «tedesco», presente ad esempio anche nelle Lettere di Mozart e in molti scritti dello stesso Lutero (die Walen), che palesa con corriva faciloneria un evidente pregiudizio etnico. La parola disprezzo, in tali scritti, compare puntualmente riferita agli italiani. Al contrario noi (e con «noi» intendo in primo luogo me stesso), pur consapevoli di così biasimevoli atteggiamenti, riteniamo sinceramente eccellente e centrale la cultura allemande nel contesto europeo.
[xiv] Ad esempio il dannunziano Sperelli diventa Spinell nel racconto Tristano e lo stesso, detestato Gabriele D’Annunzio diventa un ben più nobile Gustav Von Aschenbach nella Morte a Venezia, che, a sua volta, come è emerso recentemente da serrate analisi, è una meditata ri-scrittura del Fuoco dannunziano. Lusinghiera allusività? Ma allora perché quell’ambiguità, quel ribrezzo nei confronti dell’Italia, presenti in racconti come Il pagliaccio e Mario e il mago (in quest’ultimo, l’aristocratico disgusto non va solo alla «malattia» del ventennio fascista, il che sarebbe moralmente impeccabile e anzi tollerante e financo eccessivamente mite nei toni, ma anche al «volgarissimo», «osceno» timbro delle popolane italiane, così palesandosi come disgusto epidermico e pregiudiziale).
[xv] Th. Mann, Mario e il mago, in Id., Racconti, trad. it. di Lavinia Mazzucchetti, Milano, Mondadori, 1983.
[xvi] P. Rühmdorf, Die neugewonnene Wertschätzung des Prosaartisten, in Was halten Sie von Thomas Mann?, cit., pp. 134-135.
[xvii] L’espressione è tolta, sebbene in affatto diverso senso, da G. Leopardi, Il pensiero dominante, xxvi dei Canti, Milano, Mondadori, 1987, pp. 177-183, di cui vogliamo qui rammentare il celebre, sublime incipit: «Dolcissimo, possente / dominator di mia profonda mente; / terribile, ma caro / dono del ciel; consorte / ai lúgubri miei giorni, / pensier che innanzi a me sì spesso torni».
[xviii] H. Wysling, «Geist und Kunst». Thomas Manns Notizen zu einem «Litteratur-Essay», in P. Scherrer-H. Wysling, Quellenkritische Studien zum Werk Thomas Manns, Bern-München, 1967, pp. 123-233. Cfr. anche la traduzione italiana, Spirito e arte, a cura di Maurizio Pirro, Bari, Palomar, 1997. Notiamo qui solo di sfuggita come il titolo manniano Spirito e arte somigli a quello di Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, Milano, SE, 1989 e a quello Lamberto Caffarelli, L’arte nel mondo spirituale, Faenza, Montanari, 1925. Né le somiglianze, imputabili in gran parte al medesimo contesto culturale, si limitano ai soli titoli, anche se un influsso diretto di Kandinsky su Thomas Mann non è documentabile. È certo, invece, e documentato, che Lamberto Caffarelli conoscesse benissimo l’opera di Kandinsky e che avesse Thomas Mann tra le sue letture préferées.
[xix] La lettera a Eduard Korrodi pubblicata sulla «Neue Zürcher Zeitung» del 3 febbraio 1936 contiene la definitiva presa di posizione di Thomas Mann sulla situazione della Germania Nazista. Vedi la traduzione italiana in Th. Mann, Lettere, a cura di I.A. Chiusano, Milano, 1986, pp. 301-307.
[xx] Con il titolo Deutsche Hörer! sono raccolti i discorsi radiofonici tenuti da Thomas Mann per la BBC a partire dall’ottobre 1940. In essi Mann esorta continuamente i tedeschi a prendere le distanze dal regime hitleriano e a lottare per il successo della democrazia.
[xxi] Nel saggio, scritto nell’aprile del 1938, Thomas Mann nega che si possa parlare di due Germanie radicalmente distinte, una buona, l’altra perversa. Con Hitler sarebbero al potere, al contrario, elementi da sempre presenti nel disegno generale dell’anima tedesca, non ricomposti in senso umanistico. V. Th. Mann, Fratello Hitler e altri scritti sulla questione ebraica, Milano, Mondadori, 2005, pp. 93-104.
[xxii] Lettera del 6.4.1925, in W. Benjamin, Lettere 1913-1940, trad. it. di A. Marietti e G. Backhaus, Torino, 1978, pp. 114-115.
[xxiii] F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Milano, SE, 1986.
[xxiv] Th. Mann, Morte a Venezia, trad. it. di Anita Rho, Torino, Einaudi, 1990.
[xxv] Come ha dimostrato H. Wysling, tutte le opere attribuite ad Aschenbach corrispondono a lavori di Mann progettati, ma mai portati a compimento (cfr. H. Wysling, Aschenbachs Werke. Archivalische Untersuchungen an einem Thomas-Manns-Satz, in «Euphorion», 59, 1965, pp. 272-314).
[xxvi] Th. Mann, La morte a Venezia, trad. it. di E. Filippini, Milano, 1991, p. 10.
[xxvii] F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, cit., p. 11.
[xxviii] Ibidem.
[xxix] Nel 1979 è apparsa la traduzione italiana della «Parte didattica» della Farbenlehre con il seguente titolo: Jh.W.v. Goethe, La teoria dei colori, a cura di R. Tronconi e con un’introduzione di C.G. Argan, Milano, Il Saggiatore, 1979.
[xxx] Jh.W.v. Goethe, Tag und Jahreshelfte, 1830, in Id., Poetische Werke, Berlin 1981, vol. IV, p. 180.
[xxxi] La Farbenlehre di Goethe si articola in due volumi e in tre parti.
[xxxii] Cfr. D. Kuhn, Goethes Geschichte der Farbenlehre als Werk und Form, in «Deutsche Viertelsjahrschrift», 34, 1960, pp. 369-387. «La Farbenlehre di Goethe è l’unico tentativo di rilevanti dimensioni fino ad oggi intrapreso, e in buona parte riuscito, di dar luogo a una Geistesgeschichte della teoria della Natura e della scienza su di essa fondata. Il suo concentrarsi sui colori le dona profilo e forza a un tempo: la quantità di materiale viene produttivamente circoscritta, il nesso all’occhio quale il senso più nobile mai lascia dimenticare l’uomo il quale, come sempre accade in Goethe, anche qui emerge dalla storia. In questo modo la parte è più generosa che il tutto». Così ebbero ad osservare più di cinquant’anni fa gli stessi curatori dell’edizione delle opere scientifiche di Goethe. Cfr. Jh.W.v. Goethe, Zur Farbenlehre. Historischer Teil, Ergänzungen und Erläuterungen, a cura di D. Kuhn e K.L. Wolf, in Id., Die Schriften zur Naturwissenschaft, Weimar, 1959, vol. 6 (II), p. IX.
[xxxiii] Th. Mann, Perduta, in Id., Padrone e cane e altri racconti, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 88-93.
[xxxiv] Cui pure è dedicato il primo saggio critico di Mann, Heinrich Heine il Buono, in Th. Mann, Fratello Hitler e altri scritti sulla questione ebraica, cit., pp. 3-7.
[xxxv] Th. Mann, Tonio Kröger, trad. it. a cura di Anna Rosa Azzone Zweifel, Milano, Rizzoli, 2009.
[xxxvi] Th. Mann, La montagna incantata, traduzione e introduzione di Ervino Pocar, Milano, Corbaccio, 2011.
[xxxvii] Bernhard Blume, Thomas Manns Goethe-Bild, in «Publications of the Modern Language Association of America», 1944; poi in volume, Bern, Franke, 1949.
[xxxviii] Secondo la celebre – e sconvolgente – affermazione goethiana, olimpica intuizione sulla “genetica del genio”.
[xxxix] F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, Milano, SE, 1986. Vide supra.
[xl] Th. Mann, Ora difficile, in Id., Racconti, a cura di Italo Alighiero Chiusano, Milano, Bompiani, 1986, pp. 431-442.
[xli] Th. Mann, I Buddenbrook, trad. it. di Anna Rho, Torino, Einaudi, 1992.
[xlii] Th. Mann, Altezza reale, in Id., Romanzi, vol. I, trad. it. di Margherita Carbonaro, Milano, Mondadori, 2007, pp. 889-1258.
[xliii] Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 29.
[xliv] In apertura del nostro contributo. Vd. supra.
[xlv] Che abbiamo richiamato in apertura del presente contributo. Vd. supra.
[xlvi] Vd. supra l’‘idolo critico’ di Thomas Mann, Sulla poesia ingenua e sentimentale di Schiller, op. cit.
[xlvii] Che richiama la goethiana idea della «metamorfosi delle piante» e della loro comune derivazione dall’Urpflanze.
[xlviii] Th. Mann, Altezza Reale, op. cit.
[xlix] Th. Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, IV voll., trad. it. di Bruno Arzeni, Milano, Mondadori, 2006.
[l] Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, a cura di Peter de Mendelssohn, 20 voll., Frankfurt a.M., 1980-86, XI, pp. 572-577.
[li] Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, cit., XIV, 2, p. 157.
[lii] Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann 1909-1955, a cura di Volkmar Hansen e Gert Heine, Hamburg, Knaus, 1983, p. 49. Cfr. l’Introduzione di H. Detering ad Altezza Reale, ed. cit., p. 842.
[liii] Ernst Bertram, Thomas Mann. Zum Roman «Königlische Hoheit», «Mitteilungen der Literaturhistorischen Gesellschaft Bonn» IV, 8 (1909), pp. 195-217; si veda anche Th. Mann, Gesammelte Werke – Frankfurter Ausgabe, cit., IV, 2, pp. 174-178.
[liv] Josef Hofmiller, Thomas Mann, «Süddeutsche Monatshefte» VII (1910), pp. 137-149. Cfr. l’Introduzione di H. Detering ad Altezza Reale, cit., p. 882.
[lv] Così Walter Killy in un articolo dedicato a Thomas Mann, che si può leggere nel Deutsches Literatur-Lexicon, vol. VII, Gütersloh-München, Berthelsmann, 1990, p. 449.
[lvi] Th. Mann, Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe, cit., XI, p. 574.
[lvii] Th. Mann, ibidem, XI, p. 579.
[lviii] Cfr. P. Rühmkorf, Gestelzte Manierlichkeiten, cit., e Id., Die neugewonnene Wertschätzung des Prosaartisten, cit., articoli da noi discussi supra e richiamati alle note 11 e 16.
[lix] Th. Mann, Ora difficile, op. cit.
[lx] Die Manns. Ein Jahrhundertroman. Film del 2001 con Armin Müller-Stahl, Sebastian Koch, Veronica Ferres, regia di Heinrich Breloer.
*
Ecumenismo e identità nazionale in Mann [n° 3] »
Questo testo è in formato DOC (72 KByte)
*
Ecumenismo e identità nazionale [n° 2] »
Questo testo è in formato DOC (52 KByte)
*
Ecumenismo e identità nazionale in Mann [n° 1] »
Questo testo è in formato DOC (40 KByte)
*
Steiner e Kandinsky in Caffarelli [abbozzo] »
Questo testo è in formato DOC (55 KByte)
*
Per una rinascita del Galeotus [definitivo] »
Questo testo è in formato DOC (69 KByte)
*
- Filosofia
Oggettività del mondo artistico nella redenzione
Oggettività del mondo artistico nella realtà redentrice
L’aspetto liberatore della creazione artistica ci richiama col suo luminoso ed eterno atto alla oggettiva realtà redentrice, per approfondire il processo del lavoro spirituale che elabora la natura nel modo dello spirito umano come Arte. Una parola illumina questo atto liberatore, al di là del senso teologico e di scuola, con nuova profondità, rivelatrice: transustanziazione.
Vediamo l’Amore come un’attenzione conscia all’Unità, soggiacente essenza di tutte le differenze. Nell’atto poetico tale segreta essenza la vediamo apparire come impulso corporificante e come forma spiritualmente corporificata. L’Io poetico appare il punto agente che coniuga amore e collera in un Amore incarnante se stesso come realtà umana dell’Arte.
Così la sostanza collerica che è essenzialmente solidificantesi nella differenza e nel distacco viene investita dalla forza unificatrice della sostanza amorosa e creata a nuovo, come la fiamma fa del carbone bragia.
Transustanziazione possibile in quanto l’Io dell’Artista imbeve l’io alienato delle cose, e ne trasforma l’entità naturifica che le manteneva nella Collera. E ciò che mantiene le cose nella Collera è lo spirito di mera e astratta differenza, di egoistico sonno.
Mentre l’io dell’artista è attento alla cosa, in questa si opera un passaggio dell’io attento, che la riconosce come assimilabile e l’accompagna con un suo sentimento. E questo, afferrata la cosa, l’intona diversamente da quel che era quando non era guardata. L’attenzione dell’artista non è mai passiva, non è mai mero guardare, ma attivo uguagliare la cosa al riguardante imbevendosi di un Io amoroso e transustanziandosi in Amore. Questo è il miracolo di tutti i momenti in tutti i piani della vita, grazie a cui il mondo perpetuamente si rinnova da perpetue ceneri.
E la cosa, l’oggetto dell’arte, non oppone a tale compenetrazione se non l’aspetto esteriore, che le resta, ma diventato lucido nell’Io che se ne impossessa; e l’io nell’atto allarga se stesso, perché si accresce dall’atto che risolve in Lui ciò che aveva contro.
L’attenzione è tutta, veramente, per questo reciproco ricercarsi e possedersi, in questo affondarsi dell’uno nell’altro, un atto d’amore.
E in nient’altro potremmo trovare la ragione di questo umano volgersi alle cose, agli oggetti dell’attenzione, e stare attenti alle cose e trasformarle in immagine sentimento e idea, se non nel fatto di avere in sé, l’Uomo, la Gioia, e di sentire il tutto divino desiderio di donarla al mondo e di trasformare il mondo in Gioia.
Il mondo creato dall’artista è un mondo di dono e di grazia, nel quale ciò che fu preso come natura è ridonato come Sopranatura, come mondo umano di Bellezza.
Mi rappresento la vita di un grande artista come un piccolo sistema planetario, realissimo nel piano invisibile e animico della natura, anche se non visibile nel fisico.
Un sistema, di cui l’artista è il sole, e attorno gli vengono gravitando e crescono con lui fecondati dalla luce del suo pensiero, dal calore della sua anima, si sottilizzano con lui evolutivamente, camminano con lui nel mondo stesso dei pianeti quelle anime che egli modifica includendole nel cerchio del suo mondo creativo.
Questo mondo o sistema interiore è ben più permanente, oggettivo e reale di qualunque aspetto fisico che sul piano visibile possa essere stato assunto dall’opera dell’artista.
E questo mondo interno è l’oggettiva realtà permanente della sua arte, mentre l’opera esterna può dirsene un’ombra e un segno.
Questo lato interno è una vita sottilmente organizzata come quella di un alveare: prende l’aspetto della forma suprema, la forma cosmica.
Così, attorniato da anime che gli offrono materia d’arte, sulle quali si è posato il suo occhio trasformatore, circondato da quelle misteriose energetiche Entità che nell’opera egli ha portato a fisica espressione in simboli e in termini di umane rappresentazioni, l’Artista si muove nel cammino del suo proprio divenire come un piccolo sistema di anime-forme celesti; e questo è il lato arcano del suo lavoro.
Le anime cercano il suo calore nell’orbita tracciata dal potere vincolante del suo pensiero che lavora. Attratte esse a lui da quella congeniale identità che le ha poste nel cerchio del suo mondo, in questo trovano l’energia per sottilizzarsi.
L’azione dell’artista sugli individui vissuti in lontana epoca o coeva, che egli faccia materia del proprio lavoro ed elevi al mondo contemplativo, ha un felice riflesso sul divenire dell’individuo scelto.
Amleto è più che Amleto dacché Shakespeare lo ha poeticamente lavorato. Il Dottor Faust non invano è stato redento nel poema goethiano.
Faust, reale oggettiva permanente anima, trova nel poema del poeta la mirabile scala di ascesa del proprio divenire.
Non ci si può figurare quanto il pensiero di Leonardo abbia aggiunto al divenire di Lisa del Giocondo, e quanto l’attenzione poeticamente amorosa di Raffaello al divenire della Fornarina. Come sarebbe il mondo senza l’Incompiuta di Schubert?
Perché il fissarsi dell’attenzione di tali centri di forze creative su qualche vita individuale non avviene senza che una vigorosa emissione di energie evolutive non l’investa come impulso di vita ascendente.
Immobile è l’espressione contemplativa che ne foggiano gli artisti, ma immobile in alto, e come ideale. L’anima dei raffigurati vi si volge come a modello; in su ne è tratta da un certo divino amor proprio. E vede la propria vera immagine nell’immagine ideale che il poeta ha realizzato, e non più in quella empirica realtà già da essa vissuta.
L’artista e quelle anime affini da lui lavorate con energie poetiche, e fatte in qualche grado depositarie delle sue forze, permangono uniti nel loro perpetuo divenire in una unità certo sotterranea e talora non affiorante alla soglia della coscienza normale, ma pure operante a formar nuclei ed organi di evoluzione nel tessuto dell’oggettivo mondo spirituale.
L’azione estetica che li riunì una volta è un filo di oggettivante spirito che non si romperà più.
Perpetua rimarrà la sensazione di essere state toccate da un soffio creativo. Un desiderio di ascendere, di fiorire nel mondo dello spirito è il germe vivo destato da tale soffio.
Tutto ciò che è bello nel mondo oggettivo origina da un’occhiata d’amore gettata su di loro da un artista.
Creando una forma ideale il poeta muove e sviluppa sé: ogni attività è aumentativa. Ma una forma ideale è una forza che crea un desiderio di somiglianza. Gli uomini che possono comprenderla desiderano uguagliarsi a quel pensiero che fu pensato di essi.
Gli uomini non scendono in basso perché i poeti divinamente si ostinano a crearli in alto.
Anche il loro sangue non è più come sarebbe se nessuno li pensasse poeticamente. Un sangue spirituale ricco non di vitamine ma di forze ideali si mescola al sangue terrestre e carnale, ricco di anticorpi e di malattie. L’artista non teme di illudersi. E resta in quello stato di fede in cui la sua poetica illusione si fa l’energica novità a cui lentamente gli uomini coevi devono avvicinarsi e vengono avvicinandosi per modellarsi alla forma oggettiva dell’ideale.
Attorno a Whitman il mondo americano era pur sempre un mondo di commercio e di interessi di cassa.
Poteva parere che Whitman fosse un solitario illuso e un ingenuo idealizzatore di uomini e donne, che in realtà erano tutt’altra cosa.
Ma Whitman creò un’immagine del futuro, modellò una verità che è rimasta sul popolo americano come un ritmo selezionante dalla massa una razza nuova, movimentò un ritmo creatore che non può morire, modellò una nuova razza oggettivamente presente nel mondo archetipo della mente, ne incarnò la figura nel canto. Lentamente la natura e le cose si piegheranno a questa immagine che di esse fu formata da un veggente: «ché d’un nodo eterno / si lega il genio alla natura, e quanto / promette il primo la seconda adempie» (Schiller; trad. Maffei).
Gli oggetti (viventi o inerti) amati in tale forma evolutiva dall’artista si sviluppano per mezzo della fedeltà alla forma esatta che per essi e di essi è stata pensata. Può qui applicarsi quello che Goethe sentenzia per bocca di Pantalis nel prodigioso finale che chiude il terzo atto della seconda parte del Faust: «Non è solo il merito, ma anche la fedeltà che salva le persone dall’oblio».
Ma l’artista si sviluppa con la fedeltà al moto ascendente del divenire spirituale, sulla quale egli può appoggiare la fede di non andar travolto nel mondo elementare, dopo la morte.
La sua vita diventa quel divino potere della Bellezza, che perennemente intesse nuovi veli alla Verità, che mai si mostra nuda.
Si rallegri dunque chi per interna luce sente di dover portare il peso della Bellezza per incarnarla nel mondo. Egli porterà con sé per sempre questo potere accrescendogli potenza con l’opera, come il suo proprio modo di divenire, come quella peculiare attitudine di servizio che aiuta gli uomini col mezzo della Gioia, la forma più attraente della Compassione e della Conoscenza, verso le altezze finali del Piano Divino.
L’Arte sotto il diretto impulso dell’intelligenza è generatrice della forma mentale e logica, oggettiva, organica e corporea dell’opera; dove prevalendo l’ordinamento strutturalmente logico del diverso e la costruzione del materiale sensibile, la misura genera il godimento astratto spiritualmente sensibile nella contemplazione.
Onde un carattere di decorativa serietà, un’accurata misura di corpo, dove l’anima non appare come Gioia interna di collegamenti mistici con l’Oltre, ma come esteriore constatazione della proporzionalità perfetta attuata nell’armonia della misura.
Questa arte produce in chi la crea e la contempla un raffinamento del senso della forma, un’attitudine mentale a foggiare e a sentire il gesto della linea e il movimento organico delle apparenze corporee nei rapporti di linee, luce, colori, volumi, superficie, suoni, accordi (rapporti verticali), toni, melodia (rapporti orizzontali) e del convenire delle parti con le parti in un tutto di sensibilità logica oggettivantesi: a legare le molteplici forme in un tutto strutturale, dove le proporzioni le analogie e le rispondenze sono, in senso mentale, tangibili ed emergenti in autentica corporeità.
Paolo Melandri
9 marzo 2013
Verso una rinascita dello Spirituale [n° 3] »
Questo testo è in formato DOC (68 KByte)
*
Verso una rinascita della spiritualità [n° 2] »
Questo testo è in formato DOC (61 KByte)
*
Verso una rinascita della spiritualità artistica »
Questo testo è in formato DOC (51 KByte)
*
- Musica
Personalità di Mozart [con la Seconda Parte]
La personalità di Mozart
Otto Jahn, seguito in questo da Hermann Abert, identifica la caratteristica saliente della personalità di Mozart con la continua attività creativa. Secondo Jahn, Wolfgang, a differenza di Leopold, non poteva interrompere a piacimento il pensiero musicale, ma ne era sopraffatto, trascinato continuamente. Naturalmente nemmeno i maggiori biografi mozartiani volevano dire che il vero Mozart vivesse altrove, come vuole invece il mito; tuttavia, in diversi passi della loro diasamina, lasciano intendere qualcosa di molto simile: l’infantilismo, di cui parla Nannerl nelle sue memorie, sarebbe un indizio importante per intendere che tra Mozart e il mondo esterno esisteva una forte discrasia, una quasi-incomunicabilità, per cui tutti i pensieri più profondi il compositore li avrebbe affidati unicamente alla musica. A questa interpretazione vorrei contrapporre la mia, che non intende certo far deserto dove si è già edificato, e bene, ma “rimettere le cose a posto”, come più volte disse lo stesso Mozart della sua musica (ad esempio del Don Giovanni, K 527).
Se si dice che Mozart pensava sempre alla propria musica, ne era sopraffatto, investito come da una sorta di romantica terzana creativa, si dice da un lato un’ovvietà, e dall’altro si contraffanno i tratti autentici della sua personalità. Infatti, a cos’altro pensavano, continuamente, Bach, Haendel e Beethoven, per esempio? Non erano forse, come dimostrano anche eloquenti e informatissime biografie, continuamente coinvolti nel gioco della creazione e dell’elaborazione motivica, armonica e timbrica? Se questo è vero (e vi è davvero scarsa possibilità che non lo sia), Bach, Haendel, Beethoven e, in genere, tutti i grandi Maestri, avrebbero avuto la stessa identica personalità di Mozart, a parte qualche trascurabile idiosincrasia, visto che il “mozartiano in Mozart” sarebbe proprio il continuo, inarrestabile processo creativo. Certamente la caratteristica dell’ininterrotto pensiero musicale creò problemi d’inserimento nella società non solo a Mozart ma anche ai suddetti compositori, e a molti altri. Ma non può risiedere qui il nocciolo del problema, perché non dobbiamo parlare della personalità dei grandi musicisti, ma di quella di Mozart che, così descritta, assurge allo status di simbolo e di ipostasi, ma perde ogni credibilità agli occhi di chi si voglia accostare a lui con sincero spirito d’indagine, e non nell’intento di suggestionare o commuovere.
Dunque dobbiamo far scendere un po’ dal piedistallo questo Mozart, che è stato anche ridotto a sublime idiota nella pellicola di “Amadeus”, oppure è stato sempre associato a qualcosa di misterioso e di lontano, ma non ha ricevuto mai un po’ di comprensione umana e di attenzione per le sue caratteristiche personali, né dai contemporanei né dai posteri. Insomma Mozart interessava ed interessa sempre come mito, mai come uomo reale. La prova probante di tanti musicologi non solo attuali sarebbe la straordinaria, “miracolosa” capacità di Mozart di completare mentalmente le sue partiture, per poi stenderle su carta con comodo e a tempo debito. Sono costretto ad insorgere una buona volta contro questa banale mistificazione, perché esattamente lo stesso si potrebbe dire di Bach, di Haendel e, se volete, perfino di Cimarosa, Boccherini, o di Salieri. Fino a che Beethoven non venne a rivoluzionare la prassi compositiva portando con sé, come caratteristica saliente e discriminante, il rovello del “vero” Grande Artista, che non si accontenta mai dei suoi pensieri musicali, ma ricerca una perfezione siderale, la prassi creativa dominante fu, appunto, quella mozartiana. Si dirà che le partiture mozartiane sono più complesse di quelle dei suoi contemporanei e che sono “incredibilimente perfette”. Ma questo è tutto ciarpame pseudo-romantico, che avvilisce la qualità e l’estrema raffinatezza della musica mozartiana rendendola un prodotto “divino”, buono per tutte le stagioni e molto gradito anche alle mucche (che, secondo molti allevatori, aumentano la produzione di latte, ascoltando la sua musica). In realtà abbiamo schizzi preparatori di mano di Mozart che riguardano il Finale dell’Atto I del Don Giovanni, composizione particolarmente difficile per la presenza delle due orchestre sulla scena e in platea, che, come tutti sanno, suonano nello stesso lasso di tempo musiche diverse nel ritmo e nella impostazione tonale, creando artificiose e bellissime dissonanze, ma rimanendo sostanzialmente fedeli al concetto dell’eufonìa e al “credo mozartiano” (espresso in una lettera a Leopold) di piacere agli intenditori senza offendere le orecchie dei dilettanti; la partitura della Sinfonia K 297, detta “Parigina”, una delle più alte realizzazioni di musica “assoluta” in assoluto, presenta moltissime cancellazioni e correzioni, attestanti cambiamenti di rotta anche abbastanza sostanziali, nonché infiniti ritocchi riguardanti l’orchestrazione e la distribuzione delle parti, tali da fare invidia anche a un Mahler in vena di pignolerìe e di difficoltà mirabolanti per gli esecutori; la leggenda della musica “tutta composta mentalmente” deriva da un’unica lettera a Nannerl, in cui il fratello si scusa dell’ordine in cui le manda un Preludio e Fuga da lui composto (KV 394 / KE 383a, in Do), e cioè prima la Fuga e poi il Preludio perché, come dice lui, mentre trascriveva mentalmente la Fuga, stava componendo il Preludio che segue nello stesso fascicolo: si tratta, agli occhi di chi sappia un po’ distinguere, di una composizione assolutamente “minore” e poco impegnativa per il musicista, un esercizio, insomma, nello stile di Handel, quale risulta anche dalle moderne esecuzioni, nessuna delle quali ci rivela un capolavoro. Estendere questa ammissione mozartiana a tutte le altre sue composizioni è un atto arbitrario e cialtronesco, proprio di chi vuole creare il “mostro”, il “fenomeno da baraccone” a tutti i costi. Anche se, purtroppo, la Vedova Mozart ha “fatto pulito” di tutte le stesure preliminari in forma di “parcella” del suo defunto marito, e questo per avvalorare la leggenda messa in giro, sia pure inconsapevolmente, dall’acidula sorella Nannerl, allo scopo evidente di guadagnare il più possibile dalla pubblicazione e dalla vendita di tutte le partiture in suo possesso, noi sappiamo da testimonianze inequivocabili (dalle Lettere, da alcune affermazioni di J. Haydn) che il metodo seguito da Mozart per tutte le sue composizioni di qualche momento era quello di stendere prima uno schizzo generale, poi di passare alla stesura a più voci in forma di “parcella” e infine di giungere alla stesura “definitiva”, in bella copia; là dove la Vedova non è giunta a metter le mani, e cioè nelle parti “autentiche” del Requiem del marito, notiamo in atto questo processo elaborativo, comune anche a Haydn e a tutti i compositori più “impegnati” e raffinati della loro epoca. Abbiamo, dall’altro lato, composizioni “buttate giù” al cembalo come improvvisazioni burlesche, alle quali ha preso parte, talvolta, un’altra persona presente al gioco: ottimo esempio, la “Marche funèbre del Signor Maestro Contrappunto” KV 453a (1784), nella partitura della quale si notano forti sbavature dovute alla posizione verticale del foglio, e interventi di mano ignota, certamente di un’allieva da lui coinvolta nell’esercizio, secondo prassi didattiche diffuse alla fine del ’700. Mozart ha inoltre voluto “rimpolpare” composizioni altrui, come nel caso dell’operetta “La pietra filosofale” in cui diede una mano a Schikaneder, stendendo, “a tempo perso”, quasi tutte le parti dei fiati (Anh. C 7.06), in cui eccelleva; nella Clemenza di Tito (K 621), invece, aveva lasciato da “rimpolpare” alcuni numeri che noi oggi percepiamo come perfettamente compiuti a sé, ma fu solo la mancanza di tempo che gli impedì di stendere le parti dei fiati in arie in cui erano previsti dalla Partitura, ma potevano anche essere “omessi” senza pregiudicare la comprensione del pezzo, come ad esempio nell’eloquente aria di Publio “Tardi s’avvede”, elaborata dal punto di vista vocale, ma accompagnata soltanto dagli archi, nonostante all’inizio di essa fossero stati indicati anche 2 oboi e 2 corni e nonostante la situazione stimolasse in Mozart effetti “da Leporello” per la grossolana ingenuità del personaggio, effetti da conseguire, appunto, attraverso un sapiente uso dei fiati, che certamente Mozart aveva già escogitato, ma che poi non ebbe il tempo di stendere. Questo certamente significa che, anche dopo il buon successo praghese, e sistemata la barcollante situazione finanziaria, Mozart sarebbe tornato sulla partitura della Clemenza e, d’un solo fulmineo sguardo supervisore, l’avrebbe portata tutta ai livelli delle sue Opere maggiori. Infatti nella Clemenza di Tito vi sono arie (evidentemente compiute e rifinite) dalla lussureggiante scrittura orchestrale, ed altre appena accompagnate da frasi essenziali degli archi: altro che “terso chiarore lunare” e “poetica della rinunzia” nell’ultima (o penultima, poiché il Flauto magico, K 620, è contemporaneo alla Clemenza, K 621) Opera teatrale! Che Mozart non potesse essere del tutto soddisfatto dello stato in cui si trovava la partitura della Clemenza, lo testimonia il fatto che, quando dovette riorchestrare il Messia di Handel (KV 572), inserì una “petite bande” di fiati al completo (2 corni, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 1 flauto) in tutte le arie dell’oratorio, e così fece nella sua trascrizione dell’Acis und Galathea (KV 566), dell’Alexanderfest (KV 591) e della Cäcilien ode (KV 592) del medesimo compositore. Tutto questo, e quanto aggiungerò via via nello stendere questo ritratto musicale, mette fine per sempre e indubitabilmente a tutte le leggende su Mozart “divino inconsapevole” e “genio e sregolatezza” sorretti da alcunché di divino e inspiegabile, quasi un’anticipazione del rimbaudiano “deréglement de tous les sens”, nonché all’odiosa e sciocchissima idea di un Mozart rivale di Cristo nell’assegnazione del titolo di “Figlio di Dio”. Sì, perché è normale sentir dire che il corpo che Mozart ebbe fu il luogo in cui si incarnò “maggiormente”, più che in ogni altro, lo Spirito divino. Che sciocchezze! Viene in mente il “più vasta orma stampar” di manzoniana memoria, espressione che appartiene, appunto, ad una poesia romantica, tutta intrisa dei concetti allora au dernier cri. Il paragone, talvolta stretto al limite della parodia, tra Mozart e Cristo è non solo empio e irrispettoso della fede di tanti lungo i secoli, ma assolutamente fuori luogo, perché anche Wolfgang credeva, e quanto!, nell’«Amor che muove il sole e le altre stelle». È vero che egli non poneva, ad esergo delle sue composizioni, il “Soli Deo Gloria” con cui principiava sempre il suo “carissimo amico” Haydn e che era stato usato allo stesso modo da Johann Sebastian Bach quarant’anni prima (dedica e richiesta di aiuto), ma anche in questo Mozart non si discostava dalla prassi più comune ai suoi tempi, perché né Johann Christian Bach, né Carl Philipp Emanuel Bach, né Wilhelm Friedmann Bach, né Leopold Mozart, né Domenico Scarlatti, né Johann Kuhnau, né Baldassarre Galuppi, né Johann Schobert, né L. Honauer, né H. Fr. Raupach, né J. G. Eckard, né I. Holzbauer, né E. Eberlin, né Johann Froberger, né insomma alcuno dei suoi primi maestri, da cui “apprese il mestiere” e con molti dei quali ebbe spesso contatti personali o epistolari, mai usò tale formula, almeno per iscritto, giudicandola senz’altro “cosa del secol passato” e indubbiamente di cattivo gusto, ché una preghiera la si può sempre recitare, senza lasciarne traccia sul manoscritto. Una testimonianza toccante della fede di Mozart, a chi sappia leggere recto e verso, e abbia consuetudine con il suo modo di parlare e di scrivere, risulterà sempre la famosa frase che disse di fronte al pastore luterano secolarizzato e filosofo illuminista Hans Friedrich Neumann. Neumann, incontrando Mozart a Berlino durante il viaggio di quest’ultimo in Germania nel 1789, gli spiegò con sussiego e saccente meticolosità che Gesù Cristo non era mai esistito, non solo come lo raccontavano le Scritture, ma in assoluto, essendo i Vangeli nient’altro che un collage di citazioni dall’Antico Testamento, cucite attorno ad una figura assolutamente non credibile, contraddittoria, insomma a un’invenzione di sana pianta, non riuscita neanche tanto bene. Ed essendo così soverchiante la valanga d’argomenti che l’ex-pastore portava a suffragio della sua tesi, Mozart non ebbe nemmeno l’ardire di replicare, ma scoppiò a piangere e disse semplicemente: «Ach, e la messe era pur sì bella!». «Era pur sì bella» lo disse in Italiano, mentre esordì in Tedesco e messe lo disse in Francese. Lungi da costituire una prova del suo infantilismo, tale da deliziare il suo biografo-psicologo Hildescheimer, la frase rivela una fortissima tensione e commozione d’animo, che portò Mozart sull’orlo di una crisi di nervi (durante il viaggio del 1789 era già profondamente malato: figurarsi quanta voglia aveva di farsi indottrinare da un filosofo illuminista, discepolo di quel Voltaire di cui aveva già scritto al padre nel 1778: «è morto come meritava, mangiando la propria merda»). Infatti non è Mozart a ricordare l’episodio, in una delle tantissime e circostanziate lettere che scriveva alla moglie, rimasta a Vienna, anche due volte al giorno, e pur piene di “bozzetti” e “ritratti dal vivo” di persone incontrate, ma lo stesso filosofo Neumann, in una Memoria certamente credibile, perché riporta l’impasto linguistico usato spesso da Mozart, soprattutto quando si sentiva a disagio e non sapeva cosa dire, come dimostrano eloquentemente le Lettere scritte al padre in occasione del suo matrimonio, fortemente osteggiato dal genitore. Questo non è infantilismo, ma multilinguismo di una persona cresciuta dai cinque ai sedici anni in continuo viaggio, o turnée che dir si voglia, e abituata a rispondere a ciascuno nella sua favella, tornando al Tedesco o al Francese quando si sentiva insicuro. Mozart, ad esempio, aveva una conoscenza dell’Italiano e degli italiani degna di un grande scrittore e conoscitore d’anime, e certe sue lettere scritte nella nostra lingua non sfigurano a fianco di quelle dell’Alfieri, o del Foscolo. Dunque, incominciamo a scoprire che le sue doti non erano soltanto musicali, ma anche letterarie, nel senso che ricordava verbatim quanto gli veniva detto, parola per parola, e non perché fosse un campione della memoria, un Pico della Mirandola insomma, ma perché aveva un enorme interesse nei confronti di chiunque gli stesse davanti, che fosse un facchino o una Maestà imperiale. Egli è perciò il più umanista dei compositori, perché per lui il centro resta sempre e soltanto l’uomo, anche al di là della musica. Fosse vissuto nell’800, quando i musicisti facevano anche professione di letterati, ci avrebbe lasciato le più belle memorie mai scritte da chiunque. E questa non è musica, né letteratura in senso stretto: è senso acuto dell’osservazione, e Mozart sarebbe benissimo potuto essere un grande romanziere, se i tempi fossero stati maturi, e se la sua continua attività musicale gli avesse fruttato abbastanza da potergli permettere di dedicarsi a tempo pieno anche ad un’altra professione. La frase «la messe era pur sì bella» non sottintende superficialità ed estetismo ante litteram come vorrebbero i cultori della sua sublime ingenuità, ma significa, ellitticamente, che il contenuto della messa era bello, appagante, non i riti esteriori. Inoltre, dopo esser passato dal Tedesco al Francese, Mozart prosegue in Italiano la frase, e questo perché quanto gli veniva alle labbra si adattava perfettamente all’idioma in cui trovava espresse cocenti passioni nei libretti d’Opera, e in particolare allo stile “sostenuto” e tragico del Recitativo Accompagnato. La frase, infatti, non sfigurerebbe in bocca a Donna Elvira, o a Donn’Anna, quando apprende che «quegli è l’uccisore del padre mio». Anche nelle lettere a Puchberg, confratello massone che gli prestò danari nel 1788, ricorrono espressioni idiomatiche di taglio teatrale, tipiche dei recitativi accompagnati. Mozart non deve averci pensato sopra, tanto più che riteneva umiliante e degradante chiedere soldi in prestito, per cui possiamo immaginare con notevole esattezza che questo fosse il suo modo d’esprimersi anche “a viva voce”, quando si trovava in situazioni imbarazzanti, o addirittura tragiche. L’espressione «era pur sì bella» è sicuramente autentica, e mozartianissima, nonostante venga riportata da Neumann a distanza di anni (il quale, comunque, si sarà stupito dell’insolito eloquio del suo interlocutore, a dir poco bizzarro anche per i molto tolleranti cànoni dell’epoca), perché ricorre, tale e quale, anche in una delle ultime, e delle più tragiche lettere di Mozart, datata “settembre 1791” e indirizzata a Lorenzo Da Ponte. Per il suo più amato librettista italiano, scrive in Italiano, e benissimo (ma per la sua grande abilità nell’utilizzo della lingua italiana basti come esempio la dedica dei Quartetti K 387, 421, 428, 458, 464, 465 “Al mio caro amico Haydn”).
Ma per parlare della lettera a Lorenzo Da Ponte, dobbiamo fare qualche premessa. Dopo la prima rappresentazione del Flauto magico (30 settembre 1791) Mozart si mise a lavorare di buona lena al suo Requiem, già incominciato durante l’estate. Questo zelo febbrile, che perdurava da più di un anno, di comporre a ritmi molto sostenuti era in palese rapporto con la sua malattia, che a sua volta era la conseguenza di anni di scarsa nutrizione, di eccessivo lavoro e di preoccupazioni di ogni genere. Già da ragazzo era stato più volte gravemente malato, per lo più dopo gli strapazzi dei viaggi, e anche del primo periodo viennese sappiamo attraverso il dottor Barisani di due casi analoghi. Alla rappresentazione del Tito a Praga era giunto già molto sofferente e da allora la sua salute peggiorò giorno dopo giorno. Già durante il compimento del Flauto magico andava soggetto a svenimenti e lo stato d’animo s’incupiva a vista d’occhio. Lo prova la singolare lettera in Italiano cui abbiamo accennato sopra, indirizzata a Da Ponte a Londra, il 7 settembre 1791: «Aff.mo Signore. Vorrei seguire il vostro consiglio, ma come riuscirvi? ho il capo frastornato, conto a forza, e non posso levarmi dagli occhi l’immagine di questo incognito. Lo vedo di continuo, esso mi prega, mi sollecita, ed impaziente mi chiede il lavoro. Continuo, perché il comporre mi stanca meno del riposo. Altronde non ho più da tremare. Lo sento a quel che provo, che l’ora suona; sono in procinto di spirare; ho finito prima di aver goduto del mio talento. La vita era pur sì bella, la carriera s’apriva sotto auspici tanto fortunati, ma non si può cangiar il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quello che piacerà alla provvidenza. Termino ecco il mio canto funebre, non devo lasciarlo imperfetto». Questa lettera è piena d’espressioni idiomatiche mozartiane, e il lettore avrà già riconosciuto il passo che a noi più interessa: «la vita era pur sì bella», quasi identico a «e la messe era pur sì bella»: evidentemente Mozart si esprimeva così anche nella conversazione, come attesta la testimonianza, straordinariamente precisa, di Neumann. Altra espressione singolarmente vivida e drammatica è, ad esempio, «ho il capo frastornato, conto a forza», con quel riferimento quasi preterintenzionale al “contare”, alla metrica compostiva, dunque; poi abbiamo quel «continuo, perché il comporre mi stanca meno del riposo», mozartianissima tra le confessioni: il lavoro compositivo stanca lo stremato compositore meno del labile riposo di chi sa di avere i giorni contati; ed ecco quell’«altronde non ho più da tremare», dove senti il trillo allarmato degli archi, vero effetto da Opera Seria; segue il liricissimo «Lo sento a quel che provo», degno attacco d’Aria di Furore, con tanto di Furie e di spettri che dilaniano “il core”; e siamo venuti a «la vita era pur sì bella», che introduce il tema fatalistico, degno del Concerto n. 20 in re minore per fortepiano e orchestra, K 466: «non si può cangiare il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quello che piacerà alla provvidenza». Il fatalismo Wolfgang l’aveva ereditato da suo padre Leopold, ed espressioni simili risuonano sovente nella corrispondenza tra i due, per esempio in relazione ai cattivi rapporti che entrambi intrattenevano con l’Arcivescovo Colloredo, dove però il più remissivo è il padre, mentre il figlio a volte esplode in veri e propri moti di ribellione. Ma non andiamo troppo oltre con i paragoni: la lettera appena presentata, per quanto scritta ormai in articulo mortis, riassume molti degli aspetti più caratteristici della personalità di Mozart, non ultimo la paura per «questo incognito», che si è tramutata da diffidenza verso ogni furfanteria dei propri colleghi, e soprattutto degli “intriganti Italiani”, in vero e proprio orrore paranoico degno degli scenari apocalittici che così spesso si spalancano sulle pagine del Requiem.
Parte seconda
Sappiamo da molte fonti che Mozart amava sinceramente gli animali: nelle sue lettere gran parte è riservata ai suoi animali domestici, cani e uccelli. In certi periodi si interessò anche di cavalli, sappiamo infatti che nel periodo viennese si dedicava per consiglio del medico a quotidiane cavalcate mattutine. Non è stato però mai un cavallerizzo appassionato, per il persistere di una certa qual diffidenza verso i cavalli. Durante il primo periodo viennese (1782-1785), quando i lauti guadagni gli consentivano un tenore di vita assimilabile a quello degli aristocratici, la sua carrozza era tirata da sei cavallini bianchi ungheresi, da lui mantenuti nelle sue stalle e cui voleva non fossero lesinati né foraggio della miglior qualità, né le cure e tutte le attenzioni di cui avessero bisogno: una spocchierìa alla moda degna del più raffinato, vanitoso – e facoltoso – cittadino della Capitale imperiale, o Residenza, come si diceva allora.
Se la posizione di Mozart nei riguardi della religione fu determinata in buona parte dall’ambiente circostante e soprattutto dall’educazione ricevuta, il suo sviluppo corrisponde però perfettamente alla sua natura. Data la mentalità del padre, nulla di più naturale che egli sia stato educato alla più rigorosa fede cattolica. Seppure in minor misura, Wolfgang condivise anche il punto di vista paterno nei riguardi di altre confessioni. Così per esempio distingue nettamente i compositori luterani dagli altri e ancora nel 1778 esprime il desiderio di trovar lavoro in una città cattolica. In effetti è rimasto fino alla fine un fedele seguace della Chiesa cattolica, anche quando cominciò a criticarne l’aspetto dogmatico. Ciò è ben comprensibile. Tutto il suo essere tendeva in ogni cosa a prender le mosse da un’immagine sensibile; e solo così poteva procedere nell’organizzazione del pensiero e della creazione artistica. Di tutte le confessioni quella che più rispondeva a questa esigenza era appunto il cattolicesimo che parte dal dato sensibile e afferrabile per giungere al simbolo. Durante tutto il periodo del suo sviluppo la posizione di Mozart nei riguardi della religione è sostanzialmente determinata dall’influsso paterno. Ancora le sue parole del 24 ottobre 1777 suonano anche formalmente come riflesso della fede di Leopold: «Ho sempre Dio davanti agli occhi, riconosco la sua onnipotenza, temo la sua ira, riconosco però anche il suo amore, la sua pietà e misericordia verso le sue creature. Non abbandonerà mai i suoi servi… se le cose andranno secondo il suo volere andranno anche secondo il mio, quindi nel migliore dei modi». In seguito le considerazioni religiose si fanno più rare nelle sue lettere; avvertiamo che il pensiero di Mozart si fa più libero in questo campo, pur senza rinnegare mai minimamente i fondamenti cattolici. Non si deve dare troppa importanza alle frecciate contro i preti, frequenti soprattutto dopo l’entrata di Wolfgang nella massoneria, giacché proprio uno dei suoi migliori amici, Bullinger, era prete. La critica di Mozart anche in questo caso si rivolgeva agli individui, non alla categoria. Più sintomatiche sono le frequenti, pressanti interrogazioni di Leopold se il figlio sia andato sempre a messa e se si sia confessato, segno che su questo punto non era del tutto sicuro. In effetti Mozart cominciava a interpretare a suo modo certi precetti della Chiesa, ad esempio il digiuno. Molto più significativo è però il fatto che assai per tempo, accanto alla credenza dogmatica, cominciò a farsi sentire in lui anche l’impulso mistico. Lo provano i lavori sacri della giovinezza, che, sia per il numero che per il carattere, sono la migliore testimonianza delle sue forti esigenze religiose. Ma in essi proprio le parti di intonazione mistica, come il «Qui tollis», l’«Et incarnatus est», ecc., rivelano la più profonda partecipazione del loro autore. Si avverte qui per la prima volta la spinta alla contemplazione diretta della divinità, al di là di ogni limite dogmatico e razionale, onde attingere con l’esperienza interiore ciò che la Chiesa tenta di definire concettualmente. Vi si esprime nel contempo quell’anelito mistico al sovraterreno, che non si dovrebbe mai trascurare pur riconoscendo in lui una schietta gioia di vivere.
Il problema della morte e dell’aldilà ha occupato Mozart, come è naturale, più nel periodo della maturità che durante la giovinezza. Date le sue convinzioni religiose va da sé ch’egli abbia creduto fermamente nell’immortalità dell’anima individuale, nell’eterna salvezza e nel ritrovamento, dopo la morte, di tutti i suoi cari. Nelle messe giovanili le parti riguardanti questi argomenti, come l’«Et vitam venturi saeculi», rivelano tuttavia come Mozart non si fosse ancora svincolato dall’àmbito più strettamente dogmatico: esse infatti si muovono nell’àmbito impersonale della convenzione, esibendo una spigliata ma non approfondita consocenza del contrappunto, in fughe e fugati da manuale, “impettiti” e privi di autentica partecipazione emotiva. Come sempre, anche qui era necessaria l’esperienza per indurlo a una presa di posizione più precisa. Ciò accadde alla morte della madre, sulla quale scrive a Leopold: «Tre cose mi hanno consolato in questa triste circostanza, la mia fiduciosa rassegnazione al volere di Dio, la serena bellezza della sua morte, che mi ha fatto pensare a come in un attimo sia divenuta tanto felice – tanto più felice di noi, che ho desiderato di partire in quell’istante con lei. Da questo desiderio e da questo anelito è derivata la mia terza consolazione, che cioè non l’abbiamo perduta per sempre, che la rivedremo, e staremo insieme, più felici e contenti che in questo mondo».
Anche alla morte del dottor Barisani nel 1787 Mozart si esprime analogamente : «Lui sta bene! – ma io, noi e tutti coloro che lo conoscevano da vicino, non staremo mai più bene fino a che non avremo la fortuna di rivederlo in un mondo migliore per non lasciarci più».
Da allora in poi Mozart ha riflettuto sempre più profondamente sui cosiddetti “problemi” (ma che lui non avrebbe mai chiamato così, semmai “misteri”, o forse “casi”: l’espressione «ne’ suoi casi», intesa in senso davvero molto lato, ricorre spessissimo nel frasario mozartiano, tra l’accezione filosofica e quella, molto più semplicemente, cronachistica) della morte e dell’immortalità. Era particolarmente grato alla massoneria, che gli dava molti suggerimenti in quella direzione. Si veda in proposito il famoso passo della sua ultima lettera al padre, del 4 aprile 1787. Leopold era a letto ammalato ed è singolare come il figlio, quasi vedesse nel futuro, si fosse già familiarizzato con l’idea della prossima perdita del padre e gli rivolgesse frasi di filosofica consolazione, come ad uno già pronto all’ultimo viaggio: «Perché la morte, a ben guardare, è il fine ultimo della nostra vita, da un paio di anni mi sono familiarizzato con questa vera e migliore amica degli uomini, cosicché la sua immagine non ha per me nulla di terribile, anzi mi dà calma e consolazione. Ringrazio Iddio di avermi concesso l’occasione (Lei mi comprende) di riconoscere nella morte la chiave della nostra vera felicità. Non mi corico mai senza riflettere che, per quanto giovane, potrei non vedere il giorno seguente, ma nessuno di coloro che conosco può dire che nella vita io sia triste o scontento. Per questa mia serena gioia ringrazio ogni giorno il mio creatore e la auguro di cuore al mio prossimo».
*
- Musica
La personalità di Mozart [Inizio]
La personalità di Mozart
Otto Jahn, seguito in questo da Hermann Abert, identifica la caratteristica saliente della personalità di Mozart con la continua attività creativa. Secondo Jahn, Wolfgang, a differenza di Leopold, non poteva interrompere a piacimento il pensiero musicale, ma ne era sopraffatto, trascinato continuamente. Naturalmente nemmeno i maggiori biografi mozartiani volevano dire che il vero Mozart vivesse altrove, come vuole invece il mito; tuttavia, in diversi passi della loro diasamina, lasciano intendere qualcosa di molto simile: l’infantilismo, di cui parla Nannerl nelle sue memorie, sarebbe un indizio importante per intendere che tra Mozart e il mondo esterno esisteva una forte discrasia, una quasi-incomunicabilità, per cui tutti i pensieri più profondi il compositore li avrebbe affidati unicamente alla musica. A questa interpretazione vorrei contrapporre la mia, che non intende certo far deserto dove si è già edificato, e bene, ma “rimettere le cose a posto”, come più volte disse lo stesso Mozart della sua musica (ad esempio del Don Giovanni, K 527).
Se si dice che Mozart pensava sempre alla propria musica, ne era sopraffatto, investito come da una sorta di romantica terzana creativa, si dice da un lato un’ovvietà, e dall’altro si contraffanno i tratti autentici della sua personalità. Infatti, a cos’altro pensavano, continuamente, Bach, Haendel e Beethoven, per esempio? Non erano forse, come dimostrano anche eloquenti e informatissime biografie, continuamente coinvolti nel gioco della creazione e dell’elaborazione motivica, armonica e timbrica? Se questo è vero (e vi è davvero scarsa possibilità che non lo sia), Bach, Haendel, Beethoven e, in genere, tutti i grandi Maestri, avrebbero avuto la stessa identica personalità di Mozart, a parte qualche trascurabile idiosincrasia, visto che il “mozartiano in Mozart” sarebbe proprio il continuo, inarrestabile processo creativo. Certamente la caratteristica dell’ininterrotto pensiero musicale creò problemi d’inserimento nella società non solo a Mozart ma anche ai suddetti compositori, e a molti altri. Ma non può risiedere qui il nocciolo del problema, perché non dobbiamo parlare della personalità dei grandi musicisti, ma di quella di Mozart che, così descritta, assurge allo status di simbolo e di ipostasi, ma perde ogni credibilità agli occhi di chi si voglia accostare a lui con sincero spirito d’indagine, e non nell’intento di suggestionare o commuovere.
Dunque dobbiamo far scendere un po’ dal piedistallo questo Mozart, che è stato anche ridotto a sublime idiota nella pellicola di “Amadeus”, oppure è stato sempre associato a qualcosa di misterioso e di lontano, ma non ha ricevuto mai un po’ di comprensione umana e di attenzione per le sue caratteristiche personali, né dai contemporanei né dai posteri. Insomma Mozart interessava ed interessa sempre come mito, mai come uomo reale. La prova probante di tanti musicologi non solo attuali sarebbe la straordinaria, “miracolosa” capacità di Mozart di completare mentalmente le sue partiture, per poi stenderle su carta con comodo e a tempo debito. Sono costretto ad insorgere una buona volta contro questa banale mistificazione, perché esattamente lo stesso si potrebbe dire di Bach, di Haendel e, se volete, perfino di Cimarosa, Boccherini, o di Salieri. Fino a che Beethoven non venne a rivoluzionare la prassi compositiva portando con sé, come caratteristica saliente e discriminante, il rovello del “vero” Grande Artista, che non si accontenta mai dei suoi pensieri musicali, ma ricerca una perfezione siderale, la prassi creativa dominante fu, appunto, quella mozartiana. Si dirà che le partiture mozartiane sono più complesse di quelle dei suoi contemporanei e che sono “incredibilimente perfette”. Ma questo è tutto ciarpame pseudo-romantico, che avvilisce la qualità e l’estrema raffinatezza della musica mozartiana rendendola un prodotto “divino”, buono per tutte le stagioni e molto gradito anche alle mucche (che, secondo molti allevatori, aumentano la produzione di latte, ascoltando la sua musica). In realtà abbiamo schizzi preparatori di mano di Mozart che riguardano il Finale dell’Atto I del Don Giovanni, composizione particolarmente difficile per la presenza delle due orchestre sulla scena e in platea, che, come tutti sanno, suonano nello stesso lasso di tempo musiche diverse nel ritmo e nella impostazione tonale, creando artificiose e bellissime dissonanze, ma rimanendo sostanzialmente fedeli al concetto dell’eufonìa e al “credo mozartiano” (espresso in una lettera a Leopold) di piacere agli intenditori senza offendere le orecchie dei dilettanti; la partitura della Sinfonia K 297, detta “Parigina”, una delle più alte realizzazioni di musica “assoluta” in assoluto, presenta moltissime cancellazioni e correzioni, attestanti cambiamenti di rotta anche abbastanza sostanziali, nonché infiniti ritocchi riguardanti l’orchestrazione e la distribuzione delle parti, tali da fare invidia anche a un Mahler in vena di pignolerìe e di difficoltà mirabolanti per gli esecutori; la leggenda della musica “tutta composta mentalmente” deriva da un’unica lettera a Nannerl, in cui il fratello si scusa dell’ordine in cui le manda un Preludio e Fuga da lui composto (KV 394 / KE 383a, in Do), e cioè prima la Fuga e poi il Preludio perché, come dice lui, mentre trascriveva mentalmente la Fuga, stava componendo il Preludio che segue nello stesso fascicolo: si tratta, agli occhi di chi sappia un po’ distinguere, di una composizione assolutamente “minore” e poco impegnativa per il musicista, un esercizio, insomma, nello stile di Handel, quale risulta anche dalle moderne esecuzioni, nessuna delle quali ci rivela un capolavoro. Estendere questa ammissione mozartiana a tutte le altre sue composizioni è un atto arbitrario e cialtronesco, proprio di chi vuole creare il “mostro”, il “fenomeno da baraccone” a tutti i costi. Anche se, purtroppo, la Vedova Mozart ha “fatto pulito” di tutte le stesure preliminari in forma di “parcella” del suo defunto marito, e questo per avvalorare la leggenda messa in giro, sia pure inconsapevolmente, dall’acidula sorella Nannerl, allo scopo evidente di guadagnare il più possibile dalla pubblicazione e dalla vendita di tutte le partiture in suo possesso, noi sappiamo da testimonianze inequivocabili (dalle Lettere, da alcune affermazioni di J. Haydn) che il metodo seguito da Mozart per tutte le sue composizioni di qualche momento era quello di stendere prima uno schizzo generale, poi di passare alla stesura a più voci in forma di “parcella” e infine di giungere alla stesura “definitiva”, in bella copia; là dove la Vedova non è giunta a metter le mani, e cioè nelle parti “autentiche” del Requiem del marito, notiamo in atto questo processo elaborativo, comune anche a Haydn e a tutti i compositori più “impegnati” e raffinati della loro epoca. Abbiamo, dall’altro lato, composizioni “buttate giù” al cembalo come improvvisazioni burlesche, alle quali ha preso parte, talvolta, un’altra persona presente al gioco: ottimo esempio, la “Marche funèbre del Signor Maestro Contrappunto” KV 453a (1784), nella partitura della quale si notano forti sbavature dovute alla posizione verticale del foglio, e interventi di mano ignota, certamente di un’allieva da lui coinvolta nell’esercizio, secondo prassi didattiche diffuse alla fine del ’700. Mozart ha inoltre voluto “rimpolpare” composizioni altrui, come nel caso dell’operetta “La pietra filosofale” in cui diede una mano a Schikaneder, stendendo, “a tempo perso”, quasi tutte le parti dei fiati (Anh. C 7.06), in cui eccelleva; nella Clemenza di Tito (K 621), invece, aveva lasciato da “rimpolpare” alcuni numeri che noi oggi percepiamo come perfettamente compiuti a sé, ma fu solo la mancanza di tempo che gli impedì di stendere le parti dei fiati in arie in cui erano previsti dalla Partitura, ma potevano anche essere “omessi” senza pregiudicare la comprensione del pezzo, come ad esempio nell’eloquente aria di Publio “Tardi s’avvede”, elaborata dal punto di vista vocale, ma accompagnata soltanto dagli archi, nonostante all’inizio di essa fossero stati indicati anche 2 oboi e 2 corni e nonostante la situazione stimolasse in Mozart effetti “da Leporello” per la grossolana ingenuità del personaggio, effetti da conseguire, appunto, attraverso un sapiente uso dei fiati, che certamente Mozart aveva già escogitato, ma che poi non ebbe il tempo di stendere. Questo certamente significa che, anche dopo il buon successo praghese, e sistemata la barcollante situazione finanziaria, Mozart sarebbe tornato sulla partitura della Clemenza e, d’un solo fulmineo sguardo supervisore, l’avrebbe portata tutta ai livelli delle sue Opere maggiori. Infatti nella Clemenza di Tito vi sono arie (evidentemente compiute e rifinite) dalla lussureggiante scrittura orchestrale, ed altre appena accompagnate da frasi essenziali degli archi: altro che “terso chiarore lunare” e “poetica della rinunzia” nell’ultima (o penultima, poiché il Flauto magico, K 620, è contemporaneo alla Clemenza, K 621) Opera teatrale! Che Mozart non potesse essere del tutto soddisfatto dello stato in cui si trovava la partitura della Clemenza, lo testimonia il fatto che, quando dovette riorchestrare il Messia di Handel (KV 572), inserì una “petite bande” di fiati al completo (2 corni, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 1 flauto) in tutte le arie dell’oratorio, e così fece nella sua trascrizione dell’Acis und Galathea (KV 566), dell’Alexanderfest (KV 591) e della Cäcilien ode (KV 592) del medesimo compositore. Tutto questo, e quanto aggiungerò via via nello stendere questo ritratto musicale, mette fine per sempre e indubitabilmente a tutte le leggende su Mozart “divino inconsapevole” e “genio e sregolatezza” sorretti da alcunché di divino e inspiegabile, quasi un’anticipazione del rimbaudiano “deréglement de tous les sens”, nonché all’odiosa e sciocchissima idea di un Mozart rivale di Cristo nell’assegnazione del titolo di “Figlio di Dio”. Sì, perché è normale sentir dire che il corpo che Mozart ebbe fu il luogo in cui si incarnò “maggiormente”, più che in ogni altro, lo Spirito divino. Che sciocchezze! Viene in mente il “più vasta orma stampar” di manzoniana memoria, espressione che appartiene, appunto, ad una poesia romantica, tutta intrisa dei concetti allora au dernier cri. Il paragone, talvolta stretto al limite della parodia, tra Mozart e Cristo è non solo empio e irrispettoso della fede di tanti lungo i secoli, ma assolutamente fuori luogo, perché anche Wolfgang credeva, e quanto!, nell’«Amor che muove il sole e le altre stelle». È vero che egli non poneva, ad esergo delle sue composizioni, il “Soli Deo Gloria” con cui principiava sempre il suo “carissimo amico” Haydn e che era stato usato allo stesso modo da Johann Sebastian Bach quarant’anni prima (dedica e richiesta di aiuto), ma anche in questo Mozart non si discostava dalla prassi più comune ai suoi tempi, perché né Johann Christian Bach, né Carl Philipp Emanuel Bach, né Wilhelm Friedmann Bach, né Leopold Mozart, né Domenico Scarlatti, né Johann Kuhnau, né Baldassarre Galuppi, né Johann Schobert, né L. Honauer, né H. Fr. Raupach, né J. G. Eckard, né I. Holzbauer, né E. Eberlin, né Johann Froberger, né insomma alcuno dei suoi primi maestri, da cui “apprese il mestiere” e con molti dei quali ebbe spesso contatti personali o epistolari, mai usò tale formula, almeno per iscritto, giudicandola senz’altro “cosa del secol passato” e indubbiamente di cattivo gusto, ché una preghiera la si può sempre recitare, senza lasciarne traccia sul manoscritto. Una testimonianza toccante della fede di Mozart, a chi sappia leggere recto e verso, e abbia consuetudine con il suo modo di parlare e di scrivere, risulterà sempre la famosa frase che disse di fronte al pastore luterano secolarizzato e filosofo illuminista Hans Friedrich Neumann. Neumann, incontrando Mozart a Berlino durante il viaggio di quest’ultimo in Germania nel 1789, gli spiegò con sussiego e saccente meticolosità che Gesù Cristo non era mai esistito, non solo come lo raccontavano le Scritture, ma in assoluto, essendo i Vangeli nient’altro che un collage di citazioni dall’Antico Testamento, cucite attorno ad una figura assolutamente non credibile, contraddittoria, insomma a un’invenzione di sana pianta, non riuscita neanche tanto bene. Ed essendo così soverchiante la valanga d’argomenti che l’ex-pastore portava a suffragio della sua tesi, Mozart non ebbe nemmeno l’ardire di replicare, ma scoppiò a piangere e disse semplicemente: «Ach, e la messe era pur sì bella!». «Era pur sì bella» lo disse in Italiano, mentre esordì in Tedesco e messe lo disse in Francese. Lungi da costituire una prova del suo infantilismo, tale da deliziare il suo biografo-psicologo Hildescheimer, la frase rivela una fortissima tensione e commozione d’animo, che portò Mozart sull’orlo di una crisi di nervi (durante il viaggio del 1789 era già profondamente malato: figurarsi quanta voglia aveva di farsi indottrinare da un filosofo illuminista, discepolo di quel Voltaire di cui aveva già scritto al padre nel 1778: «è morto come meritava, mangiando la propria merda»). Infatti non è Mozart a ricordare l’episodio, in una delle tantissime e circostanziate lettere che scriveva alla moglie, rimasta a Vienna, anche due volte al giorno, e pur piene di “bozzetti” e “ritratti dal vivo” di persone incontrate, ma lo stesso filosofo Neumann, in una Memoria certamente credibile, perché riporta l’impasto linguistico usato spesso da Mozart, soprattutto quando si sentiva a disagio e non sapeva cosa dire, come dimostrano eloquentemente le Lettere scritte al padre in occasione del suo matrimonio, fortemente osteggiato dal genitore. Questo non è infantilismo, ma multilinguismo di una persona cresciuta dai cinque ai sedici anni in continuo viaggio, o turnée che dir si voglia, e abituata a rispondere a ciascuno nella sua favella, tornando al Tedesco o al Francese quando si sentiva insicuro. Mozart, ad esempio, aveva una conoscenza dell’Italiano e degli italiani degna di un grande scrittore e conoscitore d’anime, e certe sue lettere scritte nella nostra lingua non sfigurano a fianco di quelle dell’Alfieri, o del Foscolo. Dunque, incominciamo a scoprire che le sue doti non erano soltanto musicali, ma anche letterarie, nel senso che ricordava verbatim quanto gli veniva detto, parola per parola, e non perché fosse un campione della memoria, un Pico della Mirandola insomma, ma perché aveva un enorme interesse nei confronti di chiunque gli stesse davanti, che fosse un facchino o una Maestà imperiale. Egli è perciò il più umanista dei compositori, perché per lui il centro resta sempre e soltanto l’uomo, anche al di là della musica. Fosse vissuto nell’800, quando i musicisti facevano anche professione di letterati, ci avrebbe lasciato le più belle memorie mai scritte da chiunque. E questa non è musica, né letteratura in senso stretto: è senso acuto dell’osservazione, e Mozart sarebbe benissimo potuto essere un grande romanziere, se i tempi fossero stati maturi, e se la sua continua attività musicale gli avesse fruttato abbastanza da potergli permettere di dedicarsi a tempo pieno anche ad un’altra professione. La frase «la messe era pur sì bella» non sottintende superficialità ed estetismo ante litteram come vorrebbero i cultori della sua sublime ingenuità, ma significa, ellitticamente, che il contenuto della messa era bello, appagante, non i riti esteriori. Inoltre, dopo esser passato dal Tedesco al Francese, Mozart prosegue in Italiano la frase, e questo perché quanto gli veniva alle labbra si adattava perfettamente all’idioma in cui trovava espresse cocenti passioni nei libretti d’Opera, e in particolare allo stile “sostenuto” e tragico del Recitativo Accompagnato. La frase, infatti, non sfigurerebbe in bocca a Donna Elvira, o a Donn’Anna, quando apprende che «quegli è l’uccisore del padre mio». Anche nelle lettere a Puchberg, confratello massone che gli prestò danari nel 1788, ricorrono espressioni idiomatiche di taglio teatrale, tipiche dei recitativi accompagnati. Mozart non deve averci pensato sopra, tanto più che riteneva umiliante e degradante chiedere soldi in prestito, per cui possiamo immaginare con notevole esattezza che questo fosse il suo modo d’esprimersi anche “a viva voce”, quando si trovava in situazioni imbarazzanti, o addirittura tragiche. L’espressione «era pur sì bella» è sicuramente autentica, e mozartianissima, nonostante venga riportata da Neumann a distanza di anni (il quale, comunque, si sarà stupito dell’insolito eloquio del suo interlocutore, a dir poco bizzarro anche per i molto tolleranti cànoni dell’epoca), perché ricorre, tale e quale, anche in una delle ultime, e delle più tragiche lettere di Mozart, datata “settembre 1791” e indirizzata a Lorenzo Da Ponte. Per il suo più amato librettista italiano, scrive in Italiano, e benissimo (ma per la sua grande abilità nell’utilizzo della lingua italiana basti come esempio la dedica dei Quartetti K 387, 421, 428, 458, 464, 465 “Al mio caro amico Haydn”).
Ma per parlare della lettera a Lorenzo Da Ponte, dobbiamo fare qualche premessa. Dopo la prima rappresentazione del Flauto magico (30 settembre 1791) Mozart si mise a lavorare di buona lena al suo Requiem, già incominciato durante l’estate. Questo zelo febbrile, che perdurava da più di un anno, di comporre a ritmi molto sostenuti era in palese rapporto con la sua malattia, che a sua volta era la conseguenza di anni di scarsa nutrizione, di eccessivo lavoro e di preoccupazioni di ogni genere. Già da ragazzo era stato più volte gravemente malato, per lo più dopo gli strapazzi dei viaggi, e anche del primo periodo viennese sappiamo attraverso il dottor Barisani di due casi analoghi. Alla rappresentazione del Tito a Praga era giunto già molto sofferente e da allora la sua salute peggiorò giorno dopo giorno. Già durante il compimento del Flauto magico andava soggetto a svenimenti e lo stato d’animo s’incupiva a vista d’occhio. Lo prova la singolare lettera in Italiano cui abbiamo accennato sopra, indirizzata a Da Ponte a Londra, il 7 settembre 1791: «Aff.mo Signore. Vorrei seguire il vostro consiglio, ma come riuscirvi? ho il capo frastornato, conto a forza, e non posso levarmi dagli occhi l’immagine di questo incognito. Lo vedo di continuo, esso mi prega, mi sollecita, ed impaziente mi chiede il lavoro. Continuo, perché il comporre mi stanca meno del riposo. Altronde non ho più da tremare. Lo sento a quel che provo, che l’ora suona; sono in procinto di spirare; ho finito prima di aver goduto del mio talento. La vita era pur sì bella, la carriera s’apriva sotto auspici tanto fortunati, ma non si può cangiar il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quello che piacerà alla provvidenza. Termino ecco il mio canto funebre, non devo lasciarlo imperfetto». Questa lettera è piena d’espressioni idiomatiche mozartiane, e il lettore avrà già riconosciuto il passo che a noi più interessa: «la vita era pur sì bella», quasi identico a «e la messe era pur sì bella»: evidentemente Mozart si esprimeva così anche nella conversazione, come attesta la testimonianza, straordinariamente precisa, di Neumann. Altra espressione singolarmente vivida e drammatica è, ad esempio, «ho il capo frastornato, conto a forza», con quel riferimento quasi preterintenzionale al “contare”, alla metrica compostiva, dunque; poi abbiamo quel «continuo, perché il comporre mi stanca meno del riposo», mozartianissima tra le confessioni: il lavoro compositivo stanca lo stremato compositore meno del labile riposo di chi sa di avere i giorni contati; ed ecco quell’«altronde non ho più da tremare», dove senti il trillo allarmato degli archi, vero effetto da Opera Seria; segue il liricissimo «Lo sento a quel che provo», degno attacco d’Aria di Furore, con tanto di Furie e di spettri che dilaniano “il core”; e siamo venuti a «la vita era pur sì bella», che introduce il tema fatalistico, degno del Concerto n. 20 in re minore per fortepiano e orchestra, K 466: «non si può cangiare il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quello che piacerà alla provvidenza». Il fatalismo Wolfgang l’aveva ereditato da suo padre Leopold, ed espressioni simili risuonano sovente nella corrispondenza tra i due, per esempio in relazione ai cattivi rapporti che entrambi intrattenevano con l’Arcivescovo Colloredo, dove però il più remissivo è il padre, mentre il figlio a volte esplode in veri e propri moti di ribellione. Ma non andiamo troppo oltre con i paragoni: la lettera appena presentata, per quanto scritta ormai in articulo mortis, riassume molti degli aspetti più caratteristici della personalità di Mozart, non ultimo la paura per «questo incognito», che si è tramutata da diffidenza verso ogni furfanteria dei propri colleghi, e soprattutto degli “intriganti Italiani”, in vero e proprio orrore paranoico degno degli scenari apocalittici che così spesso si spalancano sulle pagine del Requiem.
*
- Musica
La Cantata en burlesque di Bach
La Cantata en burlesque di Bach
A mia madre
Analizziamo quella che per noi è l’ultima delle Cantate profane di Bach, la Cantata en burlesque come la intitolò il librettista Picander nel quinto volume delle sue poesie, stampato nel 1751.
Picander dovette avere una parte decisiva nell’indurre Bach a scrivere quest’opera, così riaprendo un capitolo che forse, nelle sue intenzioni, era chiuso. Il personaggio in onore del quale questa vasta e originale opera fu scritta (non sappiamo se fosse il committente, o se si trattasse di un omaggio a Picander), il Cammerherr Carl Heinrich von Dieskau, commissario regio all’esazione delle imposte, era infatti il superiore burocratico del librettista che era passato dall’amministrazione postale a quella delle imposte sulle bevande.
Il «nuovo superiore» aveva da poco ereditato la tenuta agricola di Klein-Zschocher, che allora era subito fuori le porte di Lipsia e dal secolo scorso fu incorporata nell’area urbana. L’atto di omaggio dei contadini al nuovo signore fu festeggiato il 30 agosto 1742, giorno del suo compleanno. «Come sarebbe più povera la nostra conoscenza di Bach, se non avessimo questo pezzo delizioso», scrisse Friedrich Blume, sottolineandone la posizione «altrettanto isolata nella sua opera, quanto è il Dorfmusikanten-Sextett in quella di Mozart». Il paragone è efficace, ma non del tutto fedele, perché nell’operetta di Bach non vi è neppure una stilla del veleno sarcastico che scorre abbondante nella composizione mozartiana.
La raffigurazione dei contadinelli e delle loro ragazze alle prese con arie e recitativi curiali, la tenera nostalgia di una impossibile semplicità sono espressione della finzione, tutta settecentesca, di un bon naturel intravisto e bastante a se stesso: essa resta illusoria e come sul punto di svanire.
La “semplificazione” dello stile, la riduzione delle pretese contrappuntistiche a una omofonia appena velata, l’abbondanza delle danze predilette dalla moda più recente, Bourée, Mazurka e Polacca, di cui la Sinfonia, con la mutevolezza dei suoi ritmi e «affetti», di continuo alternati e spezzati, come in un intermezzo orchestrale di un’opera di Hasse, fornisce insieme un inventario e una sintesi: la presenza di melodie popolari o popolaresche, la scrittura umoristica, il limitato numero degli esecutori, l’idioma musicale orecchiabile e «naturel», tutti questi caratteri indicano che Bach ha colto nell’opera l’occasione per dimostrare, a cinquantasette anni, la capacità di aggiornamento del suo stile, sol che avesse voluto piegarlo ai gusti della nuova generazione.
L’elogio dell’amore contenuto nell’aria del soprano all’altezza del n° 4 della Partitura a tal punto si sporge nella Stimmung della nuova età illuministica, che vi si colgono, senza fastidiose forzature anticipatrici, il timbro e il taglio melodico “semplice” e “sentimentale” di tanti altri fanciulli a venire fino ai Papageno e Papagena del Finale del Flauto Magico.
L’avvicinamento della Cantata en burlesque al mondo dominato dall’estetica “galante” della naturalezza e semplicità (Picander rende addirittura omaggio all’aggettivo, divenuto insegna del gusto e della morale: Das ist galant, esordisce una delle due arie del soprano) segna in Bach un omaggio stilistico alla moda: uno sconfinamento risoluto e visibile, tuttavia seguìto da un’immediata ritirata nel territorio di partenza.
Con quella semplicità di linguaggio e di mezzi (violini, viole, contrabbasso per il continuo, più isolati interventi del flauto traverso e del corno) l’uscita dal vecchio mondo della Cantata curiale, sacra o aulica, tuttavia sempre «seria», del Sublime Barocco, è totale. L’opera è un unicum germogliato in una terra di nessuno che sta oltre il terreno coltivato per tanti anni alternando simili musiche, rimbalzanti dalla chiesa al concerto, entro un’identica matrice estetica e stilistica.
Appena oltre la siepe, c’è in attesa lusinghiera e pronto all’applauso il facile mondo dell’incipiente «Sensibilità»; ma Bach, dopo la breve passeggiata, se ne ritae perché il «semplice» non lo seduce e il «naturale», come sempre ottenuto a spese della polifonia, non lo attira.
Paolo Melandri / 15 gennaio 2012
*
- Musica
Mozart e i Bach
Mozart e i Bach
Tra i modelli dello stile strumentale e vocale di Mozart occupa un ruolo di primo campo l’opera di Johann Christian Bach, detto il “Bach londinese”, o, in maniera ancor più scandalosa, il “Bach cattolico”. Ultimo dei figli di Johann Sebastian, non poté beneficiare dell’insegnamento paterno e venne mandato a studiar contrappunto a Bologna, presso Padre Martini, che, intorno al 1750 e giù giù fino al 1770 ca., era stimato il massimo conoscitore europeo dell’Ars reservata. E non a torto, ché seppe fare del promettente Johann Christian un compositore colto e originale. Padre Martini era allora uno dei pochi italiani ad avere familiarità con una parte almeno, sebbene ridotta, della produzione di Johann Sebastian; possiamo quindi presumere che sia stato lui a spiegare a Johann Christian le peculiarità e la raffinatissima dottrina dell’armonia della musica del defunto padre, per cui aveva una speciale venerazione: una copia di un ritratto del “grande Bach” (quello di Haussmann) si trova infatti presso il fondo della “Fondazione Martini” a Bologna.
In ogni caso lo stile del “Bach londinese” sarà molto più mozartiano (ante litteram) che bachiano, presentando molti tratti comuni con la “prima maniera” del genio salisburghese, quella improntata alla galanterie per intenderci. Johann Christian si convertì al cattolicesimo per riconoscenza nei confronti di Padre Martini e molto probabilmente perché non trovava niente di “irrazionale” nella fede proclamata dalla Chiesa di Roma. Negli anni in cui rimase in Italia scrisse musica sacra cattolica e i primi saggi di musica strumentale da camera; poi, sempre in Italia, si votò al Melodramma che lo rese rapidamente famoso in tutta Europa. Come Handel molti anni prima, decise però di abbandonare la patria del Belcanto per cercare fortuna a Londra, dove un’economia già decisamente capitalistica e liberistica consentiva una veloce ascesa sociale a chi arrischiasse il “colpo” di “mettersi in proprio” e di comporre musica “su commissione esterna”, senza essere al servizio o sotto la protezione di alcuna istituzione ecclesiastica o mondana. Per sua fortuna, Johann Christian era dotato di un temperamento docile e accomodante, agli opposti della sanguigna passione di Handel, ed era anche, per sua natura e spontaneamente, freddo e calcolatore. Così riuscì come Handel e meglio di Handel cinquant’anni prima di lui sulla scena del Melodramma londinese, che era poi, tout court, melodramma italiano in lingua italiana. La sua Fortun, come si diceva allora in cattivo tedesco, non accennò a declinare fino alla morte, avvenuta per infarto nel 1782. Nel frattempo aveva visto innalzata una statua in suo onore ai Vauxall Gardens, come già a suo tempo Handel, e aveva organizzato, nella Capitale inglese, una lunga serie di Concerti quindicinali per abbonamento, i “Bach-Abel Concerts”, insieme a un collega e rivale al Cembalo, Abel appunto. Questi furono i primi Concerti su sottoscrizione dedicati interamente alle Composizioni per fortepiano e orchestra, e funsero da modello per le sublimi arcate delle esibizioni viennesi mozartiane degli anni ’80 del ’700, coronamento e gloria del Klavierkonzert, per sempre.
Durante i soggiorni londinesi dell’enfant prodige Wolfgang Amadeus (nato nel 1756), tra il 1764 e il 1765, egli fu guida e méntore del giovane talento, concedendogli, in pubblico, lo straordinario onore di suonare con lui ai “Bach-Abel Concerts” (durante i quali soleva tenerlo sulle ginocchia, o addirittura affidargli l’esecuzione di intere sue Sonate e Fantasie, nonché l’obbligatoria improvvisazione sopra di esse) e in privato, frequenti e intensive lezioni di orchestrazione e tecnica del Belcanto. Mozart gli dedicò i primi Concerti per fortepiano e orchestra, K 175, amplificazione in chiave bravouristica e sinfonica di Sonate di Johann Christian: essi, com’è stato osservato, sono come sontuosi abiti indossati dal prodigioso bambino e hanno il piglio e l’allure dei futuri capolavori in questo genere, ancora là da venire (la serie mozartiana più importante risale appunto agli anni viennesi, gli anni ’80, in cui Wolfgang, a sua volta, tentò la sua Fortun nella Capitale ov’era la Residenz degli Absburgo, avviandola a diventare la “città della musica”).
Più tarda fu, da parte di Mozart, la conoscenza approfondita del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, che ebbe modo di fiorire e dispiegarsi durante i Concerti domenicali organizzati, a Vienna, dal Barone Van Swieten, già imperialregio ambasciatore presso la Corte di Prussia di Federico II negli anni della giovinezza, e poi dilettante di alto profilo e divulgatore entusiasta e intransigente del “verbo” di Handel e Bach alla fine del secolo che li aveva visti fiorire, e che li aveva già dimenticati. Mozart divenne presto più entusiasta del suo entusiastissimo Mecenate, e nel 1789 intraprese addirittura un viaggio a Lipsia per conoscere più a fondo le partiture bachiane, dalle quali dichiarava continuamente che aveva ancora da “imparare molto”, nonostante all’altezza di quell’anno, così famoso per altre ragioni, egli avesse già composto la maggior parte dei cosiddetti “capolavori della maturità”. Il viaggio gli fece constatare la pochezza di coloro che si dichiaravano “allievi di allievi” di Bach, ma gli diede anche la soddisfazione di partecipare all’esecuzione, in suo onore, di un Mottetto del Maestro, composizione così raffinata da lasciar stupefatto un Musikus par suo, che dominava e aveva perfezionato e trasceso tutti gli stili europei. Quando, recandosi a Lipsia, dalla carrozza intravvide le prime guglie della città, uscì in questa semplice ma lapidaria affermazione: «Bach è morto da quarant’anni ormai, ma le sue composizioni saranno studiate e ammirate finché vi sarà anche un solo Connaisseur sulla terra».
Durante lo stesso viaggio gli venne fatto osservare da un philosophe à la page, ex pastore protestante (cominciavano i furori giacobini), che il Cristianesimo altro non era stato che un’impostura ben organizzata (ecc. ecc.), al che egli replicò, in lacrime: «ma la Messe era pur sì bella»… I tempi cambiavano, e per lui in peggio, e ormai la Musa lo votava alla morte.
Paolo Melandri
1 gennaio 2012
«Nescio qua de causa a quam plurimis
adulescentibus otium adeo aestimatur,
ut nec verbis nec verberibus ab hoc
sinant»
*
- Letteratura
La luna e il mito in Thomas Mann
La luna e il mito nell’opera di Thomas Mann
A Gustave Flaubert
I pozzi in cui la luna si lascia rimirare sono pozzi particolari. Quello di Thomas Mann è il profondo “pozzo del passato”, l’insondabile pozzo in cui lo scandaglio della sua inquietudine e della sua ambizione intellettuale ha incontrato la superficie oscura della narrazione della Bibbia e ha ritrovato le figure dei patriarchi che con le loro storie hanno dato nomi, leggi, ordine e sogni alla vita degli uomini. Il riflesso della loro esistenza ricopre come un’ombra il contorno delle vite che ripetono lontani modelli cui è affidata l’invenzione di essere i primi avi raccontati dalla memoria della Tradizione. A conoscere e a imparare le loro vicende, l’avventuroso primo differenziarsi delle loro generazioni, si dubita dell’inizio, di quel fondo che dovrebbe essere principio. Lo smarrimento esistenziale che il moderno narratore di alcuni capitoli della Genesi esorcizza, fissandolo al realismo della precisione geografica ed etnologica è soltanto la condizione per ricreare il naturale legame umano con la divinità nelle sue forme di confortante pietà o di barbarico terrore. È il curioso, ammirato e incerto stupore del “giovane Giuseppe” che «provava un senso di vertìgine, come noi quando sporgiamo sull’orlo di un pozzo». Un antico pozzo il suo, «al di là delle colline a nord di Hebron, un po’ a oriente dalla strada che veniva da Urusalim, nel mese di Adar, in una sera di primavera. La luna era così chiara che si potevano leggere cose scritte».
Se si vuol prestar fede alla esatta realtà della leggenda raccontata da Thomas Mann, la luna si sarà certamente rispecchiata nell’acqua fredda di quel pozzo ai confini del tempo, ma è lo splendore del suo alone che il giovane protagonista adorava: «Sembrava che pregasse perché, levato il volto verso la luna che lo illuminava intero, tenendo i gomiti sui fianchi, gli avambracci alzati, le palme delle mani aperte e volte in alto, si dondolava lievemente, ora da una parte ora dall’altra, cantilenando suoni e parole… “Abu-Chammu – Aoth – Abaoth – Abiram – Chaammi-ra-am…”. In questa litania improvvisata si confondevano tra loro tutte le possibili e più vaste associazioni di idee. Dava alla luna vezzeggiativi babilonesi, la chiamava Abu, padre, e Chammu, zio; fra questi nomi metteva anche quelli di Abram, l’avo suo, vero o presunto… Ma c’erano, oltre questi, dei suoni con un particolare significato, che si riferivano, più o meno direttamente, al pensiero di “padre” e che andavano oltre la cerchia della religione astrale diffusa in oriente…».
Il primo capitolo delle Storie di Giacobbe aveva presentato il giovane Giuseppe dall’aspetto “grazioso e amabile” anche nei suoi difetti mentre invocava la luna, appena turbato, durante quel lirico colloquio con la luce notturna, dal tremore di un attacco nervoso che discordava con l’armoniosa affabilità della persona e ne indicava l’ambiguità tra il gioco, il capriccio e la vocazione mistica e profetica. L’incantesimo della luna illumina da vicino la finzione letteraria che si sostituisce al XXXVII capitolo della Genesi: alla sua luce l’adolescente ebreo dalle unghie tinte di rosso è l’ambizioso e volubile, il vezzeggiato e carezzevole, intelligente figlio di un patriarca che nella sua vita aveva conosciuto l’inganno e l’illusione, ma aveva anche saputo esercitarli su altri. Non è soltanto un figlio più giovane preferito agli altri, anche se resta quella «figura che lusinga specialmente la gioventù con speranze e con fantasìe», così come aveva lusingato Goethe quasi fanciullo che aveva scritto anche lui una lunga storia biblica dettata all’obbediente segretario del padre che non possedeva certo le virtù del vecchio Eliezer: «Egli ci appare tranquillo e chiaro e profetizza a se stesso i pregi che dovrebbero elevarlo al di sopra della sua famiglia. Caduto in disgrazia per opera dei fratelli, rimane saldo e onesto nella schiavitù…»
Il vecchio Goethe, nel quarto libro di Poesia e verità, aveva ricordato ancóra i meriti e gli onori giustamente spettati a chi aveva saputo riconoscere la propria fortuna.
Lo scrittore borghese che si accinge a descrivere con l’erudita acribìa di uno specialista in antichità orientali la devozione del giovane Giuseppe per la luna, una divinità sospetta al padre, vuole, con il miraggio della precisione, annullare la distanza storica cedendo allo spirito della narrazione che lo tenta con tutto il potere della suggestione scientifica del suo tempo; non rinuncia però al nascosto gioco delle parodistiche correzioni, delle divertite modificazioni anacronistiche anche se vogliono soltanto apparire ubbidienti rettifiche suggerite dalle nuove scoperte della scienza e dell’archeologia.
A un lettore di romanzi che facesse attenzione a quella luna che la letteratura riesce quasi sempre a “mostrare altrui nel pozzo”, tornerebbe alla mente un’altra figura a lui devota, immersa in quella luce d’Oriente e di epoche lontane che rendeva mitico per la fantasia borghese il fascino dell’esotismo, la figura di una figlia amata da un padre diversamente preoccupato della divinità, una figlia inventata dall’immaginazione di Gustave Flaubert: Salammbô, cantilenante i nomi della luna sulle colline di Cartagine.
I gomiti sui fianchi, le mani aperte come Giuseppe, Salammbô invoca Baalet, Tanit, la luna, regina delle cose umide e della fecondità eterna, l’incontrastato principio femminile che lotta e si oppone alla crudeltà e alla impietosa signorìa di Moloch, il sole. Il dualismo, che la storia della cultura e delle religioni prima della letteratura hanno insegnato e tramandato, presiede al destino dei protagonisti, ne determina i comportamenti e le azioni, così come nel romanzo di Thomas Mann il culto di Baal e di re Toro è contrapposto alla esaltazione lunare; rappresenta il segreto timore di Giacobbe, preoccupato che i suoi figli possano venir distratti dal buon solido lavoro a danno di quell’ordine e di quella riverenza per il nuovo dio che lui stesso aveva aiutato a scoprire liberandolo dalle primitive imprecise forme di una collettività che, come raccontano i primi volumi della tetralogia, aveva appena imparato a distinguerlo dal proprio “io”. Sole e luna si contendono il dominio e il governo sugli uomini e sulla terra; questa binarietà era principio strutturale nel romanzo di Flaubert, contrapponeva i personaggi non solo nella parabola delle loro avventure ma ne scopriva, nel segno della differenza tra maschile e femminile, la tensione risolvibile solo nella caduta o nel superamento dell’uno con la vittoria dell’altro.
A Sainte-Beuve che l’aveva accusato di non aver saputo far resuscitare – per familiarità o per affinità – la civiltà del mondo antico, Gustave Flaubert aveva risposto definendo l’attrazione esercitata su di lui: «La curiosité et l’amour qui m’a poussé vers des religions et des peuples disparues, a quelque chose de morale en soi et de sympathique, il me semble».
Thomas Mann, nel novembre 1928, prima di leggere, a Vienna, alcuni capitoli delle Storie di Giuseppe, pur volendo affermare la sua distanza da Flaubert, parlava anche lui di simpatia per i tempi di civiltà scomparse: «Prima di cominciare a scrivere ho riletto Salammbô, per vedere come oggi non si deve costruire un romanzo. Soprattutto niente broccato archeologico, niente di erudito artistico-artificioso, nessun culto volutamente antiborghese di pesante erotismo! Quella archeologia è un’attrazione, è un fascino, tra gli altri, decisamente quello che ha minore effetto, quello che ha minore importanza… L’antico Oriente mi attrae e nutro per l’antico Egitto e la sua cultura, già dai miei primi anni di ragazzo, simpatia e predilezione… non ne so davvero poco sull’Oriente, sono diventato un po’ orientalista come ai tempi della Montagna incantata ero studioso di medicina. Fare dell’elemento archeologico – per quanto lontano sia – scopo e oggetto dell’arte è, fino a un certo grado, inevitabile, e ciò per quell’allegra esattezza che è mezzo di realizzazione. Vorrei raccontare le pie storie proprio come sono avvenute realmente, o come avrebbero potuto accadere se… Ma per non considerare più questo “se” esiste appunto l’esattezza che non può sussistere senza una certa critica unoristica della Bibbia; così come la componente della ricerca scientifica fa parte della concezione del romanzo che avrà molti più elementi saggistici di quanti non ne avesse il precedente…».
Il Flaubert stanco, amareggiato e ammalato degli anni 1875-77, che in Bouvard et Pécuchet sta intanto infierendo sulla balorda fatica di Sìsifo della ricerca d’identità dei suoi eroi e sua stessa, sembra paradossalmente volgersi nei Trois contes a una dimensione quasi religiosa di speranza e utilità della vita. L’unità delle tre storie sta in questo succedersi dialettico di alienazione, irriducibilità e via d’uscita, che in Flaubert è un fatto assolutamente nuovo, e anticipa l’atteggiamento di Thomas Mann in Giuseppe e i suoi fratelli.
In questa chiave è giusto tenere in considerazione le indicazioni di Thibaudet quando presenta ciascuno dei Trois contes quasi come contrappunto ad altrettante opere maggiori dello scrittore: Un cuore semplice a Madame Bovary; la Leggenda di San Giuliano l’Ospitaliere a La tentazione di Sant’Antonio; ed Erodiade a Salammbô. Ma in ognuno di questi collegamenti l’elemento giustificativo è di tipo e valore diverso, in misura decrescente d’importanza.
Laddove in Madame Bovary il movimento dell’eroina è governato da una frenetica spinta centrifuga che tende a dilatare fino al limite della rottura tragica il cerchio in cui Emma è inscritta, in Un cuore semplice tutto si svolge nel senso contrario: di una continua autoriduzione – posta sotto il segno della luna – che approda alla beatitudine del nulla. Nel San Giuliano e nella Tentazione il dato comune può ritrovarsi in quella specie di esotismo cronologico che è la medievalità delle rappresentazioni (i bestiarî, la caccia…) e nelle partenze dell’ispirazione: immagini remote colte dal ragazzo Flaubert rispettivamente nella vetrata della cattedrale e in un baraccone da fiera della familiare Rouen, storie dentro la storia del suo fantasticare; ma nel primo caso la tragedia ha una catarsi di santità, mentre nel secondo è l’elemento diabolico a far da protagonista. E ancóra meno sostanziale sembra il legame tra Erodiade e Salammbô: esso non è da ricercarsi tanto nelle storie quanto invéce nel loro autore, in quel dèmone che lo assillava al perseguimento di un passato lontano in paesi lontani, di un altrove assoluto, spingendolo a un forsennato e minuzioso lavoro di documentazione erudita, così simile a quello di Thomas Mann nel suo Giuseppe.
L’apparente difformità dei tre argomenti e delle vicende, che indurrebbe a prima vista a considerare affatto casuale la coesistenza dei Trois contes nello stesso volume e a mettere in discussione la loro plausibilità come opera unitaria, risulta abbastanza inessenziale a quella lettura ravvicinata e approfondita che innegabilmente essi richiedono: come certi quadri rivelano soltanto a uno sguardo insistente l’importanza dei loro particolari, così i Trois contes hanno bisogno di più di una lettura perché ciascuno di essi riveli al lettore l’apparato intero del suo movimento, gli partecipi il suo ritmo. Un ritmo certo più agevole nella sussurrante successione e registrazione di eventi di Un cuore semplice; addirittura miracoloso in San Giovanni l’Ospitaliere dove (come è stato osservato) tutto corre in una dimensione di silenziosa levità lunare e onirica; più spezzato e faticoso in Erodiade, dove una folla di motivi storici, di suggestioni archeologiche ed erudite, di sollecitazioni del senso e di condizioni esistenziali si addensa in uno spazio forse troppo esiguo.
Paolo Melandri
19 agosto 2011
*
Il genio di Bach More Tasso Leopardi ecc (2^ vers) »
Questo testo è in formato DOC (96 KByte)
*
Il genio di Bach (1^ stesura provvisoria) »
Questo testo è in formato DOC (60 KByte)
*
Proust e Pascoli visti da D’Annunzio (I parte) »
Questo testo è in formato DOC (63 KByte)
*
Volti del Mecenatismo (con espunzione di 2 poesie) »
Questo testo è in formato DOC (425 KByte)
*
Lo Scipio e Petrarca e i nuovi Annales »
Questo testo è in formato DOC (96 KByte)
*
- Letteratura
Marine dall’Antichità a Proust
Le zibaldonesche annotazioni che – stese currenti calamo, per oltre un trentennio, da D’Annunzio – costituiscono il corpo del Libro segreto , sono assai più ricche di spunti d’ingegno e di tentativi ermeneutici dell’Antico di quanto comunemente si sia disposti a credere: pagine intere (pp. 97-101) sono dedicate a una personale definizione di ‘filologia’ e ad una rievocazione della biblioteca di Alessandria; a p. 121 la descrizione del gioco del rimbalzello (“Quali fanciulli divini fanno ancora il gioco del rimbalzello coi neri sassi levigati, su lo stagno dell’ombra? […] quel medesimo dell’onda che precipita avanti, rotola e schiuma al frangente. […] la sua bianchezza brilla di una banda di luce, rientra nell’ombra, si colora di acqua marina…”) è un ricordo dell’Octauius di Minucio Felice, 3 2, 4 e ss.: Cum diluculo ad mare inambulando litore pergeremus, ut et aura adspirans leniter membra uegetaret et cum eximia uoluptate molli uestigio cedens harena subsideret… […] Ibi harenas extimas, uelut sterneret ambulacro, perfundens lenis unda tendebat; et, ut semper mare etiam positis flatibus inquietum est, etsi non canis spumosisque fluctibus exibat ad terram, tamen crispis tortuosisque ibidem erroribus delectati perquam sumus, cum in ipso aequoris limine plantas tingueremus, quod uicissim nunc adpulsum nostris pedibus adluderet fluctus, nunc relabens ac uestigia retrahens in sese resorberet. Sensim itaque tranquilleque progressi oram curui molliter litoris iter fabulis fallentibus legebamus. Haec fabulae erant Octauii disserentis de nauigatione narratio. […] pueros uidemus certatim gestientes testarum in mare iaculationibus ludere. Is lusus est testam teretem iactatione fluctuum leuigatam legere de litore, eam testam plano situ digitis comprehensam inclinem ipsum atque humilem quantum potest super undas inrotare, ut illud iaculum uel dorsum maris raderet [uel] enataret, dum leni impetu labitur, uel summis fluctibus tonsis emicaret emergeret, dum adsiduo saltu subleuatur .
È questo uno dei più bei ‘pezzi di stile’ della letteratura latina, e nel presente contributo ci accingiamo a dimostrarne anzitutto il rapporto intertestuale con il succitato passo di D’Annunzio e con numerosi brani della Recherche proustiana. Molta attenzione, difatti, Marco Minucio Felice riservò nel suo dialogo all’aspetto letterario: Cicerone è un modello sempre presente nella costruzione del periodo, cosa che si può verificare anche nell’esigua pericope testé riportata. E alcune scene della cornice che inquadra il dialogo sono pezzi di bravura ampiamente apprezzati nel corso della storia letteraria europea, come vedremo, in particolare, nell’àmbito della letteratura francese, da Baudelaire, dai decadenti, come Huysmans , e da Proust. Tra tali descrizioni paesaggistiche ‘di cornice’ ci paiono particolarmente suggestive quella, poc’anzi citata, dei ragazzi che giocano a ‘rimbalzello’ sulla spiaggia, facendo cioè rimbalzare sull’acqua dei sassi piatti, la passeggiata sull’estremo lembo di sabbia bagnato dalle onde – forse primo motivo ispiratore di liriche dannunziane quali Undulna –, la sosta sulla scogliera (4, 5), dove i protagonisti si siedono a parlare in una fresca mattina d’autunno, riecheggiata nella poesia baudelairiana intitolata Chant d’automne , e infine, last but not least, la conclusione, con i tre amici che si salutano contenti della bella discussione, e felici di avere appianato le divergenze.
Tra i precedenti illustri delle ‘marine’ di Minucio Felice possiamo senz’altro annoverare numerosi passi omerici, tra cui il notissimo iliadico di A 34: par¦ qîna polufloísboio qal£sshj , e l’odissiaco di l 75 s.: sÁma tέ moi ceàai poliÁj έpi qinì qal£sshj, / ¢ndrÕj dust»noio, kaì έssomέnoisi puqέsqai : quest’ultimo passo si costituisce come un distico di esametri con regolare cesura dopo il terzo longum, accorgimento metrico che rende la tournure fortemente cantilenata, e perciò più facilmente memorizzabile [l 76 ha cesura trocaica]. Altre memorabili descrizioni del mare troviamo in Eschilo, Prom., 88-91 e in Virgilio, georg., II, 158-160. In Eschilo, Prometeo, appena serrato nelle catene da Dominio, Terrore ed Efesto, così si rivolge allo scenario che lo circonda: ð dîoj aίq¾r kaì tacÚpteroi pnoaí, / potamîn te phgaì pontíwn te kum£twn / ¢n»riqmon gέlasma pammÁtor te gÁ… . Virgilio, nel secondo libro delle Georgiche, dedicato agli alberi, trae lo spunto dalla flora enotria per intessere uno stupendo elogio dell’Italia. Successivamente, dopo aver trattato della varia natura dei terreni, si sofferma in modo particolare sulla vite e sull’olivo, di cui la terra italica è sempre stata ricca. Chiude il libro un commovente inno alla vita rustica. Quanto all’elogio dell’Italia, bisogna dire che esso più tardi diventerà, nelle letterature greca e romana e medievale fino a Petrarca, quasi un «tópos» : si vedano, fra gli altri, per i Greci, gli elogi del geografo Strabone e dello storico Dionigi d’Alicarnasso; per i latini, quello di Plinio il Vecchio, nat. hist., III, 6, 39-40. All’interno di questo elogio dell’Italia è naturalmente celebrato il mare (georg., II, 158-160): an mare quod supra memorem quodque adfluit infra? / anne lacus tantos? te, Lari maxime, teque, / fluctibus et fremitu adsurgens Benace marino? .
Veniamo ora alla Recherche. In À l’ombre des jeunes filles en fleur, il narratore, giunto con la nonna al Grand-Hôtel di Balbec, fa, all’indomani del suo primo pernottamento ‘in villeggiatura’, la scoperta del «mare nudo» . Tale esperienza salva Marcel dall’angoscia; egli abbandona senza rimpianto tutto ciò che, per l’innanzi, gli aveva suggerito il nome di Balbec: l’ovidiano paese dei Cimmerî, le ombre perenni e il mare in tempesta. A salvarlo è quel meccanismo interiore che lo aveva salvato fin dall’infanzia: lo spirito dell’Analogia, che ritrova unità tra il mare e la terra, tra il mare e le montagne, tra il mare e il sole; e precorre l’insegnamento del pittore Elstir, quando gli mostrerà il Port de Carquethuit. Con una specie di spavalda ironia, in questo passo Proust, il narratore, viene incontro a Marcel, la persona agens, e lo soccorre. E così crea la sua più bella marina, dove l’orchestrazione metaforica barocca, che sembra rubata a un concettista spagnolo, la tradizione della pittura marina dal Seicento a Turner agli Impressionisti, una grandiosa summa di cultura, si esprimono in un sublime divertimento, come un gioco che a tratti rivela la sua deliziosa leggerezza parodica: «Mais le lendemain matin! […] quelle joie… de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines de la bibliothèque , comme dans les hublots d’une cabine de navire, la mer nue, sans ombrages, et portant à l’ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s’élançaient l’un après l’autre comme des sauteurs sur le tremplin! À tous les moments, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l’Hôtel et avec laquelle je faisais d’inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ses vagues en pierre d’émeraude çà et là polie et translucide, lesquelles avec une placide violence et un froncement léonin laissaient s’accomplir et dévaler l’écroulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage ».
Il grido di gioia alla vista del mare all’incipit di questo brano ci rammenta il grido che nell’Anabasi di Senofonte (4, 7, 24) mandano i mercenarî greci guidati da Senofonte stesso di fronte al mare: q£latta, q£latta! L’espressione famosa è qui forse inconsapevolmente riecheggiata o implicitamente allusa ad indicare una sospirata salvezza, come quella incontrata dai reduci dalla battaglia di Cunassa, acquistata dopo molti rischi e pericoli (nel caso di Proust, peripezie interiori), il raggiungimento di una meta agognata. Alla base di tale visione proustiana sta anche senza dubbio il celebre passo lucreziano (2, 1 s.), citato esplicitamente altrove nella Recherche (dal barone Charlus , ad es., in Sodome et Gomorrhe: ma è soltanto uno dei tanti casi che si potrebbero elencare), dove il poeta evoca la tranquillità di chi, dalla terraferma, osserva il mare tempestoso: suaue, mari magno turbantibus aequora uentis, / e terra magnum alterius spectare laborem . Poco importa che il mare in Lucrezio sia tempestoso e che in Proust sia solo soavemente increspato, perché non mancano altri passi antichi in cui la contemplazione delle vaste distese del mare è additata come un potente lenitivo contro i travagli dell’anima, e il romanziere potrebbe avere attinto anche ad essi: Cicerone, pro Mur., 2, 4, ad Att., 2, 7, 4, Orazio, ep., 1, 11, 10, Orienzio, Commonitorium, 1, 500. Ma il motivo è già presente nel comico greco Archippo, fr. 43 K.: æj ¹dÝ t¾n q£lattan ¢pÕ tÁj gÁj Ðr©n , mentre una formulazione imparentata, anche se più generica, è l’έx£nthj leÚssw toÙmÕn kakÕn ¥llon žconta , riportata anche da paremiografi (Zenob. vulg., 3, 95) e lessicografi (Suda e 1546). Variazioni sul tema si hanno in un frammento sofocleo (636 R.: tra i testimoni c’è il citato luogo di Cicerone), e in un passo di Girolamo (adu. Pelag., 1, 12). Proverbi simili si hanno in italiano (Bello è contemplare il mare dal porto), inglese e tedesco; tra le riprese letterarie va segnalata una di Schiller (Wilhelm Tell, 1, 1), senz’altro da annoverarsi tra le fonti del luogo proustiano.
Ritorniamo ora alla Recherche. Proust divide il suo testo in due campi metaforici, quello del mare e quello del sole: da una parte e dall’altra, analogie legano i due campi a realtà d’ogni sorta, finché con un ultimo gesto Proust fonde il mare e il sole in una realtà unica. Ecco le immagini del mare. In primo luogo, le onde sono come dei tuffatori, che uno dopo l’altro si gettano dal trampolino (cfr. l’etsi non canis spumosisque fluctibus exibat ad terram del testo minuciano, che, nonostante l’avversativa, suggerisce la stessa immagine). Essi ci ricordano il celebre ipogeo etrusco detto appunto dei tuffatori di Tarquinia. Poi viene stabilita l’immagine centrale: quella del paragone tra mare e montagne.
Un simile accostamento analogico si trova sovente nelle scene naturalistiche della pittura antica. In un’opera originale d’epoca ellenistica tarda si trova, ad esempio, la sintesi di tutti gli elementi che costituiscono il paesaggio alessandrino, con la sua inestricabile mescolanza di osservazioni realistiche e di scene di genere, come avviene talvolta nel romanzo greco e nei passi dell’Octauius di Minucio Felice testé citati. Il grande mosaico realizzato, attorno all’80 a.C., per il santuario della Fortuna a Palestrina, l’antica Preneste , è opera di artisti greci, originarî dell’Egitto, almeno a giudicare dal tema scelto: si tratta di una visione sintetica e – saremmo tentati quasi di dire – sinottica della valle del Nilo, brulicante di vita, e delle sue rive a tratti rocciose. Questo quadro disinvolto di una vasta distesa del paese è tutt’altro che un paesaggio reale: si tratta di una giustapposizione di minuscole scene realistiche, legate tra loro dalle acque calme e luccicanti del Nilo, dalle linee di imponenti ammassi di rocce che sembrano dissolversi in paludi, rilievi montuosi artificiali quanto quelli delle scene dell’Odissea dell’Esquilino , e da un cielo striato da fasce luminose dai colori cangianti, in una composizione percossa a tratti da macchie di luce, con riflessi e ombre sull’acqua. Tali elementi da pastiche policromo e variegato si rintracceranno poi, dopo un lungo intervallo, solo nelle marine del Seicento e in quelle di Turner , tanto ammirato da Proust.
L’analogia proustiana tra mare e montagne si divide in tre analogie parallele. Il mare è un «vasto anfiteatro abbagliante e montagnoso», con le «vette nevose dei suoi flutti in pietra di smeraldo qua e là levigato e traslucido» (è il primo cenno all’analogia con il regno delle pietre preziose); oppure assomiglia a «colline», che vengono danzando verso l’osservatore, mentre le prime ondulazioni appaiono in una «lontananza trasparente», vaporosa e bluastra come i ghiacciai in fondo ai quadri dei Primitivi toscani; oppure le onde sono di un «verde così tenero» come quello delle praterie alpestri: «ici ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n’était qu’après une longue plaine sablonneuse que j’apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre comme ces glaciers qu’on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. D’autres fois, c’était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d’un vert aussi tendre que celui que conserve aux prairies alpestres… moins l’humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière ».
Il campo analogico del sole si allarga ancora, perché il sole lo fa ardere come un topazio, lo fa «fermentare, diventar biondo e latteo» come la birra, «schiumoso» come il latte: mentre una misteriosa divinità, muovendo uno specchio nel cielo, fa trascorrere delle «ombre azzurre» sulla superficie delle acque: «Me persuadant que j’étais ‘assis sur le môle’ ou au fond du ‘boudoir’ dont parle Baudelaire, je me demandais si son ‘soleil rayonnant sur la mer’ , ce n’était pas – bien différent du rayon du soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant – celui qui en ce moment brûlait la mer comme un topaze, la fasait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments s’y promenaient çà et là de grandes ombres bleues que quelque dieu semblait s’amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel .
Quanto al sole, esso appare soprattutto nella sua incarnazione antropomorfica, di chiara matrice classica, via via più parodistica. Dapprima timidamente: «sorride senza viso» sul mare-montagna; e poi discende a salti ineguali, per le stesse montagne, come un gigante di buon umore: indica da lontano a Marcel, con un dito sorridente, le cime blu del mare; infine, stordito dalla passeggiata tra i picchi e le loro valanghe, «tra il cilestrino tremolìo del mare» , entra nella stanza di Marcel, dove si ripara dal vento, abbandonandosi sul letto disfatto, e sgranando le sue ricchezze sul lavabo e sulla valigia aperta. Ma ecco altre analogie: la luce del sole è liquida e mobile come l’acqua; mentre la spiaggia e le onde praticano una breccia nel resto del mondo per farvi passare e accumulare la luce, che si deposita sul mare. I due campi d’immagine si sono già toccati e fusi più di una volta, e attendono ora la loro incoronazione unitaria finale (che è sintesi e coronamento dell’insieme). Chi la provoca è un’immagine sacra, il ricordo della Gerusalemme celeste nell’Apocalypsis di Giovanni, 21, 18-20: et erat structura muri eius ex lapide iaspide; ipsa uero ciuitas aurum mundum simile uitro mundo. (19) Et fundamenta muri ciuitatis omni lapide pretioso ornata. Fundamentum primum iaspis, secundum sapphirus, tertium chalcedonius, quartum smaragdus, (20) quintum sardonyx, sextum sardius, septimum chrysolithus, octauum beryllus, nonum topazius, decimum chrysoprasus, undecimum hyacinthus, duodecimum amethystus . Tutto si fonde, tout se tient, o per dirla con Pound, «it all coheres» : il mare-montagna, la luce-oro, il mare e la luce del sole come luce preziosa, il mare-montagna come Gerusalemme celeste, dando così alla visione marina il tocco finale della visione utopica. «Questa sala da pranzo [dell’albergo] di Balbec, nuda, riempita di sole verde come l’acqua di una piscina, a qualche metro dalla quale l’alta marea e il giorno pieno innalzavano, come davanti alla città celeste, un bastione indistruttibile e mobile di smeraldo e d’oro». Il possente spirito dell’analogia, che dispone di due o più elementi e li collaziona, crea un elemento solo, la terra-mare, il mare-terra, abolendo, come nella già citata opera di Turner intitolata Yachts che si avvicinano alla costa, ogni demarcazione tra essi. Proust fa un omaggio a Baudelaire, parlando di «cette multiforme et puissante unité» che richiama senza ombra di dubbio «une ténébreuse et profonde unité» delle Correspondances baudelairiane . Il paesaggio marino-montano di Marcel culmina nella visione della Gerusalemme celeste. Anche qui due allusioni ci trasportano in momenti emblematici della storia dell'ebraismo. L’arcobaleno che avvolge le chiese di Criquebec allude al patto di alleanza tra Elohim e gli uomini: dixitque deus: hoc signum foederis, quod do inter me et uos et ad omnem animam uiuentem, quae est uobiscum in generationes sempiternas; arcum meum ponam in nubibus, et erit signum foederis inter me et inter terram (Gn. 9, 12-13) . Mentre le onde «miracolosamente allontanate», nella falsa grotta marina, alludono al gesto di Jahvè che con un forte vento orientale fa risalire indietro il Mar Rosso, così che, per i figli di Israele, le acque formano un muro a destra e a sinistra (Es. 14, 21-22). Tali visioni bibliche, il patto di Noè e il passaggio del Mar Rosso, erano state più volte raffigurate su vaste tele da Turner nel corso della sua prodigiosa carriera: Proust ne conosceva alcune riproduzioni a stampa nel Liber studiorum (eccellente mezzo di diffusione della produzione turneriana nel corso del XIX sec.), pubblicato per la prima volta dal pittore nel 1819 per i tipi del suo amico stampatore W.F. Wells, e sottoposto poi a numerosi rimaneggiamenti e aggiunte . In queste marine il paesaggio si conclude in una visione simbolica: i momenti essenziali dell’alleanza tra Dio e l’uomo, la visione della Città cubica e perfetta, al di fuori della storia, dove l’uomo abita in Dio, diventato suo tempio.
Ma a questa conclusione escatologica Proust perviene attraverso un lungo processo di assimilazione e di decantazione di un solo verso baudelairiano, il già citato «sole raggiante sul mare». Non è neanche un verso, è la fine del verso 20 di Chant d’Automne, la punta della quinta strofa della poesia:
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.
Questo frammento di verso che, nella sua semplicità, sfiora quasi la banalità (ma il sublime risiede spesso nel banale), Proust, d’altronde, lo prende non tanto dalle Fleurs du Mal, nella cui edizione del 1861 comparve questo poemetto, quanto invece dalla melodia che Fauré compose su Chant d’Automne : «Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres; / adieu, vive clarté de nos étés trop courts! / J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres / les bois retentissant sur le pavé des cours. // Tout l’hiver va rentrer dans mon être: colère, / haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé, / et, comme le soleil dans son enfer polaire, / mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé. // J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe… // J’aime des vos longs yeux la lumière verdâtre, / douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer, / et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre, / ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer ».
«Il sole raggiante sul mare», ‘verso-feticcio’ di Proust , è il sole del poema di Baudelaire rivisto da Fauré. In esso, il poeta e il musicista non possono essere separati, come per Le Papillon et la Fleur di Hugo , o per Ici-bas tous les lilas meurent di Sully Prudhomme , ai quali Proust è ugualmente affezionato e legato dalle melodie. Questo verso ritorna continuamente sotto la sua penna: il verso cantato.
In una lettera a Reynaldo Hahn, che risale probabilmente al 1895, Proust riporta una conversazione con Fauré, che avrebbe espresso dei dubbi sul valore che Reynaldo poteva attribuire alle sue melodie, in confronto a quelle che egli aveva composto: «E gli ho detto che, al contrario, ti avevo più spesso sentito cantare i suoi “donneurs de sérénade” che i tuoi , e che tu cantavi così bene il Chant d’Automne» . Chant d’Automne era una di quelle melodie che Reynaldo intonava con la sua voce di baritono, accompagnandosi al pianoforte, nei salotti.
Tuttavia, per Proust, il Chant d’Automne di Baudelaire-Fauré esisteva già prima che Reynaldo lo cantasse. Fernand Gregh racconta, nei suoi ricordi, che Proust canticchiava «con un’aria estatica e una voce stonata, con gli occhi socchiusi e la testa buttata all’indietro»:
J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre.
Nell’estate del 1892, durante un soggiorno dai Finaly a Trouville, egli avrebbe dedicato questo verso a Marie Finaly, che aveva gli occhi verdi .
Non è questo verso, ma la coda della quinta strofa della stessa poesia, che Proust cita in una lettera a suo padre, al ritorno da Trouville, nell’autunno dell’anno successivo: «Sono felice di ritrovarmi a casa, la cui gradevolezza mi consola… del fatto di non poter vedere più, come dice Baudelaire in un verso di cui potrai percepire, spero, tutta la forza, “il sole raggiante sul mare”» . Un’allusione più implicita, più intima, compare in una lettera scritta da Trouville e databile intorno all’ottobre del 1898, indirizzata proprio al cantore della melodia di Fauré, Reynaldo Hahn, che soggiornava allora a Dieppe: «Vi dirò, capovolgendo i bei versi di Baudelaire, che «rien aujourd’hui, ni le boudoir, ni le soleil rayonnant sur la mer ne me vaut l’âtre…» .
In tutta l’opera di Proust, il «sole raggiante sul mare» ricompare di continuo, a cominciare dal poema in prosa intitolato Rimpianti, fantasticherie: colore del tempo, nei Piaceri e i giorni: «Era venuta la notte, sono andato in camera mia, ansioso di restarmene nell’oscurità senza più vedere il cielo, le montagne e il mare splendenti sotto il sole» . In un’altra pagina dei Piaceri e i giorni, nella Malinconica villeggiatura di Madame de Breyves, «le soleil couchant, dans la mer» serviva già come termine di paragone con l’«inesprimibile sentimento del mistero delle cose in cui il nostro spirito sprofonda in un radioso splendore di bellezza», e veniva citato il poeta del Chant d’Automne, «giacché, come ha detto Baudelaire, parlando dei tardi pomeriggi d’autunno, ci sono sensazioni la cui vaghezza non esclude l’intensità, e non c’è punta più acuminata di quella dell’infinito» . Il «sole raggiante sul mare» che Proust sembra interpretare, all’altezza dei Piaceri e i giorni, come irradiazione del sole in autunno, è all’origine di uno squisito dolore. «Come sono penetranti – penetranti fino al dolore! – le giornate d’autunno al tramonto!». Così incominciava Il «Confiteor» dell’artista, nello Spleen di Parigi, fonte della citazione approssimativa di Proust .
Il mare, altro poema in prosa appartenente ai Rimpianti, fantasticherie: colore del tempo, che riprende il ritornello: «Scintilla sotto il sole e ogni sera sembra morire con lui» . Ecco una nuova indicazione: Proust associa l’irradiazione al calar del sole sul mare, con il crepuscolo, con l’autunno. E sempre con la tristezza sognante: «È il momento dei suoi riflessi melanconici, così dolci che guardandoli ci si sente struggere il cuore». Colpisce il tono baudelairiano di questi poemi in prosa, specie nell’aggettivo ‘doux’, lo stesso attribuito al «rayon jaune», di cui Proust fa abuso come Baudelaire. L’atmosfera è quella del Viaggio e della nostalgia del sole: «La gloire du soleil sur la mer violette / la gloire des cités dans le soleil couchant» . Infine, in Marina, la prossimità spaziale e, al tempo stesso, il contrasto tematico fra le due costruzioni sembrano avere Chant d’Automne come fonte comune: l’alternativa è quella del mare «sotto il sole sfolgorante, in cui si riflette il cielo che ha il suo stesso azzurro», e del mare «agitato, giallo sotto il sole come un gran campo di fango» . Insomma, tutta l’esperienza proustiana del mare si riassume in una variazione sul verso di Baudelaire. I piaceri e i giorni trovano «il sole raggiante sul mare» non appena viene fatto un accenno al mare, e si può addirittura supporre che, senza il verso di Baudelaire, la prosa di Proust non conterrebbe marine. Ma Proust evita quest’espressione. Parla di «vedere… il mare brillare sotto il sole», di «sole che cala sul mare», o di mare che «brilla sotto il sole», come se girasse attorno a un’idea fissa, a un ritornello ossessionante.
Alla ricerca del tempo perduto mostra un altro atteggiamento, rispetto a Baudelaire: «il sole raggiante sul mare» non viene più imitato come lo era stato nei Piaceri e i giorni, né è vietato o passato sotto silenzio come in Jean Santeuil, ma viene apertamente indicato come il verso inimitabile e perfetto. Il «sole raggiante» è ormai citato, come abbiamo visto, tra virgolette, in All’ombra delle fanciulle in fiore. Così, durante le passeggiate con Mme de Villeparisis: «Prima di salire in carrozza, avevo composto la “marina” che andavo a cercare, che speravo di vedere con il “sole raggiante”, e che a Balbec non scorgevo se non troppo sminuzzata» . Il «sole raggiante» ha ora il valore di una parola d’ordine, suscitatrice d’analogie, di un «sesamo» ruskiniano che riassume in sé tutte le visioni poetiche del mare, da Omero a Virgilio a Ovidio a Minucio Felice a Huysmans, essendone – come dire, metatemporalmente – all’origine (almeno per quanto concerne la ‘memoria poetica’ del narratore). Recatosi a Balbec, il protagonista è come alla ricerca degli «effetti descritti da Baudelaire» . Ritrovare la sensazione trasposta nei Fiori del male costituisce ora lo scopo del viaggio: ritrovare, non più ricopiare o temere. Rimane, comunque, intero l’enigma del verso, del suo potere agli occhi di Proust. Essendo così vicino al cliché, com’è che lo affascina fino a questo punto? I poemi in prosa dei Piaceri e i giorni ricollegavano quest’immagine con il crepuscolo, associando il «sole raggiante» ai «raggi del sole calante», al sole basso di settembre. All’epoca, il «sole raggiante sul mare» corrispondeva al «sole calante sul mare». In All’ombra delle fanciulle in fiore, invece, fin dal primo momento a Balbec, quest’immagine viene spostata e interpretata diversamente, di proposito. Il protagonista, come abbiamo visto, scorge il mare dalla sala da pranzo del Grand-Hôtel: «Persuadendomi che ero “seduto sul molo” o in fondo al boudoir di cui parla Baudelaire, mi domandavo se il suo “sole raggiante sul mare” non fosse – molto diverso dal raggio della sera, semplice e superficiale come una linea dorata e tremula – quello che bruciava in quel momento il mare come un topazio, lo faceva fermentare, diventare biondo e lattiginoso come birra schiumante, come latte, mentre di tanto in tanto vi trascorrevano qua e là grandi ombre azzurre, che qualche dio sembrava divertirsi a spostare, muovendo uno specchio nel cielo» .
Proust rivede la sua lettura del Chant d’Automne; esita. Le ultime due strofe del poema (non musicate da Fauré) alludono sicuramente al crepuscolo: «soyez la douceur éphémère / d’un glorieux automne ou d’un soleil couchant». Ma il «sole raggiante», allo scopo di creare un contrasto e di preparare la nostalgia, dev’essere quello dell’estate: «Ah! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, / goûter, en regrettant l’été blanc et torride, / de l’arrière-saison le rayon jaune et doux!». Il «sole raggiante sul mare» non è altro che l’astro allo zenit - «Moi, Roi des étés» -, e il protagonista di All’ombra delle fanciulle in fiore corregge l’errore dei Piaceri e i giorni. A partire da questo libro, il momento poetico proustiano si è trasferito dal chiaro di luna, dal tramonto o dall’alba huysmansian-minuciana, alla dodicesima ora, ma lo stesso verso continua a rimanerne l’emblema. Le parole «seduto sul molo», che Proust accosta al «boudoir» del Chant d’Automne, non appartenendo a nessun poema dei Fiori del Male, ma evocando l’espressione «disteso sul belvedere o appoggiato al molo», nel Porto dello Spleen a Parigi , mantengono, tuttavia, in questa messa a punto, una certa confusione. D’altronde, non è neanche dal «boudoir» che viene visto il «sole raggiante», in Chant d’Automne, come invece Proust, che non è mai – per sua esplicita ammissione – lettore molto attento, supponeva già in una minuta appartenente ai zibaldoneschi brogliacci per l’inizio del soggiorno a Balbec, in cui, d’altra parte, era ancora come un sole «sparso» sul mare che egli interpretava il «sole raggiante»: «non è così, da una camera estranea e fredda d’autunno, che Baudelaire osserva – poiché il verso precedente gli fa vedere il “boudoir”, la donna amata e il focolare – il sole raggiante sul mare? Non è come faccio anch’io, dal balcone d’una camera d’autunno, che egli restava a assaporarlo?» . Ma, se qualche incertezza può sussistere, in questa minuta, riguardo alla lettura del poemetto, nel testo definitivo risulta comunque chiara la distinzione tra il raggio, nella sua unicità di particolare ultimo e fragile, e l’irradiazione intesa come illuminazione di tutta la superficie del mare: il «sole raggiante» non è altro che «la strada girevole dei suoi raggi», secondo un’espressione che compare in All’ombra delle fanciulle in fiore, accanto alla precedente. In ogni caso, che il «sole raggiante sul mare» sia quello di mezzogiorno, anziché quello del crepuscolo, non mette forse in rilievo anche la bellezza del participio presente, che permette questo slittamento, nell’ambiguità che lo caratterizza, dato che si tratta, contemporaneamente, di un aggettivo e di un verbo?
Un brouillon per il secondo soggiorno a Balbec, in Sodoma e Gomorra, conferma questo spostamento. Questa pagina si trova nel punto in cui viene descritta la visita dell’anziana Mme de Cambremer e di sua nuora, nata Legrandin, al Grand-Hôtel: l’anziana signora farnetica come Sainte-Beuve e la giovane parla solo per clichés. Rivolgendosi alla giovane Cambremer, il protagonista imita il modo di parlare fiorito, saturo di aggettivi qualificativi, di suo fratello. Infatti, il lezioso Legrandin veniva presentato, nella Strada di Swann, come colui che non poteva più «ascoltare altra musica se non quella suonata dal chiaro di luna sul flauto del silenzio» . Egli citava Desjardins, «un limpido acquerellista»:
Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu.
«Non è un’efficace postilla a quest’ora?» . Ora invece, imitando il fratello davanti alla sorella, il protagonista cita Baudelaire. E che cos’altro, se non «il sole raggiante»?
«Mostrando una linea dorata e tremula che il sole disegnava sul mare: - Mi chiedo spesso se non è di questo ‘raggio’ che Baudelaire ha voluto parlare quando dice: “Rien ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer”. Credo che egli pensi a qualcosa di meno lineare e superficiale, anzi a quel calore di tutto il mare a mezzogiorno, quando è forte, pieno di luce e schiumoso come latte» . Questo brano assomiglia molto a quello di All’ombra delle fanciulle in fiore sulla prima colazione a Balbec (per cui vd. supra), ma la logica è assai più contorta, forse perché è quella del pastiche (questa moderna applicazione del concetto antico-umanistico dell’æmulatio): la linea prodotta dal sole ricorda il verso di Baudelaire, ma per mettere sùbito in dubbio la sua adeguatezza a quel momento della giornata. Là , quest’associazione era diretta: lo splendore del sole di mezzogiorno portava a una pertinente rilettura di Baudelaire. Qui il protagonista continua così: «Sapete che sto parlando della poesia Chant d’Automne. Certamente conoscete la melodia ammirevole che Fauré ha scritto su questi versi». Quest’allusione conferma che non si può scindere la poesia di Baudelaire dalla versione che ne ha dato il musicista, e, più generalmente, che la poesia della Recherche passa attraverso melodie .
Stabilito ora che il primo ipotesto delle marine proustiane è da rintracciarsi senz’altro in Baudelaire, abbiamo il compito di chiederci se – e in quale misura – tutta la fitta rete di riecheggiamenti classici da noi evocata , che sta alla base della cultura e della creatività stessa baudelairiana, fosse presente a Proust durante il concepimento di questa «eco di un tópos classico». Elementi sulla reale portata della (sconfinata) erudizione letteraria proustiana desumiamo soprattutto da uno scritto giornalistico incluso nei Pastiches et mélanges intitolato Sentiments filiaux d’un parricide . L’articolo per il «Figaro», poi confluito nella raccolta miscellanea, il più tragico dei racconti proustiani, venne composto tra il 25 e il 30 gennaio 1907, data in cui comparve sul giornale. La ‘trama’ è basata su un fatto di cronaca. Qualche anno prima, Proust aveva conosciuto Henry van Blarenberghe, un uomo piacevole e distinto. Quando, nel maggio 1906, gli morì il padre, sentì verso di lui la simpatia, la solidarietà e complicità d’orfano, che così sovente egli provava; e gli scrisse una lettera «in nome» dei suoi morti . Van Blarenberghe gli rispose ringraziandolo con delicatezza di «quel messaggio d’oltretomba» : Proust gli scrisse di nuovo, sentendosi sempre più vicino a lui e parlandogli della propria malattia dopo la morte del padre e della madre ; in una lettera del 12 gennaio 1907, van Blarenberghe gli confessò che anche lui non riusciva a riprendersi dallo sconvolgimento che gli aveva causato la morte del padre . Pochi giorni dopo, il 25 gennaio, Proust leggeva il «Figaro», quando fu attratto da una notizia: Un dramma della follia. Henry van Blarenberghe, il suo gentile e malinconico corrispondente, aveva ucciso la madre: i domestici avevano visto Mme van Blarenberghe scendere le scale con il viso coperto di sangue e gridando: «Henry! Henry! Cosa hai fatto!»; subito dopo aveva levato le braccia in alto e si era abbattuta a terra, con la faccia in avanti. I poliziotti erano entrati nella casa. Avevano forzato la porta della camera dell’assassino, trovandolo moribondo: Henry van Blarenberghe aveva il viso coperto di ferite che si era fatto con un pugnale, mentre la parte sinistra era dilaniata da un colpo di fucile. L’occhio pendeva sul guanciale. Il 30 gennaio Gaston Calmette, direttore del «Figaro», chiese a Proust un articolo sul delitto, e Proust lo scrisse febbrilmente in una sola notte, dalle tre alle otto di mattina . La sera, quando gli portarono le bozze, aggiunse la conclusione.
Era soltanto un fatto di cronaca, «un dramma della follia», diceva il «Figaro»: ma, per Proust, quel ‘pasticciaccio’ aveva il respiro del mito, la grandezza della tragedia greca. «In che pura, in che religiosa atmosfera di bellezza morale ebbe luogo» scriveva «quest’esplosione di follia e di sangue». Citava Eschilo, Sofocle, Shakespeare, Dostoevskij, Tolstoj. Henry van Blarenberghe diventava, ai suoi occhi, Aiace che massacrava i pastori e le greggi dei Greci , Edipo che uccideva il padre, induceva la madre-moglie al suicidio, e si accecava per non vedere «né il male che aveva subìto né quello che aveva causato» , Oreste che uccideva la madre e veniva inseguito dalle Furie , Re Lear che stringeva tra le braccia il cadavere di Cordelia… Sebbene in questo caso la sua cultura classica riposasse precipuamente su un brano del Cours de Littérature dramatique di Saint-Marc Girardin , Proust comprese perfettamente la struttura del mito antico. Quei delitti erano stati delitti sacri: Atena aveva velato gli occhi di Aiace; Edipo era stato perseguitato dall’oracolo di Apollo; Oreste aveva obbedito all’ordine di Apollo. Henry van Blarenberghe si era fatto saltare l’occhio con un colpo di fucile: Edipo si era forato gli occhi con la spilla d’oro di Giocasta, per non vedere.
Ma questa interessante rivisitazione della tragedia antica da parte di Proust non getta che fiochi lumi sulla sua formazione classica, la quale dovette essere per forza di cose – essendo Proust un grande critico modernista – sfaccettata e come passata attraverso il vaglio di molteplici raffronti e contaminazioni con le letterature posteriori. In questo impegnativo e mai dismesso lavorìo di scavo verso il passato, alla ricerca delle radici culturali, due essenzialmente furono i suoi maestri: John Ruskin e J.K. Huysmans. Sulla dirompente novità della poetica dell’inuentio inaugurata da Ruskin nei Modern Painters (1843) , secondo cui inventare è come per i latini inuenire, trovare quel che esiste già, e sulla sua influenza sul metodo narrativo-espositivo di Proust, ovvero quel particolare «genio dell’ekphrasis» - per usare, estendendone senso e portata, un’espressione di André Chastel relativa a Roberto Longhi - che anima tante pagine e costituisce forse l’essenza stessa della Recherche, sarebbe troppo lungo dissertare in questa sede. Osserveremo solamente come le stesse poetiche pascoliana e dannunziana, entrambe basate su un vibrante ritorno alla ‘verità’, sarebbero inconcepibili senza l’esempio di quel Maestro. Quanto a Huysmans e al suo romanzo À Rebours, è noto come la sensibilità dell’adolescente Marcel ne fosse stata a tal punto permeata che, più tardi, gli sarebbe riuscito difficile guardare le cose – e in ispecie gli oggetti d’arte – con occhi diversi da quelli di Des Esseintes . Gran parte dell’erudizione classica di Huysmans, così, passò a Proust fin dall’età in cui questi non era ancora in grado di compiere precise scelte estetiche.
Le pagine che Huysmans volle dedicare alla cultura latina del protagonista di À Rebours , infatti, per la singolarità dei giudizi critici esposti, furono a lungo oggetto d’indagine da parte di eruditi e scrittori, e destano ancora l’attenzione degli studiosi. Al fine dunque di meglio comprendere la formazione estetica di Marcel, dobbiamo chiederci in primo luogo quali siano state le fonti erudite alle quali Huysmans attinse la sua «informazione di base» e poi da chi, e fino a qual punto abbia accolto i suggerimenti dei filologi classici per le sue bizzarre (ma acute) valutazioni degli scrittori latini. È noto come Huysmans avesse chiara coscienza del desiderio, che era vivo in lui, di trasformare il romanzo in qualcosa di più ambizioso, dove non fosse assente il saggio artistico e letterario: «Il y avait beaucoup de choses que Zola ne pouvait comprendre, d’abord ce besoin que j’avais d’ouvrir les fenêtres, de fuir un milieu où j’étouffais, puis le désir qui m’appréhéndait de secouer les préjugés, de briser les limites du roman, d’y faire entrer l’art, la science, l’histoire» . È altrettanto noto come queste premesse venissero poi pienamente adempiute solo da Marcel Proust nella sua Recherche. Non parliamo di filiazione diretta – ché qui non si tratta di mere questioni di critica ‘fontaniera’ – ma del permanere di un solido progetto culturale, influenzato in entrambi i casi da suggestioni delle vivaci speculazioni estetiche di Carlyle, Ruskin e Pater.
Anche le pagine di À Rebours sulla letteratura latina mostrano evidente l’amore del documento. Abbiamo una esplicita testimonianza a questo riguardo grazie alla pubblicazione del carteggio di Huysmans con Jules Destrée . Huysmans dice: «J’ai passé plus de huit mois à recueillir des notes, je défie un parfumeur, un latiniste, de me prendre en faute, au point de vue du document exact» . Vediamo di stabilire, per quello che è nelle nostre possibilità, quali siano queste fonti erudite.
Per quello che concerne la letteratura latina cristiana e quella medioevale, è già stato notato che Huysmans ha tenuto presente la grande opera di A. Ebert, Allgemeine Geschichte des Mittelalters in Abendlande, Leipzig (Vogel) 1874-87. Di lì può aver tratto notizie anche su Minucio Felice. Ce ne informano H. Brunner e J.L. De Coninck nel loro scrupoloso studio delle fonti di À Rebours . Gli autori si sono basati su quello che dice Remy de Gourmont, secondo il quale lo studio di Huysmans è «condensé du vaste travail d’Ebert. Sur les analyses de ce lourd et docte professeur, Des Esseintes piqua ses ingénieuses épithètes» . Brunner e De Coninck hanno anche voluto vedere delle coincidenze fra Huysmans ed Ebert nel giudizio su alcuni scrittori della cosiddetta ‘decadenza’, come Frontone, Apuleio e Minucio Felice, ma il passo di Ebert, che fa parte dell’introduzione , è troppo generico, sommario e insufficiente a giustificare quello che Huysmans dice di questi autori . Il confronto inoltre è stato condotto sul testo tedesco di Ebert , ma c’è da domandarsi se Huysmans avesse così buona conoscenza di quella lingua o non piuttosto se egli abbia conosciuto la traduzione francese del I volume dell’opera di Ebert , comparsa per merito di J. Aymeric e J. Condamin, entrambi maestri-amici di Proust , presso A. Leroux, a Parigi nel 1883 . Questo dubbio ci pare possa cadere esaminando attentamente il passo nel quale Huysmans parla di Tertulliano.
Des Esseintes definisce lo stile di Tertulliano «un style concis, plein d’amphibologies, reposé sur des participes, heurté par des oppositions, hérissé de jeux de mots et de pointes…» . Queste parole rispondono perfettamente al testo della traduzione francese del passo corrispondente: «Nous trouvons en lui un esprit de contradiction qui nous attache par la richesse des antithèses, par l’abondance des pointes et des jeux de mots» e ancora nelle espressioni «… des phrases hachées, inconcinnae, et des costructions concises reposant sur des participes…» . In ambedue i casi inoltre la parola tedesca, resa poi famosa da Freud , «Wortwitz» è resa con «pointe». E non è facile che si trovi in due diverse traduzioni questo esito, che non è di banale versione, ma implica la manifestazione di una certa personalità da parte di chi traduce. Inoltre sia Huysmans che J. Condamin e J. Aymeric si servono dell’espressione «reposer sur des participes». Nel testo originale di Ebert era detto semplicemente che, per arrivare a certi effetti, l’autore «wirkt in einzeln stehenden Wörtern, abgebrochnen Sätzen gedrängten Participialconstructionen» cioè, «si serve di parole in sé singolari, di frasi spezzate, di costruzioni participiali forzate» .
Anche nei confronti della letteratura latina di età augustea e della prima età imperiale, Huysmans è, a tratti, singolarmente ben informato. E come è sua consuetudine (e sarà consuetudine di tutti i decadentisti, da Wilde a D’Annunzio a Proust), mostra particolare interesse per la notizia rara, preziosa. Vediamo qualche esempio.
Huysmans conosce e sfrutta la notizia, che è in Macrobio , sull’imitazione da parte di Virgilio del II canto dell’Eneide da un poema di Pisandro. Di Petronio rimpiange due opere, da lui scritte e perdute: Eustion e Albutia . Di esse parlava Fulgenzio. La prima di queste informazioni Huysmans, a nostro avviso, deve averla attinta alla grande Storia letteraria di Teuffel, opera fondamentale che ha formato intere generazioni di studiosi: essa proprio in quegli anni veniva tradotta in francese , e non può essere sfuggita a Huysmans nella sua ricerca di documentazione accurata; a questa infatti lo vedremo rifarsi in numerosi passi. Ma Huysmans non deve essersi accontentato di accettare pianamente queste informazioni. Sembra infatti essere andato a leggere il passo di Macrobio , al quale il Teuffel rinviava per la notizia riguardante il soggetto del secondo libro dell’Eneide, imitato da Pisandro . Alle parole di Macrobio: «quae librum secundum faciunt a Pisandro paene ad uerbum transcripserit» , corrispondono perfettamente quelle di Huysmans: «le simple vol que nous a révélé Macrobe du II chant de l’Éneide presque copié mots pour mots dans un poème de Pisandre» . Il personaggio di Enea «indecis et fluent» era già detto da Teuffel «sans initiative personelle», «un caractère peu convenable au principal héros d’une epopée» . E negativa era stata anche la valutazione di Teuffel dei pastori virgiliani, privi di vita, infinitamente inferiori a quelli teocritei . Il ritratto complessivo di Virgilio, tracciato da Teuffel : «Il rassemble des materiaux avec un zèle d’érudit et polit la forme avec une patience d’artiste, mais le travail le plus consciencieux ne réussit pas à remplacer la force créatrice, l’imagination, l’énérgie, l’originalité, la clarté et la vie», è sostanzialmente quello negativo che appare in Huysmans : «Il eût bien accepté les fastidieuses balivernes que ses marionettes échangent entre elles, à la cantonade; il eût accepté encore les impudents emprunts faits à Homère, à Théocrite, à Ennius, à Lucrèce, … enfin toute l’inénarrable vacuité de ce tas de chants; mais ce qui l’horripilait davantage c’était la facture de ces hexamètres, sonnant le fer blanc, le bidon creux, allongeant leurs quantités de mots pesés au litre selon l’immuable ordonnance d’une prosodie pédante et sèche; c’etait la contexture de ces vers râpeux et gourmés, dans leur tenue officielle, dans leur basse révérence à la grammaire, de ces vers coupés, à la mécanique, par une imperturbable césure, tamponnés en queue, toujours de la même façon, par le choc d’un dactyle contre un spondée. Empruntée à la forge perfectionnée de Catulle, cette invariable métrique, sans fantasie, sans pitié, bourrée de mots inutiles, de remplissages, de chevilles aux boucles identiques et prévues; cette misère de l’épithète homérique revenant sans cesse, pour ne rien désigner, pour ne rien faire voir, tout cet indigent vocabulaire aux teintes insonores et plates, le suppliciaient». Non certamente in questo modo pensava Proust di Virgilio, che infatti è così spesso citato, con evidente ammirazione dell’autore, nella Recherche . Un punto di contatto è, invece, il giudizio su Petronio.
Quanto a Petronio, Huysmans l’avrà letto o in latino o in versione francese. Certo mostra di conoscerlo bene, ma quello che è egualmente notevole è che Huysmans esprime concetti che allora erano di moda e venivano dati per certi presso i filologi. Per esempio Huysmans pensa che veramente i personaggi del romanzo di Petronio abbiano un linguaggio diverso, secondo la loro condizione sociale e la loro patria; il che è vero, come ha dimostrato la filologia del XX secolo, solo entro certi limiti. Tutto questo avrà piena realizzazione, ancora una volta, solo nella Recherche di Proust, così sensibile alla mimesi della lingua d’uso e delle sue sonorità continuamente cangianti. Huysmans dice a questo proposito: «faisant parler à chacun son idiome, aux affranchis, sans éducation, le latin populacier, l’argot de la rue; aux étrangers leur patois barbare, mâtiné d’africain, de syrien et de grec; aux pédants imbéciles, comme l’Agamemnon du livre, une rhétorique de mots postiches» . In realtà tale caratterizzazione linguistica dei personaggi è poca cosa e non sempre avvertibile. Ma Huysmans aveva letto di questo procedimento verisimilmente nella stessa letteratura di Teuffel : «Le langage des acteurs est en rapport parfait avec leur caractère et leur position. Encolpe lui-même parle la langue des gens instruits de la meilleure époque, temperée seulement par le laisser-aller de la conversation…; la plupart des autres interlocuteurs s’expriment au contraire dans l’idiome populaire, rempli de locutions proverbiales, de propos grossiers… et même de grécismes (en raison du pays à moité grec où l’action a lieu)». È evidente come Huysmans abbia forzato e caricato la reale situazione linguistica del romanzo. Quanto alla presenza di fatti di lingua africani o siriaci, essa non corrisponde affatto a verità. Ma si comprende come un artista quale Huysmans forzasse anche il vero, pur di introdurre l’elemento affascinante della lingua barbara.
Così non si lascia sfuggire l’occasione di sottolineare a proposito di Apuleio l’esistenza di un latino d’Africa. Ma qui egli è giustificato; vi credeva anche la filologia del tempo. E questo egli poteva ancora ricavare da Teuffel . In fondo quanto egli dice dello scrittore africano è già tutto in Teuffel: «La diction d’Apulée a en général un certain parfum exotique, bien qu’il manie la langue latine avec une extrême habilété… on trouve chez lui un style manieré et affecté… Sa diction, mélange d’idiomes de provenances diverses…» . E Huysmans a proposito della lingua di Apuleio dice: «Elle roulait des limons, des eaux variées, accourues de toutes les provinces, et toutes se mêlaient, se confondaient en une teinte bizarre, exotique, presque neuve; des maniérismes…» .
Anche se la corrispondenza verbale fra il testo di Teuffel e quello che Huysmans dice di Lucano è meno stretta, tuttavia l’idea fondamentale espressa dallo storico tedesco, che in Lucano sia un grande vigore formale che nasconde debolezza di pensiero, è mantenuta da Huysmans.
È molto probabile dunque che Huysmans si sia servito della Storia Letteraria di Teuffel per la sua informazione sugli autori che abbiamo esaminato e anche su altri, come Rutilio, Ausonio, Claudiano. Naturalmente, muovendo da questa lettura Huysmans avrà allargato la sua viva curiositas in determinate direzioni. Non escluderemmo che la notizia su Eustion e Albutia, opere perdute di Petronio, nominate da Fulgenzio, non gli derivasse dall’edizione di Fr. Bücheler , cui rinviava Teuffel. Anche la preziosa edizione di Petronio fatta da J. Dousa (Leyden 1585) che Huysmans immagina sia posseduta da Des Esseintes è l’unica, fra le cinquecentesche, ricordata da Teuffel . Si può fare ancora un’osservazione. Huysmans – è ciò che più ci interessa – tratta degli scrittori latini dal II al V secolo senza distinzione, senza separare letteratura pagana da cristiana. Ebbene, questa è proprio l’impostazione di Teuffel, seguìta pressoché all’unanimità dai critici e dagli storiografi posteriori, la quale costituisce una novità e un indubbio progresso nelle storie della letteratura latina. Sino allora infatti la letteratura cristiana era trattata a parte, a tutto danno della storia.
La buona volontà di documentarsi non impedì tuttavia a Huysmans di cadere, nonostante la sua ostentata sicurezza, in un grossolano errore. Fra i poeti cristiani infatti egli ammira particolarmente Commodiano. Ma la sua conoscenza dell’autore deve essere stata molto scarsa, appena un’informazione da manuale. Altrimenti non si comprende come possa definire il Carmen Apologeticum «un recueil d’instructions, tortillées en acrostiches» ; il che potrebbe andar bene per le Instructiones, non certo per il Carmen. Evidentemente ha confuso, mal rileggendo le sue note . E nemmeno è vero che in questo poema si trovino esametri acrostici. Quanto però a quello che dice sulla qualità degli esametri corrisponde esattamente a quello che aveva scritto Teuffel . Così c’è da pensare che anche per gli autori cristiani abbia tenuto presente l’opera del filologo tedesco.
Le osservazioni che abbiamo fatto ci confermano nell’impressione che si riporta da una lettura d’insieme di queste notazioni di Huysmans sulla letteratura latina, che è questa: l’intento di documentarsi sulla materia da trattare è sopraffatto, come nel Proust della Recherche e nel D’Annunzio del Libro segreto , dal prevalere della nota dettata dal gusto personale, condizionato dal desiderio di stravaganza e della ricerca della notizia rara, preziosa. La loro formazione culturale li porta a valorizzare al massimo il linguaggio degli autori trattati; soprattutto in quanto capace, con innovazioni anche ardite, di esprimere ogni più riposta sensazione dell’animo. Le innovazioni formali sono invece da condannare quando appaiono mero esercizio filologico, che denota povertà di ispirazione .
Vediamo ora quale peso notevole abbia avuto sui giudizi di Huysmans, riguardo agli autori latini, il gusto e l’opinione degli scrittori del suo tempo che ammirava e cui doveva gran parte della sua formazione.
Huysmans comincia col ripudiare la letteratura classica. E per far questo con la massima efficacia, prende di mira gli esponenti più rappresentativi dell’età di Augusto. Primo fra tutti Virgilio, quello che «les pions surnomment le cygne de Mantoue» . Abbiamo visto con quali parole di disprezzo egli tenti di liquidare la sua arte. La retorica di Cicerone gli sembra ampollosa e vuota e in Orazio vede soltanto un’arguzia consumata da vecchio pagliaccio [cfr. Mommsen ca. 1855]. Tanto in prosa che in poesia, la massima attenzione di Huysmans è rivolta all’elocutio degli autori di cui si occupa. E sarà sempre su questo filo conduttore che si volgerà ad esaminare gli scrittori più aderenti al suo gusto. Il primo che lo interessa è Lucano ed è ancora la lingua che muove la sua attenzione; egli la trova, rispetto agli scrittori che lo precedettero: «élargie, déjà plus expressive et moins chagrine» , ma trova Lucano ancora vuoto nel contenuto. L’autore che riscuote intimamente le sue simpatie, come colui che ha saputo dare un quadro della Roma del suo tempo, in una lingua ricca, varia, colorita, è, come abbiamo visto, Petronio. La descrizione che egli fa della sua arte è vivacissima, e tale da attirare l’emula attenzione tanto di Proust quanto dei nostri poeti decadenti. Con il gusto di uno scrittore che si è formato alla scuola del realismo egli scova in Petronio gli aspetti più singolari della sua arte, che sono anche i più vicini alla sua sensibilità .
Quello che più sorprende in una visione globale è il totale misconoscimento della classicità latina. Se nel periodo romantico si apprezzò al massimo il mondo greco a discapito della civiltà latina, pur tuttavia rimasero sostanzialmente vivi l’interesse e l’ammirazione per i grandi scrittori latini dell’età augustea . Per tutti – e anche, come abbiamo visto, per Proust – Virgilio resta il sommo maestro. D. Nisard nel suo studio sui poeti latini della decadenza conferma che la poesia classica resta la più alta sul piano dei valori assoluti . Definisce tuttavia uno stile comune agli autori delle epoche di decadenza, antichi e moderni, che ha una sua bellezza «faisandée» (cioè ‘frolla, imputridita’) e che il critico potrebbe soffermarsi a valorizzare in sé e per sé se non fosse ancora legato a far risaltare in un’opera d’arte l’insegnamento morale che ne può derivare . La letteratura resta ancora sostanzialmente letteratura di idee e niente può esserle sacrificato. Pur tuttavia il fatto che Nisard abbia spostato l’attenzione verso gli scrittori della decadenza, isolandoli come realtà a sé stante, ci sembra importante a determinare un certo orientamento del gusto. È già stato osservato infatti come verso la metà del secolo apparve in Francia una serie di studî, d’impressioni, di polemiche, che contribuirono ad arricchire il clima di cultura in cui si svolse il decadentismo . Articoli apparsi su riviste contribuirono a rafforzare la conoscenza e a orientare il gusto per scrittori e atteggiamenti di pensiero prima poco noti, quando non sentiti come ripugnanti alla chiarezza classica. Proprio nella «Revue des deux mondes» apparve nel 1874 uno studio di Gaston Boissier sui poeti latini della decadenza . La sua attenzione è rivolta al linguaggio di Petronio con espressioni che richiamano alla mente quelle usate da Huysmans e da Proust , e parimenti all’importanza del romanzo come documento della società del suo tempo . Tali osservazioni furono preziose tanto a Huysmans quanto a Proust per l’elaborazione dei loro romanzi.
Alcuni degli scrittori più rappresentativi del loro tempo, ai quali Huysmans e Proust amano ispirarsi, hanno indubbiamente orientato il loro gusto. Sfogliando la Correspondance si può vedere come Flaubert ammiri sì, i classici latini, Virgilio , Orazio, sia per il contenuto altamente morale che per la forma . Ma questo egli fa anche per autori del primo e del secondo secolo, per Petronio e per Apuleio , e non manca di scandalizzarsi che la conoscenza di persone che si dicevano colte, si limitasse in realtà ad autori del secolo la cui venerazione era imposta dalla disciplina scolastica: «M. de Sacy, membre de l’Académie française, m’a declaré qu’il n’avait jamais lu Lucrèce ni Pétrone. “Mon Dieu, je m’en tiens à Virgile!”. O France! C’est un triste pays. Je me sens submergé par le flôt de bêtise qui le couvre» . Secondo la testimonianza di Léon Daudet, E. De Goncourt sdegnava i grandi classici dell’antichità come il protagonista di À Rebours. Inoltre «il affichait une certaine préférence pour quelques auteurs faisandés tels que Pétrone, Martial, Perse, qu’il lisait dans les traductions et dont le bariolage abscons et vireux lui plaisait. Huysmans a exprimé quelques-unes des préférences para-classiques d’Edmond de Goncourt» .
Ma ancor prima e ancora maggiormente ci sembrano da ricercare le origini di certi giudizî e atteggiamenti di Huysmans (e, sulla sua scia, di Proust) in Baudelaire. È ancora Baudelaire, l’autore del «sole raggiante sul mare», a essere il modello dei decadentisti. Nella Lettre à Jules Janin il poeta delle Fleurs du Mal esprime la sua insofferenza per Orazio e la preferenza per autori non classici, con queste parole: «Toujours Horace et Margoton! Vous vous garderiez bien de choisir Juvénal, Lucain, ou Pétrone: celui-là avec ses terrifiantes impuretés, ses bouffoneries attristantes. (Vous prendiez volontiers parti pour Trimalcion, puisqu’il est hereux, avouez-le). Celui ci [scil. Lucano], avec ses regrets de Brutus et de Pompée, ses morts ressuscités, ses sorcières thessaliennes, qui font danser la Lune sur l’herbe des plaines désolées; et cet autre [scil. Giovenale] avec ses éclats de rire pleins de fureur. Car vous n’avez pas manqué d’observer que Juvénal se fâche toujours au profit du pauvre et de l’opprimé! Ah! le vilain sale! – Vive Horace, et tous ceux pour qui Babet est pleine de complaisances!». Su Cicerone, nello stesso scritto leggiamo: «Cicéron, petite farce de journaliste… Cicéron philippiste. Sale type de parvenu» . I pastori di Virgilio che Huysmans definisce freddi come marionette già destavano antipatia in Baudelaire, quando, a proposito della poesia di Hégésippe Moreau, affermava: «Les deux amours alternent, comme des bergers de Vergile, avec une symétrie mathématique désolante» .
Nella premessa, più tardi soppressa, all’edizione prima di Franciscae meae laudes , il poeta poneva la domanda: «Ne semble-t-il pas au lecteur, comme à moi, que la dernière décadence latine – suprème soupir d’une personne robuste, déjà transformée et préparée pour la vie spirituelle – est singulièrement propre à exprimer la passion telle que l’a comprise et sentie le monde poétique moderne? … Dans cette merveilleuse langue, le solécisme et le barbarisme me paraissent rendre les négligences forcées d’une passion qui s’oublie et se moque des règles. Les mots, pris dans une acception nuovelle, révèlent la maladresse charmante du barbare du nord, agénouillé devant la beauté romaine».
Nelle parole di Baudelaire viene affermata sia la consonanza intima dell’inquieta anima moderna con una letteratura che esprime sia una crisi spirituale – il passaggio a una concezione religiosa della vita e della realtà, con tutti i dubbî, le angosce, le inquietanti intuizioni che quella ha in sé, prima di giungere all’acquiescenza nella fede – sia la rivolta contro il conformismo, la norma, la regolarità. Notevole è parimenti un continuo proporsi un problema di linguaggio. Il dramma degli uomini e delle generazioni si rispecchia necessariamente per Baudelaire nella tensione stilistica della lingua, nello sgretolamento delle sue strutture, nell’impasto rivoluzionario delle parole. Uguale sentimento è in Huysmans e in Proust. Di qui nasce quella curiosa impressione, in chi legge le pagine sulla cultura latina di Des Esseintes e di Marcel, di trovarsi dinanzi, più che a una rassegna della letteratura latina, a una storia, drammatica, della lingua letteraria.
Huysmans ha potuto dare – per la prima volta compiutamente – una tale valutazione del mondo classico, perché ha compreso, e accolto, il significato di ‘decadenza’ non come degenerazione o, altrimenti, sviluppo del classicismo, che era quello degli accademici, ma come momento storicamente e linguisticamente indipendente. Momento di crisi profonda, di formazione e di affermazione della sensibilità moderna, che deve estrinsecarsi in un linguaggio nuovo. È il concetto di decadenza espresso da Baudelaire nelle Notes nouvelles sur E. Poe .
In un periodo di ‘decadenza’ così intesa, dove lo sfaldarsi di un glorioso lascito letterario cede il posto a uno scambio tra diverse culture, venne concepito da un placido e raffinatissimo prosatore, un apologista cristiano lontano dai toni apocalittici dell’accusa, un dialogo che è tra i testamenti spirituali più freschi e commoventi dell’umanità, l’Octauius di Minucio Felice.
PAOLO MELANDRI
*
- Letteratura
Echi di una notte mitica
Echi di una notte mitica: da Ennio a Pascoli
Tentando di seguire, non passibus aequis, il percorso mentale di un critico-poeta, Giovanni Pascoli, leggiamo da Eco di una notte mitica , scritto in cui l’Autore rintraccia la eco virgiliana dell’«ultima notte di Ilio» nell’«Addio monti» di Lucia (con il brusco commiato dal paese che lo precede): «…può darsi che Manzoni non pensasse a Virgilio mentre scriveva. Ma la sua fantasia, senza che esso se ne rendesse conto, elaborava elementi virgiliani. La notte degli imbrogli e dei sotterfugi è l’ultima notte di Ilio trasformata in modo che nessuno, nemmeno il Manzoni, sospetterebbe la strana trasformazione. Eppure è così» .
Pascoli parla della memoria poetica, capace di inusitati richiami, di cui egli stesso fornisce numerosi esempi nei carmi latini. Stupisce la sicurezza del critico-rabdomante che percepisce ad intuito il fluire della vena virgiliana ‘sotto il velame’ della narrazione romanzesca. Chi legga gli archivi di Casa Pascoli troverà, sotto la ‘dubitosa modestia’ dell’interprete, la chiave ermeneutica capace di disserrare l’enigma del suggestivo ragionamento pascoliano e della ‘conoscenza intuitiva’ calorosamente propugnata: «Sono studi senza importanza […]. Ma c’è il caso che rivelino il meccanismo del cervello de’ grandi più che altri studi più seri e minuziosi. […] Mi piace: non è un cercar le fonti, ma l’ispirazione. Non conta nulla. Non è scienza. Ma è divertente. Il genio che lavora».
Qui Pascoli fa un’importante distinzione tra il concetto di ‘eco’ e quello di ‘fonte’. Molto si potrebbe osservare sulla innovatività del metodo di ricerca pascoliano e sulle critiche che egli muoveva alla filologia d’oltralpe (di cercare, a volte in modo piuttosto sterile, i ‘modelli’ e le fonti di ogni passo di un autore, ecc.) : alcune di esse hanno poi avuto una consacrazione accademica, altre rimangono discutibili: ma non è questa la sede per affrontare così vasti problemi.
Da parte mia ho sempre creduto che la facoltà immaginativa di Manzoni, nel concepire «la notte degli imbrogli e dei sotterfugi», sia stata accesa altresì dal ricordo di una celebre scena dell’opera buffa cioè – il lettore se ne avvede facilmente – di Atto II, Scena IX (da «Zitti, zitti, piano piano» in poi) del Barbiere di Siviglia di C. Sterbini-G. Rossini, con tutto quello che segue fino alla fine dell’opera: questa sezione del capolavoro melodrammatico rossiniano presenta infatti – a mio avviso – notevoli analogie con il succitato episodio romanzesco del tentato ‘matrimonio a sorpresa’ non solo per quanto concerne la situazione, ma pure per il tono generale e per quella atmosfera eccitata che concorrono a creare l’amore, le tenebre, il pericolo. È radicato nella memoria di ogni manzonista (e non solo) il ricordo di Manzoni negli anni di dissipatezza giovanile come è descritto dagli aneddoti milanesi (in cui fu visto giocare d’azzardo nel ridotto della Scala): il nostro maggior prosatore avrà assistito ad almeno una rappresentazione del Barbiere .
La critica di Pascoli è spesso una critica divinatoria, che si manifesta nei termini della rivelazione: essa può aiutarci a capire gli stretti legami esistenti fra atto poetico e atto critico, tra poesia e filologia.
«Gli esuli di Ilio si volgono, al chiarore del giorno, a rivedere la patria – i Danai occupavano in armi le soglie –; al chiaror della luna guarda Lucia al palazzotto di Don Rodrigo e il suo paesello e la sua casetta, col fico che sopravanzava il muro del cortile» .
Raffrontiamo i testi: «Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne: il palazzotto di Don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d’addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì; scese con l’occhio giù giù per la china, fino al suo paesello, guardò fisso all’estremità, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera; e, seduta, com’era, nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segretamente» (I promessi sposi, cap. VIII).
Questo passo manzoniano ha dunque alle spalle il seguente virgiliano:
Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
ducebatque diem, Danaique obsessa tenebant
limina portarum; nec spes opis ulla dabatur:
cessi et sublato montes genitore petiui
(Aen. II 801 ss.).
L’accostamento fatto da Pascoli è a mio avviso senz’altro convincente , ma il Rückblick qui descritto si ritrova altresì in due testi dissimili e distanti nel tempo, ascrivibili il primo alla sfera dei modelli, il secondo a quella degli imitatori di Virgilio.
Il modello del passo virgiliano sopra considerato – e di Aen. VIII 685 – è con buona probabilità Ennio , in questo caso imitatore di Euripide: scen. (Androm.) 92-99 V2. (=75-78 TRF3 =81-94 Joc. =41 Tr.):
O pater, o patria, o Priami domus!
Saeptum altisono cardine templum;
uidi ego te, adstante ope barbarica,
tectis caelatis laqueatis
auro ebore instructam regifice.
Haec omnia uidi inflammari,
Priamo ui uitam euitari,
Iouis aram sanguine turpari .
Questo canticum enniano in dimetri anapestici ‘rifà’, con molto patetismo, Eur. Androm. 384 ss. Non mancano nel passo, splendido per fulgore d’immagini e per elaborazione stilistica, nessi alliteranti (cfr., al v. 1, il ripetuto o e pater… patria… Priami, con la paronomasia pater… patria, al v. 7 ui uitam euitari, con figura etimologica, ché euitare =uitam eripere [cfr. exanimare] si trova per la prima volta qui), un triplice omoteleuto (tectis caelatis laqueatis, al v. 4), perfino una triplice rima (ai vv. 6-8).
L’imitatore di Virgilio, e probabile mediatore tra Virgilio e Manzoni, è invece, a mio avviso, Milton . Nell’ultimo libro del Paradise Lost dell’Inglese, infatti, Adamo ed Eva si volgono, in una luce naturale e soprannaturale al tempo stesso, varcato definitivamente il confine tra il luogo della beatitudine e la landa dell’esilio, a rivedere la Patria perduta – gli angeli stolis albis induti, le spade fiammeggianti nelle vigorose mani, ne occupano le soglie:
and from the other hill
to their fixed station, all in braight array
the Cherubim descended…
whereat
in either hand the hast’ning Angel caught
our ling’ring parents, and to th’ eastern gate
led them direct, and down the cliff as fast
to the subjecyed plain; then disappeared
(Paradise Lost, XII 628-640).
I luoghi da lasciare appaiono belli come mai prima – perché sono visti con gli occhi del rimpianto – ai due pellegrini nel mondo ignoto, pieno di pericoli e di potenzialità, minaccioso e attraente insieme, bisognoso delle cure dell’uomo:
They, looking back, all th’ eastern side beheld
of Paradise, so late their happy seat,
wawed over by that flaming brand, the gate
with dreadful faces thronged and fiery arms
(Paradise Lost, XII 641-644).
I nostri progenitori si volgono dunque indietro e (benché Milton non lo dica esplicitamente) siamo indotti a immaginare che vedano gli alberi del parádeisos – al centro sopravanza l’altezza degli altri l’albero della conoscenza, l’albero del peccato – poi, dandosi la mano, uniti nella caritas, nel mutuus ardor, si fanno strada verso l’Ignoto, vanno coraggiosamente incontro a un destino di prova e di espiazione nelle mani della Provvidenza. Rileggiamo attentamente i noti versi:
the world was all before them, where to choose
their place of rest, and Providence their guide:
they hand in hand, with wand’ring steps and slow,
through Eden took their solitary way
(Paradise Lost XII 646-649).
The world was all before them, where to choose / their place of rest, and Providence their guide: facciamo attenzione ai concetti espressi così eloquentemente dal dettato miltoniano, e in particolare alla parola Providence. A chi consideri la portata di questo concetto già stoico – e tutt’altro che estraneo alle idee filosofico-religiose virgiliane – assumerà nel romanzo, in pressoché tutta la produzione manzoniana, e le puntuali riprese di immagini dell’Eneide nel finale del Paradiso perduto apparirà chiaro come si debba individuare proprio nel passo miltoniano l’anello di congiunzione tra i commiati, ricchi di patetismo, descritti da Virgilio e da Manzoni. In Milton vi sono infatti elementi che mancano in Virgilio e che ritroviamo in Manzoni: a farsi strada verso l’Ignoto è in tutti gli autori una coppia, una famigliola in nuce o in atto – in Virgilio essa è privata tragicamente dell’elemento femminile di Creusa -, ma se Enea è guidato dal Fato, le due coppie Adamo-Eva e Renzo-Lucia sono guidate dalla Provvidenza cristiana. Milton è certamente il trait d’union tra Virgilio e Manzoni , senza perciò cancellare o sostituire nella tenace memoria poetica di quest’ultimo il ricordo del primo. A un livello non sappiamo se consapevole o inconsapevole dovettero risuonare insieme nella ‘fucina’ dell’«artiere» Manzoni al momento della creazione dell’«Addio monti» questi due ‘echi di notti mitiche’, quella dell’abbandono di Troia incenerita e quella dell’abbandono del Paradiso perduto.
Manzoni ‘continua’ Virgilio e Milton – in una prospettiva scritturale-patristico-dantesca potrei dire che adempie alcune premesse presenti allo stato germinale nei poeti epici – e noi possiamo comprendere a fondo quel passo dei Promessi sposi soltanto entrando nell’«officina» di Manzoni, e cioè mediante il confronto con l’Eneide e il Paradiso perduto, affiancando i tre celebri passi in un’«analisi contrastiva».
La poesia cosmica di Milton era cara all’«ultimo figlio di Vergilio» , al dantista sagace e penetrante che solo osò guardare ‘sotto il velame’ con l’audacia del fanciullo. Nella biblioteca di Castelvecchio Milton è presente insieme a Shakespeare, Keats, Shelley, R. ed E. Browning, Tennyson, D. G. Rossetti, Longfellow, Carlyle, tradotti o in lingua originale. Pascoli, come pare , lo ebbe presente nella composizione de Il ciocco (Canti di Castelvecchio) e altrove, e stupisce che qui non menzioni l’analogia. A mio avviso non sarebbe senza frutti una ricerca degli echi di Milton lungo la produzione manzoniana e pascoliana.
Nonostante gli aspri attacchi anticattolici dell’Inglese , la sua concezione dell’amore coniugale profondamente diversa da quella di Manzoni, il suo originalissimo ‘materialismo cristiano’ , quantomeno inusuale per un pensatore cattolico ortodosso , profondi contatti tra i due ‘poeti sacri’ sono ravvisabili nella comune concezione di una Provvidenza sapiente e paziente riparatrice degli errori dell’uomo tentato dal Seduttore, la scelta (giovanile per entrambi) di dedicarsi al genere innografico (si pensi soprattutto all’Inno per la nascita del Redentore di Milton: la scelta di soggetti tanto elevati e impegnativi non deve esser considerata un fatto scontato: i poeti inglesi del XVII sec. – così come gli italiani del primo XIX – prediligevano, com’è ben noto, temi mitologici e/o celebrativi ) e la visione teleologica della storia. Il male (e il peccato, e la connessa riparazione) in Manzoni è problema troppo dibattuto per potermene occupare in questa sede. Per una (a mio avviso) convincente interpretazione (che non risolve – né deve risolvere – la vexata quaestio) rimando il lettore all’opera epocale di E. Raimondi Il romanzo senza idillio . Posso solo auspicare che si sondi maggiormente il terreno di contatto tra Manzoni ed esponenti del Romanticismo d’oltralpe di matrice spiritualistica come Chateaubriand non estranei all’orbita di influenza del capolavoro di Milton.
Un altro studioso che, come Pascoli, faceva largo uso della divinatio, Richard Bentley, apprestò una contestata edizione di Milton, in cui qua e là ‘rifaceva’ il testo . I versi del Paradise Lost precedentemente considerati sono un po’ in contrasto con quello che li precede: in essi l’esposizione del piano provvidenziale da parte dell’arcangelo Michele non può impedire che i nostri progenitori si sentano sconfortati alla vista della lunga fatica che li attende nel mondo da popolare e da coltivare. La discrepanza che, artisticamente considerata, accresce il patetismo del commiato, non mancò di scandalizzare il ‘logicissimo’ Bentley . Il quale fu indotto a pensare, riguardo a questi versi, di avere di fronte un’interpolazione, opera di qualcuno che non fosse entrato abbastanza a fondo nel ‘piano dell’opera’: così arrivò a presumere di poter ‘divinare’ con buona approssimazione i versi originali – quelli dettati da Milton – a partire da quelli ‘interpolati’. Siamo qui di fronte a un’aberrazione dell’ingegno emendativo di Bentley, la quale comunque getta luce sulla forza dell’intelletto del grande critico, sull’intelaiatura concettuale del poema religioso e sull’«eccentricità» dell’episodio (conclusivo) qui considerato.
I progenitori hanno appena avuto un colloquio con l’arcangelo Michele, che ha rivelato loro il destino che li attende e quello dei discendenti, e ha profetato l’ora della Redenzione, in cui tutta la terra sarà fatta Paradiso. L’Eden chiude i battenti, Adamo ed Eva se ne vanno:
They hand in hand, with wand’ring steps and slow,
through Eden took their solitary way.
«Perché» si chiede Bentley «questo distico congeda i nostri progenitori lasciando loro nell’angoscia e noi nella malinconia?» Come giustificare l’espressione ‘a passi lenti e vagabondi (with wand’ring steps and slow)’? Passi irregolari? Non sembra appropriato, giacché nel verso precedente essi erano ‘guidati dalla Provvidenza (and Providence their guide)’. Sfiducia nei destini dell’uomo? nella forza della Grazia divina? E perché ‘lenti’ quando Eva stessa poc’anzi affermava di essere pronta e impaziente di andare:
… But now lead on;
in me is no delay…
E perché il ‘solitario cammino’? Come spiegare le espressioni che alludono alla solitudine dei protagonisti, a un loro triste e quasi smarrito allontanarsi dal Paradiso? Gli spostamenti di Adamo ed Eva non erano anche prima solitari, entro i confini del locus omnium amoenissimus , dal momento che da essi soltanto era costituita la stirpe umana?
«Potrò a questo punto permettermi, – dice Bentley – dopo tante precedenti ipotesi, di proporre un distico, vicino quant’è possibile alle parole dell’Autore, e totalmente in accordo con il suo progetto?
They hand in hand with social steps their way
through Eden took, with heavenly comfort cheered ».
Bentley presume di conoscere con esattezza il ‘progetto’ miltoniano, e, di conseguenza, polemizza con il testo in quanto non gli si adatta. Se egli sembra dimentichi l’ordine di Dio a Michele – so send them forth, though sorrowing, yet in peace (XI 117) – resta comunque vero che il ‘progetto’ di Milton, la sua idea iniziale circa la chiusura del poema, era di dimostrare che tutto alla fine sarebbe risultato giusto – and justify the ways of God to men (I 26) – e che ciò avrebbe soddisfatto profondamente sia Adamo che noi.
Considerando l’anomalia di questo passo di ispirazione e ‘pathos’ virgiliani rispetto al ‘piano dell’opera’, Bentley – checché ne pensassero i suoi contemporanei – non risulta affatto uno sciocco.
Paolo Melandri