chiudi | stampa
Raccolta di articoli di Bruno Corino
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
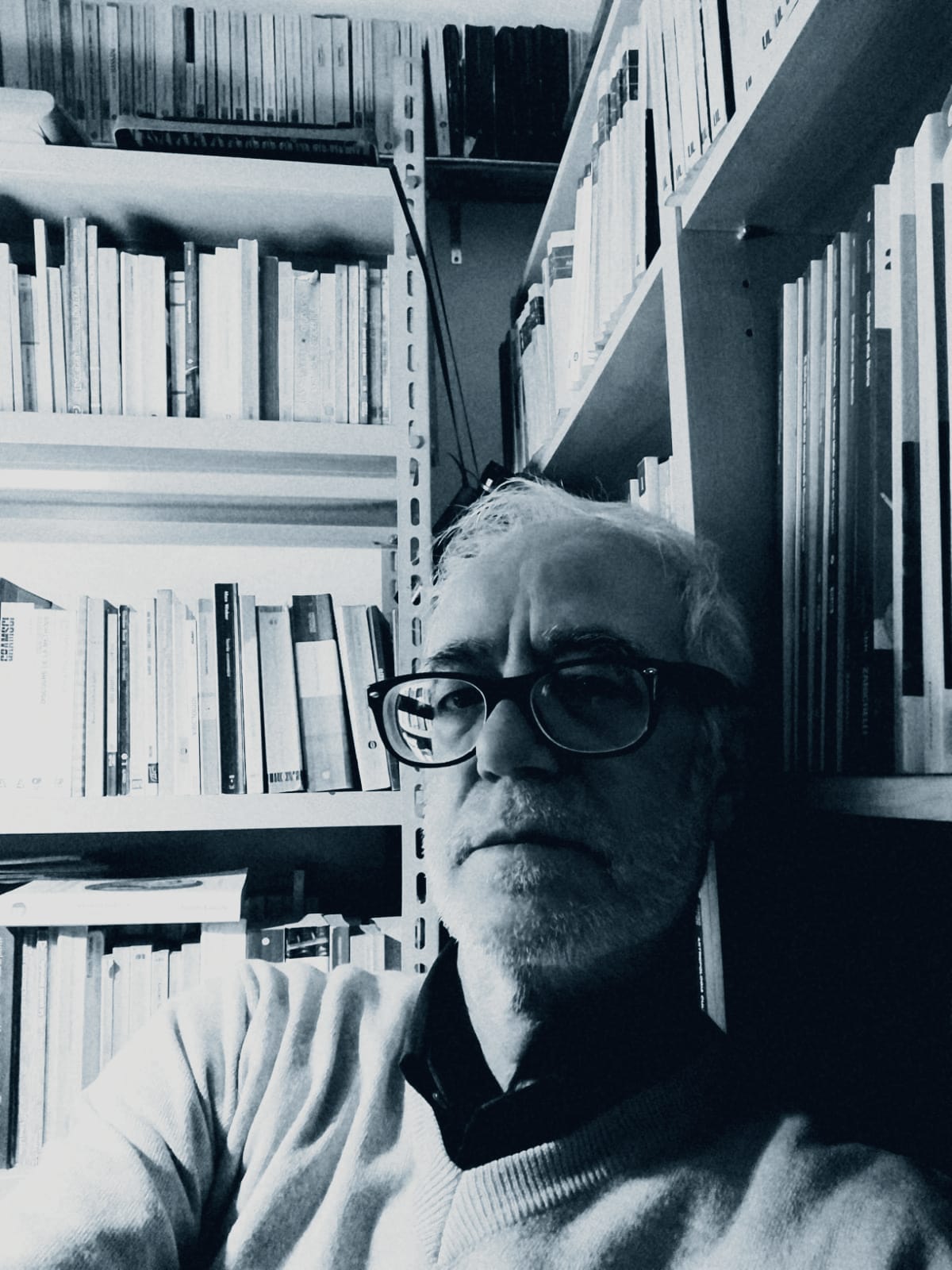
*
- Letteratura
La “cosa” letteraria non abita più nella carta stampata
La “cosa letteraria” non abita più nella carta stampata. Si è trasferita altrove. Nella volontà di non comunicare il comunicabile. È il medium che ha deciso questa svolta. Non il cosiddetto “libero arbitrio”. Non abita più nella carta stampata, come accadeva un tempo, perché nell’attuale epoca il medium ha preso decisamente il sopravvento sul linguaggio, sul logos, allo stesso modo in cui in un’altra epoca il logos aveva soppiantato la physis.
Il fondamento da cui la «cosa letteraria» ha ora origine, da cui si dischiude alla luce nel suo apparire, è il medium, non più il logos, non più la physis. Un medium che svela/rivela la metafisica del logos. E la svela/rivela in quanto il medium non si pone più come suo strumento, ma come sua “verità”.
Con la fine del logos finisce l’epoca dell’interpretazione, perché il medium non vuole essere interpretato, ma vuole soltanto comunicare, vuole soltanto informare, e, informando, attivare altra informazione, in un processo ricorsivo e senza scopo. In un senso illimitato. Nella nostra epoca, in questo nostro tempo, la comunicazione è fine a sé stessa, non è più lo strumento del dire, ma è lo stesso “dire”.
L’interpretazione resterà un compito riservato al sapere accademico, a una “casta sacerdotale” che non si rassegnerà mai a prendere consapevolezza che la cosa letteraria non abita più nel libro stampato. Ogni libro a stampa rimandava ad altri libri a stampa. Ogni pagina stampata ad altre pagine stampate. Ed è così che pagina dopo pagina la critica si consolidava. Su un’opera, un autore nel tempo si formava un labirinto interpretativo. È sempre quel sovrasenso o un surplus di senso che gli interpreti tentavano di decifrare. Ognuno a modo loro, secondo la propria formazione, la propria storia, la propria militanza. Ma anche seconda la propria inclinazione, il proprio gusto. L’interprete, spontaneo o esperto che fosse, s’esercitava intorno a un surplus, a una sovrabbondanza di significati, a una riserva inesauribile, in quanto era proprio in forza di questo surplus che la letteratura aveva ragione di esistere.
Ora si può soltanto comunicare. Chi decide di apparire comunica. Nessuno si illuda che dietro l’angolo ci sia l’esperto/interprete pronto a decifrare la sua apparizione! L’ermeneutica è finita con l’avvento dell’era dell’informazione. Con l’avvento dell’eccesso informazionale.
L’apparizione potrà essere ripresa nella rete, ma nessuno si preoccuperà di interpretarla. Perciò si è costretto ad apparire in modo sempre più comprensibile, più chiaro ed efficace. Ad apparire come un articolo di giornale. Ad essere trasparente e a tutti visibile. Nessun doppio fondo, nessuna trascendenza. Si è come s’appare.
Il racconto o la poesia si avvicina a un pezzo giornalistico, fino al punto che tra un racconto e un articolo di giornale non si noterà tra non molto nessuna differenza. E si finirà per leggere un racconto con lo stesso atteggiamento con cui si legge una notizia: per essere informati. Questo spiega il grande successo di Roberto Saviano: informazione intrisa di narrazione, e che ha valore finché ha valore la notizia. Questo spiega il grande successo di Massimo Gramellini: una narrazione intrisa di informazione. Tutto orbita intorno all’informazione. È l’informazione a comandare sulla narrazione.
Il sovrappiù di senso, la “riserva di significati” diventano un fattore di disturbo. L’eccesso di significato è rumore. Il polisenso un’assurdità.
Il paradosso sta dunque qui: la “cosa letteraria”, che per statuto conteneva un sovrasenso, che era costituita da un surplus di senso, nel momento in cui si configura come mera comunicazione, come informazione narrata, rinuncia a sé stessa. Cessa di essere una “cosa letteraria”, e veste quelli del prodotto letterario.
Può soltanto proporsi come intrattenimento o evasione, ma non più come “trascendenza”. Poiché proporsi di andare in questa direzione significherebbe incontrare la strada dell’incomunicabilità. Ma i medium non permettono la incomunicabilità. Il suo codice è abbastanza elementare: informazione o non informazione. Se si decide di informare bisogna farlo in modo chiaro, come insegnano tutte le scuole di giornalismo, altrimenti bisogna scegliere il silenzio, ossia la non comunicazione.
La letteratura fondata sul linguaggio andava oltre la mera comunicazione. Si parlava di ipersenso. Si parlava di pluralità semantica. Di ambivalenza. La letteratura era linguaggio, logos non banale né scontato. Non linguaggio strumentale, ma linguaggio come orizzonte, linguaggio come apertura dell’Essere. Lo si è scoperto tardi, tutto sommato. Nell’Ottocento. Con Hölderlin, anzitutto. E poi con Baudelaire e i maudits. Con Mallarmè la parabola toccò quasi l’apice sino a perdersi nell’onda del silenzio.
Nel Novecento divenne una verità elementare. Lampante. Nello stesso Novecento, quando la grande letteratura sapeva di correre il rischio di essere fagocitata dall’industria culturale, di essere banalizzata. E qui che le strade si sono divise. Letteratura di intrattenimento (quindi di facile consumo, d’evasione), guidata già dalla volontà di informare. O letteratura della trascendenza, dell’abbondanza dei significati. Letteratura come emblema di profondo cambiamento. Delle coscienze. Della storia o delle storie. Insomma, una letteratura che porta a riflettere. A incidere nel profondo. Letteratura che abbia in sé per costituzione fisica quel “sentimento del contrario” di pirandelliana memoria.
Ma questa seconda strada, volente o dolente, conduceva alla incomunicabilità. Alla consegna del silenzio, come sentenziò Roland Barthes, non inteso in senso banale, come rifiuto a parlare o a scrivere, ma inteso in senso esistenzialistico. Ad esprimere ciò che non è esprimibile senza essere banale. Beckett docet. Ma anche Kafka. L’ultimo Joyce. Ionesco. Il Nouveau roman: Alain Robbe-Grillet. L’ultimo Pirandello quello di Quando si è qualcuno. Alfine la babelica visione di Sanguineti, di Zanzotto. Un qualcosa che sfugga al facile consumo, che induce all’impegno della trascendenza. Qui l’interprete assume una funzione smisurata. Senza l’interprete/esperto il lettore è completamente cieco.
Ma quando i significati espressi s’identificano con l’informazione, quale sorte attende la letteratura? Quale cammino riserva alla sua sorte? Comunicazione strumentale, utile a farsi capire, a non essere frainteso?
Oppure….....................
Ed è in questa esitazione, in questa sospensione, in questo non dire il dicibile che la letteratura può salvarsi, evitare di precipitare nel vuoto, ossia di inabissarsi nell’eccesso informazionale…
Aprile, 2013
Id: 2906 Data: 01/03/2022 07:46:29
*
- Letteratura
L’Istoria de’ miei avi filosofici-litterari
Un meo avo litteraio si chiamava Aristarco Scannabue, mejo conosciuto ar secolo comme Giuseppe Baretti, il quale amava, metaforicamente, menar la Frusta addosso a tutti quei moderni goffi e sciagurati, che vanno tuttodì scarabocchiando commedie impure, tragedie balorde, critiche puerili, romanzi bislacchi, dissertazioni frivole, e prose e poesie d’ogni generazione, che non hanno in sé il minimo sugo, la minima sostanza, la minimissima qualità di renderle o dilettose o giovevoli ai leggitori ed alla patria.
Er meo avo, Aristarco Scannabue, avea in odio l’Arcadia, quella combriccola de’ poeti e poetastri, che amavan recitar certe pastoral poesie, travestiti da pastorelli e pastorelle, che perdeano il tempo a scrivere delle fanfaluche, così dicea Egli, amanti d’inutili notizie, e che, non sapendo come adoprar e impiegare bene il tempo, vanno appresso a delle corbellerie.
Er meo avo, Aristarco Scannabue, avea due gran mustacchi ch’ei portava sul labbro superiore, perché eziandio avea difetto nel labbro inferiore. Le donne del villaggio non lo trattavano familiarmente, e gli uomini di rado s’arrischiavano a parlargli. Il vecchio Aristarco sfogava la sua innata bizzarria su un fojio letterario, Egli avea studiato nell’adolescenza sotto il celebre Diogene Mastigoforo, alcune lingue orientali, dopo essersi bene insignorito del greco e del latino.
Er meo avo, Aristarco Scannabue, non amava gli inzuccherattisimi versi de lo Zappi, dicea ch’era poeta lezioso e galante; dicea anche che da un picciolissimo seme nasce una zucca molto smirurata, e che dei fondatori dell’Arcadia molti de’ quei nomi sarebbero miseramente sprofondati nel Lete, dicea, infatti, il buon profeta.
Ma ciò che er meo trisavolo, Aristarco Scannabue, non potea sapere è che l’Arcadia non è una stagione passeggera de la istoria umana, bensì è stagione perenne de lo suo animo, che ogni vorta torna puntuale a far sentire la sua voce. L’Arcadia, insomma, è forma di oziosità letteraria, male antico dell’Italica letteratura, portata sempre ad astratta e permanente inclinazione salottiera, accademica, formalistica, e di niuna utilità poetica.
Un altro meo avo litterario e filosofico se chiamava Giordano Bruno, al secolo conosciuto come Filippo Bruno, figlio de’ Giovanni Bruno, homo d’armi, e di Fraulissa Savolino, condannato a morte da la Congregazione de lo Sant’Uffizio, e abbrucciato vivo in un giorno di febbraio con la lingua “in giova” a Campo de’ Fiori.
Questo meo avo, omo piccolo, scarmo, con un pochetto de barbetta nera, che un insigne anglo clericale, roso da l’invidia, quasi pe’ desprezzo, solea chiamare omiciattolo italiano, non perdea mai occasione per sferzare quei dottori in gramatica e fare strame de’ l’istituzione ove regnava una costellazione di pedantesca ostinatissima ignoranza e presunzione mista con una rustica inciviltà.
Questo meo avo aveva insomma in uggia li pedanti, delli quali amava fare gran caricatura, e dicea che essi ne la ruota del tempo rappresentavano la notte dell’ignoranza che pretende de spacciarsi come il giorno della sapienza.
Dicea il meo trisavolo che questi personaggi sono al tempo stesso comici et tragici, e con la di lor mortal pedanteria finiscono sempre co’ lo uccidere lo sviluppo de lo sapere. Di lor fece gran scempio ne lo Candelaio, ove tratteggiò un mondo ordinato da uno principio arrovesciato.
Questo meo avo avea soprattutto in odio li aristotelici de li tempi sua, che avean orrore de varcare l’aria, discovrir le stelle e di trapassar li margini de lo mondo, ed evocava soprattutto lo declino morale dentro cui il mondo stava per incamminarsi e auspicava quanto fosse mai necessario l’opra salvifica di uno spirito libero.
Il meo avo, detto anche il Nolano, avea capito che la casistica, figlia de la aristotelica memoria, imponea rigidamente regole a fin de soffocar la ragione stessa dell’arte, e finia per contrastare e per contrarre de lo mondo la sua sterminata varietate.
Ei facea dir a Teofilo ne’ La cena de le ceneri che li omini rari, eroici e divini passano per questo camino de la difficoltà, a fine che sii costretta la necessità a concedergli la palma de la immortalità. La via che porta alla vita un pensiero nuovo, e che conduce a riconoscere l’universo come infinito e vario, discendendo da uno principio eterno e non mutabile, è sempre irta e dominata da la vôta gramatica e dalla insensata pedanteria.
Il meo avo, Bruno Giordano, sapea bene che l’asineria non è mai condizione storica, e che, quantunque cambino usi et costumi e li omini e donne non so’ mai li stessi di tempi in tempi, e che mutazione et variazione scandiscano il ritmo dell’intero Cosmo, li pedanti so’ sempre uguali, di alea in alea, essi non cangiano mai.
A questo meo avo un tempo dedicai questo bel canto:
Tra lo infinito cosmo e questa vita breve
la stretta è uguale, niente si biforca
e tutto s'attorciglia, come due moti
che s'intrecciano in un nodo
viaggiano et spaziano nel vôto
senza meta e senza sosta;
ma la picciol/mente s'ostina
a ricercare ne lo immenso
la causa, lo principio, la fonte
che la salvi e che la elegga a Nume
prendendo della lettera di Pitagora
lo sinistro lato che la svia
e le fa perdere la vista de lo lume,
acciò non sa che togliendo lo limite
che divide l'essere da se stesso
la sua libertate si dischiude
ed essa mente come per magia
s'infinitizza vincendo la paura
che la teneva avvinta alla catena,
e nulla più frena lo suo fûror
che la conduce a discovrir del mondo
le perle et i moti, sue contrazioni et sigilli
et tutto quel che delplus-verso è vero signo.
Ma il più antico dei mia avi, e il più sempatico, è senza altro er Burchiello, al secolo conosciuto comme Domenico Di Giovanni, de’ Fiorenza, bizzarro rasoio, spirto avventuroso, chiassoso estroso, ma generoso e folle…
Er Burchiello c’avea alle calcagne testuggini e tartufi, e quanno le annava male avea contro tutti li birri de la repubblica senese, un po’ pecché avea in uggia l’italica lirica, aulica e dotta, un po’ pecché viveva mendico con lo suo mestiere.
Er Burchiello amava la poesia giocosa e le accozzaglie, e nella sua rimeria estrosa se divertiva a mettece ogni sorta de’ frattaglie. E così che se divertiva a scrivere Nominativi fritti e mappamondi. Er Buzzi meo un po’ è sbucciato da la burchia del burchiello, insomma, talvolta me sembra una vera burchiellata.
Er meo Burchiello più che al piacere de la rima, cedea alla messa in scena de la aulica letegata tra la Penna e lo suo attrezzo de mestiere, quello che le dava un tozzo de pane da magna’ la sera a lume de candela. Ah!, caro meo Avo, comme anchor son attuali le tue rasolate! Te, che mai potei sapere che anche lo discendente Tua non avrebbe fatto de la penna l’attrezzo del mestiere suo, e che se va ramingo ad incontrar chi vive a li margini de la repubblica litteraria.
Id: 2890 Data: 26/01/2022 19:35:01
*
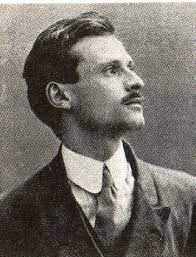 - Letteratura
- Letteratura
Variazioni sopra un verso di Marino Moretti
Da giorni c’è un verso che mi martella nella testa:
Piove. È mercoledì. Sono a Cesena…
trattasi famoso incipit A Cesena nella raccolta Il giardino dei frutti di Marino Moretti
…non è un bigliettino appiccicato dal poeta al fine di informare sua cara famigliola pessime condizioni meteorologiche Cesena – stop – o dir o far saper luogo ove trovasi giorno mercoledì – stop – …
Ecco, non è un’informazione, non è una notizia diffusa a privato uso…
Eppure, se qualcuno, dopo anni dalla sua morte, avesse trovato tra le sue carte un bigliettino con su’ scritto Piove. È mercoledì. Sono a Cesena senza conoscere seguito non avrebbe mai saputo se in realtà fosse verso/disperso o foglietto sperso, “postit” d’altri tempi insomma…
dubbio avrebbe arrovellato la di lui coscienza:
inizio di un verso, aborto poetico? O altro?
trattasi, semplicemente, di messaggio scritto sul primo fogliaccio capitatogli tra le mani?
Chissà….
In mancanza di contesto specifico, quell’enunciato rimarrebbe esposto a limbo ambiguità, in eterno: è informazione o “altro”? Questione indiscernibile… direbbe il Leibniz teutonico…
Ma noi sappiamo che non è un’informazione. Sappiamo che il poeta non voleva comunicare a suoi parenti et amici ove trovassesi quel giorno e che tempo facesse a Cesena. Sappiamo, appunto, che è il primo verso di nota poesia. Assodato che trattasi di verso di famosa poesia, cosa comunica suo Autore? Niente! Come niente? Marino Moretti, lui di persona, uomo nato a Cesatico nel 1885 e vissuto tra città natale e Firenze, firmatario del manifesto antifascista di don Benedetto Croce, etc. etc. purtroppo non comunica niente… O che blasfemia dice cotesto omo?!? Forse che non pare abbastanza evidente che il succitato poeta comunichi sua crepuscolare malinconia? C’è tutta: la pioggia, la sorella sposa, il grigio borgo, la tristezza, l’ombra grigiastra, etc. etc. insomma che te tu vuoi di più? Che ce lo scrivesse a tergo: “poesia melanconica”?
Calma, calma, buonuomo, io ti dico che Moretti – Autore esterno – non comunica niente, anzi forse il giorno che buttò giù i primi versi il poeta, l’uomo era allegro e gaio come non gli capitava da tempo perché rapito da demone creativo. Non ho le pruove, ma capisci cosa intendo dire? Intendo dire, lui, Marino, la persona non c’entra un bel niente. Te lo assicuro. A Cesena non mi parla della di lui malinconia, ma della Malinconia. Se lui voleva parlare della malinconia a sé o a qualcuno avrebbe scritto qualcosa di questo tipo: “Sono a Cesena, in visita a mia sorella da poco sposatasi… come è triste questa città… poi oggi che è mercoledì piove pure, etc. etc.”. Vedi, buonuomo se lui avesse voluto parlare della di lui malinconia si sarebbe più o meno espresso in questi termini, certamente più raffinati dei miei, ma il tono non sarebbe cambiato di tanto… lui avrebbe informato qualcuno di come si sentiva quel giorno, e in quell’ora, ne avrebbe spiegato le ragioni, se ne aveva voglia, per filo e per segno… e se poi, a distanza di anni avessimo letto questa lettera avremmo saputo come Moretti si sentiva quel giorno… ma in fondo, a pensarci bene, a me o anche a qualcun altro come si sentisse quel giorno il tal Moretti non sarebbe importato un bel niente, che l’avesse scritto in verticale o in orizzontale! Chi non ha avuto giornata uggiosa? Chi non s’è sentito oppresso da un senso di malinconia o di solitudine almeno una volta alla settimana nella vita? Non ci trovo nulla di strano, nulla di interessante. Insomma, il poeta, l’uomo non m’informa su un suo stato d’animo quando decide di scrivere un verso, l’Autore non mi comunica un bel nulla. E se lo facesse gli risponderei: senti fratello, puoi chiamarti anche Moretti Marino, ma io ho già tanti guai che non mi va d’ascoltare i tuoi anche se me li metti in versi o in prosa! Avrai pure una vita interessante, piena di emozioni, ma ne parliamo a cena magari attorno a un calice di vino amaro!
Sono a Cesena,
in visita alla mia povera sorella sposa,
e piove, e ciò rattrista il mio animo...
…………………………………….
Se tu Moretti avessi scritto questi “melanconici” versi, e m’avessi chiesto: “Senti come sono malinconici questi versi?”; io t’avrei risposto: “Ti sbagli, Marino, questi versi non sono affatto malinconici, forse lo eri tu mentre li buttavi giù. Vedi, Marino, in questo sono un po’ kantiano: non è perché tu mi parli per iscritto di monete sonanti, io ne sento il suono, così: non è perché tu mi parli in rime di malinconia io ne odo il timbro. Il concetto è così semplice che lo capisce anche un bambino. Non ti pare?”.
Ma che vai cianciando, diamine! Egli mi parla di Cesena, della sua sorellina, de’ “il nonno ricco del tuo Dino”, insomma, mi parla delle cose della propria vita! È vero, è vero, è tutto vero, ma non ha importanza, può darsi pure che il Moretti fosse figlio unico (si fa per dire), la qualcosa non cambierebbe punto. Son cambiati i tempi! Tutto qua. Il buon Cesarotti o il divino Metastasio t’avrebbe parlato non di sorelle o amanti sue, ma di Aminta, Megacle, Licida, Alcantro, Aristea; non senti che nomi belli? Magari sotto le vesti antiche di Argene, il Trapassi ci vedeva i moti e gli affanni della sua ultima amata, il dolor di suo commiato e il rapido furtivo bacio, e da poeta esperto avrebbe detto dell’Amor e dell’Amicizia, con eleganza e, secondo il suo consueto stile arcadico, li avrebbe messi assieme in scena, travestiti da due pastorelli. Allora, che vuol dire? Il Trapassi non aveva le giornate tristi? Non era anch’egli uomo come il Marino?
Ma la poesia è sfogo, è anima che si proietta in parole, è manifestazione di stato d’animo, è umore… vale a dire, invece di ingurgitare sana camomilla, e aspettar che il manifestato umore passi o cessi è meglio scriverci su’ quattro versi? Fa bene al tuo organismo spurgare in versi il cattivo umore? Or bene! Allora, fallo, spurga, sputa fuori tua gioia o tua delusione, mettila pure in versi o in rime, ma ciò non toglie che infine trattasi di “sana” terapia, di “cura” alla tua malinconia, e se funziona, intendo dire se ciò alla fine ti guarisce, ti solleva l’umore, ti provochi effetto catartico, fallo e fallo pure bene se ti riesce. Ma non restarci male quando il tuo lettore non si commuove, non rimane scosso dal tuo terapeutico sfogo! Ma come t’ho parlato di un bimbo a cui sfugge di mano un aquilone a significare quando la vita sia crudele nei confronti di chi è fragile e tu non ti commuovi? O sei un insensibile o non capisci un tubo! Volevi che ci mettessi anche un cane per moltiplicare l’effetto? Ma no, dico io, è che me lo potevi dire anche a voce! Se trattasi di storia inventata o immaginata non vedo il motivo del perché commuovermi, se trattasi di storia vera capitata a tuo figliolo mentre correa sulla spiaggia, t’avrei risposto: “Mi dispiace… per il dolor provato dal bimbetto”, cioè t’avrei manifestato tutta la mia commozione per l’accaduto, così come avrei fatto nel caso in cui tu m’avessi comunicato scomparsa di tuo parente affine…
Vedi, per dirla brutalmente, a me del contenuto non me ne frega niente! Che sia bello o brutto è uguale. Che Moretti sta a Cesena, un mercoledì qualunque in visita a sua sorella a me sinceramente non importa niente! Ciò che a me importa è la poesia A Cesena e non Moretti che neanche conosco!
Insomma, in questa poesia si mette in moto all’improvviso quel processo descritto da Mario Luzi secondo il quale un vocabolo comune (Piove), una qualunque parola (Mercoledì), legandosi ad altre quasi con algebrica precisione, crea un circuito che brucia tutta la quotidianità! In questo “bruciare” muore il “segno linguistico”, quello usato ai fini della comunicazione pragmatica, quel segno brucia perché, appena buttato dentro il fuoco della comunicazione pragmatica, immediatamente si consuma, come un pezzetto di carta, dopo aver assolto il suo compito: “Mercoledì sono a Cesena”, sms comunicato da amico ad amica, appena assolve sua funzione informazionale cessa di esistere, finisce nel cimiterio delle cose dette o scritte, svanisce. Altro è segno linguistico quando supera soglia del livello pragmatico, e non absolve compito di comunicare proprio moto d’animo: in questo andare oltre limite, come insegnano valenti semiologi, nasce surplus di comunicazione letteraria per cui il segno si configura come ipersegno. È ipersegno che guida autore implicito nella suddetta lirica, e non autore reale a guidare segno come capita comunicazione pragmatica. E trattasi di ipersegno poiché i «“significanti” in poesia, se, da un lato, rimandano pur sempre ai ‘significati’, dall’altro si costituiscono invece come entità autonome e, al limite, depositarie esse stesse di senso» (S. Agosti). In poesia o testo letterario ogni “significante” rimanda a complessa articolazione di significanti supplementari: fonetici, timbrici e ritmici. Quindi, cambia completamente statuto del segno. Siamo su un altro piano, non più quello della comunicazione pragmatica, ma letteraria: su questo piano il segno non è più “tocchetto” che arde in veloce combustione, ma potenza, forza che si sprigiona ogniqualvolta gli si dà voce. Recitato in mille modi, reiterato più e più volte, testo letterario aumenta sua potenza, sua combustione, suo valore: nulla si consuma, nulla si distrugge, ma tutto si compie.
Id: 2886 Data: 24/01/2022 17:23:33
*
- Ecologia
Della saggezza nascosta nella natura sin dalle origini
L’acqua, il fuoco, il vento, la terra: ecco i quattro elementi contro i quali gli alberi, nella loro quotidiana lotta per la sopravvivenza, devono combattere. Contro la potenza del fuoco non hanno difese; il fuoco è il loro implacabile nemico! Nella loro esperienza secolare, gli alberi hanno sempre temuto il fuoco; soltanto quando arriva, all’improvviso, una pioggia torrenziale, “provvidenziale”, che possa spegnere l’incendio divampante, possono tirare un respiro di sollievo, se nel frattempo la sua furia devastatrice non ha completamente lambito le loro radici vitali o le loro fronde.
Per il resto, gli alberi hanno imparato nel tempo a difendersi dai loro nemici naturali. Ho scritto “loro nemici naturali”; in realtà, nei confronti di questi elementi essi hanno rapporti ambivalenti: da un lato sono quelli che possono distruggerli; dall’altro sono anche quelli grazie ai quali possono sopravvivere: come farebbe un albero a nutrirsi se non ci fosse l’acqua e la terra? O a riprodursi senza la forza del vento che sparge dappertutto il loro polline?
Eppure, dico che se l’umanità in genere osservasse meglio il corso della natura e lo rispettasse nel profondo della sua genesi e del suo sviluppo, acquisterebbe una saggezza riposta che nessuna lingua umana è in grado di insegnare!
Anzitutto, osserva l’arte della quercia: la sua forza proviene dalla terra. Ha un tronco frondoso e maestoso, le sue radici penetrano nelle estreme profondità del terreno. Da quel terreno, talvolta secco, talvolta arido, sa trarre tutta la sua linfa vitale. La forza e la potenza delle sue profonde radici danno alla quercia un senso di grande stabilità; non c’è forza di vento che possa scuoterla e piegarla; non c’è pioggia che possa percuoterla; e poi, i suoi rami sono generosi, accolgono nidi e ripari per quei piccoli animaletti che vivono smarriti nei suoi maestosi tronchi screpolati; la sua ombra diventa un riparo per tutte quelle piccole piante che temono la forza del sole e dà freschezza al terreno che la circonda. Così deve essere l’uomo: le radici della sua fede e delle sue credenze devono affondare nel terreno, alimentarsi di tutto ciò che la Terra gli offre. Impara dalla quercia a non lasciarti travolgere dalla indifferenza degli uomini, a non disperare dal senso arido delle cose, cerca in loro il senso remoto, supera il senso arido delle cose, sii saldo nei principi e nelle fondamenta, resti tetragono nonostante le avversità della vita, e, soprattutto, sii generoso con coloro che vengono a contatto con te. Impara a proiettare le tue ombre o le tue immagini intorno a sé, a dare ristoro a chi sosta sotto il suo maestoso manto.
In secondo luogo, osserva l’arte del pioppo: un albero che cresce lungo le rive dei fiumiciattoli; ha un tronco poroso, leggero, affusolato, e sa elevarsi verso in alto, fino a toccare a volte la punta del cielo; ha profilo filiforme, ironico, ma sagace. Impara a conoscere la secolare pazienza del pioppo: non teme la burrasca; sa che l’acqua scorre sotto le sue radici; che nulla ristagna; e che è quello scorrere incessante ad alimentare la sua via. Egli sa che l’acqua è il suo nemico ma anche la sua forza, ed è con questa forza che il pioppo è riuscito a convivere: la teme, ma allo stesso tempo la domina. Così devi essere, uomo: leggero, proteso verso alti ideali, paziente, e non timoroso del divenire. Lascia che il tempo scorra sotto le tue radici, non lasciare che i ricordi ristagnino nella tua memoria. Il tempo deve essere la tua forza. Perciò, impara a saper attendere la piena e la siccità, l’abbondanza e la scarsità, a vivere il pieno e il vuoto, la presenza e l’assenza. Impara tutto questo osservando attentamente e con pazienza questo antico maestro.
Infine, molto potrebbe insegnarti la straordinaria saggezza del cipresso, che da tempi immemorabili combatte in silenzio contro la forza dei venti: i suoi rami si assottigliano nella crescita e si uniscono al corpo per renderlo ancora più forte. Possiede un tronco flessibile, ma robusto; sa andare nel profondo del terreno, ma allo stesso tempo sa proiettarsi verso l’alto. Il cipresso trae il suo alimento dalla forza dei venti, poiché sa che sono essi a farlo crescere in armonia con la natura, senza la quotidiana carezza dei venti la pianta crescerebbe storta e senza direzione. Sono dunque i venti che sanno stimolare nel modo giusto questo albero, ed è dalla loro forza che il cipresso riceve quella giusta misura per crescere in proporzione. Ma il suo corpo sa lottare contro gli eccessi di questa forza, sa come evitarli senza esserne travolto.
Sii anche tu, uomo, ambivalente come il cipresso quando ricevi la forza degli stimoli, non lasciarti travolgere da questo eccesso, e impara a vivere con questa forza, impara soprattutto a capire quanto gli stimoli siano indispensabili alla tua crescita e armonia, impara a conoscere la grazia con la quale il cipresso sa affrontare la forza dei venti, e non lasciare che i tuoi tormenti crescano senza armonia. Assottigliati, dunque, quando la bufera degli stimoli scuota le tue membra, accoglie invece i suoi soffi quando arrivano leggeri sul tuo corpo. Impara a capire che soltanto un tronco robusto e flessibile come quello del cipresso può affrontare gli eccessi del vento.
E così, umano, impara a lottare contro i tuoi tre nemici, e a convertirli, come insegnano gli alberi, in forze vitali: combatti il senso arido della vita, il divenire del tempo e l’eccesso di stimoli. Perché anche se tu sai che contro il fuoco della morte non hai difese da opporre, osserva bene come le piante sanno lottare contro il senso della morte: impara, dunque, cosa vuol dire rinascere, impara infine a vivere nell’eterno. Ecco perché dico: lunga vita alla Natura e alla sua Saggezza.
Id: 2881 Data: 23/01/2022 16:30:25
*