chiudi | stampa
Raccolta di articoli di Enzo Sardellaro
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
 - Letteratura
- Letteratura
The new license plate of John Osborne
When John Osborne gained great popularity by means of his “Look Back in Anger,” he changed the license plate on his sports car, showing a good sense of humor. It read: “A.Y.M” (1). What happened to Osborne? Was he going mad perhaps? No. Osborne was completely clearly understanding, that he represented an icon of the “anger” of young people who projected themselves into the fictional creation that were the Angry (A.) Young (Y.) Men (M.), of whose world Osborne had become the guru or prophet.
As many writers of success, Osborn (born in 1929, the son of working-class parents) failed at school that he left at fifteen, before trying his hand at journalism and then becoming known as both actor and playwright . Sports car and the theatre made the fortune of Osborne, because he started the “New Wave” of English Drama thanks to his hero, Jim (or Jimmy) Porter, a university graduate of about 25, who was a bitter failure in a “cruel” and “unjust” society.
When “Look Back in Anger” was first played at the Royal Court Theatre in 1956, Osborne obtained a checkmate, simply because the Royal Theatre in Chelsea was the home of all the beatniks who “soon” recognized themselves in the frustrated disillusioned and “angry” Jim Porter. Jim Porter, alias John Osborn, has a university degree, “but” refuses to accept a job in which he will have to behave as a middle-class or upper-class man, and makes a living by selling things from a barrow in the market. Jim is extremely discontent and irritable and bad character is made still worse by Alison’s aristocratic self-control. The other characters of the play are Cliff, a friend who lives in another room in the house, and Miss Drury, their landlady who lives below them.
The house becomes a “mad-house,” and a real “zoo” where all cried.
Alison- Look out, for Heaven’s sake! Oh, it’s more like a zoo every day!
Jimmy- Darling I’m sorry.
Alison- Get out!
Jimmy- I’m sorry, believe me
Alison (to Cliff)- Where is he?
Cliff- In my room.
Alison- What’s he doing?
Cliff- Lying on the bed. Reading, I think (Look Back in Anger).
While we are waiting for the “rude” awakening of Jim, we would simply underline that “Look Back in Anger” scored a tremendous success in 1956 as it interpreted the frustration and anger of the younger generations in the 50’s. Jim Porter, the hero, became a symbol of the vague aspirations of dissatisfied young people and their protest against Establishment. One day someone asked Alberto Moravia about the British Establishment in the 50’s. “But what is the so-called British ‘establishment’? It is the Court, the abuses of the powerful, the State […] In Italy the establishment is the Italian State, the Church, and the monopoly in industry” (2).
But who were the Angry Young Men “really”? Kenneth Allsop was no soft or tender with them: “The larger result is that the new dissentients feel unassimilated […] The go-getter is no new type, either to society or fiction, but the difference in the post-war model is that, although driven by ambition, envy and greed […], he has no admiration or liking for the class he is gatecrashing. He wants its advantages and privileges, but […] he has no wish to be assimilated. […]” (3). In conclusion, according to Kenneth Allsop, the A. Y. M. were insignificant social climbers. Maybe Kenneth Allsop had been too harsh in his judgment of Osborne , but it is a fact that John Osborne drove a sports car (including a Bentley and a Cadillac) and not a mini-car in the mid 50's:
“Osborne would own a few cars in his time, including a Bentley and a Cadillac” (4).
Works Cited
1) “With the proceeds of this success Osborne bought his first car. When the license plates arrived they bore the initials A.Y.M.” ( see Alan Carter, “John Osborne”: Edinburgh, Oliver and Boyd, 1973, p. 12).
2) From an interview with Moravia in “L'Espresso,” October 20, 1963.
3) Kenneth Allsop, “The Angry Decade,” London, Peter Owen Limited, 1958, p. 27.
4) John Heilpern, “ John Osborne: A Patriot for Us,” Chatto & Windus, 2006, p. 152. With regard to this, Dan Rebellato tells us a funny story: “At the end of Osborne’s 1960 television play, A subject of the Scandal and Concern, the narrator signs off sardonically suggesting that the audience may all be waiting for the adverts. ‘That’s all. You may retire now. And if a mini-car is your particular mini-dream, then dream it’ (Presumably the sports car Osborne brought with the fists profits of Look Back in Anger was a maxi-dream)” ( See Dan Rebellato, “1956 and All That: The Making of Modern British Drama”: London, Routledge, 1999, p. 33).
Id: 1708 Data: 16/05/2016 18:56:11
*
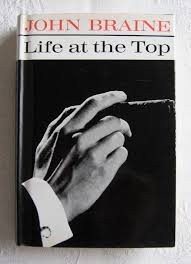 - Letteratura
- Letteratura
The melancholy trajectory of Joe Lampton
Presento in questa sede un breve articolo che avevo scritto alcuni anni fa, e che poi per varie ragioni è rimasto nel cassetto.
John Braine (1922-1986) became known to the public for his novels Room at the Top (1957) and Life at the Top (1962). In these novels he tells the story of a man who, having married a well-to-do woman in order “to get to the top,” discovers that he is not accepted by the new people around him. He tries to break away from them, but he returns home to resume his “life at the top.”
Joe Lampton, the hero of Life at the Top, has married Susan Brown, the daughter of his boss, a steel industry owner, in order to “get at the top,” trying to reach the summit of social and economic success for a man of his social extraction. The marriage, however, proves failure. Susan suffers a lack of affection going back to her previous lover [Mark]: “In the sequel Life at the Top [1962], Joe learns by experience the superficiality and aridity of life at the top and the backlash of the torrid love affair which he sacrificed in his climb still trouble him in family life.” ( Blamires, 1983: 33).
Joe’s relations with Susan’s father are strained and difficult, and they come to a crisis when he has a verbal confrontation with his father-in-law at a meeting of the Council. Having returned to his house some time after, Joe has another violent altercation with Susan who confesses that Barbara, one of their children, is Mark’s daughter. Embittered and desperate, Joe tries to escape from all these people he now hates, and he moves to London, staying in a small and a dreary flat with Nora, his new lover. The success of Joe Lampton has sprung from the thematic identification of the readers.
In fact, Joe Lampton reflects in many ways the aims, the ambitions, and even the failure of the typical Angry Young Man in the years following World War II. In his struggle to reach the “top,” Joe finds himself fighting a series of interpersonal conflicts which will bring him down to spiritual defeat: “He seemed to be totally unaware that he himself had approved the compulsory purchase order.” (Braine, 1962:188).
Works Cited
Blamires, H. (1983). A Guide to Twentieth Century Literature. London: Methuen & Co. Ltd.
Braine, J. (1962). Life at the Top. Boston: Houghton Mifflin Co.
Id: 1645 Data: 16/02/2016 20:20:47
*
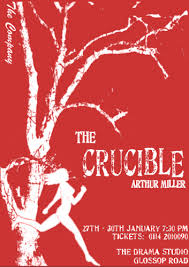 - Letteratura
- Letteratura
Nota su the Crucible, di Miller
Credo che i riferimenti contemporanei di The Crucible siano tutto sommato abbastanza trasparenti, e che Arthur Miller abbia voluto riferirsi oltre ogni dubbio al senatore McCarthy e alla sua “crociata contro i comunisti”. Tuttavia, per comprendere a fondo il messaggio di Miller, è necessario inquadrare storicamente i fatti cui egli fa riferimento.
Nell’Inghilterra del ‘600 molte donne furono accusate di stregoneria, e in genere appartenevano tutte alle classi più povere, mentre i loro accusatori, per contrario, erano di condizione sociale più elevata. A Salem, però, succede l’esatto contrario, in quanto le frizioni sociali riguardavano gli abitanti di due regioni non solo distanti, ma anche abbastanza differenti tra di esse. Gli “accusatori” vivevano nel settore occidentale del distretto di Salem, in una zona distante dal mare.
Per contrario, gli “incriminati”, e coloro che presero le loro difese, abitavano sulla costa, avevano fiorenti contatti commerciali con la città, Salem Town, ed erano sicuramente più agiati rispetto agli abitanti dell’interno. Entrambi i gruppi menzionati discendevano da coloni calvinisti, che erano immigrati in Massachusetts verso il 1630, e che avevano tentato di dar vita a una “città di santi”, ovvero a una comunità estremamente devota e fedele alle leggi di Dio. Tuttavia, con lo scorrere del tempo, gli abitanti della costa si erano notevolmente arricchiti, suscitando rancori e odio degli abitanti, quasi tutti contadini, della parte occidentale, più legati alle antiche costumanze e che accusavano i “nuovi ricchi” di essere soltanto degli egoisti arricchiti e dei falsi cristiani.
In siffatta situazione, qualunque pastore svolgesse il suo ministero a Salem era in grave difficoltà, poiché era messo in mezzo tra le due comunità ostili, e non riusciva ad accontentare nessuno; per cui, in genere, i pastori se ne andavano ben presto, non riuscendo a gestire la situazione. Le cose cambiarono però quando a Salem arrivò un nuovo pastore, Samuel Paris, che, tra l’altro, in un momento precedente della sua vita si era dato al commercio, ma senza successo, per cui egli nutriva nell’animo un fiero risentimento nei confronti dei mercanti e delle loro ricchezze. Quando egli arrivò a Salem, si schierò subito dalla parte dei contadini più legati alla tradizione, che avevano nostalgia per l’antico modo di vivere della loro comunità, e che vedevano messi in crisi tutti i valori dei Padri Fondatori, a causa dello stile di vita “satanico” dei ricchi ed egoisti mercanti della costa, colpevoli ai loro occhi di essere la causa prima della decadenza della comunità di Salem.
Nel febbraio del 1692 iniziò a Salem una vera e propria “caccia alle streghe”: circa venti persone furono giustiziate e quasi duecento condannate al carcere per stregoneria. Il punto nodale della situazione stava in questo: che quasi tutte le persone indagate e giustiziate appartenevano al gruppo dei “ricchi” che abitavano sulla costa, accusati tutti di avere stipulato un patto con il diavolo. A proposito di ciò A. Miller, parlando dei vari personaggi del suo Crucible, ebbe a scrivere che, con la caccia alle streghe, vennero “sistemati molti conti privati” ed “esplosero i sospetti e l’invidia dell’infelice nei confronti di colui che erra felice” (1). In conclusione, ciò che avvenne a Salem fu una sorta di resa dei conti tra due comunità di eguale origine ma molto diverse negli stili di vita.
Osserviamo che, nel momento in cui A. Miller scriveva The Crucible (1952-1953) negli Stati Uniti si viveva un momento molto difficile, caratterizzato da un notevole numero di processi ( spesso irregolari) contro tutti coloro che si supponeva simpatizzanti del comunismo. Osserviamo anche che, come era accaduto a Salem con la caccia alle streghe, proprio perché i funzionari incaricati di svolgere le indagini erano profondamente convinti di trovarsi in quegli anni di fronte a un complotto internazionale comunista, e che l’America fosse minacciata da una impressionante rete di spie sovietiche, arrivarono a mettere in atto metodi di indagine particolarmente lesivi delle libertà individuali. Gli indagati erano sottoposti a pressioni materiali e psicologiche molto pesanti, come quella, per esempio, dell’insistente richiesta (come nei processi alle streghe) di fare i nomi di altri comunisti: infatti, solo la denuncia chiara ed esplicita delle “spie” era il segnale di una effettiva disposizione degli imputati di collaborare con la giustizia. Il rifiuto di “fare nomi” era invece interpretato come una prova evidente di colpevolezza, e addirittura di assenza di “pentimento” degli imputati.
Miller, prendendo spunto da quella temperie storica, volle soprattutto evidenziare le prevaricazioni del potere politico che, sulla base di prove non certe, privava molti cittadini americani dei più elementari diritti umani e civili e agiva contro di essi con estremo rigore e brutalità, non lasciando così spazio a nessuna forma di “dissenso” sociale. In termini oggi molto in voga, potremmo dire che l’America di McCarthy si mostrava integralmente “fondamentalista”, piegando con le buone o con le cattive chiunque non fosse socialmente omologato a certe convinzioni politiche. Qui sta, in senso più largo, il significato più profondo e anche “attuale” del “Crogiolo”: un aperto dissenso per quei governi che, in modo intransigente, non lasciano spazi ad altre interpretazioni del mondo e della vita.
Nota
1) Per la storia delle streghe di Salem, Vedi il libro di Paul Boyer-Sthephen Nissembaum, Salem Possessed. The Social Origins of Witchcraft, Paperback edition, 1976. [ “La città indemoniata. Salem e le origini sociali di una caccia alle streghe”, Torino, Einaudi, 1986]. A. Miller, Act One, 1 Ouverture, in The Crucible, London, Penguin Twentieth Century Classics, 1968.
Id: 1644 Data: 16/02/2016 14:12:49
*
 - Letteratura
- Letteratura
“Furori americani”. Da John Ford a William Faulkner
“Furore”, di John Ford (1940), con Henri Fonda e Jane Darwell, ebbe al tempo un notevole successo di critica e di pubblico. Il film ha le sue radici nell’omonimo romanzo di John Steinbeck, e, in un affascinante bianco e nero girato con una macchina fissa, “inchioda” uno dei momenti più tribolati della storia americana, cioè a dire gli anni immediatamente successivi alla “Great Depression”. Il film ricostruisce un po’ l’epopea dell’ “American way of life”, incarnando l’indomito spirito americano di povera gente annientata dalla depressione, ma che lotta a denti stretti contro ogni avversità e ingiustizia, puntando generosamente e con tutte le proprie forze su un “domani migliore”. Tom Joad, il protagonista del film, interpretato da un grande Henri Fonda, diventerà un po’ il simbolo degli oppressi che però non rinunciano a lottare, secondo il tipico “cliché” della mentalità americana.
Ma, discorrendo intorno ai “furori americani”, non possiamo dimenticare un “furore” scaturito dalla penna di William Faulkner, "L'urlo e il furore", pubblicato nel 1929, che aveva però tinte molto più fosche di quelle emerse sia dal film di John Ford sia dal romanzo omonimo di Steinbeck. Il titolo originale del romanzo era invero "Il frastuono e il furore", e poi, per qualche ragione ignota (ma, come al solito, probabilmente per un fatto di “marketing” [neanche tanto intelligente, almeno sotto il profilo squisitamente stilistico e linguistico], "frastuono" fu sostituito con un magnifico "Urlo", che, ovviamente, doveva richiamare alla mente dei lettori il famoso “Urlo” di Munch. In realtà, "frastuono" avrebbe meglio rispettato la volontà dell'autore, che l'aveva pescato da Shakespeare (Macbeth), laddove egli diceva: " La vita è un racconto narrato da un idiota, pieno di ‘frastuono’ e di furore che non hanno significato alcuno". Se il titolo della traduzione italiana avesse mantenuto l'originario termine “frastuono”, che traduce pressoché letteralmente l’inglese “sound”, "rumore assordante", “frastuono”, appunto, avrebbe sicuramente meglio rispettato le volontà di William Faulkner, che volle trasmettere ai propri lettori l’immagine tragica di una famiglia di bianchi del vecchio Sud, totalmente “frastornata" e senza punti di riferimento etici.
Il romanzo di William Faulkner è infatti ambientato nel Sud degli Stati Uniti; protagonisti ne sono i Compson (padre, madre e tre fratelli), “segnati” senza rimedio alcuno nella psiche, e che , a poco a poco, rivelano un comportamento “degenere”. Il padre è completamente alcolizzato, e la madre una nevrotica assoluta; come tali, sono completamente incapaci di dare un benché minimo indirizzo ai figli, che sono ovviamente abbandonati a se stessi. Benjy è un idiota, mentre Quentin muore suicida, a seguito di distorti rapporti con Caddy, verso la quale nutre torbidi sentimenti che vanno molto al di là dell’affetto fraterno.
Caddy alla fine si sposa, ma è abbandonata quasi subito dal compagno, che è venuto a sapere che la bambina di Caddy non è sua, e la caccia di casa. Caddy torna in famiglia, ma, purtroppo per lei, che deve allontanarsi per lavorare, della bambina si occupa Jason, uno dei tre fratelli, che, cinico e immorale, non soltanto tratta in malo modo la bambina, ma si appropria anche dei soldi che Caddy manda a casa per la figlia. La vita della bambina (il cui nome è, stranamente, “Quentin”) scorre via tribolata, assistita soltanto dall’affetto di Dilsey, la vecchia cuoca di colore, da tempo immemorabile al servizio dei Compson. Alla fine Quentin decide di andarsene via, e infatti fugge di casa con un attore.
"The Sound and the Fury", che è un capolavoro assoluto di Faulkner, “sembrerebbe” soltanto narrare la "decadenza" morale ed intellettuale di una famiglia di “bianchi” del Sud degli Stati Uniti, ma il discorso di William Faulkner è molto più sottile, perché, attraverso la “degenerazione” dei Compson, egli quasi “profetizza” un imminente “collasso” della civiltà dei bianchi. Faulkner non disse quale nuova “stirpe” si sarebbe erta a sostituire l’antica razza dominante, ma pare di capire che essa sarebbe stata costituita, molto “alla Manzoni”, dagli “umili”. Soltanto ad essi sarebbe stato dato un futuro, mentre per i bianchi, razza ormai degenere, sembrava si potesse cantare un definitivo ed irreversibile “de profundis”.
Faulkner, con un occhio di lince , aveva intravisto, sia pure “per aenigmitate”, qualcosa di “frastornante” nella società americana di quel lontano 1929, un “qualcosa” che lo portò ad immaginare una “catastrofe di civiltà”, che soltanto i grandi poeti e i grandi scrittori sanno intravvedere, sia pure indistintamente, tra le brume della storia. Certamente la “Great Depression” dette una grossa mano ad instaurare in America un clima da “The End”, ma William Faulkner seppe guardare “al di là dello steccato” ed “oltre” gli aspetti meramente economici, dipingendo un “malessere” indistinto, e affondando il bisturi nel “nucleo vitale” della società americana: la famiglia.
Enzo Sardellaro
Id: 1283 Data: 18/01/2015 20:07:41
*
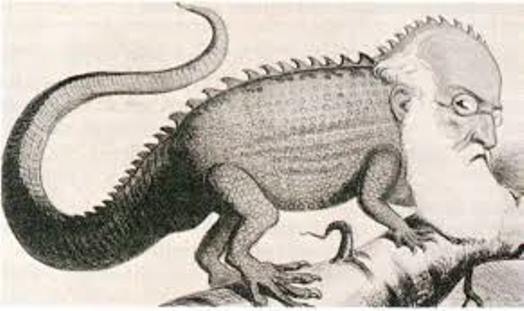 - Storia
- Storia
“L’Italia delle crisi” e gli economisti
Epicarmo Corbino (1890-1984) e l’Italia di Depretis
Che l’Italia sia praticamente in crisi un po’ da sempre non è una semplice impressione personale (forse condivisa da molti), ma un dato di fatto difficilmente confutabile. Tale impressione è viepiù rafforzata allorché si viene a leggere qualche pagina di uno dei più notevoli economisti italiani del ‘900, Epicarmo Corbino (Ministro del Tesoro nel Governo De Gasperi tra il 1945 e il 1946), il quale fu un economista con una forte propensione per la storia, nonché un profondo conoscitore di politica e anche di uomini. Rileggendo alcune sue pagine, non si può non rimanere stupiti non soltanto della sua dottrina, indiscutibile e di altissimo livello, ma anche delle sue straordinarie capacità di tracciare profili indimenticabili di cose economiche e storiche, venate oltre tutto d’una sapiente ironia che non guasta mai, anche allorché egli trattava argomenti estremamente seri dell’Italia tra gli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento. Decisamente interessanti, e per vari versi anche divertenti , furono alcune sue riflessioni sulla “qualità” che dovevano possedere i vari ministri delle finanze italiani.
“L'esperienza di questo periodo [1881-1890] della finanza italiana ci consente di affermare che quando un capo di governo ritiene necessario dare alla finanza un indirizzo energico, diretto a salvare ad ogni costo l'avanzo, il portafoglio delle finanze deve essere dato ad un uomo di scarsa immaginazione, ma di schiena molto dura. Un uomo cosiffatto dà affidamento che la finanza sarà salvaguardata dagli attacchi di coloro i quali vogliono aumentare le spese senza aumentare le entrate. Quando, invece, si voglia porre la finanza in una posizione secondaria, rispetto alle altre necessità dello Stato, allora, il tipo più adatto di ministro è quello dell'ex-funzionario, di grande talento inventivo, e capace di ricorrere a tutti gli artifici necessari per salvare le apparenze, mentre si rovina la sostanza. Ora se Depretis e Crispi avessero voluto fabbricarsi un uomo adatto alle loro esigenze politiche, non sarebbero mai riusciti ad ottenerne uno migliore di quello, che le vicende politiche portarono al posto prima tenuto dal Sella e dal Minghetti”.
Lo “straordinario” ministro delle Finanze cui accennava Corbino era “Agostino Magliani [che]resse le sorti della finanza italiana per un periodo che non aveva precedenti e non ebbe esempio dopo di lui. Dal dicembre 1877 al dicembre 1888, cioè per ben undici anni, salvo due brevi interruzioni, egli tenne il portafoglio delle Finanze e quasi sempre quello del Tesoro, restando al suo posto con tutti i ministeri, attraverso tutte le vicende parlamentari”. Non abbiamo ulteriore spazio per soffermarci ancora sull’ottimo Agostino Magliani, che però troveremo un po’ più avanti, fatto oggetto di una battuta di Bonghi. A parte le battute, Epicarmo Corbino fu anche un osservatore estremamente attento alle condizioni sociali delle masse popolari italiane, tenute, nella stessa Roma e alle soglie del nuovo secolo, il 1900, ad un livello di vita pressoché simile “a quello di qualsiasi più selvaggia tribù dell'Africa centrale e della Polinesia”. Il suo cenno ai “guitti” di Roma resta ancora oggi uno spaccato di vita difficilmente eguagliabile:
“In uno dei suoi primi discorsi alla Camera il Sonnino così descriveva le abitazioni dei guitti : ‘A 5 o 6 miglia dall'alma città, in vista ancora della cupola di S. Pietro, si trovava gente che viveva in uno stato uguale a quello di qualsiasi più selvaggia tribù dell'Africa centrale e della Polinesia. In un'angusta grotta scavata nel tufo, la quale giungeva appena ad altezza d'uomo e restava aperta la notte al vento ed alla umidità esterna, erano pigiate insieme una ventina e più di persone di sesso diverso. E poiché il Governo aveva dichiarato di volere prendere provvedimenti solo dopo avere avuto i risultati di un'inchiesta, egli soggiungeva di essere certo che, se l'on. Ministro dell'Interno avesse visitato una sola volta uno di questi abituri di guitti, ne avrebbe risentito un'impressione così dolorosa, da non aspettare più i lenti risultati di tarde inchieste per cominciare a provvedere in qualche modo, e a riparare a questo grave sconcio sociale, di cui la responsabilità pesava quasi interamente sui proprietari dei fondi, poiché era questione sopratutto (sic) di caseggiati e di locali, in latifondi posseduti da ricchissimi signori, da opere pie e fino a poco tempo prima da capitoli di chiese e monasteri. Bell'esempio di carità ecclesiastica, egli diceva nel conchiudere’”.
Negli anni ’80, sotto il governo Depretis, le condizioni dei contadini italiani, costretti a vivere in “isquallide tane”, erano, secondo Corbino, a dir poco allucinanti:
“Non era più possibile nascondere, e lo ammetteva lo stesso Depretis nel suo discorso programma dell'ottobre 1882, che nelle città e nelle campagne intere famiglie vivevano agglomerate in isquallide tane; che ogni principio di igiene era loro ignoto od impossibile: non buone acque potabili, non aria sana, nessuna applicazione, insomma, di quelle discipline destinate a far diminuire la mortalità, e a far sì che l'uomo cresca sano e robusto, secondo le leggi di natura . Il colera del 1884 richiamò l'attenzione del Governo sulle tristi condizioni sanitarie di molti Comuni del Regno. Un'inchiesta fu ordinata a questo proposito, ed i risultati di essa, consacrati in una relazione, che fu una vera rivelazione, misero in evidenza il molto, anzi il moltissimo, che si doveva ancora fare in questo campo. Deficientissimo risultò allora in molti Comuni il rifornimento di acqua potabile, ma dopo l'epidemia colerica si fece maggiore la cura del Governo e delle amministrazioni locali per migliorare, da questo lato, le condizioni igieniche del Paese […]Fognature, latrine e focolari mancavano del tutto in molti Comuni, erano scarsi in moltissimi altri, e solo in pochi si presentavano in condizioni decenti ed igieniche. La nettezza urbana era spesso affidata ai proprietari frontisti, o mancava del tutto; la pulitura dei pozzi neri era fatta per lo più con mezzi scoperti, ed è agevole pensare quanto ciò contribuisse alla diffusione delle malattie infettive. Il lavoro da compiere per mettere un po’ d'ordine in questo caos sanitario era enorme, e bisogna riconoscere a Crispi di avere intuito la gravità del problema”.
Venendo ora alla storia politica del nostro Paese all’indomani dell’Unità, Corbino tratteggiava un quadro estremamente convincente delle vicende politiche dell’Italia di quegli anni, con osservazioni che, stranamente, hanno tutto il sapore di un’incredibile “contemporaneità”:
“All'inizio del decennio era al potere Cairoli, con Depretis allo interno. Il ministero, nominato nel novembre 1879, aveva rinnovato la Camera nel maggio 1880 e viveva nella tranquillità consentita dall'opposizione del gruppo di estrema sinistra, e da quella, molto più temperata, dei residui della vecchia Destra. Dopo un ventennio di regime parlamentare, durante il quale si era consolidata l'unità nazionale, non mancavano da noi gli scontenti e correva, naturalmente, anche da noi il vezzo di schernire il Parlamento e i troppi discorsi dei deputati, e nel ripetere siffatti triviali giudizi, si rimpiangevano i tempi nei quali si andava per le spiccie e non ci si lasciava soffermare dalle chiacchiere”.
La “decadenza del Parlamento”
“Talvolta le recriminazioni sulla decadenza del parlamento venivano dagli stessi banchi della Camera, come quando il Lacava di Sinistra ne attribuiva la causa al collegio uninominale […] Si discuteva allora la proposta di riforma della legge elettorale politica, ma prima ancora che la discussione si concludesse il Ministero fu attaccato sull'andamento della politica estera per la questione di Tunisi; ed il Cairoti battuto presentò le dimissioni […] Sotto il Depretis furono, risolti parecchi problemi importanti, e fu approvato il trattato di commercio con la Francia. Intanto nel maggio-giugno 1881 era stato presentato il disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica e l'adozione dello scrutinio di lista, riforma sanzionata con la legge 7 maggio 1882, n. 725, che rendeva necessaria la rinnovazione della Camera”.
“La XIV Legislatura fu chiusa il 25 settembre 1882; le elezioni ebbero luogo nell'ottobre senza giustificare né i sinistri presagi, né le liete previsioni, che erano state manifestate come possibile effetto delle modificazioni al diritto elettorale ed al sistema di votazione. Fu in questa occasione che prese forma concreta quella fase della nostra vita politica, che è nota con il nome di ‘trasformismo’, avendo il Depretis invitato a collaborare all'attuazione del programma governativo tutti gli uomini di buona volontà”.
I Partiti, dopo il “trasformismo”:
“La discussione che si svolse alla Camera nel maggio 1883 è interessante per il fatto che, per oltre dieci giorni, le più eminenti figure del nostro mondo politico si sforzarono di vedere che cosa restasse dei vecchi partiti, e se il programma e l'azione del Governo si svolgesse secondo le direttive della Destra o della Sinistra. Fu infatti allora che dalla Destra, scesa in campo coi suoi più eloquenti e più dotti oratori, si sostenne che i partiti erano morti, che essi costituivano un mero ricordo storico, un vieto anacronismo, che Destra e Sinistra erano questioni bizantine, arcadia politica, vano suono di non intesi nomi”.
“Trasformismo” e “comicità”:
“In sostanza, diceva lo Zanardelli, si verifica questo fatto curiosissimo: tutti gli uomini di Destra, che erano contro il Depretis,, sono passati con lui; quasi tutti gli uomini della antica Sinistra, che erano con lui, se ne sono separati, ed era perciò necessario dire che gli uni e gli altri avevano tutti perduto completamente il senno, ed avevano tutti mutato, per poter dire che il solo che non mutava era il Depretis!”.
Il giudizio di Giovanni Giolitti: Depretis? “Un uomo di buon senso”
“La parola ha avuto cattiva fama, che si è ripercossa sull'uomo, che fu accusato di scetticismo e di cinismo, ma né al trasformismo mancarono profonde ragioni politiche, né il Depretis meritava quel giudizio : egli era un uomo in cui era assai sviluppata una delle principali doti dell'uomo di governo; il buonsenso . Questo giudizio del Giolitti risponde, secondo me, alla natura delle cose : ormai nelle grandi questioni, che il paese doveva affrontare, prevaleva la parte tecnica; si trattava di vedere quali soluzioni fossero le più convenienti, non secondo un programma teorico, ma secondo gli aspetti concreti, che presentavano i vari problemi. E perciò aveva ragione il Depretis quando, nel 19 maggio 1886, difendendosi dall'accusa di aver provocato la confusione dei partiti, diceva : ‘Quanto all'adesione di una gran parte degli uomini che appartennero all'antica Destra, chi non vede che la forza stessa delle cose, la risoluzione delle questioni che ci avevano divisi, il loro consenso alle opinioni, alle proposte nostre, almeno nelle parti essenziali, li condusse naturalmente a noi, come altri si separarono da noi, o in conseguenza di crisi parziali, o perché si mostrarono dissenzienti sopra concetti di capitale importanza che pure avevamo chiaramente dichiarati?”.
Depretis: la “personificazione del disagio”
“La maggioranza formatasi nel maggio 1883 si andava frantumando determinando nel paese uno stato di antipatia verso la Camera in genere, e facendo puntare gli strali dell'opposizione di Sinistra, alla Camera, e dei gruppi contrari al governo, nel paese, contro la persona del Depretis, accusato, come egli stesso ebbe a dire il 19 maggio 1886, di avere fuori umiliato la Patria, dentro, con subdole arti di governo, incoraggiata e quasi insegnata la immoralità politica. Non più che tre anni addietro egli, il Depretis, pareva ed era il solo naufrago della Sinistra storica, il solo che potesse essere con fortuna al timone dello Stato. Dopo solo tre anni su quel nome, già tanto rispettato per doti innegabili di rettitudine e di amor patrio, si raccolsero violenti e impetuosi tutti i rancori e i malumori del giorno: quell'uomo cosi ponderato nell'agire, cosi alieno dal destare invidie e gelosie, sembrò personificare ogni causa del disagio in cui viveva il paese, ogni motivo del malessere che travagliava tutti”.
Dogali, la guerra e la “fiducia” al Governo
Sotto il nuovo governo Depretis, “Tutto procedeva in relativa calma quando arrivò fulminea la notizia della tragica, ma gloriosa giornata di Dogali. Il 28 gennaio del 1887, la colonna De Cristoforis, mentre si recava da Massaua a Saati, per aiutare quel forte, attaccato dal nemico, fu assalita dagli abissini nella gola di Dogali. Erano i nostri 512 contro una diecina di migliaia di nemici, e si batterono da eroi, fino a quando sul campo non rimase un uomo vivo o in grado di combattere, e caddero tutti come se fossero allineati: di 512 uomini solo 80 sopravvissero alla strage, ma anch'essi con molte ferite. L'impressione nel paese fu enorme e, come sempre accade in questi casi, il Ministero dovette pagarne il fio. Il Governo domandò 5 milioni per i primi rinforzi da inviarsi nel Mar Rosso, e niuno o quasi fece opposizione alla domanda, anzi la legge fu poi approvata con 317 voti favorevoli e solo 12 contrari. Invece sulla questione di fiducia, il Ministero che, poco prima, il 27 gennaio, aveva raccolto senza sforzo una maggioranza uguale a quella del giugno 1886, ne ebbe una di soli 34 voti”.
Il giudizio di Corbino sull’uomo Depretis e sull’ “onnipresente” Ministro Magliani:
“Dall'epoca dell'avvento della Sinistra (18 marzo 1876), al giorno della sua morte, salvo due brevi interruzioni durante i primi due Ministeri Cairoli, Agostino Depretis fu il capo della vita politica italiana, ma di temperamento pacifico, portato per natura più a girare gli ostacoli che a superarli, egli fu più uno strumento del giuoco delle forze politiche, che una volontà coordinatrice delle forze stesse. Non desiderò mai le maggioranze strabocchevoli, ma spesso si contentò di andare avanti con maggioranze esigue, vincolando perciò l'azione del Governo alla necessità di continui compromessi. Non ebbe mai avversari poderosi, né nella vecchia Destra, che egli disarmò impadronendosi dei punti più comodi del suo programma, né nella Sinistra Storica e nel partito progressista i cui capi avevano forse la convinzione che anch'essi non avrebbero potuto fare diversamente”.
“Più che capace di influire sull'ambiente, Depretis era il tipo rappresentativo della, deformazione dell'istituto parlamentare che trovava nell'opportunismo e nell'individualismo i suoi sintomi rivelatori, e che si manifestava con l'incompostezza e il disordine dei partiti, il continuo decomporsi e ricomporsi di gruppi e di fazioni senza alcun concetto politico. Mancò spesso al Depretis l'energia di affrontare problemi seri, come quello della finanza, dove gli faceva comodo mantenere l'onorevole Magliani, nonostante che ciò gli procurasse, fin dal 1884, un dissidio con un sempre più importante gruppo di deputati. Forse egli non volle disfarsene per tema di farsene un nemico, perché, come ebbe a dirgli il Bonghi, egli era ‘un uomo fortunato a cui mancava una sola fortuna, quella di mantenersi amici gli amici, anche quando cessava di mantenerli ministri’”.
Il giudizio conclusivo di Epicarmo Corbino su Depretis, l’ultimo dei “sopravvissuti” del Risorgimento
“La sua morte fu dannosa all'Italia sopratutto per il momento delicato in cui avvenne, perché tolse alla vita politica italiana un uomo di grande buon senso ed un elemento moderatore, la cui influenza avrebbe attenuato la impulsività del Crispi ed avrebbe evitata la rottura commerciale con la Francia. La sua scomparsa riduceva ormai a poche persone i sopravvissuti dell'epoca del Risorgimento, e fra essi solo il Crispi aveva una posizione di primo piano”.
Nota
E. Corbino, “Annali dell’economia italiana”, Città di Castello, 1933, Vol. III (1881-1890), pp. 1-38.
Id: 1263 Data: 23/12/2014 20:19:52
*
 - Storia
- Storia
Dai fondi del Piano Marshall ai fondi europei
Oggi in Italia da più parti si lamenta il fatto che i fondi europei restino largamente inutilizzati. Il fenomeno è variamente interpretato, ma, da un punto di vista squisitamente storico, esso vanta un’ illustre tradizione in Italia, a partire dai fondi che furono a suo tempo erogati all’Italia dal cosiddetto “Piano Marshall”. Questo piano, che costituì il più massiccio intervento di aiuti economici degli Stati Uniti in Europa, e naturalmente in Italia, fu però largamente disatteso dai governi italiani che si succedettero nell’immediato dopoguerra. Nel suo ampio e succoso studio sull’argomento, P. Savona sottolineava che
“La Francia aveva prelevato per intero i 1.132 milioni a disposizione, il Regno Unito 739 su 742. Ancora a metà del 1950 l’Italia aveva prelevato 80 milioni su 206,5 (mentre gli altri Paesi avevano prelevato la quasi totalità dei fondi disponibili)” (1).
Le argomentazioni “scientifiche” allora addotte a spiegare il fatto furono sostanzialmente legate alla considerazione che l’uso massiccio dei fondi del piano Marshall avrebbe innescato in Italia spinte inflazionistiche difficilmente controllabili.
“Il movimento inflazionistico, infatti, si accentuò soprattutto nei quindici mesi che vanno dal giugno 1946 al settembre 1947, sotto la spinta di [alcuni] fattori principali (…) [come] il continuo e crescente ricorso alla Banca d’Italia, conseguenza dei pesanti deficit del Bilancio dello Stato” (2).
Einaudi e i “liberisti classici” misero in atto questo tipo di politica economica contando anche sul fatto che la loro “egemonia economica” era indiscussa e indiscutibile nel campo degli studi economici, per cui “la loro superiorità intellettuale […] aveva ridicolizzato qualunque tentativo di teorizzazione dell’intervento dello Stato nell’economia” (3).
Per questa ragione, quando alcuni deputati in Parlamento ( ed anche lo stesso Marshall negli Stati Uniti) s’azzardarono a criticare la politica economica perseguita dal governo, il Ministro Pella, in nome dei “sacri principii liberisti” disse a chiare lettere che era letteralmente impossibile per chi era addentro alle “segrete cose” (dell’economia) non accorgersi che i fondi del Piano Marshall celavano esiti “larvatamente inflazionistici”:
“Pella, che aveva sostituito Einaudi (eletto alla Presidenza della Repubblica), dichiarò di respingere con energia suggerimenti e soluzioni LARVATAMENTE INFLAZIONISTICI” (4).
E con ciò la questione fu definitivamente chiusa.
Venendo ora ai tempi nostri, “mutatis mutandis”, registriamo lo stesso fenomeno in relazione ai cosiddetti “fondi strutturali europei”, anche se le interpretazioni addotte su di esso sono un po’ meno “scientifiche” e dottrinali. Per quanto riguarda i fondi europei “non spesi”, la spiegazione che, a mio parere, meglio rispetta il criterio di verosimiglianza, di logicità e di “non-partigianeria” ( e persino verificabile un po’ da tutti) è quella prospettata di recente da S. Gatto, il quale osserva:
“L’amministrazione centrale italiana e quelle regionali sono state in gran parte inefficienti e svogliate nell’usare a dovere i fondi europei destinati all’Italia, spesso non spesi. Il risultato di una mancanza di visione strategica nei confronti dell’Europa che è tipica italiana. L’Italia è un paese che fatica a sviluppare progetti collettivi, sempre sopravanzati da quelli particolari e personali. Il successo in Italia è individuale non di squadra” (5).
Il che, per onore di verità, è anche la posizione dell’attuale leader Renzi, il quale, più o meno, rispetto al tema in questione, esprime le medesime considerazioni nell’intervista con Alan Friedman:
“ Il vero dramma dell’Italia, osserva Renzi, è che questi fondi europei sono stati spesi per 707.000 progetti […] Cioè si fanno progetti di piccolo cabotaggio, 100.000 euro, 150.000 euro. Questo significa che il consenso politico cresce, perché l’assessore provinciale che distribuisce, o fa bandi di concorso su quei soldi, coltiva gli orticelli. Ma il Paese salta” (6).
L’impressione è che le argomentazioni addotte siano effettivamente prive dell’aura dottrinale che sapevano creare i nostri economisti alla Einaudi intorno all’argomento, ma che esse, tuttavia, non siano del tutto prive di fondamento, anzi!
Note
1) Cfr. P. Savona, “La stabilizzazione monetaria in Italia e il piano Marshall”, in “Il Piano Marshall e l’Europa”, a cura di E. Aga Rossi, Roma, Istituto dell’ Enciclopedia Italiana, 1983, p. 187.
2) P. Savona, p. 181.
3) P. Savona, p. 186.
4) P. Savona, p. 187.
5) Cfr. S. Gatto, “Italia e Spagna: destini paralleli?”, Lo Spazio della Politica, 2012, p. 75.
6) Cfr. A. Friedman, “Ammazziamo il Gattopardo”, Rizzoli, 2014.
Id: 1257 Data: 07/12/2014 19:28:04
*
- Storia
Il “popolo schiavo” e la congiura dei Pazzi
Già discorrendo intorno a Machiavelli, s’era introdotto il tema della “crisi” d’Italia degli inizi del Cinquecento; un paese, dicevamo, parcellizzato e in completa balia delle forze straniere. Facciamo un passo indietro, e portiamoci verso la fine del Quattrocento, epoca in cui accaddero eventi che dimostrano due cose: l’estrema litigiosità degli stati italiani e la loro incombente e conseguente debolezza di fronte ai pericoli esterni, costituiti non soltanto dalle potenze europee, ma anche dai Turchi, che nel 1486 misero a ferro e fuoco Otranto, senza che nessuno si rendesse effettivamente conto della gravità del fatto. Ma non è tanto sui Turchi che soffermeremo la nostra attenzione, quanto su alcuni eventi interni, che provocarono il progressivo indebolimento di alcuni importanti stati italiani, come la Toscana, per esempio, che fu teatro della celeberrima “Congiura dei Pazzi”.
Nella congiura dei Pazzi, consumata in Santa Croce a Firenze, nel corso di una messa, perse la vita Giuliano dei Medici, malato e incapace di offrire un’adeguata resistenza, mentre Lorenzo riuscì a cavarsela, scatenando poi contro i Pazzi e i loro alleati una delle vendette più selvagge che la storia italiana ricordi (degna delle furie di Cesare Borgia). Alcuni storici, come A. Fabronio, ci hanno lasciato testimonianza dell’efferatezza dei supplizi inflitti da Lorenzo dei Medici ai suoi malcapitati avversari: alcuni “furono tagliati a pezzi”, un altro fu squartato, e la sua testa mozzata fu trascinata per tutta la città (“per tutto Firenze”); e infine i loro corpi furono “sotterrati nel carnajo di San Pietro Scheraggio” (1). Al di là degli eventi cruenti che interessarono direttamente la congiura, di cui abbiamo ampia testimonianza anche da parte di illustri contemporanei (2), sarà piuttosto interessante comprendere sia i riflessi politici che la congiura dei Pazzi ebbe sull’Italia sia le ragioni di fondo che portarono la famiglia dei Pazzi a ordire quella fatale congiura.
I Pazzi, in fondo, furono soltanto l’ultimo anello della catena. A monte c’erano le tensioni espansionistiche sia del re di Napoli, Ferdinando, sia di Papa Sisto IV, i quali vedevano nel forte stato mediceo un ostacolo da abbattere a tutti i costi, in vista di un possibile allargamento dei loro rispettivi domini, che guardavano verso il centro Italia (Romagna). La Famiglia dei Pazzi s’inserisce in questo quadro perché, a Firenze, essi erano gli esponenti di spicco del ricco ceto borghese, aperto agli scambi commerciali con tutti gli stati italiani, fortemente legati per tradizione alle antiche “libertà comunali”, mentre i Medici erano essenzialmente banchieri, interessati oltremodo alle transazioni finanziarie e, per così dire, “protettori” del popolo, a cui elargivano feste e sussidi, ma che in realtà erano espressione di un’oligarchia ristretta, poco disponibile a spartire il potere con chicchessia.
Fu il popolo il vero “difensore” di Lorenzo dei Medici e del suo potere pressoché assoluto su Firenze, e i Pazzi non trovarono in città un solo sostenitore. Machiavelli, dall’alto della sua disincantata e lungimirante visione della “realtà effettuale”, scrisse con spietata ironia: “Messer Jacopo ancor che vecchio […] salì a cavallo e se ne andò alla piazza del Palagio chiamando in suo aiuto il popolo e la libertà. Ma perché [=poiché] l’uno (popolo) era della fortuna e liberalità de’ Medici fatto sordo e l’altra (libertà) in Firenze non era cognosciuta, non gli fu risposto da alcuno”[ “Messer Jacopo , nonostante l’età avanzata, salì a cavallo e si diresse verso il Palazzo, chiamando in suo aiuto il popolo. Ma poiché l’uno (il popolo) era sordo a tutti i richiami per via della liberalità dei Medici e l’altra (la libertà) era del tutto sconosciuta a Firenze, nessuno gli rispose”] (3).
Così, con la congiura dei Pazzi e la vittoria dei Medici furono perdute “due libertà”: quella del popolo di Firenze, che fu, dopo quel tragico evento, in completa balia dei Medici e di Lorenzo ( che diventa “quasi signore della città […][mentre] el popolo e lo universale ne rimane schiavo” (Guicciardini)]; e quella d’Italia, perché gli stati più potenti della penisola si dissanguarono in lotte fratricide, aprendo così la strada alle conquiste straniere. E così, concluse Guicciardini, “E questo è il fine delle divisione e discordie civili: lo sterminio di una parte; il capo dell'altra diventa signore della città; e i fautori e i suoi aderenti , di compagni quasi sudditi; il popolo e lo universale ne rimane schiavo” (4).
Note
1) A. Fabronio, “Laurentii Medicis magnifici vita”, Pisa, 1784, Vol. I, pp. 108-109, nota 79.
2) Un testimone d’eccezione della congiura dei Pazzi fu il grande scrittore e letterato A. Poliziano, autore della “Coniurationis Commentarium. Commentario della congiura dei Pazzi”, a c. di L. Perini, Firenze University Press, 2012.
3) Il passo di Machiavelli è riportato da L. Perini, p. 61. Comunque il passo è leggibile nelle “Istorie Fiorentine”. La citazione è tratta da “Opere di Niccolò Machiavelli: ‘Istorie fiorentine’ e altre opere … ”, a cura di A. Montevecchi, Torino, 1986, p. 708).
4) F. Guicciardini, “Storie Fiorentine”, Bari, Laterza, 1958, p. 38.
Id: 1250 Data: 29/11/2014 16:01:52
*
- Letteratura
Ignazio Silone: Nostro Contemporaneo
Ci sono autori, nella storia della nostra letteratura, ai quali si può a giusta ragione assegnare l’etichetta di veri e propri “profeti” del nostro tempo. Uno di questi è sicuramente Ignazio Silone, noto al grande pubblico come autore di un romanzo famoso, “Fontamara”. Tuttavia, non è su “Fontamara” che appunteremo la nostra attenzione, bensì su un testo forse poco noto al pubblico, “La scuola dei dittatori”, del 1938.
“ La scuola dei dittatori “ ci presenta un personaggio estremamente interessante, che porta un nome che è tutto un programma: Tommaso il Cinico. Tommaso il cinico si offre ai lettori come un vero e proprio “conoscitore” degli anfratti più oscuri della tirannia. Egli interagisce con due personaggi altrettanto curiosi e degni di attenzione, due americani, Mister Doppio Vu, il cui obiettivo principe è di diventare un acclamato “dittatore” e il professor Pickup, che mostra un’evidente disistima per la democrazia, asserendo addirittura che essa è un puro “nonsense” anche negli Stati Uniti.
E così, discorrendo intorno alla democrazia, il disincantato Tommaso detto il cinico spiega ai suoi interlocutori quali sono le radici profonde del “fallimento” delle democrazie occidentali: “ “La causa prima e vera della decadenza dell'odierna vita politica è ch'essa è gremita di dilettanti presuntuosi. Ognuno che fallisce in altra professione, crede di poter riuscire nella politica” (1). Se teniamo conto del fatto che Silone vergava queste righe nell’ormai lontano 1938, possiamo ben dire che l’etichetta di “profeta” dell’Italia contemporanea gli si attaglia alla perfezione. Ma non è finita qui. In un passo successivo, l’incredibile, e, per vari versi, degno d’ammirazione Tommaso il cinico aggiunge: “Una classe dirigente in declino vive di mezze misure, giorno per giorno, e rinvia sempre all'indomani l'esame delle questioni scottanti. Costretta a prendere decisioni, essa nomina commissioni e sottocommissioni, le quali terminano i loro lavori quando la situazione è già cambiata. Arrivare in ritardo significa […] anche illudersi di evitare le responsabilità, lavarsene le mani, per mostrarle bianche e pure agli storici futuri ” (2).
Poi Tommaso il cinico (alter ego di Silone) (3), ci informa, dall’alto della sua impassibile indifferenza, circa le “tecniche” usate dai dittatori per risultare “convincenti” presso le masse, stanche delle “lungaggini” delle democrazie: “Contro i mali d'ogni genere le dittature conoscono un'antica panacea (4): il sacrificio tempestivo di appropriati capri espiatori. E’ un metodo sbrigativo, immune degli inconvenienti del metodo democratico, con le sue campagne scandalistiche, le interminabili discussioni parlamentari, le commissioni d'inchieste inconcludenti e i processi che durano decenni” .
Mi pare che il messaggio di Tommaso il cinico sia chiaro: allorché ci si mostra stanchi degli eccessivi indugi e dell’incapacità decisionale della democrazia, la porta verso la dittatura è non soltanto aperta, ma addirittura spalancata. Il bello è che Tommaso il cinico ci addita anche i reali “responsabili” della “decadenza” della democrazia: una classe dirigente spesso ottusa, degenere e inconcludente.
Ignazio Silone, nostro contemporaneo.
Note
1) I. Silone, “La scuola dei dittatori”, a cura di B. Falcetto, “I Meridiani”, Milano, Mondadori, 1998, Vol. 1, p. 1031.
2) Ivi, p. 1056 sgg.
3) Silone stesso si definì un cinico: “Ero un cinico, però non egoista e nemmeno un altruista. Non mi importava nulla né degli altri né di me stesso” (Cfr. G. P. di Nicola-A. Danese, “Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta”, Torino, Effatà Editrice, 2011, p. 105).
4) Il vetusto ma sempre valido “Dizionario delle scienze naturali” [Firenze, 1846, Vol. XVII, p. 68] ci ragguaglia sul fatto che “la voce ‘panacea’ era per gli antichi chimici sinonimo di ‘rimedio universale’”.
Id: 1249 Data: 28/11/2014 10:23:25
*
- Natura
Diseconomie industriali
Premessa
Oggi il problema della salvaguardia dell’ambiente costituisce uno dei fattori discriminanti tra “civiltà” e “barbarie”. I recenti accordi tra gli Stati Uniti e la Cina per porre un limite all’inquinamento industriale, ci offre lo spunto per approfondire un tema di estrema urgenza e attualità, che forse è bene vedere anche in una prospettiva storica per meglio comprenderne le implicazioni non solo ambientali e sociali, ma anche economiche. Di qui è nato questo breve articolo, che porta un titolo per vari versi forse poco familiare ai lettori: “Diseconomie industriali”. In nota riporto una breve bibliografia di riferimento per chi volesse approfondire l’argomento.
Il fabbisogno di materie prime
Poiché le materie prime sono distribuite casualmente sulla crosta terrestre ed esse devono essere redistribuite secondo i bisogni della società, la domanda industriale di materie prime comporta un aumento del commercio internazionale: “Sul piano ambientale il problema di fondo riguarda le relazioni fra sviluppo del commercio e protezione dell'ambiente” ( Maiocchi, 2010, p. 77). Un effetto conseguente dello spostamento di materie prime verso i luoghi di trasformazione industriale è anche lo spostamento di altri fattori della produzione, come la migrazione della manodopera e gli investimenti di capitali in vari paesi. Lo stesso colonialismo del XIX e del XX secolo nacque non solo per la collocazione dei prodotti finiti delle potenze industriali, ma anche per il fabbisogno di materie prime.
La brusca inversione delle tendenze demografiche
Dopo la penuria di risorse, il secondo male maggiore della crescita economica è l’inquinamento industriale, che tende a privare l’umanità del suo ambiente naturale e, in prospettiva, ad elevare il tasso di mortalità, producendo addirittura una brusca inversione delle tendenze demografiche: “L'aumento dell'incidenza e della mortalità per tumori dell'apparato polmonare viene posto in relazione con l'abitudine al fumo di sigaretta e con l'inquinamento atmosferico, originato dal riscaldamento domestico, dall'attività industriale” ( Lanza, 1982, p. 14).
Le tecnologie ecologiche
Gli stessi materiali modificati nella loro struttura dal processo produttivo, oltre a produrre una evidente degradazione ambientale, si reinseriscono con estrema difficoltà nel riciclo naturale. Infatti, al giorno d’oggi il disinquinamento assume il vero e proprio ruolo macro-economico di fattore della produzione. Oggi l’ economizzazione del problema inquinamento ha determinato un’importante serie di innovazioni, come le cosiddette tecnologie ecologiche, vari prodotti meno inquinanti e l’affinamento delle tecniche di valutazione dell’impatto ambientale: “Innanzitutto cerchiamo di comprendere il significato del termine: quando si parla di "Green IT" si fa riferimento a un nuovo filone di studio e di realizzazione di tecnologie ecologiche o verdi rivolte al rispetto dell'ambiente […] Non sono le automobili, le industrie, gli aerei, le discariche varie a rendere sempre più improbabile il futuro dell’uomo su questa terra?” ( Teti, 2009, p. 7).
Catastrofi ecologiche e “vulnerabilità” del nostro ambiente,
Fra i problemi indotti dalle Rivoluzioni industriali ricordo infine quelli che, a causa della loro nocività, provocano un’ evidente diminuzione della qualità della vita. Questo è un fattore che, a differenza delle ricchezze, non può essere monetizzabile e misurabile per mezzo del cosiddetto valore aggiunto, che è un parametro indicatore del livello di ricchezza di uno Stato. A differenza dei beni economici, i beni che riguardano il benessere dell’umanità, come l’acqua pulita, l’aria pura e il godimento delle bellezze naturali, sono beni liberi e gratuiti. Di qui deriva la necessità di mettere in discussione ogni giorno le cosiddette diseconomie industriali, che alimentano sempre più le preoccupazioni del cittadino intorno al timore di catastrofi ecologiche e alle vulnerabilità del nostro ambiente, sempre più sottoposto a fattori distruttivi di origine umana più che naturale: “Il proliferare di zone industriali in tutto il Paese non può non incidere sulle caratteristiche del trasporto di merci [...] In realtà concorre ad intensificare i trasporti su strada aggravando il traffico della rete e creando diseconomie a carico della collettività” ( Pasquini, 1974, p. 124).
Note
Lanza, G.G. (1982). Attualità in oncologia. Padova: Piccin.
Maiocchi, A. (2010). Altiero Spinelli e il modello economico-sociale di sviluppo. Altiero Spinelli: il pensiero e l’azione per la federazione europea, a cura di U. Morelli. Milano: Giuffré.
Pasquini, M. [a cura di]. (1974). Ambiente e informatica: problemi nuovi della società contemporanea. Roma: Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari.
Teti, A. (2009). Il futuro dell'Information & Communication Technology: Tecnologie, timori e scenari futuri della “Global Network Revolution”. Milano: Springer-Verlag.
Id: 1241 Data: 15/11/2014 18:36:01
*
- Politica
Tra storia e polemica: il Senato della Repubblica
Polemiche e critiche sull’elezione del Senato della Repubblica
Da tutte le forze politiche ormai si sbandiera ad ogni piè sospinto che il “bicameralismo perfetto” va superato al più presto per “sveltire” le operazioni di governo. Senza entrare nel dibattito odierno, fin troppo caldo, mi sono preso una prospettiva storica non particolarmente lunga (circa una decina d’anni), ma nemmeno tanto breve, al fine di vedere quali erano le vedute di cambiamento del Senato della Repubblica alcuni anni or sono, e cioè quando si era un po’ “fuori” dal focus delle polemiche e delle discussioni odierne.
Al fine di “storicizzare” la questione, mi sono rifatto a due fonti soltanto, anche, e soprattutto, per semplificare il più possibile un tema che, di fatto, è estremamente complesso. La prima fonte è costituita da due resoconti stenografici degli interventi del Senatore D’Onofrio (del 2004), e l’altra da un intervento di Beniamino Carovita, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso Università di Roma “La Sapienza”, su “Il Quaderno di Astrid” (del 2007).
In realtà, il dibattito odierno sulle modalità di elezione del Senato della Repubblica non è una questione di lana caprina, ma rappresenta lo scontro di posizioni diverse tra quanti tenderebbero a vedere, nelle modalità di elezione dei senatori ( “indiretta” o “diretta”), da un lato il “depotenziamento” della funzione del Senato rispetto alla Camera dei Deputati, e dall’altro chi invece vorrebbe che il Senato conservasse pari forza e “dignità” rispetto alla Camera. Tengo a precisare che questa impostazione è una “semplificazione” del problema, e che tende a vedere essenzialmente gli aspetti, diciamo così, “più nobili” della questione, dando pressoché per scontato che pure probabilmente esistono anche motivazioni “meno” nobili, sulle quali si sorvola in questa sede.
Dalla lettura delle “fonti” sembrerebbe abbastanza evidente il fatto che un Senato che non fosse eletto “direttamente” dal popolo risulterebbe tutto sommato un’istituzione abbastanza “scolorita” rispetto alla Camera dei Deputati, che invece può contare sulla piena “legittimazione” del voto popolare. Ciò detto, veniamo ora agli interventi del Senatore D’Onofrio:
“Nell’illustrare l'emendamento 3.2000 desidero, signor Presidente, ripercorrere per qualche minuto una vicenda molto importante che riguarda come si intende, da parte del Senato, proporre, nella riforma costituzionale, la composizione e le funzioni del Senato federale.
Da questo punto di vista, sebbene l'emendamento affronti un problema fondamentale come quello delle modalità di voto e quindi della contestualità con i Consigli regionali, è importante aver presente che l’Aula ha già votato, ovviamente in modo consapevole dal momento che è stata richiamata più volte l’attenzione su questo punto, l’articolo 2 - se non sbaglio - del testo di riforma costituzionale, nel quale si afferma che il Senato è un "Senato federale". Ossia, la scelta per il modello federale del Senato è già stata compiuta da quest’Aula mentre, credo opportunamente, essa non ha ritenuto di definire federale l’ordinamento della Repubblica, perché in un ordinamento che compiutamente federale non è, è federale il Senato.
Si tratta quindi di un passaggio al modello federale del nostro Stato che riguarda quella delle due Camere che non è chiamata a concorrere alla funzione di Governo sulla base di una legge elettorale. Quest’ultima, come viene scritto nel testo costituzionale proposto dal Governo, deve favorire la formazione di una maggioranza in una delle due Camere - chiamiamola la Camera di Governo - mentre l’altra Camera è definita Senato federale.
Nel corso dell'importante dibattito svoltosi in Commissione si è pervenuti progressivamente alla convinzione che il Senato dovesse essere federale per composizione più che per funzioni. Non che le funzioni siano irrilevanti, ma la composizione finiva per diventare la caratteristica fondamentale del Senato più delle funzioni stesse.
Vi era una continuità di fondo tra ispirazione della proposta del Governo e il lavoro in Commissione: comunque, i senatori dovevano essere eletti direttamente dal corpo elettorale. Richiamo questo concetto perché ha rappresentato e rappresenta un punto di snodo dell'ultimo emendamento presentato da me, che concerne una delle possibili modalità di elezione del Senato, ma non modifica quello che è stato considerato da sempre nella proposta del Governo un elemento di discrimine, l'elezione diretta dei senatori” (1).
In un successivo intervento, del marzo 2004, D’Onofrio asseriva:
“Alcuni colleghi affermano che si va verso un Senato debole. Occorre capire se la scelta di un nuovo soggetto istituzionale interamente eletto dal corpo elettorale delle rispettive Regioni è o meno una scelta che di per sé lo rende forte o no: se la forza, in altri termini, può essere data da elementi diversi dalla elezione dei senatori. A me è sembrato che così non fosse. Da questo punto di vista, il voto sull’articolo 3 espresso ieri ha rappresentato, a mio giudizio, un complicato e faticoso tentativo di dar vita ad un organismo rappresentativo ad elezione popolare diretta che, in quanto tale, mi sembra sia una delle ipotesi che si sono discusse e si stanno discutendo anche nel Paese.
Altre ipotesi sono state discusse nel Paese e non sono state finora accolte; dubito si trattasse di ipotesi di per sé più forti dal punto di vista della composizione -ora verrò alle funzioni - perché mi è sembrato (ma posso sbagliare) di ritenere l’elezione diretta dei senatori un elemento di forza e l’ipotesi di una composizione del Senato in cui fossero presenti soggetti non eletti direttamente un fatto di debolezza. Tutti hanno detto che così non è e non ho nulla da obiettare. Però, vorrei fosse chiaro che di questo si è trattato. Abbiamo costruito un Senato composto di senatori eletti dal corpo elettorale, non abbiamo dato vita ad un Senato di persone elette per fare un altro mestiere: consiglieri comunali, sindaci, Presidenti di Provincia, persone ovviamente degnissime, ma che hanno forza in un contesto come quello regionale o locale, almeno fino ad ora”(2).
I rilievi in materia di Beniamino Carovita:
“Infine, il superamento del bicameralismo paritario e perfetto è sempre di più all’ordine del giorno. In realtà, la modifica del ruolo del Senato è ormai più un problema di forma di governo che di forma di stato, giacché in Italia, come in altri Paesi regional-federali, le entità sub-statali possono trovare altre – e più efficienti – forme di rappresentanza al centro: comunque, il superamento del bicameralismo perfetto verso una Camera di rappresentanza territoriale, sganciata dal circuito della fiducia politica può essere auspicabile e costituire la chiave per risolvere alcuni problemi di funzionamento del sistema istituzionale, sempre che il Senato delle Regioni e delle autonomie, nella difficoltà di individuare un ruolo preciso, non diventi una sorta di doppione, a base territoriale, del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”
“Ho già detto che il bicameralismo paritario e perfetto, in una forma di governo parlamentare, è poco o per niente compatibile con formule elettorali di tipo bipolare e che dunque il meccanismo di rappresentanza andrebbe cambiato, andando verso un Senato di rappresentanza dei territori, ovvero verso la soppressione di una delle due Camere.
Se ciò, per le ragioni sopra ricordate, non fosse politicamente possibile, occorrerebbe allora intervenire su una delle due Camere (presumibilmente, il Senato) depotenziando la carica maggioritaria e comunque distorsiva della formula elettorale , in modo da rendere possibile (o comunque più facile) “adeguare” la maggioranza uscita in Senato a quella uscita alla Camera, eletta invece con una legge più “dis-rappresentativa”. Si potrebbe così pensare per il Senato ad una legge elettorale simile a quella del Senato 1948-1993, che – sul modello tedesco - coniughi collegi uninominali (per rappresentare i territori, secondo la richiesta costituzionale) e risultato proporzionale (per “adeguare” la maggioranza del Senato a quella della Camera)”.
A questo punto, visto che “la soppressione” del Senato non è più un’opzione perseguibile, bisognerà vedere in che modo il Senato sarà “depotenziato”. Certo è che i sostenitori dell’elezione diretta del Senato puntano a un “depotenziamento” molto “soft”, mentre gli altri cercano in tutti i modi di “adeguarlo” alle esigenze di governo. Tra l’altro, e per dovere di imparzialità, ci sono costituzionalisti che, nel complesso, non vedono una “crisi di legittimazione” nel fatto che non ci sia un diretto “coinvolgimento del corpo elettorale” nell’elezione dei senatori : “Non sembrano emergere preclusioni di sorta a considerare l’elezione indiretta del Senato una delle possibili forme della sovranità che la Costituzione ben potrebbe contemplare alla luce delle virtualità che la riforma del Titolo V ha impresso al principio di sovranità” (3).
Aspettiamo gli eventi.
Nota
1) Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 543 del 19/02/2004. D’Onofrio Relatore.
2) Senato della Repubblica, XIV Legislatura. 554° Seduta pubblica. Resoconto stenografico. Mercoledì, 3 marzo 2004. D’Onofrio Relatore.
3) L. Castelli, Il senato delle autonomie: ragioni, modelli, vicende, 2010, p.67.
Id: 1152 Data: 22/07/2014 18:52:40
*
 - Turismo
- Turismo
Italian Beautiful Places : The Lake of Como
Foreign travellers who arrive at the shores of Lake Como can admire one of the most beautiful places of Italy. Como is a long lake which runs deeply into the hills, and the roads leading to the Lake Como are rich in vineyards, while at every turn of the way travellers find views of enchanting beauty. The Lake of Como in Roman times was called “Larian Lake,” and its northern part is called the “Lago di Chiavenna,” from the small town of that name. Como is a flourishing industrial town and lies at south west end of the Lake of Como, enclosed by an amphitheater of mountains.
In Roman times Como was called “Comum” which was the birthplace of Pliny the Elder (23-79 AD) and his nephew, Pliny the Younger (61-113 AD). At Como stands the magnificent Cathedral, entirely of marble, with the nave of Gothic style (14th century). Another important church of Como is San Fedele, with a very beauty and fine octagonal apse, while the Palazzo Giovio, of the Renaissance style, contains the local Civic Museum. Como maintains almost intact its old medieval walls, and on the south west side you can appreciate some well-preserved towers, such as the so-called Porta Vittoria which stands with its very massive structure.
The shores of Lake Como are scattered of many villas, while little boats lie at every landing place. Among the villas of Lake Como, you may visit the villa of Pliny the Younger, called “Villa Pliniana.” It takes its name from the well-known Roman writer and philosopher, nephew of Pliny the Elder, who escaped the tumultuous life of Rome under the Late Empire by giving himself up to the quiet pleasures of this country. This villa is famous for its spring, but a few miles away you can find another well-known spring called “Fiume di Latte” ( the River of Milk), so called from the milky colour of waters. You may make an easy excursion to Fiume di Latte starting from Varenna, a small town located under a wooden hill crowned by the ruins of an old castle with a tower, celebrated as the residence of Theodolinda, daughter of Garibold King of the Bavarians.
On the west bank of the lake, near Cernobbio you find the Villa Olmo, built by Innocenzo Odescalchi with a very elegant rooms and a delightful garden, where visitors are admitted. Bellagio is another little town worth visiting, located on a spectacular promontory that offers a picturesque view of marvelous beauty, embracing a vast stretch of Lake Como, and where you may visit the superb Villa Melzi. The shores of Lake Como offer their clients a great variety of Grand Hotels or low rents with a wide range of services and structures …
Id: 1128 Data: 05/07/2014 13:57:52
*
- Turismo
In giro per l’Italia. L’architettura Romana [Around Italy]
Around Italy. The Roman Architecture.
La cultura occidentale passò attraverso l’Italia. L’architettura romana
L'Italia è un punto focale per il turismo internazionale, e presenta una miriade di monumenti antichi, specialmente d’età romana. Per questa ragione, ho approntato questa mini-guida ( in italiano ed in inglese), che forse potrà contribuire a una migliore conoscenza delle nostre antichità. Uno degli aspetti più importanti dell’architettura romana è data dall’arco, una forma architettonica di cui i Romani fecero largo uso nei monumenti e in altre strutture.
Around Italy. The Roman Architecture
Western Culture Passed Through Italy. The Roman Architecture
Italy is a focal point for international tourism, and it presents a remarkable series of ancient monuments, and, especially, of Roman origin. I have therefore thought to get ready this MINI-GUIDE (in Italian and English) that perhaps will contribute to a better understanding of our ancient history. One of the most important aspects of the Roman architecture is given from the arch, an architectural form that the Romans largely used in monuments and other structures.
Dagli esempi di arco etrusco agli archi di trionfo a Roma e in Italia
La parte fondamentale dell’architettura romana, a Roma e in Italia, fu l’Arco, che fu usato dai Romani a partire dall’età augustea. L’arco fu usato dapprima dagli Etruschi (esempi di archi etruschi si possono vedere a Perugia [Umbria] e a Volterra [Toscana]). In seguito la sua tecnica costruttiva fu adottata dai Romani. L’arco costituì il motivo fondamentale dell’architettura Romana. In seguito, con la scoperta del cemento, i Romani adottarono lo schema della volta negli edifici pubblici e privati.
The Arch from Etruscan Examples to the Triumphal Arches in Rome and in Italy
The fundamental principle of the Roman architecture in Rome and in Italy was based upon the arch, which was used by the Romans in the Age of Augustus. The arch was used first by the Etruscans (you can see some examples of Etruscan arch in Perugia [Umbria] and Volterra [Tuscany]). Early success of this technique led to its widespread adoption by the Romans, and the arch emerged as a fundamental element of Roman architecture. Then, with the improvement of concrete, the Romans adopted the scheme of vaulting in public and private buildings.
Dalla Val D’Aosta a Roma
Il più semplice esempio di arco romano è costituito dall’ Arco di Augusto, che i visitatori possono vedere ad Aosta (Val d’Aosta), che ha una fornice soltanto. L’ arco di Augusto a Susa (provincia di Torino, Piemonte) è molto più ricco ed elegante nella sua possente mole. Un altro esempio di arco romano si può ammirare a Roma. L’ Arco di Tito si innalza lungo l’antica Via Sacra, ed è costituito da colonne di stili differenti. Sulle pareti del fornice si possono ammirare due rilievi, che esaltano le imprese dell’imperatore Tito. Anche l’ Arco di Traiano (a Benevento, Campania) è finemente decorato e degno di una visita. Tuttavia, l’esempio migliore e più articolato di arco romano è quello dell’Arco dell’imperatore Settimio Severo, nel Foro Romano, con tre fornici. Infine, vicino al Colosseo e a fianco della Via Sacra, troverete anche l’ Arco di Costantino, famoso nel mondo per la sua grandiosità e la decorazione.
From the Aosta Valley to Rome
The most simple use of the arch can be seen in the Arch of Augustus, in Aosta (Aosta Valley), with only one arch. The Arch of Augustus at Susa (province of Turin, Piedmont) is more rich, elegant and remarkable for its enormous size. There are many examples of these arch structures in Rome, such as the Arch of Titus (along the ancient Via Sacra) supported by columns of different styles. In the middle of the walls there are some small side-reliefs showing the triumphs of the emperor Titus. The Arch of Trajan (Benevento, Campania) is finely decorated and worthy of a visit. However, the best example might be the Arch of the Emperor Septimius Severus, in the Roman Forum , with three arches. Finally, near the Colosseum and the Via Sacra, you will also find the Arch of Constantine, world famous for its grandiose structure and decorative designs.
Architettura Romana: Roma
Lo sviluppo del sistema delle volte
Come abbiamo visto, il sistema delle volte iniziò con la scoperta dell'arco. I monumenti più rappresentativi dell'architettura romana a Roma sono costituiti di tre tipi di base: la volta a botte, la volta a cupola e la volta a crociera.
The Roman architecture. The development of the vault system
Rome
As we have seen, the vault system began with the discovery of the arch. The most representative monuments of the Roman architecture at ROME were composed of three basic types: the Barrel Vault, Dome Vault and Cross Vault.
Secondo la tradizione …
La Cloaca Massima risale ai tempi più antichi della storia di Roma, e , secondo la tradizione, sarebbe stata costruita al tempo di Tarquinio Prisco (VII secolo). L’antico Carcere Tullianum (VII secolo), ai piedi del Campidoglio, ha una struttura a cupola, e forse anticamente fu un serbatoio per la raccolta dell’acqua, poi trasformato in carcere. Esso fu chiamato anche Carcere Mamertino, dove, secondo la tradizione, furono incarcerati Vercingetorige, il re dei Galli, San Paolo e San Pietro.
According to Tradition …
The Cloaca Maxima (a long barrel-vaulted tunnel) dates from the most ancient times in Roman history, and, according to tradition, it was built in the time of the Etruscan King Tarquinius Priscus (7th century). The old Tullianum prison ( 7th century BC), at the foot of the Capitol and near the Arch of Septimus Severus, has a domed structure, and perhaps it was available for water harvesting at its beginning, then transformed into prison. It was also called Mamertine Prison, where, according to tradition, Vercingetorix, the king of the Gauls, Saint Paul and St. Peter were imprisoned.
Il Pantheon
Il cosiddetto sistema della Volta a Bacino è visibile nel Pantheon, edificato da Agrippa nel 27 a. C. Il Pantheon è un tempio rotondo con la cupola emisferica, in cui il diametro e l’altezza da terra (34 metri) sono perfettamente uguali. La cupola è appoggiata sul muro perimetrale, che ha pertanto uno spessore di circa 7 metri. La cupola è a cassettoni, e anticamente era rivestita di bronzo. Il Pantheon è preceduto da un atrio octastilo, diviso in tre navate, mentre le colonne sono di stile Corinzio. La volta a crociera fu invece usata per la costruzione del Tempio detto di Minerva Medica (vicino alla Stazione Termini, Roma).
The Pantheon
The so-called Dome system is visible in the Pantheon, built by Agrippa in 27 BC. The Pantheon is a round temple with a hemispherical Dome, where the diameter and the height from the floor (34 meters) are perfectly equal. The dome is supported on the perimeter wall, which has a thickness of about 7 meters. The dome has a coffered ceiling, and was once covered with bronze. The Pantheon is an octastyle and is preceded by an atrium, divided into three naves, while the columns are of the Corinthian style. Instead, the Cross Vault was used for the construction of the temple known as Minerva Medica (near the Stazione Termini, Rome).
Enzo Sardellaro
Id: 1124 Data: 03/07/2014 11:51:01
*
- Storia
La notte dell’11 novembre 1940. L’ attacco aereo su Taranto
Premessa
La storia militare è un genere poco frequentato e quasi di nicchia nell’ambito della storiografia. Il che è perfettamente comprensibile, in quanto il settore specialistico è fortemente connotato e, per così dire, “riservato” ad un ambito che prevede una specializzazione altissima e pressoché scontata. Tuttavia, l’attacco su Taranto ebbe riflessi non soltanto strettamente militari, ma anche politici, con il coinvolgimento dei massimi vertici sia italiani (Mussolini) sia tedeschi (Hitler). Per queste ragioni, basandomi essenzialmente sull’ottimo studio di F. Mattesini (1), ho in qualche modo sintetizzato in questo articolo gli aspetti salienti di quel lontano raid inglese condotto con successo contro la nostra flotta del Mediterraneo , che, per la portata degli eventi successivi, può forse ancora suscitare l’interesse dei lettori appassionati di storia militare .
L'attacco aereo su Taranto e le sue conseguenze sul settore militare del Mar Mediterraneo.
La notte dell'11 novembre 1940 l'attacco aereo inglese su Taranto si sviluppò in condizioni metereologiche molto favorevoli per l'identificazione dei bersagli. Secondo i rapporti italiani, c'era “bel tempo, cielo sereno, brezze da nord-est, la luna crescente alle ore 15.45 ed una visibilità eccellente”. Il raid degli Swordfish inglesi fu preceduto da tre allarmi, perché le vedette avevano segnalato la presenza di un aereo, ritenuto un velivolo da ricognizione, che volò prima su Taranto, dirigendosi poi in direzione di Grottaglie. In realtà era un idrovolante Sunderland, pilotato dal colonnello Gilbert Nicholetts, che aveva annotato sul suo taccuino che la flotta italiana non poteva lasciare il porto inosservata.
Alle ore 21.05 fu lanciato un nuovo allarme per un rombo di aerei provenienti da Santa Maria di Leuca. Un terzo allarme suonò alle 20.55, per un nuovo rombo d’aerei. Dopo 10 minuti, iniziò l'attacco, che sarebbe finito a 00:21 del 12 novembre 1940. L'attacco aereo fu lanciato da 21 Swordfish , con lo scopo di colpire soprattutto le corazzate italiane, perfettamente visibili alla luce dei razzi lanciati dagli aerei britannici. I siluri arrivarono a destinazione con successo per ben 6 volte. La corazzata Littorio fu colpita da quattro siluri, e anche le navi da battaglia Duilio e Cavour furono colpite con un siluro, mentre gli incrociatori Trento e Libeccio furono soltanto sfiorati e non furono segnalati danni.
Gli inglesi persero due aerosiluranti, per cui soltanto 19 dei 21 Swordfish ritornarono alle portaerei. Secondo i rilevamenti di alcune unità navali della seconda squadra (vedi il rapporto dell' Ammiraglio Iachino No 813/SRP del 13 novembre 1940), gli inglesi attaccarono in gruppi di tre aerei ciascuno, volando a bassa quota sul mare. Secondo gli Ammiragli Iachino e Campione, l'attacco inglese fu condotto con estrema perizia e coraggio. Allo stesso tempo, nella sua relazione n. 0330/SRP del 25 novembre 1940, l’ Ammiraglio Campione sottolineò che “[...] la difesa (...) contro gli Swordfish si era dimostrata imprecisa ed insufficiente (...) perché furono compiuti gravi errori di valutazione circa le potenzialità d’attacco degli avversari [...].
In effetti, a monte delle gravi perdite subite dalla flotta italiana nel porto di Taranto, ci sarebbero stati vari errori di valutazione da parte dell'Alto Comando. Furono sì effettuate accurate ricognizioni aeree sugli spostamenti della flotta inglese nel Mediterraneo, ma ciò che aveva fuorviato l'Alto Comando italiano furono essenzialmente i movimenti della Mediterranean Fleet. L'Alto Comando italiano riteneva che la flotta inglese si stesse dirigendo verso la costa della Cirenaica, per poi rientrare alla base di Alessandria; e su questa ipotesi erronea furono disposte le rilevazioni aeree sui movimenti delle navi britanniche. In realtà, gli spostamenti della Mediterranean Fleet furono studiati ad arte e soltanto con l'esplicito scopo di confondere qualsiasi ricognizione aerea italiana, mentre, di notte, l’ Illustrious ed altre navi inglesi (per attuare il piano d'attacco su Taranto) si dislocavano in zone di mare dove i ricognitori italiani quasi sicuramente non sarebbero andati a cercarli.
Quale fu la reazione dell' Alto Comando tedesco di fronte alla grave sconfitta della flotta italiana nel Golfo di Taranto? L’ Ammiraglio Eberhard Weischold, accreditato presso l’Alto Comando in Italia, affermò che i gravi danni subiti dalla flotta italiana nel porto di Taranto furono dovuti alla strategia errata dell'ammiraglio italiano, che egli considerò “troppo difensiva”, cosa che permise alle navi britanniche “di rafforzare costantemente la loro offensiva nel Mediterraneo”. Non meno negativi furono i commenti dell’Alto Comando della Marina tedesca (Kriegsmarine der Oberkommando), nel cui Diario di guerra (9 novembre 1940) si legge : "[...] I movimenti della flotta inglese con le sue basi aeree si svolgono con sorprendente sicurezza nelle immediate vicinanze della flotta navale italiana, come se la flotta italiana non ci fosse [...]."
Ci furono sicuramente conseguenze molto gravi sul controllo del Mar Mediterraneo; infatti, dopo il disastro di Taranto, la Mediterranean Fleet guadagnò il controllo completo del Mediterraneo centro-orientale. Questo fatto, in sé, avrebbe causato enormi difficoltà per il rifornimento dei soldati italiani impegnati in Albania e in Libia. Il successo inglese nel Mediterraneo segnò anche un momento critico per la condotta delle operazioni militari della Germania, che contava invece sulla flotta italiana per un attacco massiccio su Suez. Ma la sconfitta subita a Taranto aveva certamente diminuito le capacità operative della flotta italiana nel Mediterraneo.
In una siffatta situazione, l' Ammiraglio Reader, comandante in capo della Marina tedesca, fece presente a Hitler l'esigenza di intervenire con un aiuto significativo a favore dell’ Italia (con unità operative di aria e di terra), e soprattutto di ottenere il controllo “diretto” delle operazioni militari in Grecia e in Nord Africa, dove l'Italia non aveva conseguito risultati significativi. Hitler acconsentì alle richieste dell'Ammiraglio Raeder, perché temeva non soltanto il tracollo militare dell'Italia, ma anche quello del regime politico di Mussolini. Pertanto, Hitler inviò varie unità tedesche per supplire alle evidenti carenze dell'alleato su più fronti, dislocando in Sicilia, nel dicembre 1940, il X Fliegerkorps, nonché circa 200 aerei addestrati per la guerra sul mare, mentre, dal febbraio 1941, lo stesso Hitler stanziò anche un reparto motorizzato in Libia, che avrebbe poi formato il nucleo del famoso Africa Korps, sotto il comando del Generale Erwin Rommel.
Allo stesso tempo, un intero reparto della Wermacth, assistito dall'ottava unità della Luftwaffe, si precipitò in Bulgaria, in previsione di una massiccia offensiva in Grecia. Il supporto del X Fliegerkorps svolse un ruolo importante nel dare maggiore fiducia alla Marina militare italiana, fortemente prostrata dal disastro di Taranto. Infatti, l'intervento del X Fliegerkorps, tra il 10 e l’11 gennaio 1940, inflisse un colpo molto serio alla Mediterranean Fleet, danneggiando severamente la portaerei Illustrious, affondando l'incrociatore Southampton, ed infine costringendo la Marina britannica a rimanere confinata per guasti nella zona orientale del Mediterraneo fino a metà aprile 1941.
Questo evento permise alla Marina militare italiana ritrovare forza e fiducia in sé stessa e anche di riprendere un qualche controllo sul Mediterraneo centrale, con evidente beneficio per i rifornimenti in Albania e in Libia. Come possiamo vedere, il disastro sofferto dalla Marina italiana a Taranto ebbe conseguenze molto gravi sia sulla stabilità dell'alleanza con la Germania, a cui Mussolini aveva chiesto un inevitabile sostegno militare, sia sulla stabilità del regime stesso, di cui Hitler temeva giustamente il collasso dopo le deludenti operazioni militari italiane in Grecia e in Libia.
Nota
1) F. Mattesini, L’attacco aereo contro Taranto nella notte dell’11 novembre 1940, in Società di storia militare, Quaderno 1994, Roma, Gruppo Edit. Internazionale, 1995, pp. 113-154, con ampia bibliografia. Riportiamo i riferimenti ad alcune opere di particolare interesse. Cfr. E. Canevari, La Guerra italiana, retroscena della disfatta, Roma, Tosi, 1949, Vol. II, p. 216. B.B. Scholfield, La notte di Taranto, Milano, Mursia, 1973. A.B. Cunningham, Fleet Air Arm operations against Taranto on 11th November 1940, in Supplement to the London Gazzette (July 22, 1947). A. Sansoni-F. Mattesini, La partecipazione tedesca alla guerra aeronavale nel Mediterraneo (1940-1945), Roma, 1980. Per ulteriori dettagli di carattere tecnico e strategico, rinvio naturalmente al saggio, estremamente dettagliato, di F. Mattesini.
Id: 1122 Data: 30/06/2014 17:23:30
*
- Letteratura
Il Decameron: nella spirale della biforcazione
La fama di Boccaccio resterà per sempre indissolubilmente legata al Decameròn, che, tuttavia, come tutti sanno, non è di facilissima lettura, soprattutto perché il periodo talora si snoda complicatissimo, con un intreccio di subordinate che rendono ardua la comprensione del testo. Ho messo l’accento sulla “o” di Decameròn, per via del fatto che il nostro Natalino Sapegno ci ricordava a ogni pié sospinto che Decameròn è troncamento di Decameròn[e] e che l’accento cade sulla penultima sillaba, dove deve persistere, anche dopo la caduta della “e”. Mi si permetta la preterizione: Decàmeron, con l’accento sulla “a”, è semplicemente … sbagliato.
Comunque, lo scopo di questo mio breve intervento è molto semplice: offrire una rapida panoramica su come lavorava in prosa l'amico di Petrarca e l'estimatore per eccellenza di Dante. La questione della sostanziale incomprensibilità della prosa di Boccaccio non è legata, come taluno potrebbe essere tentato di credere, ad una sorta di “protervia” del certaldese, il quale, quasi con una punta di malcelato sadismo, si sarebbe dato “volutamente” ad una prosa criptica e involuta, tale comunque da mettere in evidente difficoltà non tanto i contemporanei ( che erano perfettamente attrezzati), quanto i lettori del nostro tempo. In realtà, come sempre accade quando si ha a che fare con autori “antichi”, il lettore dei giorni nostri dovrebbe essere avvertito che, nel Medioevo, lo scrittore non godeva di “libertà stilistica”, ma, al contrario, era legato mani e piedi alle “artes poeticae”: “In omni arte duo sunt attendenda pro illarum fine et instituto: materiae et dicendi modus” [In ogni disciplina bisogna fare attenzione a due caratteristiche per potere ben definire il suo compito e il fine proprio: il tipo di contenuto e il modo di esprimerlo] (1).
Se pertanto non si rispettavano le regole canoniche, il meno che poteva accadere era quello di essere tacciati di perfetta ignoranza. Dante, per esempio, vero maestro di equilibrismi stilistici, sapeva usare i più diversi “stili” a seconda della materia da trattare: se essa riguardava cose di “piccolo affare” si avvaleva dello “stile comico”, mentre, se si trattava argomenti “alti”, egli si serviva dello “stile tragico”. E la faccenda non si esauriva essenzialmente nelle scelte lessicali, ma coinvolgeva anche la sintassi. Per questo, se con lo stile comico uno scrittore se la cavava con periodi scarni e semplici, non così poteva agire di fronte a temi alti, in cui la prosa doveva farsi latineggiante, e il periodo svilupparsi secondo schemi fortemente analitici, rigidi e talora molto complessi, tali, comunque, da risultare oggidì pressoché incomprensibili, a meno che il lettore non voglia anche cimentarsi nell’analisi della sintassi del periodo (cosa di cui dubito).
Allorché ci avviciniamo alla lettura dell'opera maggiore di Boccaccio, non dobbiamo dunque dimenticare il fatto, essenziale, che lo scrittore di Certaldo era “obbligato” a modulare i periodi secondo i canoni retorico-stilistici dei tempi suoi, che erano estremamente dipendenti dai temi e dalla materia che via via si trattavano. Così, ad esempio, Boccaccio passava da un periodo semplice e da un lessico usuale e addirittura gergale ad un altro più articolato e solenne, a seconda se, rispettivamente, vi agivano personaggi di media o bassa levatura sociale, o , al contrario, personaggi altolocati e intellettuali: in quest'ultimo caso il periodare si slargava appunto in costruzioni ampie e latineggianti, che tra l'altro furono molto imitate nei secoli successivi, anche se non tutti apprezzavano tale tecnica del periodo, che a molti critici apparve artificiosa o, come diceva il nostro sempre irruente Papini, decisamente corruttrice dell' “aurorale trecentesca semplicità”.
Come che siano le cose, il lettore moderno, se vuole leggere il Decameron in lingua “originale”, deve accettare il dato tradizionale e cercare di adattarsi alle norme retoriche medievali che, in quanto a minuziose casistiche, erano a volte analitiche oltre ogni limite d’umana sopportazione. Lo studioso più attento al periodare boccaccesco fu sicuramente Alfredo Schiaffini (2), il quale annotò un po' tutti gli artifici stilistici messi in atto da Boccaccio. Anzitutto, egli sottolineò che, in genere, il periodo del certaldese era talmente articolato da poter essere assimilato a un «quadro», entro il quale, con sapiente stringatezza, l’autore presenta, talvolta in un periodo unico, le caratteristiche essenziali di un personaggio (V. per esempio Andreuccio da Perugia).
Fra gli artifici stilistici più usati da Boccaccio, Alfredo Schiaffini elencava le inversioni (“E, nel vero, se io potuto avessi” , per se io avessi potuto ); le separazioni, per cui tra l'ausiliare e il verbo s'inserisce un avverbio o altro, per dare “ pacata lentezza” al periodo (“l'avrei volentier fatto”, per l’avrei fatto volentieri); l’uso di termini preziosi e aulici, specie nelle novelle di contenuto elevato; oppure di “colori retorici” tipici della poesia: “Manifesta cosa è che, sì come le cose temporali tutte sono [per sono tutte, inversione] transitorie e mortali, così in sé e fuor di sé [antitesi] ...”. E queste non sono che poche annotazioni, perché, quanto a varietà di periodi, il Decameron è ricchissimo di strutture sintattiche estremamente complesse.
Il periodo “a spirale”
Iniziamo con un periodo tra i più semplici, anche se oggi come oggi, tanto semplice potrebbe non sembrare. Normalmente, il periodo meno complicato era detto a spirale, secondo una tecnica costruttiva che prevedeva una proposizione principale + una proposizione subordinata di I° grado ( di qualunque tipo) + una serie di proposizioni subordinate relative, strettamente legate fra loro e tutte dipendenti una dall'altra ( a spirale, appunto). Facciamo un breve esempio:
“Non è adunque, valorose donne, gran tempo passato [principale] /Che in Romagna fu un cavaliere assai da bene costumato [ il “che” è temporale: «allorché», «quando» «in Romagna fu, ovvero «visse»...»]/ il quale fu chiamato Messer Lizio da Valbona,/ a cui per ventura... una figliola nacque.../ la quale ... crescendo, divenne, bella e piacente...”. Come si può notare, alla principale segue una temporale introdotta da un che ( con valore temporale, nel senso di “quando” o “allorché”); seguono quindi tre relative, ognuna delle quali si regge su quella precedente.
Tradotto in italiano moderno il periodo suonerebbe più o meno in questo modo: “Sappiate, donne mie belle e virtuose, che qualche anno fa visse in Romagna un cavaliere colto ed educato che si chiamava Lizio da Valbona, il quale aveva una figlia molto attraente”.
Ma la casistica non è affatto esaurita.
Il periodo a “biforcazione”
Oltre al periodo a spirale, la manualistica medievale, coltivata a piene mani dal Boccaccio, prevedeva altresì il cosiddetto periodo a biforcazione: ne sortisce una struttura del periodo “ad albero”, per cui, sia dalla principale sia dalle subordinate successive si “biforcano” altre frasi, in forza delle quali il periodo diventa assolutamente aggrovigliato, a tal punto che a volte anche un occhio esercitato stenta a raccapezzarsi. Nella seguente “biforcazione” esemplificativa, si avverte che la principale non è all'inizio, ma al centro del periodo:
“Veramente se per ogni volta che elle a queste sì fatte novelle attendono nascesse loro un corno sulla fronte/ il quale desse testimonianza di ciò/ che fatto avessero, / io mi credo [principale]/ che poche sarebber quelle/ che v'attendessero...”.
Più o meno, la frase tradotta suonerebbe così: “ Credo che, se a quelle donne che ascoltano certe storie nascesse un corno sulla fronte, ce ne sarebbero ben poche disposte a ripetere una simile esperienza”.
Gli esempi credo spieghino ampiamente un fatto editoriale già sottolineato in questa sede a proposito di Machiavelli, ma che coinvolge pressoché tutti i classici italiani, ovvero la necessità (invalsa ormai da anni) di tradurre in italiano moderno anche il Decameron, che a molti, infatti, sembra scritto in una lingua straniera (3).
Enzo sardellaro
Note
1) Girolamo Fracastoro, Navagero. Della Poetica, a cura di E. Peruzzi, Firenze, Alinea, 2005, p. 39.
2) A. Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, Roma, 1943. Sul Decameron Cfr. le pp. 187-197, in particolare le pp. 187-192, da cui sono stati tratti gli esempi.
3) Cfr. Giulio Herczeg, Saggi linguistici e stilistici, Firenze, Olschki, 1972, pp. 154-169. Per gli esempi, cfr. pp. 154-158.
Id: 1117 Data: 28/06/2014 17:57:06
*
- Letteratura
Molière e la “grande battaglia” del ... “Tartufo”
All’inizio del 1664, Molière era al servizio del re di Francia, che gli ordinò di scrivere una commedia-balletto. Molière compose rapidamente Le mariage forcé, che fu rappresentato al Louvre verso la fine di gennaio del 1664 . La “pièce” metteva in scena un signore di cinquant’anni, costretto a sposare un’astuta ragazza, della quale egli aveva, molto imprudentemente, chiesto la mano. Per la prima volta in una commedia-balletto, i vari Intermezzi, i canti, le danze, i mimi erano legati all’intreccio. Qualche mese più tardi, Luigi XIV diede a Versailles, in onore di Louise de la Vallière, le feste più sontuose del suo regno. I festeggiamenti, ripartiti in sette giorni, ebbero un titolo comune, Les plaisirs de l’ile enchantée. La troupe di Molière, dopo aver rappresentato l’8 maggio una commedia elegante, La princesse d’Elide, il 12 maggio offrì al re e ai suoi ospiti la prima di una nuova commedia, in tre atti e in versi, Tartuffe ou l’Hypocrite. La “pièce” avrebbe sollevato, come vedremo, roventi polemiche: rimaneggiata più volte dalla prima rappresentazione, essa ottenne soltanto nel 1669 l’autorizzazione a essere rappresentata nella sua versione definitiva, in cinque atti.
Atto primo.
La Signora Pernelle approva suo figlio, il borghese Orgon, di avere accolto in casa un sant’uomo e informa apertamente di questa sua impressione tutti i membri della famiglia, che invece accusano Tartufe d’ipocrisia. Elmire, la seconda moglie di Orgon,; Damis, suo figlio; Cleante suo cognato; Dorina, una cameriera molto sincera (scena 1) pensano che Tartuffe sia un perfetto impostore. Orgon, che torna dalla campagna, s’informa invece con sollecitudine della salute di Tartuffe (scene 2, 3, 4); egli inoltre risponde in modo evasivo a Cleante, che gli ricorda il progettato matrimonio tra Mariane e Valere.
Atto II
Orgon vuole infatti unire in matrimonio Mariane e Tartuffe, malgrado la ripugnanza di sua figlia, che ama Valerio (scena 1), e nonostante le proteste di Dorine (scena 2). Dorine conforta la timida Mariane e cerca di calmare la rabbia di Valerio e Mariane verso Orgon (scena 4). Tartuffe fa intanto la sua apparizione in scena, mandato a chiamare dalla bella Elmire. La donna lo prega di rinunciare a Mariane, ma l’ipocrita approfitta dell’incontro per tentare di sedurre Elmire, che gli fa capire di acconsentire solo nel caso in cui egli favorisca il matrimonio di Valerio e Mariane.
Atto III
Damis, nascosto, ha sentito tutto e, indignato, informa il padre di quanto è accaduto (scene 4, 5). Tartuffe, vistosi scoperto, inscena la commedia dell’umiltà e si dispera dicendo che era tutto un equivoco, e che Damis si era sbagliato. Orgon cade nell’inganno, caccia di casa e disereda il figlio (scena 6); infine dona tutti i suoi beni all’ipocrita (scena 7).
Atto IV
Tartuffe evita di rispondere a Cleante, che lo prega di riconciliare Damis con suo padre (scena 1). Orgon intanto si affretta a organizzare le nozze fra Tartuffe e sua figlia, malgrado le proteste di Cleante e di Mariane (scene 2, 3). Per fare conoscere a Orgon la verità su Tartuffe, Elmire lo obbliga a nascondersi sotto una tavola (scena 4), chiama Tartuffe e lei finge di corrispondere al suo amore (scena 5). Orgon capisce infine di essere stato ingannato da un impostore e ordina a Tartuffe di lasciare subito la sua casa, ma l’ipocrita, con una reazione del tutto inaspettata, osserva maliziosamente che la casa è sua (scene 6, 7).
Atto V
Orgon si dispera per l’improvvida donazione, e anche per una cassetta che aveva incautamente dato in custodia a Tartuffe: una cassetta contenente le carte di un amico esiliato per motivi politici (scena 1). La Signora Pernelle è l’unica a credere ancora nell’onestà di Tartuffe (scene 2, 3), fino a quando compare in scena l’Ufficiale di polizia, che intima ad Orgon di abbandonare per sempre quei luoghi (scena 4). In mezzo alla famiglia riunita, Valerio offre a Orgon il suo aiuto a fuggire. La fatale cassetta infatti è stata rimessa da Tartuffe nelle mani della giustizia reale (scene 5, 6). Tartuffe in persona si presenta accompagnato dalla polizia per fare arrestare Orgon. Un colpo di scena imprevisto scioglie infine la matassa di quell’ ingarbugliata situazione.
La polizia arresta Tartuffe! Il re infatti era stato avvertito delle manovre dell’impostore, e del resto egli conosceva bene i servigi resi da Orgon alla causa reale durante La Fronda. La pièce si chiude con un elogio del re, “nemico dell’inganno”, e con l’annuncio del matrimonio di Valerio con Mariane.
Il Significato del Tartuffe
La battaglia di Moliàre contro i suoi avversari entrò nella fase più acuta con l’affare del Tartuffe. Noi non conosciamo la commedia in tre atti composta nel 1664, che però sicuramente era una farsa, dove Tartuffe era rappresentato quasi come un ecclesiastico, grossolanamente ipocrita e sensuale. I confratelli della Compagnia del Santo sacramento, società segreta che si era assegnata il compito di riformare i costumi, credette di essere stata attaccata dalla commedia di Molière, e organizzò una congiura. Luigi XIV fu costretto a impedire a Molière di rappresentare la sua commedia a Parigi.
Nel 1667, tuttavia, il re autorizzò una rappresentazione pubblica a Palazzo Reale: il poeta infatti aveva apportato alcune modifiche sostanziali al testo; la sua commedia, ormai in cinque atti, s’intitolava infatti Panulphe ou l’imposteur, e Tartuffe non era più un ecclesiastico, ma un semplice laico. Ma, in assenza del re, partito per le Fiandre, il presidente Lamoignon, incaricato delle funzioni di polizia nella capitale, fece interdire la commedia, e l’arcivescovo di Parigi minacciò di scomunicare chiunque avesse avuto la temerarietà di rappresentarla a Parigi. Il re promise di intervenire nella questione al suo ritorno. In effetti, il 5 febbraio del 1669, Tartuffe ou l’imposteur ottenne infine l’agognata autorizzazione reale e fu rappresentato in pubblico, riportando un successo straordinario.
Il problema del significato recondito del Tartuffe suscitò sin dagli inizi numerose controversie. Molière affermò che egli volle soltanto colpire l’ipocrisia, però, in realtà, la commedia possedeva una sua irreligiosità di fondo: infatti, Orgon e la Signora Pernelle, cristiani convinti e praticanti, sono entrambi personaggi assolutamente ridicoli, mentre Cleante ed Elmire risultano personaggi particolarmente simpatici, ma non sono affatto credenti. Il Tartuffe possedeva, in sintesi, indubbi elementi di irreligiosità, che sicuramente preludevano all’Illuminismo.
Sotto l’aspetto tecnico, comunque, il Tartuffe risultò un capolavoro, e il personaggio più discusso, Tartuffe, appunto, fu rappresentato con forte realismo e verosimiglianza. Questo avventuriero, che si copre con il mantello della religione per conseguire i suoi fini ambiziosi, è dotato di notevole intelligenza “pratica”, di volontà ferrea e d’una rara capacità di dissimulazione; egli sa usare tutti i toni, a seconda delle circostanze e delle persone: egli è serio e ironico, riservato e lirico, umile e minaccioso ad un tempo. Altrettanto realistica appare la rappresentazione del suo carattere di fondo: egli dimostra infatti un'incapacità pressoché totale di tenere a freno l'impeto delle sue passioni, cosa che, alla fine, lo perderà.
Nota
1) G.. Michaud, La jeunesse de Molière, Paris, Hachette, 1922.
2) Id., Le débuts de Molière à Paris, Paris, Hachette, 1923.
3) Id. Les luttes de Molière, Paris, Hachette, 1925.
Id: 1112 Data: 20/06/2014 18:20:02
*
- Letteratura
Un rapido sguardo sulla Scapigliatura …
Con il termine Scapigliatura Cletto Arrighi tradusse la parola francese bohème, che si riferiva, più che a una nozione letteraria, a un fatto di costume, inglobando in sé tutto ciò che nella realtà milanese fra gli anni '60 e '90 dell'800 appariva eslege e fuori dalla norma.
L'importanza storica della Scapigliatura consistette nell'aver preparato il terreno alla germinazione del Verismo. L'inclinazione alla rappresentazione realistica, pur commista di elementi autobiografici, contraddistinse quasi tutti gli scrittori scapigliati ( Arrighi, Ghislanzoni, Valera nonché Cesare Tronconi, vero esploratore della Milano “sconosciuta” del tempo). Tra gli Scapigliati emerse in modo particolare Cletto Arrighi, autore di Una nobile follia, una violenta requisitoria antimilitarista, ripresa poi anche in Fosca. Emilio Praga, con le Memorie del Presbiterio, fu molto bravo a rendere atmosfere misteriose, inquietanti e cupe, in una serie di racconti tutto sommato slegati tra loro, e uniti soltanto dal tema comune della vita di provincia.
Scrittori di una notevole caratura furono sicuramente Boito e Dossi, quest'ultimo di origine nobiliare, iniziato alla carriera ministeriale, e console a Bogotà e ad Atene. Carlo Dossi fu amico di Crispi, di cui condivideva le linee di politica interna ed estera. Dossi fu anche autore delle famose Note Azzurre, in cui dimostrò di essere un vero aristocratico delle Lettere. Del resto, a suo modo di vedere, il letterato che scriveva per la massa aveva scarso valore. Di qui il suo stile eccentrico, ricco di latinismi, voci rare e termini tipicamente lombardi: il tutto condito di aristocratica, e, come si dice spesso di lui, di corrosiva ironia (1), abbondantemente spalmata di pensieri, osservazioni, bizzarrie e anche “sciocchezze”, come certi giudizi negativi su Baudelaire. Dossi fu autore anche di L'altrieri (1868), una serie di racconti in cui si notano evidenti e numerose influenze straniere (da Sterne, a Hoffmann e a Dickens).
Il Piemonte “scapigliato” si presentò con Giovanni Faldella, che pure dimostrò un gusto linguistico piuttosto raffinato. Faldella prediligeva un toscanismo letterario che andava dai testi del '300 alle locuzioni più moderne, non disdegnando peraltro incursioni nel dialetto piemontese, ma senza arrivare a certe esagerazioni di Dossi. Comunque, Faldella non fu un autore di grandissimo respiro: si limitò infatti al bozzetto, dove la storia aveva scarsa rilevanza, mentre abbondava di preziosismi linguistici (non per niente Faldella fu “scoperto” da G. Contini, che in fatto di linguaggio critico “criptico” non era secondo a nessuno). Faldella riuscì molto bene nei ritratti di personaggi strani e curiosi. Forse meno colto di Faldella, ma scrittore di buona scuola fu infine Achille G. Cagna, che diede il meglio di sé nella produzione dialettale.
Nota
1) Sulla Scapigliatura e Carlo Dossi, cfr. D. Battisti, Estetica della dissonanza e filosofia del doppio: C. Dossi e Jean Paul, Firenze, 2012.
Id: 1111 Data: 20/06/2014 17:13:44
*
- Storia
Breve nota sulla Massoneria italiana
“Masonry at the Tavern” (La Massoneria in Taverna)
A. Preuss, nella sua poderosa e curata storia sulla Massoneria negli Stati Uniti, raccontava che, all’inizio, le logge Massoniche inglesi erano semplicemente indicate da un numero e poi con il nome della taverna dove gli affiliati si riunivano. Per esempio, intorno al 1738, a Londra, in Queen Street esisteva la “Lodge No 6 at the Rummer tavern”, dove gli adepti, tra una chiacchierata e l’altra, si sorbivano “three small glasses of punch” (1). Nonostante gli inizi “da taverna”, la Massoneria diventò progressivamente un' organizzazione segreta molto potente, che ebbe larga fortuna in Inghilterra, Francia e Germania. In Italia la Massoneria attecchì, a partire dal XVIII secolo, in molte regioni d’Italia, ma specialmente nel Regno di Napoli. Il periodo aureo della Massoneria italiana tra XVIII e XIX secolo fu l’età napoleonica (Infatti, Napoleone si servì della Massoneria come “instrumentum Regni”). Dopo di che, la società segreta subì un progressivo declino nel nostro paese (2).
Il problema di fondo della Massoneria fu costituito dai suoi obiettivi ultimi. In genere i Massoni furono guardati con estrema diffidenza, anche se il loro ritornello era sempre lo stesso: il loro scopo era “umanitario”. A. Preuss, di fronte all’apparente innocuità della setta, si chiese allora il motivo per cui la Massoneria fu combattuta a volte aspramente all’interno dei vari Stati. In realtà, come sappiamo, gli adepti della Massoneria occupavano vari livelli all’interno della setta, per cui coloro che erano situati ai massimi livelli avevano conoscenze molto più approfondite dei semplici affiliati, e conoscevano obiettivi e scopi che agli altri erano sostanzialmente ignoti e preclusi. Al di là di questo, i riti iniziatici, ricchi si simboli e misteri, probabilmente destarono molte diffidenze nelle autorità costituite del tempo, per cui la Massoneria ebbe sempre una vita piuttosto stentata, almeno in Italia.
Enzo Sardellaro
Note
1) A. Preuss, A Study on American Freemasonry, St. Louis. MO., 1908, p. 366.
2) Ancora oggi uno degli articoli più dettagliati sulla Massoneria italiana resta quello di B. Marcolongo, La Massoneria nel XVIII secolo, in Studi Storici (Estratto), Vol. XIX. Fasc. III-IV, Pavia, 1910.
Id: 1101 Data: 12/06/2014 20:28:58
*
- Letteratura
L’ “Indifferenza”, tra Moravia e Maupassant
Forse è solo una coincidenza, ma il fatto che, nei primi anni '50, Alberto Moravia (1907-1990) avesse curato una nuova edizione delle opere di Guy de Maupassant (1850-1893) (1), potrebbe servirci da guida per un’analisi del racconto di Maupassant “Due amici”. Tuttavia, qualcuno potrebbe chiedere: “Che cosa ha a che fare Moravia con i ‘Due amici’ di Maupassant?”. Moravia tutto sommato c’entra, nel senso che egli scrisse un libro per il quale è diventato famoso a livello internazionale, vale a dire “Gli Indifferenti” [1929]. Se c'è una parola chiave per comprendere il significato di “Due amici”, questa è, a nostro parere, l’ “indifferenza”. La trama del racconto di Maupassant è abbastanza semplice: una bella mattina soleggiata Monsieur Morissot [“orologiaio di professione e fannullone per vocazione”] incontra in una strada di Parigi Monsieur Sauvage [ “un compagno di pesca”], mentre la guerra contro i Prussiani infuriava (1870) e il cibo scarseggiava in città. Prima i due amici si recarono all’osteria a bere un bicchiere e poi decisero di andare a pescare, nonostante i Prussiani fossero alle porte di Parigi e il rischio di essere uccisi o gravemente feriti fosse piuttosto alto. In un primo momento, le cose andarono bene. I due vecchi amici attraversarono la città, discutendo sulle brutture della guerra. Poi, improvvisamente, dietro di loro sbucò una pattuglia prussiana, che li catturò e li portò davanti al comandante.
Egli li guardò, e cominciò ragionevolmente a pensare che quei due uomini anziani, per rientrare a Parigi, dovevano pure conoscere la parola d’ordine. Naturalmente, l'ufficiale prussiano era un uomo troppo scaltro per non sapere che egli si trovava di fronte solo a due vecchi incauti. Tuttavia, egli li spaventò a morte, perché voleva che gli rivelassero la parola d’ordine, fondamentale per penetrare indisturbato dentro le linee francesi. L'ufficiale prussiano urlò loro in faccia che li avrebbe fucilati all’istante, perché, nonostante il loro aspetto innocuo, li riteneva spie dei Francesi. I due amici rimasero ammutoliti dal terrore, mentre mille pensieri attraversavano la loro mente. Il comandante prussiano, in un primo momento, ordinò loro di rivelargli la parola d’ordine [ “Ditemi la parola d’ordine e vi lascio andare”]. Poi, astutamente, chiese loro di pensare alle famiglie [ “Pensate che in cinque minuti sarete in fondo a quello specchio d’acqua. In cinque minuti! Avrete pure famiglia, suppongo”]. Infine, di fronte al persistente silenzio dei due uomini, cercò di persuaderli con le lusinghe: “Allora si alzò rapidamente, si avvicinò ai due Francesi, prese Morissot per il braccio, lo portò a qualche distanza e disse a bassa voce: ‘Svelto! La parola d’ordine! Il tuo amico non saprà nulla. Fingerò di lasciar perdere’”. Di fronte al silenzio di Morissot ["Morissot rispose: “Non conosco nessuna parola d’ordine"], l'ufficiale prussiano decise di passare a metodi più duri: diede loro un minuto per rivelargli la parola d’ordine, scaduto il quale li avrebbe fatti fucilare: “Vi lascio un minuto, disse l'ufficiale; non un secondo di più”. Trascorso il minuto, "Fuoco!", ordinò l’ufficiale prussiano. Ed entrambi caddero a terra mortalmente feriti.
Possiamo dire che Maupassant fu capace di esaltare in modo efficace le figure dei due vecchi amici, che, anche se letteralmente terrorizzati e tremanti, sacrificarono la loro vita avendo cura di non per compromettere la sicurezza del loro Paese rivelando la parola d’ordine. En passant, mi sembra che l’episodio ricordi molto “La Grande Guerra”, con Sordi e Gassman che, alla fine, preferiscono la fucilazione piuttosto che il tradimento. Al di là di ogni retorica, non c’è dubbio che queste due figure di vecchi suscitano ammirazione, anche perché non erano soldati, ma due semplici e pacifici cittadini. Un'analisi più approfondita richiede al contrario l'ufficiale prussiano, che, a nostro parere, racchiude in sé tutte le caratteristiche essenziali dell’ "uomo in guerra." Questo ufficiale rimarrà per sempre negli annali della storia come un classico esempio di come la guerra può trasformare gli uomini. Infatti, “l'uomo in guerra” diventa insensibile e “indifferente” di fronte morte, e, nel racconto, il simbolo di questa insensibilità e "indifferenza" è costituito dalla “pipa” del comandante. L'immagine dell'ufficiale prussiano, che tranquillamente fuma la pipa, come se fosse andato ad una battuta di caccia invece di aver comandato un plotone d'esecuzione, è l'ultima sequenza del racconto di Maupassant. L’ “indifferenza” rispetto a ciò che era accaduto un po’ prima è variamente sottolineata dalle parole e dall’atteggiamento dell'ufficiale prussiano: ''Wilhelm!' Un soldato arrivò svelto, e il comandante, mostrando al soldato i pesci dei due uomini fucilati, disse : 'Friggi questi pesci insieme, mentre sono ancora vivi; saranno un piatto gustoso.' Poi riprese la sua pipa". M. Hurcomb, diversi anni fa, sottolineò la "deformazione e la “robotizzazione dell'uomo in guerra”, che diventa un “animale illogico”, nonché un “essere mostruoso” (2). Sull'ultima scena del racconto, J. Lechte si soffermò in particolare sul concetto di “indifferenza”: “Il lettore rimane estremamente colpito dal forte contrasto tra il finale e gli eventi immediatamente precedenti. Il finale [...] costituisce la chiave per comprendere la forza emotiva del racconto, provocata dall’ insensibile ‘indifferenza’ dell'ufficiale prussiano” (3). Certo è che, se Moravia accettò di curare un’edizione dei racconti di Maupassant, fu “anche” perché, tutto sommato, egli sentiva lo scrittore francese molto “prossimo” alla sua visione del mondo e della vita.
Enzo Sardellaro
Note
1) Maupassant, Guy, “Boule de suif e altri racconti”. A cura di Alberto Moravia. Trad. Renato Fabietti, Milano, Ed. Cooperativa libro popolare, 1951.
2) M. Hurcombe, “Novelists in conflict. Ideology and the absurd in the French Combat Novel of the Great War”, New York, 2004, p. 60.
3) J. Lechte, “Fifty Key Contemporary Thinkers”: from Structuralism to Postmodernity”, 1994, p. 135.
Id: 1067 Data: 06/05/2014 21:05:53