chiudi | stampa
Raccolta di articoli di Giovanni Baldaccini
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
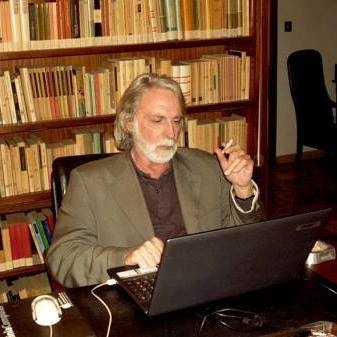
*
- Società
La notte delle indulgenze
Il mondo è finito a metà degli anni '60, quando è esploso il macello: io mi sono fermato lì.
E' finito negli anni '60, a metà, quando guidavo una Dauphine con una pietra nel cofano per appesantirla altrimenti volava e mi piacevano le donne e il pallone. E' finito quando Montale e Pasolini hanno smesso di scrivere liriche perché era finito l'infinito e gli Italiani avevano trasferito i loro sogni nel reale, perché era finita “Lascia o raddoppia”, senza accorgersi che si trattava di incubi, ma li si poteva perdonare (si era usciti da poco da una dittatura e da una guerra e tutti avevano una gran voglia di dimenticare, anche sé stessi).
Io intanto mi rimettevo dai miei traumi: abitavo in Via Dei Savorelli dopo essere stato per vent'anni in Prati, e garantisco che non è semplice compiere senza danni un passaggio simile (credo di pagarne conseguenze ancora oggi).
Dunque era finito tutto quello che era finito ed erano cominciate le indulgenze, indulgenze che durano tuttora perché siamo indulgenti e la notte è fonda.
Era così cominciata la creazione del debito pubblico per dare corpo e sostanza a scelte industriali suicide, vista la conformazione e le vocazioni naturali del paese, ma l'avvocato aveva le sue esigenze e la DC doveva promettere lavoro per coprire tutto il resto che non dava e prendeva per sé, mentre i nostalgici (leggi monarchici e fascisti) andavano messi a tacere con lo splendore rifulgente della Prima inenarrabile Repubblica.
Dunque ci si indebitava, salvo le domeniche austere perché non c'erano i soldi per rifornirsi di petrolio e si sfornavano automobilette sempre più piccole per avere sempre meno bisogno di benzina per permetterci di andare tutti al mare, in un'immagine di famiglia felicemente assopita che, se ci penso, ancora oggi mi fa rabbrividire. Ci si indebitava per fare fabbriche che scomparivano ed andare al mare senza benzina, con un'inflazione sopra il 20% e diverse svalutazioni monetarie, ma il mare non lo sapeva. Adesso abbiamo altri mezzi di assopimento, molto più penetranti ed efficaci, ma si sa, il progresso è progresso e il nulla progredisce annullando.
Intanto i democristiani andavano a messa tutte le mattine e si riunivano in conventions monasteriali dove escogitare forme di devastazione senza farsene accorgere. I socialisti continuavano la lunga epoca di devastazione che li avrebbe portati fino a Craxi, i comunisti si devastavano nel disfacimento generale e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche sorvegliava il devastabile sorvegliando che noi non sorvegliassimo troppo, mentre ci sorvegliava accuratamente come in Germania est che a sua volta si sorvegliava da sola. Se qualcuno non voleva farsi sorvegliare veniva invaso. E ti saluto Praga.
Da parte loro gli Americani studiavano il modo di intraprendere qualche nuova guerra, magari intervenendo quando era prossima a finire e fregarsi quel poco di riserve auree che ci avevano lasciato, ma scoprivano a loro volta con orrore che le streghe esistevano davvero ed instauravano una lunga caccia per sostituire l'Inquisizione che intanto, in Europa, aveva fatto la fine che aveva fatto, ma a Galileo ancora non gli avevano chiesto scusa. (A proposito, le streghe si cacciano anche oggi, solo che hanno la pelle scura).
Poi capirono una cosa fondamentale: all'Avana si gioca e si balla e le cubane non sono streghe mentre i cubani sì, soprattutto quelli con la barba.
Pensarono anche che le streghe stavano nella jungla ma se ne tornarono a casa perché erano gialle e si confondevano con le foglie. Dopo averci pensato un po' popolarono di streghe il deserto.
Stregati, si stregarono. Adesso dicono di aver subito molestie. Si sentono tutti molestati, molestate e molestatori. Quanto al loro presidente, mi molesta.
Io giravo in Dauphine, annusavo, palpavo, scalciavo, in attesa di rinchiudermi in un contenitore apposito, fatto di libri e letture, perché la lettura del mondo mi suggeriva di evitare di leggere (il mondo) e mi concentravo nel leggere altri guai.
Giravo in Dauphine e andavo al cinema, ma mio nonno era morto e mi toccava andarci da solo. I miei amici di allora, infatti, erano dei periferici isolati interessati soltanto a giocare a biliardino e neppure sospettavano che esistesse una cosa chiamata cinema. Io non ero Pasolini e li chiusi fuori di casa ben presto. E dal cinema.
Dunque stavo da solo. Rimuginavo sulle crisi di pensiero che affliggevano un po' qui e un po' lì il resto delle terre emerse, dato che Sartre se ne era andato ed anche Céline, ma il viaggio al termine della notte non finiva mai.
Era indulgente la notte e dispensava indulgenze, purché non indulgessimo a pensare, cosa che facevamo con la massima applicazione. Tra l'altro, non è vero che il Papa Re era stato destituito da un pezzo e nemmeno il duce. Eravamo stati avvisati che il tempo ritorna e l'oltre-uomo è generalmente bassotto e pelato, ma non volevamo saperlo e così c'era sempre chi pensava per noi. Il guaio è che pensava il modo di metterci sempre di più nei guai, spacciandoceli per cose desiderabili (già, si cominciava a spacciare) e così hanno inventato la TV a colori e la rete. Quanto ai pesci, non mancavano.
Liberi da intralci letterari per estinzione naturale, si è cominciato a scrivere di fatti e di fatti ce n'erano quanti ne vuoi (ne accadono fattivamente ogni giorno) solo che i fatti (per loro natura) non hanno un significato che vada oltre l'attualità e dei fatti scrivevano chi dei fatti si occupa (i giornalisti) che come è noto non sanno scrivere che di fatti. Quanto al significato, resta loro precluso.
Ogni tanto tornavo in Via Fabio Massimo per assicurarmi di esistere, ma la vedevo cambiare. Sparivano le librerie e i cinema, sparivano le signore con la veletta e i signori con il cappello, sparivano le teste. Nessuno mi salutava più e io non avevo nessuno da salutare. Non potevo neppure entrare nel portone del mio vecchio palazzo per annusarne le scale perché il portiere era morto e avevano messo un doppio cancello di cui non avevo la chiave. Nostalgicamente, leggevo i nomi sul citofono (altra novità), ma anche quelli erano cambiati. E non c'era più l'armeria, il carbonaio, il negozio di vini e oli e, soprattutto, la mia vecchia cartoleria, che amavo sopra ogni cosa, fonte per me di delizie a portata di mano (leggi penne, astucci, matite colorate, pile di carta, libri). A volte non sapevo neppure se c'ero ancora io e se il mio sospetto esserci significava ancora qualche cosa.
Persa la possibilità di significare, tutto volgeva al termine e la notte infittisce. Al termine volgeva, ma non finisce mai. E così, tra una perdita e l'altra, chi ha tentato una sintesi storica che nemmeno Marx è finito ammazzato con la benedizione dei padri fondatori e la rivoluzione bianca si è compiuta a metà e chi doveva arrestare i ladri a un certo punto ha deciso di sostituirli mettendosi in proprio, col beneplacito dei superstiti che sapevano di poter, prima o poi, riprendere a rubare.
Intanto i democristiani scomparivano, i comunisti scomparivano, i socialisti scomparivano e tutto ritornava uguale sotto mentite spoglie (Berlusconi prima, Renzi poi), noi compresi, mentre il muro di Berlino era effettivamente caduto, ma se ne costruivano altri.
Ai Cinque Stelle manca qualche altra stella e un po' di strisce per appartenere di diritto al nulla, ma sperano nella possibilità di governare per colmare la distanza. Non sanno che quel diritto lo hanno già, per natura, ma non fa niente. Loro non sanno niente.
Doblin se ne era andato al creatore per starsene ancora un po' con i suoi personaggi ed avere almeno un'ora d'aria e Schmidt lo aveva sostituito nel macello generale di personaggi e persone che continuavano a cadere in una sospensione che sospende anche la morte. Roth era morto da un pezzo, col suo mondo.
Anche la mia Dauphine era sparita ed io mi aggiravo coi fantasmi della mia fantasia ma non avevo un castello. Questo non mi permetteva di rievocare un padre _ dunque di vendicarmi _ né di aggirarmi intorno a mura fittizie da penetrare _ non mi avevano dato la licenza di agrimensore _ e questo mi confermava nella convinzione che il nulla non si penetra, caso mai il contrario.
Nullificato, sospendevo la notte, che però continuava ad aggirarsi mondo a mondo, anche nel virtuale, dove è impossibile riconoscerla come tale e catturarla, a meno di ricorrere ad algoritmi appropriati con l'effetto di rafforzarne l'efficacia. Per questo hanno inventato i telefonini.
Negli anni '60 ci eravamo arrangiati in qualche modo costruendo dal nulla un nuovo "romanico". L'Impero era caduto (gli Imperi cadono sempre), ma avevamo superato l'ennesimo medio evo, almeno ci sembrava. Non è così. L'Impero cade di nuovo, senza nulla di sacro. Cade un Romano Impero senza Roma e cade quel minimo di senso che persino un Impero porta con sé.
D'altra parte, gli Imperi cadono sempre: c'è chi si diverte a ricostruirli, quando il Tempo ritorna.
Id: 3829 Data: 02/12/2025 11:56:52
*
- Psicologia
La paura dell’abbandono e la dipendenza affettiva
Nota introduttiva
Pubblico questo articolo di mia moglie Luciana Riommi, scomparsa due anni fa, per ricordare lei, le sue conoscenze, il suo pensiero lucido.
Sempre con te, Vita mia. Sempre.
«Perché scegliere come mio partner chi mi fa più soffrire? Perché è così difficile separarsi da legami che ci fanno ammalare, che anziché potenziare e arricchire la nostra vita la immiseriscono e la mortificano?» [Massimo Recalcati, Ritratti del desiderio, Cortina, 2012, p. 97].
Interrogandosi su «tutti quei comportamenti che fissano il soggetto a ripetere compulsivamente esperienze dolorose o contrarie alla conservazione della vita», Recalcati equipara quelle che comunemente vengono chiamate “relazioni passionali” alle cosiddette dipendenze patologiche (tossicomania, bulimia, alcolismo ecc.) e si chiede ancora:
«Perché un soggetto si rende schiavo di un padrone folle (la sostanza) che lo distrugge? Perché deve mangiare fino a farsi scoppiare lo stomaco, fino a morire? Perché deve spingere la propria volontà di godimento sino a correre il rischio della morte?» (idem).
E qui la parola godimento provoca un sussulto e forse anche una reazione di rigetto, considerate le sofferenze che sono in gioco nella situazione di cui parliamo. Ma si tratta di un termine usato in modo molto specifico nella visione antropologica sostenuta dalla psicoanalisi lacaniana, che rilegge Freud alla luce degli sviluppi (fondamentalmente regressivi) caratteristici della società ipermoderna in cui viviamo.
Sappiamo che Freud, di fronte alla constatazione che i pazienti sembrano non voler guarire da ciò che fa loro male (i fenomeni della coazione a ripetere e della resistenza in analisi), aveva ipotizzato un al di là del principio di piacere – ossia quel principio funzionale alla conservazione della vita, in una sorta di “edonismo naturalistico” tendente alla soddisfazione dei bisogni/desideri allo scopo di ripristinare l’equilibrio e l’omeostasi nel sistema psico-fisico – ed era approdato alla formulazione di una opposta tendenza, la pulsione di morte, indifferente più che contraria alla vita, che Lacan rinominerà pulsione di godimento per dare maggiore enfasi a quell’elemento di eccesso, dismisura, mancanza di limite e regolazione, in una parola a quella mancanza di coscienza che la pulsione sembra mostrare quando il suo appagamento diventa più importante del benessere del soggetto e della sua stessa vita.
Un desiderio in eccesso, o un eccesso del desiderio, ossia un bisogno incontenibile, che nel caso della donna gravita prevalentemente intorno alla domanda d’amore, a cui è sempre correlata un’esigenza profonda di riconoscimento. La riflessione deve quindi cercare di risalire ai motivi di quell’eccedenza di bisogno che devia in modo distruttivo la sana ricerca di un rapporto d’amore, intendendo per sana la volontà, più o meno consapevole, di trovare nella relazione con l’altro, insieme alla reciprocità affettiva, il riconoscimento, la valorizzazione e il rispetto capaci di alimentare un senso di sé positivo, accrescere l’autostima e favorire la libera espressione individuale: in armonia con il principio di piacere (benessere). È la costruzione di uno spazio di relazione nel quale due individui si sentano liberi di continuare a conoscere se stessi e l’altro, in un processo di crescita reciprocamente accettato e incoraggiato.
Intanto va detto che nell’immaginario collettivo questo processo di crescita e di espressione personale non trova la stessa legittimazione per gli uomini e per le donne e che queste ultime troppo spesso lasciano che la “cultura” dominante fissi limiti (arbitrari) alla loro esigenza di autonomia, già minata da condizionamenti anche familiari cui loro stesse sono soggette. La dimensione storico-culturale legata alla persistenza di modelli di genere, che sanzionano ogni deviazione dai ruoli tradizionalmente assegnati ai due sessi, merita un discorso a parte, per la vastità del tema e dei fattori in gioco.
Con una operazione per certi versi arbitraria, come è arbitraria ogni generalizzazione, desidero qui tentare una possibile lettura delle determinanti psicologiche che possono spingere una donna a tollerare situazioni estreme, caratterizzate da continue esplicite violazioni, sul piano fisico come su quello psichico, della sua volontà, libertà e dignità personale, proprio da parte di chi proclama di amarla e in nome di quell’amore vorrebbe giustificare comportamenti, peraltro sempre ingiustificabili, di sopraffazione e possesso; qualcuno che spesso, almeno nella mia esperienza psicoterapeutica, presenta in modo evidente, ma non agli occhi di chi ne è vittima, alcune caratteristiche della psicopatia: l’uso spregiudicato dell’altro a scopi personali (puramente narcisistici) senza provare mai il minimo senso di colpa per l’umiliazione che infligge a un altro essere umano, di cui ritiene di poter disporre liberamente, come fosse un oggetto.
Ciò che mantiene una donna adesivamente legata e dipendente da una figura maschile di questo tipo sembra essere in alcuni casi una mancanza primaria, reale o percepita, che risale alle primissime fasi dell’esistenza: una mancanza di rassicurazione (Bowlby), di rispecchiamento (Kohut), di contenimento (Winnicott), di alfabetizzazione (Bion) ecc., per citare solo alcuni dei modi in cui viene definito questo difetto di base (Balint), che rimanda sempre a una mancanza di sintonia nella “relazione primaria” e che si traduce in una difettosa percezione di sé, oltre che nell’incapacità di metabolizzare le emozioni e i bisogni, soprattutto quel bisogno di riconoscimento e d’amore che non ha trovato risposte appropriate, sufficienti a far sentire la persona legittimata a ricevere amore e considerazione. A ciò si associa, inevitabilmente, l’incapacità di mitigarne l’obbligatorietà primitiva attraverso il filtro della coscienza. (Da qui il riferimento di Recalcati al concetto lacaniano di godimento).
Quel difetto di base a volte sembra diventare perfino una sorta di bussola che spinge in età adulta alla ricerca attiva (e tuttavia inconsapevole) dello stesso modello di relazione vissuto e patito nell’infanzia, almeno nel suo significato psicologico inconscio: forse nel tentativo vano di correggerne le distorsioni, attraverso l’idealizzazione dell’amore stesso e del suo potere curativo: “Il mio amore lo cambierà” sembrano dire, con il loro silenzio e il loro irriducibile attaccamento, le donne che subiscono ogni tipo di prevaricazione da parte di chi dice di amarle e che con atteggiamenti “passionali” sembra darne conferma.
Si tratta dunque generalmente di persone che nell’infanzia, già prima dell’acquisizione del linguaggio, hanno vissuto sulla propria pelle, letteralmente nel corpo, un’esperienza traumatica. Con questo termine intendo non tanto un singolo evento di gravità eccezionale, ma piuttosto la ripetizione e l’accumulazione nel tempo di atteggiamenti e comportamenti, spesso all’apparenza insignificanti e del tutto ordinari, che tuttavia sono stati percepiti come espressione di non-accoglimento e non-riconoscimento da parte della figura di riferimento, prevalentemente la madre o chi ne ha la funzione, che per qualche motivo è stata emotivamente indisponibile. Tale indisponibilità può essere dovuta a un eccesso di ansia, al dolore di una perdita, a una precoce separazione provocata da una malattia fisica (della madre stessa o della figlia), alla depressione, alla solitudine di fronte a un compito sentito soverchiante, o alle infinite altre ragioni personali che possono impedire a una madre, pur animata dalle migliori intenzioni, di “ascoltare” realmente i bisogni di un neonato che da solo non può nulla per alleviare i propri disagi e che finisce in un pozzo di terrore senza nome se le sue emozioni e i suoi bisogni non vengono raccolti, contenuti, alfabetizzati, ossia resi disponibili all’ulteriore elaborazione da una sorta di preventiva metabolizzazione operata dalla madre, che in tal modo li libera dall’angoscia primitiva che li pervade. Spesso la causa di tale indisponibilità sta semplicemente nella non conoscenza dei reali bisogni che caratterizzano l’infanzia di ogni essere umano e della conseguente acritica adesione a modelli “educativi” tradizionali, oggi messi in discussione dalla psicologia evolutiva.
Studi fondati sull’osservazione diretta dell’interazione tra madre e bambino a partire dalla nascita hanno dimostrato come la mancanza di sintonia (a volte co-determinata da un’attitudine troppo passiva del bambino stesso che non sollecita adeguatamente la risposta materna) possa generare un attaccamento insicuro e dunque fortemente segnato dall’angoscia di separazione; con Bowlby diremmo che non si costituisce quella base sicura su cui costruire con relativa fiducia ogni successivo rapporto umano, oltre che il rapporto con se stessi e con il mondo esterno in generale. Anche in età adulta le relazioni possono continuare a essere adesive perché ogni allontanamento dell’altro, e dall’altro, evoca il fantasma dell’abbandono: una donna può dunque attaccarsi adesivamente all’uomo che la maltratta anche perché non è in grado di tollerare l’idea del possibile abbandono conseguente alla sua ribellione, per non parlare delle conseguenze temute nel caso di una denuncia esplicita del maltrattamento subìto.
Queste considerazioni sono solo una sommaria e incompleta introduzione a un tema, delicato e complesso, che ovviamente coinvolge in vario modo anche il ruolo del padre (in quanto “padre” e in quanto “compagno della madre”) nella strutturazione di questo e altri modelli di relazione, cui concorrono ulteriormente fattori sociali, educativi e culturali. Di questi altri aspetti si parlerà in successivi interventi.
Luciana Riommi
Id: 3760 Data: 25/09/2025 17:48:19
*
- Società
Gaza
Sono stato a Gaza, ma non sono tornato. Tornare da Gaza vuol dire sopravvivere. Non fisicamente. Sopravvivere non fisicamente è difficile.
Andare a Gaza vuol dire un’immersione. Nell’aspetto concreto del Nulla, dove trovi quello che il Nulla incarna quando ti senti di non esistere.
Vuol dire anche provare quello che il Nulla prova: dolore, inesistenza, ininfluenza, sopraffazione, svuotamento e un senso forsennato del desistere.
A Gaza ci sono stato quando ho desistito.
Desistere vuol dire non avere nemmeno più pietà.
Le donne di Gaza hanno volti invisibili. Nascoste dall'inferno, sognano.
Gli uomini stanno schiena contro schiena, come fanno le ombre.
Gaza è un errore. Meglio: la conseguenza di un errore. L’errore è la manifestazione più frequente dell’umano. Questo vuol dire che l’umano è tutte le cose di cui ho parlato prima. Vuol dire anche non parlarne.
Quando sono stato a Gaza mi sono sentito in collera. Gaza è collera. La collera è un sentimento che impedisce di provare sentimenti, come i sassi che trovi per le strade. I sassi non provano nulla.
L’umano e il disumano: il disumano è umano.
Id: 3731 Data: 27/08/2025 13:58:37
*
- Società
Washington TV
Come era facile prevedere, la riunione/fiera/mercato/indecente show organizzato e orchestrato da Trump, già autore di una edizione di Miss Universo e altre scempiaggini abissali (quando non reati) è finita in una enorme bolla di sapone e, come tutte le bolle di sapore, è esplosa in faccia a chi l’ha gonfiata e relativi astanti.
Non ci sarà nessun incontro né a due, né a tre, né a tutto il cucuzzaro dato che nessuno è animato da una vera volontà negoziale e l’unico interesse in ballo è quello – per Trump – di vendere armi e per gli altri di usarle nell’illusione che servano a risolvere qualcosa. Anche questa è tuttavia previsione facile: non risolveranno nulla. Prima o poi Putin risolverà la guerra e poi verrà a dirci: volevate la fine della guerra? Bene, l’ho fatta finire. Come nel ’45, quando gli Usa conclusero a seconda guerra mondiale nel modo che sappiamo.
Putin continuerà come sta facendo ora fino a quando sarà in grado di farlo, intendo dire economicamente. Poi concluderà. Fino a quando e come porterà avanti la sua ideologia imperialista? Questo si scoprirà. D'altra parte, l'Impero è sirena antica, probabilmente fin dall'epoca di UR III e, in seguito, dell'Assiria (e, da allora, senza soluzione di continmuità). Di questo, forse, parlerò in altra sede.
Anche Trump continuerà a vendere la sua faccia come sta facendo ora, apparendo come appare, un border oscillante dato che non ha un io integrato e, come previsto da quella patologia, il suo io oscilla tra posizioni contrapposte senza nemmeno rendersene conto, ma non intendo fare diagnosi.
Dopo aver proclamato per mesi quello che sappiamo, cambiando faccia e versione, Trump si sfilerà dalla questine ucraina. Facciano gli Europei, dirà. E noi faremo.
Cosa? Nulla, oltre che danneggiarci anche oltre la misura in cui già lo abbiamo fatto, dazi compresi, ma ormai è tardi per cambiare posizione. Ignoro dove andremo a finire.
Questa guerra ha ragioni profonde che affondano fino ai tempi di Krusciov se non all’invasine tedesca durante la seconda guerra mondiale, quando buona parte degli Ucraini si schierarono con gli invasori che, tuttavia, non smisero di mitragliarli. Ha ragioni profonde questa guerra, tutte assurde come appaiono a qualsiasi persona sana di mente le ragioni della patologia. Ma tant’è, il mondo è patologica da sempre, almeno in larga parte, e non c’è da meravigliarsi.
Sinceramente detesto i personaggi di questo ridicolo teatro sghembo, ma della rappresentazione faccio parte anch’io e devo ascoltarli/ascoltare/ascoltarmi, ma non crederci.
No, non credo una parola di quello che dicono, né a quello che fanno, tanto meno a ciò che “pensano”. Detesto pensarli ma non se ne può fare a meno. Dunque pensare l’impensabile; mi succede spesso.
Confermo che di Gaza non parlo, altrimenti mi arrestano.
Id: 3727 Data: 22/08/2025 14:05:57
*
- Società
Alaska: la notte delle beffe
Non avevo la minima aspettativa che dall’incontro tra Trump e Putin potesse risultare qualcosa di positivo, né tanto meno una sia pur minima parvenza di soluzione per la guerra in Ucraina.
No, non avevo aspettative. Ero solo curioso di vedere cosa avrebbero inscenato due personaggi, che è impossibile definire persone, a beneficio del restante mondo (in realtà solo per se stessi. Il risultato è andato ben al di là delle mie peggiori previsioni e ne sono uscito con un profondo senso di disgusto.
Uno spettacolo disgustoso, dunque, messo in onda da media desiderosi di ascolto che da giorni lo presentavano come “evento storico” ma, se qualcosa di storico c’è stato, non si è trattato altro che della manifestazione di una colossale beffa attraverso la quale i due hanno dimostrato ampiamente tutto il loro disprezzo per il diritto di informazione, dando ampia ed ennesima prova di non tenere in alcun conto il resto del mondo che, loro malgrado, esiste e li circonda.
Non una parola dunque sul tema effettivo dell’incontro; soltanto vane ciance sulla vicinanza geografica tra le due super-potenze nucleari, i loro intenti comuni (si legga affari, affari e ancora affari) e su come esse siano state alleate nella lotta contro il Nazismo, tralasciando di dire come si siano al contempo spartite il mondo tramite occupazione e successiva colonizzazione (materiale e ideologica) dei paesi sconfitti. Discorso – temo – solo in apparenza vuoto; ho infatti il timore che in qualche modo si stiano preparando a ripetere quell’esperienza e la frase di Trump con la quale ha affermato che Ucraini e Europei “dovranno accettare” quanto deciso, senza specificare cosa. E che “non ci ostacolino” ha aggiunto Putin. Minacce? Neppure tanto vaghe.
Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da quell’infamia spacciata per vertice di pace? Difficile dirlo. Posso soltanto supporre che presto risentiremo parlare della Groenlandia e che la guerra in Ucraina terminerà quando Putin avrà raggiunto i suoi scopi, in attesa di ulteriori espansioni verso paesi baltici, Georgia e forse Romania, Nato o non Nato, tanto Trump non interverrà. D’altra parte Lavrov è stato abbastanza esplicito presentandosi con una maglietta recante la scritta URSS.
Grossi problemi all’orizzonte, dunque. Una eventuale invasione della Groenlandia da parte degli Usa implicherebbe una specie di dichiarazione, tacita ma esplicita, di guerra alla UE, visto che i dazi non sono bastati per renderla chiara. Che l’America non sia più dalla nostra parte dovrebbe ormai essere chiaro anche al più idiota degli idioti. Panama? Probabilmente sì (Trump vuole il canale e i soldi che procura) ma di Panama non frega niente a nessuno – sbagliando – perché ha un’importanza essenziale per il commercio mondiale. . Prevedo aumenti catastrofici per i prezzi di qualsiasi merce, anche quelle essenziali.
Quei due signori vogliono fare affari e spartirsi la torta (la torta siamo noi), ma prima o poi entreranno in conflitto, dato che un pollaio è sempre stretto per due galli (il pollaio siamo sempre noi). Dio non voglia che accada ma – temo – accadrà.
Ma di cosa vado parlando…? Siamo a Ferragosto, siamo in vacanza, vogliamo divertirci (dimenticando che, in fondo, si tratta di una festa religiosa e almeno un pensierino alla Madonna, ci si creda o meno, bisognerebbe dedicarlo).
Che ci importa (in realtà non molto) di due signori che invece di dedicarsi ad attività piacevoli se ne vanno al freddo dell’Alaska a parlare di non si sa cosa. Ma, forse, poverini, anche loro avevano caldo e impicciarsi non sta bene. Si sappia, però, che per loro la nostra trascuratezza è alimento vitale.
Non so perché alla fine dello “storico” incontro mi è venuta in mente una vecchia aria di un’opera lirica ormai fuori moda nella quale il protagonista cantava accoratamente “Ridi pagliaccio”. Lo faceva per non piangere.
Id: 3720 Data: 16/08/2025 16:43:05
*
- Società
Salto d’epoca
Premessa
Dunque dove mi trovo? A cavallo senza avere un cavallo. Ma a cavallo dove? Due epoche o forse due parvenze, ma poi perché dovrei rispondere?
Trovarsi: come frugare un’anima. Spaventata, fuggita. Inseguire? Potrebbe essere molesto. Anche perdersi. Dunque, dove mi trovo?
Si oscilla. Qualcosa si prefigura senza connotarsi e qualcosa ritorna. Vecchie figurazioni; sembra non sradicabili.
Ora, che l’antico non voglia scomparire è persino comprensibile; nulla gradisce andarsene, neppure ciò che oggi (dovrebbe) essere appunto nulla. Ma ciò che viene indugia, privo di forza a imporsi. Avrebbe bisogno d’aiuto, ma l’anima se ne è andata e senz’anima nulla accade.
Stallo, pertanto: ai limiti, spesso di una coscienza che non c'è.
Scomparse e apparizioni
L’epoca che scompare è nostalgia, soprattutto per i vecchi; i giovani non ne hanno coscienza.
L’epoca che compare ha volto ignoto. Per i giovani neppure quello. Cosa appare e scompare? La nostra malcelata ambiguità.
Siamo divisi. Frammentati tra una coscienza che, su scala temporale, è neonata, e un inconscio arcaico, antico quanto il corpo. Jung usa la metafora di un’isola nell’oceano: l’isola è la coscienza egoica, l’oceano è l’inconscio. Se tempesta, può sommergerci con facilità.
La tempesta è di carattere emozionale. Le emozioni sono la prima forma di interazione con il mondo. Paura, rabbia, attrazione, repulsione sono tra le modalità con cui da sempre ci rapportiamo all'ambiente. Si tratta di automatismi, totalmente involontari. La coscienza non vi partecipa; a volte li registra, spesso ne è travolta, a seconda dell’intensità delle emozioni.
Le emozioni, anche le più araiche, sono tutte qui, ancora oggi. Informano le nostre relazioni con l’ambiente e con gli altri con le stesse, identiche modalità di milioni di anni fa. Se positive, sostengono la coscienza, se vissute come negative, la disturbano fortemente, fino a provocare reazioni abnormi, tipo i così detti attacchi di panico.
Da qualche centinaio di anni - un tempo brevissimo, dunque – all’evoluzione naturale si è affiancata quella che definiamo evoluzione culturale cui le emozioni sembrano non partecipare quasi per nulla. Riguarda solo la coscienza e si esprime soprattutto sul piano tecnologico. Questo non è un bene: lo spirito resta indietro.
Le emozioni dovrebbero partecipare al processo di civilizzazione dell’io, evolversi. Affinché questo accada, però, sarebbe necessario che la coscienza egoica ne fosse pienamente consapevole; le conoscesse a fondo,e le indirizzasse a sostegno dell’io, organo psichico di rapporto col mondo e con gli altri. Detto in altri termini, le emozioni dovrebbero apprendere un linguaggio, alfabetizzarsi, come diceva Bion. Per questo, occorrerebbe un’educazione – diciamo “sentimentale” – adeguata, che tenesse conto delle necessità di apprendimento emotivo dei giovani, ma la famiglia latita e la scuola svolge un ruolo puramente istituzional-burocratico. Da qui lo sbando giovanile, l’anestetizzazione emotiva degli adulti, delitti, scompensi, smarrimento, guerre. Lo sbando della società: questo l’effetto. Dunque dove mi trovo? Allo sbando.
Savana
Ai margini di un boschetto affacciato sula savana. Africa; milioni d’anni fa; oggi; sempre.
Guardarsi intorno. Pieno di pericoli qui. Il peggiore, però, non è rappresentato da eventuali predatori; viene da vicino: i miei simili.
In particolare uno, il così detto “maschio alfa”. Il più violento, aggressivo, stupido. Indirizza il comportamento dell’intero gruppo ed è l’unico che può generare figli. Chi si ribella rischia moltissimo sotto forma di aggressioni selvagge e persino la morte.
Costui non è solo. Si giova di un gruppo di “solidali”, un “partito” che lo sostiene; chi ne fa parte ha i propri vantaggi.
Tutto il mondo animale è organizzato in questo modo, senza eccezioni. Una questione di "geni", c'è poco da fare; l’uomo non fa eccezione.
Preda degli arcaismi, organizza la società in maniera estremamente simile al resto degli animali.
Guardarsi ancora intorno. Si, al fondo siano in parte animali e come tali ci comportiamo. Certo, ci sono delle differenze dovute a migliaia di anni di evoluzione culturale, ma l’arcaico resta immutato.
Gli Stati sono organizzati come strutture verticali formate da individui sostenuti da “partiti”. Chi ne fa parte gode di notevoli vantaggi; Gli altri sono sudditi.
Alcuni Stati, oggi sempre meno, hanno forma democratica, il che significa che si tenta di contenere il potere di pochi attraverso strutture di delocalizzazione e controllo, la così detta divisione dei poteri. Dunque il potere viene suddiviso, ma è sempre un fatto elitario.
La forma democratica sta cadendo in disuso in una regressione cultural-temporale specchio di tempi immobili. Questo accade in moltissimi Stati del mondo, specialmente ad est, ma l’esempio più eclatante è rappresentato dagli Stati Uniti dove torna in auge il “maschio alfa”, il dittatore.
Dittature, dunque, “maschi alfa” sparsi un po’ dovunque; non è un buon segnale.
Torniamo in Africa. Al fiume; due gruppi di babbuini confinanti; per bere ci si scanna. Nessuno cede il passo, né tantomeno si pensa di dividere l’acqua pacificamente. Nessuno dei due maschi alfa accetta di bere per secondo (ne va della sua autorità) e i “compari” li spalleggiano. Rissa, “guerra”; feriti, forse morti. Alla fine uno dei due gruppi si ritira.
Oggi, nel nostro mondo supercivilizzato nessuno accetta di dividere equamente le risorse: ciascuno cerca per sé un vantaggio. L'autorità non può mostrare debolezze, ne va della sua sopravvivenza. Guerre, dunque, per le risorse, da sempre.
A livello interno, strette legislative sempre più repressive, a discapito delle opposizioni tramite l'uso di decreti legge che bypassano il Parlamento, rendono sempre meno manifestabile il dissenso, anche a livello pubblico, diciamo "di piazza".
Sembra proprio che nulla cambi ma, su scala evolutiva naturale, ultimamente si è scoperto che gli scimpanzé cacciano e spesso si uccidono tra loro atraverso vere e proprie "guerre" tra bande. Hanno imparato a mangiare carne; l’assunzione di proteine farà sviluppare il cervello e se lasceremo loro un mondo vivibile, saranno i prossimi.
Salto d’epoca
Eraclito afferma che tutto viene dal nulla e al nulla torna. Il tempo della vita è relativo, ma il tempo è funzione della coscienza, sconosciuto all’inconscio. Per sorgere dal nulla occorre dunque sorgere; l’inconscio non sorge mai: è immota stasi. Il che significa che senza l’intervento di un io cosciente non esisterà né tempo né evoluzione culturale e le emozioni non accederanno mai al linguaggio del villaggio umano, come lo chiama Bollas, che resterà silente.
La coscienza è un cammino; traccia percorsi. Da un lato, allora un inconscio arcaico e immoto, dall’altro una coscienza che scorre nel tempo di cui dovrebbe connotare epoche e significati.
Salti dì epoche, allora, da un tempo all’altro, a seconda dei livelli evolutivi della coscienza che disegna la storia cui l’inconscio non sa partecipare. Dunque dove mi trovo? Oggi senz’altro in un salto d’epoca, ma anche in un immobilismo sordo e resistente che le epoche ignora.
Per non andare troppo indietro, potremmo caratterizzare la nostra storia più recente come una serie di passaggi d’epoca. Dalla caduta dell’Impero Romano al Medioevo, dal Rinascimento all’Illuminismo, da quest’ultimo all’età moderna. Già, ma cosa caratterizza questo ultimo passaggio? La robotizzazione dell’umano.
L’epoca tecnologica in cui ci siamo affacciati rispecchia l’unilateralità di una coscienza invasa che, usando oltre misura "meccanismi", ad essi si riduce. L’ultima espressione di questo passaggio è, a mio avviso, l’intelligenza artificiale che ci dispensa perfino dal pensare: si pone un quesito e una macchina risponde per te. Utile per pochi da un punto di vista economico, significherà invece per migliaia di famiglie la perdita del reddito.
Angoscia, dunque e, per sfuggirla, sempre più stordimento nei social, nelle sostanze, nell’alcol e nel fragore di notti senza sonno.
Esposta a venti di tempesta emotiva sempre più incontrollabili, la coscienza dell’io tenta (inconsapevolmente) l’ultima difesa lobotomizzandosi in scenari sempre più virtuali. Si tratta di vera difesa o illusione? La difesa sta nel rafforzamento dell’umanità, non nella robotizzazione dell’umano.
La deriva disumanizzante mi appare evidente anche nella perdita di relazionalità cui stiano assistendo. Non ci si esprime, si comunica per interposto macchinario e virtualità. Le città sono sempre più anonime e tutti sono sempre più nessuno mentre la politica ci riduce a numeri e esprime tendenze tossiche di stampo paranoico portate avanti da destre sempre più estreme e isolazioniste che lasciano ampio spazio a un conservoo.atorismo figlio di arcaismi pericolosi, mentre la sinistra resta ancorata a forme sociali non più adatte ai tempi. Entrambe le tendenze si ancorano al passato perché temono di essere spazzate via da nuove forme di organizzazione. Per esse il salto d'epoca è un pericolo e, in tal modo, non gestendo adeguatamente il reale, ci espongono a pericoli ben pià gravi della loro sopravvivenza. A parte le guerre in corso, le espulsioni più o meno riuscite, le deportazioni e i dazi imposti al mondo da una specie di folle, la Cina sta per invadere Taiwan e forse la Russia ricorrerà all'atomica, almeno a sentire i Servizi del Regno Unito.
Essere e tempo sono dimensioni inscindibili, a patto di, come scrivere Paul Ricoeur, riconoscere che non si tratta di accrescere la Coscienza dell’Essere ma l’Essere della Coscienza. Esistere è consapevolezza; occorre dirla.
Tuttavia, tutto sorge dal nulla e al nulla torna. Questo il mio salto d’epoca?
Id: 3687 Data: 31/05/2025 11:33:21
*
- Società
Femminicidi e altre disgrazie.
Femminicidi e altre disgrazie. Ovvero, delitti senza soggetto.
Premessa
Difficile riflettere su ciò che per qualsiasi persona di buon senso assume con tutta evidenza le connotazioni di un delitto e che chi scrive non può considerare soltanto tale, dovendo, per propria definizione, avvicinarlo anche sotto l’aspetto della desolante assenza di senso psichico.
Fin dai primi frammenti di notizia, dalle ricostruzioni faticosamente accatastate, chi scrive non coglie altro che la voce della propria confusione. Vertigine priva di riferimento; presenza di un non senso che non spiega. E ha dovuto, allora, porsi di fronte a un senso impalpabile che sfugge la presa delle dita e della mente. Confrontarsi, dunque, con l’apparente assurdo e doverne tener conto per rintracciare un senso dentro il non-capire, perché fin dall’inizio non percepiva che l’asettica assenza di un soggetto.
Non rimarrebbe, dunque, altro che consegnare il fatto al suo silenzio, dove si è svolto ed estinto. Ma proprio questo è il punto e la necessità di ogni ricostruzione: dare un senso alla morte.
Ma neppure la morte. Il fatto essenzialmente non ha nome, perché la morte segue a chi ha vissuto. Ciò che sconcerta è quando non si nasce. E questo è il caso, negazione assoluta di esistenza che impedisce persino di morire.
Orizzontarsi senza un orizzonte: da qui il disagio.
Arcaismi
Stimolo-impulso-reazione: meccanismo di base in questo mondo. Formula organica di sopravvivenza cui non occorre discrezionalità. Inutilità, pertanto, della coscienza, apparsa in scena in tempi più avanzati e di cui spesso si può fare a meno.
Muoversi, alimentarsi, riprodursi: fatti. Senza intenzione, che non sia quella di mantenere schiere di organismi a discapito delle vittime di turno. Alternativamente e in equilibrio apparente. Ma questo lo diciamo noi: non sta nei fatti.
Scadimento al livello della predazione. Sarebbe già qualcosa, al di là della scarsità che vi è inscritta. Ma neppure così. Perché il delitto è un fatto dell’umano. Aberrazione come campo di ricerca, allora, se non fosse che anche questa è un’affermazione, mentre ciò che seguiamo è nell’assenza.
Senza relazione nel rapporto. Che la pulsione non ha sentimento. Cattura oggetti e scarica tensioni con l’aggressività che guida la libido. Perfettamente funzionale; ma a livelli diversi.
Inoltre, non c’è morte nel sesso: è un fatto della vita. Sopraffazione, spesso; spesso uso di un oggetto che non diventa “altro”. Morte no, se non nel senso psichico del buio in cui nuota l’istinto. Quello sarebbe il luogo da indagare; ma non basta. Perché l’istinto non getta in un dirupo i propri amanti; non distrugge le membra e i frammenti, né seppellisce sogni. Incubi, in verità, voci d’angoscia; dolore da nascondere alla vista, talmente intenso da suscitare furia. C’è qualcosa che coglie ciò che ha fatto; non vuol saperlo, ma nell’orrore c’era una un’espressione anche se solo di un bisogno cieco.
È il mondo dell’umano che soccombe nella frammentazione della psiche che annega. Deprivata della transizionalità dei propri oggetti (Winnicott), non accede al rapporto. Dunque non crea simboli, rappresentazioni interiori dell’oggetto da informare di sé nell’interscambio tra l’estraneo e il proprio che, rappresentando reciprocità di sensazioni, sentimenti, emozioni, convoglia e connota configurazioni prima inesistenti. Non accede, pertanto, alla cultura; non c’è immagine rappresentata; non c’è pensiero.
Nell’al-di-là: confusione indistinta. Violenza di vissuti inadeguati non trasformabili in rappresentazioni. Espressioni d’angoscia soffocante; solo sopraffazioni del non senso. Ingestibili e, certamente, impossibili da tollerare.
Ogni cultura crea un alfabeto; ma senza traduzione dal caos dell’indistinto alla gestione che codifica senso non c’è “alfabetizzazione” (Bion). Questo compito spetterebbe alla famiglia, alle istituzioni educative, allo Stato. Spetterebbe, se non fossero ormai anestetizzate. Detto di sfuggita, spetterebbe anche a quella meraviglia che chiamiano arte, se ancora ne esistesse una.
In tale mancanza, non si sviluppano quelle che definiamo funzioni dell’Io, attività d’ordine superiore capaci di riconoscere, gestire, comunicare e indirizzare verso un princiio di realtà che sia davvero tale, direzionalità che mette al mondo intenti e chiude il cerchio intorno ad uno scopo consapevolmente ricercato e attuato.
Riconoscere, si diceva, innanzi tutto l’altro. Entità diversa e soggettiva, e nel far ciò costruire i confini di sé stesso, a propria volta riconoscibile da solo e nel rapporto col diverso.
Ma tornando all’assenza, tutto rimane chiuso nella terra; che ribolle ed esplode perché non può gestire le tensioni. Pressione d’angoscia senza nome (Kohut) che non conosce senso e solo “spinge”: ad agire quel che non ha voce. Perché non sa il linguaggio dell’umano che nessuno ha insegnato.
La personalità narcisistica. Patologia.
Non mi dilungherò sulla personalità narcisistica e le sue patologie che spaziano dal narcisismo normale fino al livello border-line fino e psicotico dove può trasformarsi in vera e propria psicopatia. Chi desidererà approfondire potrà rivolgersi al DSM V o alle opere di Kohut e Kernberg che hanno trattato a fondo l’argomento. Personalmente, mi limiterò all’essenziale.
La patologia narcisistica è caratterizzata da un profondo senso di vuoto: il narcisista è vuoto si se stesso. Generalmente trattato dalla famiglia come un’estensione narcisistica die suoi membri – prevalentemente la madre, mentre il padre è stato per lo più assente o prevaricante - il bambino che svilupperà una personalità narcisistica è trattato come un elemento essenziale per realizzare tutto quel che i membri della famiglia hanno fallito nella loro vita. Considerato geniale e irrinunciabile, il bambino “sente” che qualcosa non va ma non osa esprimerlo per paura di perdere l’affetto. Nulla infatti il narcisista teme di più dell’abbandono. Egli percepisce pertanto un che di “falso”; teme che tutto ciò che gli viene attribuito non sia vero e sviluppa il vissuto di essere essenzialmente un bluff. Di questi suoi timori si vergogna. Immerso in una realtà che non è tale, il narcisista sviluppa un falso senso di se stesso. Il narcisista non è mai se stesso ma non osa domandarsi a chi appartenga la vita che (non) vive.
Di conseguenza non è in grado di sviluppare una sufficiente differenziazione io-tu; non sviluppa empatia, sfera del sentimento; in pratica non sa amare. Il suo bisogno è inverso: deve essere amato. A livello psicopatica l’assenza di sentimento è estrema: non prova vergogna, colpa, pentimento, qualunque delitto abbia commesso.
Dunque deve essere amato, ammirato, considerato al di sopra di qualunque altro. Non tollera confronti., ma non è relazione. Il narcisista sviluppa infatti, al posto della normale relazionalità una relazionalità oggetto-Sé. Cosa significa questoé Significa che l’altro è una sua estensione, una parte di sé essenziale della quale non può fare a meno. L’altro non esiste di per sé: è il narcisista stesso. Essenziale per la sua sopravvivenza, l’altro non può mancare; se accade, il narcisista prova angosce devastanti, fino ad arrivare alla frammentazione. Se accade, la sua rabbia è incontrollabile. L’oggetto sé che ha tradito deve essere cancellato. Non può più esistere, altrimenti continuerebbe a ricordare al narcisista un senso di abbandono e di negazione (di sé) insopportabile. Dunque, l’altro va cancellato e le sue spoglie devono sparire. Da qui le conseguenze più estreme e, ovviamente, senza senso di colpa o pentimento; siano ormai al livello psicopatico.
Uccidendo l’oggetto sé ormai inadeguato al ruolo e alla funzione attribuitagli dal narcisista, al fondo egli uccide anche se stesso. Non ha mai vissuto davvero a livello individuale e non può vivere senza l’oggetto sé cui ha demandato la propria sopravvivenza. Non è raro, infatti, che tragedie di questo tipo sfocino in un omicidio-suicidio. In realtà, a questi livelli la morte neppure esiste perché non si è mai nati soggettivamente nella psiche.
Per quale ragione poi molte donne si lasciano emotivamente irretire da uomini narcisisticamente compromessi a livello psicopatico è tema che meriterebbe approfondimento ma non lo farò. Nell’epoca in cui viviamo (o ci sembra di farlo) non sarebbe psicologicamente “adeguato”. Basta dire che esistono molte “difese” psichiche che proteggono da angosce altrimenti insopportabili e che portano a “sperare che le cose cambino” piuttosto che affrontare la realtà, ed esiste una “fragilità” definita “masochismo morale”.
A proposito, lo sapevate che molti leader attuali sono indiscutibilmente psicopatici? Ma questa è un’altra storia.
Il mondo sasso
Al di là dell’evento, la violenza e la morte non sono fatti isolati, perché la morte non è solo morire. In situazioni apparentemente culturali, nella “normalità” del mondo, dove gli aerei viaggiano lo spazio e i numeri danno forma ad una “rete” che sconvolge ogni senso del reale, le funzioni dell’Io restano sopraffatte. L’antico sogno freudiano si è definitivamente eclissato nel tramonto non dell’Edipo ma del Super-io - (ricordo che un Super-io sano è la base della morale individuale) - e nel fallimento delle funzioni egoiche incapaci di contenere e direzionare impulsi arcaici ormai debordanti.
Rafforzato dai “mezzi” della coscienza egoica che ha invaso, l'inconscio usurfuisce di strumenti "culturali" a dismisura che persino giustificano, razionalizzando, ciò che senso non ha (morale collettiva che giustifica perfino lo sterminio) nell’espressione di desolanti mancanze umane e nella rinuncia al “fare anima” (Hilmann) del mondo. Satana blandisce, e non è facile dire sempre no. Ma non c’è alcun demonio che non si chiami assenza di coscienza. Moneta svalutata, quest’ultima, priva di un prezzo valido di scambio. Il mercato globale conosce solo “cose” e di queste commercia. Tutto ha valore purché nell’immediato e dall’alba al tramonto cambia prezzo, codificando l’instabilità che annulla il tempo. Morte per fame, un tempo, si dirà. Oggi, schiere di debolezza vendono sul mercato l’abbandono. Tutti hanno un corpo che per molti è merce: basta pagare e si mantiene in vita. Il corpo. Che si trascina e perpetua lo scambio delle cose che radica un senso di abbandono fonte della mancanza a essere che domina il nostro tempo. “Il discorso del capitalista” tenuto a Milano da Lacan, ormai molti anni fa, è come se non fosse mai stato pronunciato. Neppure la parola di Cristo.
Il corpo/cosa: chi lo compra e chi vende. Turismo sessuale organizzato, import-export di organi e piacere; clandestinità di rapporti senza volto; prostituzione di pupazzi vivi dentro il ruolo di oggetti per chi non ha percorso lo sviluppo e imbriglia in corpi adulti stadi infantili senza separazione dal non sé (Mahler). Senza riflesso: gli occhi della merce, dentro uno sguardo che non può rispecchiare (Kohut).
Un mondo sasso quello che abitiamo, privo di senso e storia. Un mondo che non ha più volizione, speranza, voglia di vivere, anche nella miseria, di cui è incapace di apprezzare la bellezza. Un mondo senza mondo, senza volto d’umano. Un'epoca si chiude sempre con il caos.
Nota dell’autore. C’era un uomo di cui, pur non essendo cattolico, ho ascoltato le parole. A presto Francesco!
Id: 3660 Data: 25/04/2025 18:57:25
*
- Società
Il villaggio umano: declino e sconcerto
Sono piuttosto spaventato. Non è vero ma lo affermo.
Mi fanno paura le cose del mondo o, per meglio dire, sono preoccupato per le cose che accadono nel mondo. Dunque, mi preoccupa come va il mondo/cosa in cui oggi viviamo.
Mondo/cosa, ho scritto: che vuol dire? Che il mondo oggi parla un linguaggio che non ha significato. Siamo di fronte a “fatti”. I fatti sono qualcosa che si esau- risce: non hanno prospettiva né rimandano ad “altro”. Nel mondo succedono cose; tutto lì.
Il mondo è allora “cosa” come gli stessi fatti che vi accadono, ma perché quei fatti avvengano, quali le motivazioni che li muovono, cosa si cela dietro un appa- rire non sembra interessare più di tanto. Si riferisce ma non se ne cerca il senso.
Non starò a parlare di Ucraina/Russia/Israele/Iran/Hamas; quella è una preoc- cupazione (paura?) ormai consolidata. Fatti noti, archiviati come tali. Mi preoc- cupa il “fatto nuovo”: l’America di Trump.
L’assalto a Capitol Hill non è bastato per liberarcene. Certo, quattro anni di un anziano signore, dall’intelletto ormai labile, non hanno aiutato. La scelta della Harris, poi, meno che mai, ma ormai era troppo tardi. Sembra sia sempre troppo tardi. Queste però sono chiacchiere; non mi va di fare chiacchiere. Chiacchiera equivale a vuoto e il vuoto genera angoscia.
“L’angoscia, come la noia da cui essa deriva, è ‘l’essenziale impossibilità di una possibile determinazione’. Questo è per Heidegger lo spaesamento assoluto. E dunque ‘tutte le cose e noi stessi naufraghiamo in uno stato di indifferenza’ [...] Le cose, noi stessi, ci si mostrano soltanto nell’atto di scomparire, nell’atto dell’allontanamento. E questo eclissarsi manifesta il nulla’. Infatti, l’inferno della ciarla, la chiacchiera insensata, rivela, nella sua insensatezza, proprio il vuoto che essa vorrebbe nascondere.” (Franco Rella, Miti e figure del moderno, Pratiche Editrice, Parma, 1981, p. 62).
Angoscia, e dunque vuoto, è la parola chiave; contro di essa si ergono le difese egoiche più primitive e resistenti, ma non è questo il luogo per parlarne a fondo. Certo è – almeno ne sono certo io – che gli Americani sono angosciati. Lo sono anche gli Europei, gli Asiatici, i Russi (in parte, essi usano anche altre difese). I Cinesi no: sono troppo “cinesi” per angosciarsi.
Ma torniamo a Trump. Potrei chiedermi: Trump, chi era costui? Potrei rispon- dere: meglio lasciar perdere.
Di Trump non mi fa tanto paura quello che farà, ma quello che tenterà di fare quando si accorgerà di non poter fare quello che vuole. Quello che farà lo ha già detto ed è inutile che io stia a ripeterlo. Quello che farà quando si troverà di fronte ad alcune impossibilità di fare – leggi limiti costituzionali – è tutto da scoprire. Non lo sappiamo, per questo fa paura. Una cosa è però certa: non sarà angosciato. E neppure pentito: uno psicopatico non lo è mai.
Il punto è che quando un narcisista di livello psicopatico incontra limiti al proprio smodato desiderio, viene invaso da rabbie incontrollabili – si veda, ad esempio, l’assalto a Capitol Hill.
Un narcisista non tollera confini. Pretende di esercitare un controllo onnipo- tente sul mondo dato che tutto promana da lui. Privo di confini tra l’Io e l’esterno, si disperde in un vago che deve riempire di contenuti: i suoi. Il Sé Grandioso (Kohut) da cui è dominato non ammette frustrazioni di alcun tipo; se ne incontra, si vendica per ripristinare il controllo illusorio di cui si nutre. Se il Sé Grandioso ha raggiunto livelli psicopatici, la vendetta può essere letale, figurarsi poi se si è in possesso di un certo “armamentario” particolarmente distruttivo.
Chi glielo lascia fare – i suoi seguaci – essendo eminentemente vuoti, per vivere hanno bisogno di identificarsi con una Guida/Guru/ di un qualche tipo. Se si tratta di un esaltato, incline a mentire fino a convincersi che le menzogne che propugna sono vere, chi lo segue è un esaltato come lui. Il 75% degli elettori Americani ha votato Trump; non aggiungo altro.
Musk meriterebbe un discorso a parte, ma di lui penso quello che penso di Trump, forse peggio.
Trump non è l’unica mia preoccupazione: ne ho un’altra che non avrei mai creduto di avere: mi preoccupano le donne.
Era fuori dalla mia capacità di immaginare figurarmi che una donna – e purtroppo molte donne – potessero essere nazional/sovraniste/fasciste o quasi tali. No, questo mi sembrava proprio
impossibile; purtroppo non è così. Non c’è nulla che confligga di più con la figura femminile del modo di pensare fascio/sovranista che oggi domina il mondo maschile.
Che una donna, e dunque una madre, potesse avere inclinazioni retrograde/ maschiliste di questo tipo proprio non me lo ero figurato. Che in tutto il mondo la figura del “Padre” – cioè un principio ordinatore – sia sottoposta a una vasta
opera di demolizione e venga sostituita da marionette rigide guidate da terrori inconsci (prevalentemente paranoia), mi era chiaro da tempo, ma che potesse accadere anche alla “Madre” davvero mi ha colto di sorpresa.
Queste figure, con il loro pensiero rigidamente unico, maschi o femmine che siano, ci portano fuori dal tempo. Un’onda di retrocessione temporale ci avvolge, colorando le nostre case, i media e le nostre istituzioni di padri/madri padroni di antica memoria, di feudalesimo, a volte, direi, con tutta l’arroganza, l’incapacità di ascoltare e la prepotenza che ciò comporta. Quanto alla sinistra, essa oggi somiglia “sinistramente” alla “chiacchiera” di cui ho parlato prima.
Madre, dicevo. Dunque una figura di cura, accoglimento, sicurezza, amore. Un contenitore quieto, un porto certo dove rifugiarsi, una ricarica perenne di certezza... ma quale sicurezza, quale amore può dare una madre di tipo “Trum- piano”? Davvero temo, soltanto una degenerazione di sicurezza, accoglimento, amore. Essa segue “valori” piuttosto “militari”, rigidi, non contrattabili, non dialoganti. Non-valori, allora; ma se parliamo di non-valori, parliamo di una degenerazione dell’amore e dunque della madre: una Madre/Morte, Thanatos, mentre Eros scompare.
André Green diceva che siamo tutti figli di una madre morta; comincio a temere che sia vero.
Una madre di questo tipo non sarà mai portatrice di un “oggetto trasforma- tivo” interiore che permetterà lo sviluppo normale del bambino. Non sarà mai “sufficientemente buona”, come diceva Winnicott. Se ama è un amore conflit- tuale; potrà anche essere “tenero” verso il proprio bambino, ma sarà odio contro chi non è come lei. Inutile dire che il figlio, per essere amato, dovrà esser come lei. Una madre di questo tipo non diventerà un principio interno capace di creare linguaggio, ma continuerà a trasmettere soltanto la sua “estetica” personale che, a mio avviso è tutto meno che relazionale. Essa genererà un linguaggio rigido, unilaterale, muto.
“Col tempo, nelle situazioni normali, l’estetica materna cede alla struttura del linguaggio, e a questo punto l’essere può essere detto [...] Con la parola il bambino ha trovato un nuovo oggetto trasformativo, che facilita la transizione dalla riservatezza profondamente enigmatica alla cultura del villaggio umano. (Bollas, L’ombra dell’oggetto, 1987, p. 44).
Quello di cui ho paura è il “villaggio umano” che si prepara.
A questo punto non mi resta che chiedermi, con MajaKovskij: “Dove si appresterà per me una tana?” Non ne ho la minima idea.
Id: 3647 Data: 12/04/2025 18:45:33
*
- Storia
Wilusa: la non guerra di Troia
Premessa
Questa storia si basa sulle tavolette della biblioteca reale di Attusha, capitale dell’Impero Ittita cui Wilusa era alleata. Le parti in corsivo ne rappresentano una trascrizione “quasi” fedele. Il resto, temo sia opera mia.
Wilusa
Non credo sia andata come dicono; tutto ragiona contro.
Troppe le voci, dissipate dagli anni. Sussurri, a volte, trasportati da sabbia proveniente da luoghi improbabili, tramandati da ricordi comunque imprecisi, forse fantasie.
Tremilacinquecento: gli anni ormai trascorsi. Un sospiro nei secoli del mondo; per noi, quasi un’eternità. Mi sono sempre chiesto come quei fatti si siano svolti davvero. Omero: solo un nome. Racchiude racconti. Di notte, intorno al fuoco, per ingannare il sonno che galleggia, con memoria tesa a ricordare. Cosa non andava dimenticato? Che importanza aveva, perché proprio quegli eventi?
Le storie di città sono infinite; cosa aveva quella di diverso? Forse, ciò che si voleva non dimenticare era una presenza. Forse la bellezza, con la passione che induce. Forse, in quelle notti accanto al focolare, o al bivacco dei campi nel deserto, dove la voce scansa la paura, si imprimeva ciò che trasforma i fatti in sentimenti, li scolpisce rendendoli perenni.
Si voleva fosse ricordato che la vita non è soltanto svolgimenti. Ciò che li crea e che da essi viene ravvivato: la bellezza del significato, questo si voleva tramandare. Elena ne era nome, rappresentazione e inganno. Perché non era lei: attraverso lei.
Questa duplicità ci è pervenuta e spesso ci confonde. Non Elena ma Elena. Quale delle due? Nessuna; entrambe. L’una rimanda all’altra. Ne seguirò l’esempio, perché doppia è la vita che ricorda. E nel ricostruire con le fonti i fatti, per quel poco che il tempo ci ha concesso, disegnerò una storia che da quei fatti nasce e mentre li conferma li smentisce. Se il tuo nome suscita passioni, darò corso alle mie, facendo ciò cui la passione invoglia: inventerò di te: non Elena ma Elena. Non è andata così ma così è andata.
Prima lettera di Hattusili III
Io Hattusili III, Signore di Hattusa e delle terre nelle quattro direzioni del vento, dal deserto d’Egitto alle sabbie incompiute dell’Arabia, dai grandi monti ove il mondo finisce, allo specchio del mare; Signore delle genti che in esse vivono e delle città che vi hanno edificato, come dei campi, delle messi, gli animali e i figli, nati o che verranno; degli eserciti e gli dei che le genti straniere onorano, che tutti dovranno servirmi al mio comando contro le orde senza onore che saccheggiano e massacrano al di là delle terre conosciute. Signore delle acque, delle fonti, delle foreste e il cielo per volontà del Dio Supremo della Tempesta e la Signora che al Suo fianco siede, nonché delle divinità eterne che popolano il mondo e i suoi venti, ciò che è vivo o passato; Io, Hattusili, come mi conosci, ti dico di presentarti a me. Se lo farai non dovrai temere per la vita. Se disattenderai il mio volere, come in passato troppe volte hai fatto, verrò Io a cercarti. Non fare che ciò sia.
Presentati e avrai onoranze quando la morte ti frammenterà. Non per mia mano. O per la mia, se le tue orecchie non mi ascolteranno.
Questo doveva dirti Hattusili, Signore di Attusha e delle terre nei quattro punti del mondo… questo ti dice… questo…
Piyama Radu (vedremo in seguito a chi questo nome appartiene) non rispose mai.
Hattusili era un re, se non per nascita certamente di fatto. Non un guerriero, ma stratega. Piyama Radu era un poveraccio. Nome improbabile il suo, quanto rivelatore: Piyama vuol dire dono, Radu era una divinità benefica presente nelle case in Anatolia. Dunque, dono di un dio benevolo.
La dice lunga sulla madre, che un padre non chiamerebbe mai un figlio in quel modo. La immagino in un villaggio, forse di frontiera, di quelli presenti in Anatolia da tempo immemorabile, tipo Arslan-Tepe o Chatal Hoyuk, spesso spazzati dalla guerra, la sorte o dai pirati.
Al pascolo, con le capre. Quando un giorno qualcuno che passava con le armi, uno dei tanti soldati transitati da lì, forse Ittita, forse di una delle bande achee che facevano razzie lungo la costa, l’ha violentata per ricompensa di una vita grama.
Se ne è tornata a casa stringendosi le gambe, per la vergogna e un po’ per il dolore. Quel figlio l’ha tuttavia voluto; un dono, per lei, in ogni caso. E dono l’ha chiamato, attribuendo il regalo a una delle statuette di terracotta che teneva accanto al focolare, una di quelle cui rivolgersi per trovare il coraggio per un giorno nuovo: Radu, a lei caro.
Offriva protezione Radu; da cosa? Proviamo a immaginare uno di quei villaggi. Quattro capanne strette attorno a un palo, con un muretto a secco lungo i lati e una torre all’angolo, tipo Gerico nello strato più antico. Perché rinchiudersi? Il limite rassicura, permette di conoscere, nominare gente e cose, riconoscersi all’interno di certezze. Fuori, dove il deserto spazia in mezzo al vento e l’orizzonte è sempre sconfinato, qualunque cosa suscita sgomento. Osservare il mondo per la prima volta, con gli occhi di una coscienza incerta, rappresentata da quei limiti angusti di fango e terracotta, senza più fare parte del Grande Niente che adesso conosciamo, essere confusi in esso nell’indifferenziazione che protegge, è esperienza che scuote, rende insicuri, spesso terrorizza Così ovunque, al principio; in altre forme anche oggi.
Eh sì, si era attivato l’Io, al centro di un barlume di coscienza. Un campo psichico, se preferite (ma psiche è parola compromessa, quasi in disuso, oggi fuori moda. Inutile parlarne). Oggi conta il comportamento, ottima scorciatoia. Perfetta per evitare l’anima.
Dunque, rendersi conto spesso fa paura (per questo lo evitiamo). Ci vuole poco poi a popolare la pianura di fantasmi, misteri, nemici, da accogliere come tali, dato che anche loro ti vedono nello stesso modo. Bella complicazione davvero! Soprattutto se non se ne parla. Comunque, quando guardate uno strato antico, tipo quello che ho descritto prima, osservate una forma di coscienza.
Dinastie
Hattusili nacque da famiglia reale. Fratello del gran re Mursili, credo il terzo; uno di quelli che non scherzano. Neppure Hattusili. Stratega, generale, fa le fortune in guerra del fratello. Anche a Qadesh. dove Ramses II volta il carro.
Gracile, Hattusili, malaticcio; da bambino rischia di morire. Lo salva Isthar, cui deve la fortuna e rimane devoto. Due dei alla base del rapporto, una femmina e un maschio, ma Isthar era più grande.
Piyama non poteva vantare discendenza e la divinità cui qualcosa forse doveva era piccina. Lo ha salvato la madre. Perché lo ha voluto e gli ha voluto bene. Su questo non ho dubbi, altrimenti non gli dava quel nome. Due madri, dunque; una, però, reale. Quale conta di più? Temo entrambe. Temo nessuna.
Intanto una notte, di quelle che capitano, Mursili se ne scappa all’altro mondo (ormai qui ha preso tutto e si è scocciato). Gli succede il figlio: un cretino, come spesso accade.
Hattusili non poteva sopportarlo. Sempre secondo, nella salute come nella vita. Si prende il trono e il nipote se la passa brutta. Non lo ammazza: lo esilia.
Piyama Radu non viene cacciato, che la madre non viveva che per lui. Se ne va.
Non può restare lì; non è nessuno. Gli bolle la pelle sotto i piedi; l’aria lo asfissia. Sente l’ansia del padre, il dubbio, la sfida, la tentazione, la rabbia, la vergogna.
Scappa col primo esercito che passa – ne passavano tanti – ed esce dai pensieri delle donne per conoscere quelli del maschile. Che non fa sconti: o marci o resti indietro, se non ti accoppano prima.
Per non sbagliarsi, capisce che è più utile accoppare. Cresciuto ha già la barba e un coltellaccio qualcuno glielo ha dato. Nelle notti nel campo, quando scappa la rissa e il vino corre, tra bagliori di fuoco e roche urla, ammazza uno che lo ha provocato pensando fosse solo un ragazzino. Il suo primo guadagno nella vita: rispetto. Poi, quando ha preso una donna, ha smesso di pensare la madre: è morta quella notte.
Non era difficile; si trattava soltanto di eliminare qualcuno (magari il marito o i fratelli). Succedeva spesso lungo la costa colma di villaggi. Città, anche; bastava bruciacchiarle. Ha sparso sale su più di qualche pietra. Col suo compare, Tawagalawa, fratello del Gran Re degli Ahhyawa (Achei).
Un giorno, però, quando arrivò a Wilusa, si fermò. Non ebbe cuore di bruciarla; la voleva per sé.
Lungo la costa nord, dove il mare si spezza e il mondo crolla verso l’infinito.
Di pietra rosa, quasi come un velo, come quello che strappò alla prima donna. Col fiume che la cinge fino al mare. Bella, come un desiderio: Wilusa (Wilion per gli Achei; poi Ilion, Ilio, come la conosciiamo noi).
Sopra un confine; e il mondo che finisce non ha nome. Perché ne inizia un altro, dove chissà che cosa. Una parola dal suono di magia: possibilità. (Comunque, senza troppa retorica, tutti i commerci da e verso l’Asia dovevano necessariamente passare da lì. Ottima ragione per una scelta).
Non solo sua, che gli Ahhyawa hanno tentato di prenderla per duecento anni. Lui c’è riuscito. Per questo, però, è ancora presto.
Al Grande Re degli Ahhyawa, di là del mare, nella Sua Città.
Degnati, Signore, di ascoltare Tuo fratello Hattusili.
A Te rivolgo queste mie parole affinché Tu, Grande Re, voglia capire.
Tuo fratello Tagawalawa, sangue del sangue che Ti scorre dentro, mi offende. Egli distrugge i miei possedimenti con l’aiuto di quel cane senza terra. Semina morte presso le mie case, distrugge i miei raccolti, ruba figlie.
Non per costruire, che ciò che edifica lo distruggo io. Quanto dovrà durare questa guerra? Fermalo, Grande Re e dammi il cane. In catene presso la mia casa. Da troppi anni sfugge il suo castigo.
Non Ti chiedo di farlo: Te ne prego. Altri patti in passato abbiamo fatto ed entrambi ne raccogliamo frutti. È tempo di accordarci, perché Hattusili non tollererà altre discordie.
Ultimamente, dicono voci alle porte della Casa, Tuo fratello Tagawalawa insidia Wilusa. Questo non è concesso; se toccherà la Rocca sarà guerra. Non mandare Tue truppe in quelle zone, resta lontano.
Stretto dei Dardanelli, promontorio, 1240 circa a.C.(ora più, ora meno…).
Tempesta. Vento spazza la piana. Soffoca, tra polvere col fumo.
Fuochi lungo le mura e sopra i campi. Molti corpi crollati alla rinfusa. Odore nauseabondo e di bruciato. Sangue, anche, diffuso dentro l’aria e nei polmoni. Sciacalli, naso a terra, nella piana. Qualcuno ancora si lamenta.
Piyama (stravolto): scaglia l’ultima lancia. Poi s’asciuga (saliva, sangue, sudore sulla faccia). Puzza: sotto il metallo che lo copre.
Ha occhi strani. Pieni di rosso. Gonfi. Sembra un invasato. Ansima, urla. Fa qualche passo; barcolla; poi riprende… quindi di slancio verso la città.
Dal fumo: s’apre la porta. E’ nostra… è nostra… ! Grida Tagawalawa. Tu la governerai, in nome di mio fratello Re di Tebe!
E tu…!?
Ritorno in Grecia a prendere altre truppe. Dobbiamo tenerla… Dopo tocca a Lesbo!
Non durò molto.
Qualche mese dopo: piana di Wilusa
Dal carro: Hattusili comanda la giornata.
Bruciate le porte. Sterminateli. Portatemi il predone o la sua testa.
Non era cattivo, Hattusili: faceva i suoi interessi, a parte le incertezze che nutriva.
Ha cercato per anni di giustificarsi. Si sforzava di costruire una discendenza accettabile, falsificando la genealogia fino a far risalire la sua nascita a Hattusili I il Grande.
Era il secondo e gli bruciava; il trono spettava al nipote, Urkhi-Tesup, al sicuro nel regno di Ramesse che ne rifiutava l’estradizione. Poteva sempre tornare…
Pagò, anche, per consolidare la posizione, con ricche donazioni e svariate remunerazioni ai suoi fedeli.
A parte ciò, aveva persino tratti gentili: la sua è la prima storia d’amore raccontata nel mondo.
“E allora presi in sposa Puduhepa, figlia di Pentipsarri, il sacerdote, per ordine della divinità. E vivemmo nell’unione coniugale e la divinità ci donò l’amore dello sposo e della sposa e noi generammo figli e figlie”.
Incontrò Puduhepa da ragazzo, durante un viaggio a Kizzuwztna. Era anche lei sacerdotessa di Isthar, come il padre, e la Signora cui Hattusili doveva la vita li ispirò. Vissero nel suo culto e alla sua ombra; una vita nel nome della dea che entrambi amavano mentre si amavano.
Hattusili diede alla moglie pari dignità. Governò da regina, dotata di sigillo. Dunque, poteva comandare; dava disposizioni che firmava. Decidevano insieme: politica, trattati, culto e figli, con la pietà che la responsabilità ispira a chi la sente.
Ramesse la chiamava sorella e sposò una sua figlia. Forse era bella Puduhepa; comunque saggia. Il marito le dedicava poesie. Rimase Grande Regina anche dopo la morte di Hattusili, fungendo da reggente per il figlio Tutkhaliya IV.
Sappiamo tutto dalla autobiografia di Hattusili. Non è cosa da poco; ci dice che aveva il senso del soggetto, cosa che, a quei tempi, è per lo meno rara, data l’indifferenziazione dilagante. Per questo si amavano: erano due, non propaggini di proiezioni inconsce.
Credo pregasse a lungo Puduhepa, soprattutto al capezzale del marito (era di salute malferma, ricordate?) Da lì a poco di preghiere avrebbe avuto un gran bisogno. Anche Hattusili.
Radu tornò a fare quello che aveva sempre fatto. Era bravissimo (a fare scorrerie). Dicono battesse la campagna devastando villaggi, depredando, ammassando schiavi (soprattutto donne). Le Anatoliche erano richieste.
Ha terrorizzato la Troade per anni, senza che Hattusili riuscisse a metterci rimedio. Le truppe che mandava le ammazzava; quando erano troppe, evitava lo scontro. Ha inventato la guerriglia.
Lo ha fatto per anni, insieme ai Greci, tanto che se ne è conservata la memoria. Immaginiamo quanto se ne sarà parlato, quante storie saranno nate in proposito. Che la memoria raccoglie, raddensa e poi trasforma. Nascono leggende, nascono miti. Immaginiamo il terrore che ogni avvistamento di manipoli di uomini all’orizzonte suscitava nei villaggi indifesi della campagna. Le grida, la fuga delle donne, il raccogliere armi dei pochi uomini presenti, in genere vecchi: i giovani erano lontani, nei campi. E poi la sera, a cose fatte, quando se ne parla intorno al fuoco e si contano gli assenti. E la voce che fugge, si diffonde nei villaggi vicini. Che tuttavia già sanno, e parlano, e tremano. Fa pensare ad Achille quando bruciava la terra intorno a Troia. Un nome per una storia: la sintetizza.
La guerra e la passione
Hanno tentato per duecento anni. Fondavano colonie; quegli altri le bruciavano; attaccavano isole e città che gli Ittiti poi riprendevano e così via per secoli. Prima i Tebani, con la loro lega. Poi, alla caduta di Tebe (1230 circa a.C.), Micene con le città federate al seguito. Tanto è durata la così detta guerra di Troia. Non una guerra: molte. Racchiuse in un poema, ricordi di anni trasognati nel mito.
C’era la gente, non dimentichiamo: pensate come hanno vissuto. Per secoli; lascerà qualche traccia, no!? Perché resti il ricordo non bastano parole. Devono incidere, essere pregnanti, trasmettere qualcosa che rimane.
Affetti, restano gli affetti; sono loro che fanno la memoria. In qualche modo, da qualche parte, deve “toccare”. Rimandare, per lo meno, a qualcosa cui attribuire significato. Questo incide la carne, al centro del cervello, un poco a sinistra, appena laterale.
Cosa più adatto di un amore… Una donna (possibilmente bellissima) che valga per tutte coloro che hanno amato, sofferto, generato e, ovviamente un uomo, meglio se ispirato da una dea (Afrodite è perfetta alla bisogna). Un marito, anche, tradito. Le passioni sono sempre ambivalenti; meglio sconvolgano. Con il senso di una colpa: lecito quell’amore o meno? Più si intorbida meglio è; più facile rimanga impresso. Ad immortalare pensa l’epica: fatti adesso gesta, trasognati dalla poesia che dà spessore, immette il caduco nell’eterno. Con le passioni di pochi che diventano di tutti, universali. Che le passioni dovevano restare; con esse, ciò cui rimandavano. Non qualcuno in particolare: un’epoca. Come se la storia si fosse preoccupata di tramandare se stessa. Perché?
L’ultima notte di Hattusili III. Città di Hattusa, 1240 a. C. circa.
Il suo fisico minato da una salute incerta e molte guerre alla fine lo abbandonò. Lasciò il regno alla moglie. Costei goverò per rmolti anni, rispettata e amata dal popolo. Non durò in eterno; fu esiliata, ma questa è un’altra storia.
Città di Ugarit, 1200 a. C. circa. Notte di Piyama Radu.
Notte divaga confusa, alla deriva fino all’orizzonte.
Sciacquio da presso con la brezza lieve. Spume, anche, leggere. Rumore sciacquolante di risacca.
Movimento ripetuto avanti e indietro. avanti… ancora indietro… Invoglia sonno.
Osservando il mare. Pure sembra tranquillo… come è possibile che il pericolo venga da lì?
Sono troppo vecchio per rispondere ancora alle domande.
Come vuoi, ma la lettera parla chiaro.
Lettera?
Non l’hai letta? L’ha preparata il Governatore in persona, da inoltrare d’urgenza a ogni città!
Figurarsi… metterà mesi ad arrivare.
Sono d’accordo.
Abbiamo mesi?
No.
Alzando le spalle. Si chiude nel mantello.
Lasciami dormire, và…!
La lettera
Quella lettera non è mai partita. L’hanno ritrovata nel palazzo del Governatore di Ugarit ancora in preparazione, in cottura, per così dire (le tavolette andavano cotte, al forno). L’avvertimento che conteneva è andato in fumo.
La situazione non sarebbe cambiata. Da terra i Lydi e i KasKa; dal mare i Dori, i Sardi, i Filistei e tanti altri di cui non riporto i nomi (troppo complicato scriverli). In breve: i così detti Popoli del mare.
Navi che portavano fuoco, a ondate successive, ininterrotte. Per anni, senza praticamente protezione.
Gli Ittiti si erano annullati tra guerre dinastiche e civili e, senza di loro, le Città Stato non si federavano più. Affrontavano il pericolo una a una e una a una cadevano senza risorgere, perché gli invasori non sapevano ricostruire. Come le cavallette: prendevano e salpavano. Si è salvato solo l’Egitto, attaccando da terra le loro navi all'altezza del delta del Nilo e riuscendo a inmpedire loro di sbarcare. Se avessero toccato terra anche l'Egitto non avrebbe avuto scampo.
Gli strati VI e VII della città di Troia (ormai possiamo chiamarla così, no?) raccontano di incendi devastanti e basta. Come basta? Basta. Non sì è trovato altro; nessuno ha più ricostruito. È finita lì. Morta per quattrocento anni. Non per mano achea. I Greci non avevano interesse in tal senso (a loro serviva attiva). Sono stati quegli altri.
Piyama non ha trovato casa; come lui, nessuno. Per quattrocento anni di totale oscurità, come se il sole fosse andato via.
La fine del mondo. Proprio così, del mondo. Perché il Vicino Oriente, in quei secoli, era il mondo. Strada di civiltà, percorsa da popolazioni varie, credenze, idee, culture, rappresentazioni antiche che venivano da lontano calate in nuove forme. Hanno lasciato di tutto: scienza, religione, architettura, filosofia. Soprattutto parole, rese eterne da simboli incisi nella creta. Ci hanno costruito: senza di loro, nulla. Neppure la Grecia classica che è venuta dopo!
Questo bisognava ricordare: era finito un mondo. Anzi, il mondo. Non poteva andare perduto.
A questo la memoria serve. Senza, non si ricostruisce. Non si va avanti e neppure indietro. Proprio da nessuna parte: manca continuità.
Che si chiamasse Elena, Paride, Achille poco importa. Era il mondo e non c’era più. Con i suoi dei, le case, le visioni, passioni, vite, tentazioni, sogni, desideri, storia. Non poteva finire.
I pochi che sono rimasti, nascosti alla furia dell’ignoranza, dentro tuguri tra la neve e i monti, come a Creta, hanno pensato a non dimenticare. Per secoli hanno ricordato; la memoria collettiva ha fatto il resto.
Quando studiamo Omero, se ancora nel liceo verrà studiato, pensiamo un poco a loro. Dobbiamo ringraziarli. Ci raccontano molto; guidano l’occhio anche nel futuro. Non vi fidate se il mare questa sera non si muove. Spirano venti noti, venti vecchi. Portano tempesta da lontano e quando arriva allora è troppo tardi. Come diceva Hattusili: fa che non sia.
Piyama Radu se ne è andato via: la sua casa è la morte. È nato da una madre come noi e come noi ha dovuto fronteggiarne la presenza. Non aveva padre, come tanti di noi e ha dovuto sopportarne la mancanza.
Ha fatto quello che poteva, che il tempo in cui viveva consentiva: il suo destino.
Ogni tanto, la sera, parliamo di cavalli.
Id: 3602 Data: 24/02/2025 19:13:27
*
- Letteratura
I narratori
Ultimamente, nel mio attuale tempo senza tempo, sto rileggendo alcuni libri letti molti anni fa. Oggi ci scivolo dentro quasi senza accorgermene e, soprattutto, senza prestare alcuna attenzione a trama o stile, come facevo una volta.
Cosa mi resta allora di quel che leggo o, per meglio dire, ri-leggo? Qualcosa che non ni aspettavo, tipo una serie di associazioni involontarie, che quasi mi sorvolano la mente mentre leggo, non su quel che leggo ma su chi lo ha scritto. Non penso tuttavia all’autore. Si tratta invece di associazioni proprio sulla narrazione, sulla capacità di dire, e questo mi stupisce.
Quali gli autori (o il loro raccontare) in considerazione? Dostoevskij e Faulkner, Faulkner e Dostoevskij: narratori. Quanto ai romanzi, si tratta de L’Idiota e La paga del soldato.
Due romanzi lontani nel tempo – non il mio, proprio tra loro – dove tuttavia rintraccio qualcosa di comune: un destino. Una specie di ineluttabilità, qualcosa che trascina verso un punto senza che nessuno se ne accorga o riesca a farci niente. Ma lì trascina e arriva, inevitabilmente.
Lì vanno, senza saperlo, Joe o Donald, un vero e proprio morto che respira che neppure sa di esserlo. Lì vanno Margaret – che si accorge di tutto ma non può farci niente – o Il principe Minskij, e le donne che ama (o crede di amare) e che di lui faranno quello che lui è: un idiota.
Gli uni si muovono nella provincia americana del sud, gli altri nello splendore di Pietroburgo e delle ville che la circondano, ma tutti vanno dalla stessa parte.
Non starò a riassumere la trama di questi romanzi né le molteplici sfaccettature dei personaggi che li popolano; a questo hanno pensato i narratori. A me è venuto altro per la testa e quello devo cercar di tirar fuori.
I narratori, dunque, la loro capacità di narrare; cos’è questa capacità? Semplicemente costruire mondi, con tutte le enormi complessità che i mondi hanno. Occorre ricostruire l’ambiente dove i fatti si svolgono, la natura che li avvolge; la cultura da cui essi sono plasmati e le esperienze e i traumi che hanno reso fatti e personaggi come i narratori li descrivono.
Passioni, passioni, passioni; preferibilmente sconvolgenti. Ogni tanto un po’ di raziocinio, ma di rado. Si, qualcuno a volte pensa; di rado. Un lavoro di immensa complessità. Tuttavia semplicissimo: basta osservare. I narratori non inventano nulla: osservano. Ovviamente, occorre anche saperlo fare e raccontare.
E rendere piacevole ciò che si racconta, interessante; persino avvincente. Coinvolgerci devono - i narratori – e spesso ci riescono perfettamente.
Dunque coinvolto, rintraccio il mio destino – essere coinvolto – e il loro. Tuttavia, il loro destino (quello dei personaggi) non lo hanno deciso i narratori; essi lo hanno solo descritto: quel destino esisteva già. Attraverso gli intrighi, gi intrecci, le nevrosi, gli amori, gli inganni, quel destino si snoda. Tra boschi, fonti e ruscelli, pascoli e vigneti, scintillii di metropoli e campagne. Giorni tormentosi o luminosi; canti di uccelli e luna. Sere, spesso; comunque notte. La notte si dipana al suo calare e coinvolge tutti.
Dove mi trovo io in quelle notti? Dovunque con loro; e inevitabilmente in nessun luogo.
Un mondo, molti mondi, tutti i mondi; comunque lo stesso mondo: il nostro. Però attenzione; come ho detto, i narratori non inventano nulla: osservano. Magari esagerano un po’, ci intingono un po' la penna, ma al fondo fanno del particolare, dei casi della signorina tale o del signor comunque una generalità che va bene per tutti perché ci rappresenta tutti. Con stile più o meno variegato, discorsi espliciti o impliciti. Si, a volte, i narratori ci lasciano immaginare.
Descrizioni di banalità e frasi meravigliose, orrori e splendori, atrocità e amore, proprio come la vita, banale e splendida sempre.
Fino alla dissoluzione. Così come avviene. Semplicemente. Senza alcuna volontà.
Id: 3600 Data: 18/02/2025 12:32:10
*
- Arte
Il silenzio del vuoto: da Caravaggio a Munch
Tra pochi giorni si terranno a Roma due mostre estremamente interessanti, una a Palazzo Barberini dedicata a Caravaggio e l’altra a Palazzo Bonaparte dove verranno esposte opere di Munch. Già le sedi delle esposizioni sono di tale interesse artistico che varrebbe la pena recarvisi solo per la bellezza delle architetture. Se poi in tali sedi splendide si espongono opere meravigliose andarci è quasi un obbligo, se obbligo non fosse costrizione.
Caravaggio e Munch, così distanti nei secoli, eppure, a detta di chi scrive, estremamente vicini per messaggio. Quale messaggio? Una voce che tace di silenzio: il silenzio di Dio.
Entrambi abitano il vuoto e al vuoto conferiscono parola; dovremo dire come.
Caravaggio spoglia il cielo; lo trascina letteralmente sulla terra. Lo rende carne, ossa, sangue; che fa sgorgare, perché l’uomo muore. Spesso una vita estirpata, spesso con violenza, ma non è il personaggio che subisce: nell’immagine terrena la violenza la subisce il sacro.
Il sacro, allora, muore; perché viene tolto dalla trascendenza e immesso nell’immanenza. Fatto di terra, il sacro si fa vero. Per questo le opere di Caravaggio venivano rifiutate.
Cristo morto e deposto, San Pietro crocifisso ai limiti dell’agonia, la Madonna ormai morta e tante altre vittime e carnefici. Il carnefice è l’uomo.
L’uomo diventa carnefice nella misura in cui spoglia il divino di sacralità. Come ho detto, lo fa di carne, ossa e sangue: lo fa uomo e morire perché l’umano muore e questo è verità.
Cristo è morto per salvarci dalla morte, ma per farlo ha dovuto morire. Dalla morte non si prescinde. Né dalla vita, come testimonia il Cristo all’osteria, dove sceglie un discepolo tra vino e denaro, avidità e scompenso, nella miseria dell’umano vivo che inevitabilmente morirà, come dice quello stesso discepolo mentre, in un altro quadro, scrive con un teschio sullo scranno.
O la Madonna dei pellegrini, una popolana, scura, diffidente. Di fronte a cosa? Di fronte all’illusione.
Il cielo è nudo e Dio, ormai, non lo abita più. Sta qui, dove l’intuizione artistica lo pone. Qui, nel mondo, che non è un paradiso.
Fin qui Caravaggio, ma perché Munch? Forse il suo “urlo? Certo, Munch grida, ma cosa? Cosa quell’urlo dice? E non solo quel quadro troppo noto; anche altri.
Se nell’urlo la bocca è spalancata, altre figure sono silenziose; spesso prive di lineamenti. Se ne hanno, tacciono. Come l’uomo sul ponte di fronte a un mare in tempesta. O i personaggi della stanza in bianco e nero. O altri, soli in una stanza, cui Hopper si è senz’altro ispirato.
O folle lungo la strada, senza occhi né bocca, o gruppi di figure allineate una accanto all'altra in qualche ambiente, che ci guardano mentre le guardiamo in un dialogo che è dire senza dire. Nessuno grida: solo silenzio, ma quel silenzio è urlo.
Cosa grida quel silenzio muto? Grida di solitudine, estraniazione, abbandono. L’uomo è solo, privo di protezione, di fronte a se stesso e al gran vuoto di un mondo specchio di un non senso grande. Dio, che un tempo offriva senso, è dunque morto e il mondo ha perso una promessa grande: nessuno risorgerà o, se lo faremo, adesso siamo morti.
Né abbiamo compagnia. Ognuno è solo, nella propria prigione depressiva, come lo è l’uomo oggi, rinchiuso in un silenzio virtuale dove nessuno parla se non per simboletti o chiacchiere da tik tok, spesso balletti; una morte di Dio che oggi non interessa nessuno perché è morto anche l’uomo. Questo Munch non lo sapeva, ma aveva intuito dove andava il tempo.
Coscienza dell’abbandono: questo il grido di Munch. Un grido più disperato di quello di Caravaggio. In Caravaggio è morto il cielo, ma il trascendente trasmigra nell’umano; in Munch non c’è proprio nessuno.
Queste le esposizioni di cui ci parla Roma, una città ormai morta che di se stessa dice e di un morire antico.
Id: 3585 Data: 04/02/2025 18:37:33
*
- Letteratura
Dove la notte non finisce mai
.
Ho appena terminato la ri-lettura del Viaggio al termine della notte, scritto nel 1932 dal Dottor Destouches, meglio noto come Louis-Ferdinand Céline. Non so perché l’ho fatto; forse per noia, forse per masochismo o forse ancora per una strana quanto non dichiarata attrazione per qualcosa di malsano, in un periodo malsano, che mi ha trasmesso tutto il fascino e il malessere di ciò che malsano non è, o almeno non soltanto.
Ne ho ricavato soprattutto un’impressione che, più che tale, si è rivelata una dichiarazione di non identità: non avrei mai voluto essere Céline.
Non avrei voluto esserlo perché Céline non sa chi è; nonostante la sua ricerca spasmodica, Céline sa soltanto chi non è. Céline non è Céline, ma neppure Bardamu perché Bardamu non è neppure un morto.
Un senso dell’inutile pervade tutto fin dalla prime pagine, dall’arruolamento insensato al nulla spaventoso della guerra. E i morti, le teste che cadono, gli ordini senza senso, la mancanza di scampo.
Un uomo dominato dalla corruzione delle viscere, Céline; dalle trippe, come le chiama lui. Dal disfacimento, dalla distruzione di tutto ciò che è vivo e pertanto corruttibile. Dominato dunque da un pensiero ossessivo, quello della morte.
Dall’impossibilità di amare è dominato Bardamu perché non si può amare ciò che muore, o almeno non lo si può amare abbastanza. Ma neppure odiare, perché anche l’odio è un sentimento e dai sentimenti è meglio tenersi lontano.
E tuttavia il dolore: Bardamu non è insensibile al dolore. Se lo sente intorno, lo vive, lo trasuda, come le febbri africane da cui è afflitto e dalla tubercolosi dei sui pazienti senza speranza, perché dove esiste soltanto la morte non può esserci speranza,
Ma Bardamu non è disperato; non è capace di disperazione. La sente, la percepisce, ma ce l’ha solo intorno; non è sua. Cosa allora gli appartiene? L’orrore di esistere.
Per Céline-Bardamu esistere è impossibile: si può soltanto sfuggire. Per questo la sua vita è una fuga; nulla può essere raggiunto e se, per qualche strano caso del destino ci si avvicina a una qualsiasi forma di conseguimento, occorre subito disfare, distruggere, buttare tutto all’aria e ricominciare altrove, in qualche luogo ancora peggiore, in una fuga senza fine da sé, da un reale impossibile, dal mondo che non è altro che morte.
Spesso tornare sui propri passi, in luoghi già vissuti, perché la morte è ovunque e non esiste un luogo immune, ma tornare non è altro che riconsegnarsi alla miseria, a tutto ciò che è un vivere da morto in una Parigi tetra, una campagna tetra, un tetro trascinarsi nella coazione dell’inevitabile fine. Bardamu fa il medico ma ogni cura è impossibile.
A volte Le Voyage mi ha ricordato Fuga senza fine di Joseph Roth ma, a parte l‘evidente differenza di linguaggio tra i due autori, ogni accostamento è improponibile per via della disperazione di Roth che è sempre malinconica mentre quella di Céline è feroce. O ancora mi ha ricordato Santuario di Faulkner, ma lì l’orrore è poesia.
Vivere è dunque miseria e non soltanto del corpo. L’uomo è soltanto un miserabile che di miseria vive, fisica e spirituale. Vive di guerra l’uomo, di massacro, di abiezione perché l’uomo è solamente abietto. Trippe verminose, impulsi non gestibili, godimento fine all’attimo e all’attimo consegnato e, per godere di quel miserabile attimo, ogni mezzo è possibile.
Una natura grigia, ostile, disperante: una natura notte. E tuttavia, la notte è comunque un rifugio. Lo è perché la notte tutto sfuma e, se il mondo insopportabile sfuma, noi stessi sfumiamo. Nel rifiuto del reale, forse un’illusione: che la notte celi qualcosa di diverso che tuttavia non sopraggiunge mai.
Vivere è un incidente in cui tutto si disfa e Céline-Bardamu, qualunque cosa faccia, finisce col disfarla dato che tutto finisce nella morte. Anche l’amore, nella sua forma perversa di ossessione, sfocia nella morte, come nell’episodio della folle Madelon che condurrà alla fine di Robinson.
“Nella camera sembrava come uno straniero adesso Robinson, che veniva da un paese spaventoso, e uno non osava più parlargli”.
D’altronde, anche la parola è quanto di più inutile si possa immaginare: la morte è annullamento, la morte è silenzio.
Dimenticanza è la morte: dimenticarsi finalmente di sé. Céline non cercava altro e il romanzo è un lunghissimo addio da sé, dal mondo, dalla miseria di dover esistere, dal dolore da cui non ci si separa mai.
Due parole sullo stile. Quando lessi Il Viaggio, tanti anni fa, lo stile di Céline ni sembrò davvero rivoluzionario. Oggi anche il suo "parlato" mi appare datato e privo di qualsiasi fascino. Ahimé, cosa mi resta?
“Lontano il rimorchiatore ha fischiato, il suo richiamo ha passato il ponte, ancora un’altra arcata, un’altra, la chiusa, un altro ponte, lontano, più lontano… Chiamava a sé tutte le chiatte del fiume tutte, e il cielo, e la campagna, e noi, tutto si portava via, anche la Senna, che non se ne parli più”.
Id: 3559 Data: 20/12/2024 11:02:55
*
- Psicologia
Il silenzio della civiltà
Il mondo che abitiamo ha assunto spesso l’aspetto di un deserto. Basta pensare alla Terra “palla di neve” effetto di antiche glaciazioni che la geologia ci ha insegnato a conoscere, o al pianeta di sabbia che il deserto senza posa crea grazie anche alle variazioni climatiche, o ancora alla terra deserto d’acqua dell’immaginario mitologico che si riferisce al così detto diluvio universale. Il deserto cui intendo riferirmi è invece un deserto di parole, una “terra silenzio” spogliata di ogni significante e dunque priva di significati, un luogo che non parla che una lingua muta che nulla significa se non l’assenza che silenziosamente esprime.
La civiltà silente in cui abitiamo e che abbiamo costruito prima di ammutolire era espressione di duplicità. Lacerata dal conflitto tra natura e cultura provocato dallo sviluppo della coscienza egoica, la nostra civiltà “disagiata” viveva nel disagio creativo di quella che si presentava come unica condizione esistenziale, scomoda ma possibile. Sempre mal sopportata dal soggetto che ricerca il godimento, questa cultura sublimante e figlia della sublimazione è oggi soppiantata da una diversa forma di civiltà intollerante alle difficoltà dell’esistere, al punto da precipitare inconsapevolmente nella “comodità piacevole” del nulla.
Apparentemente viva, colma di benessere e piacere, dispensatrice di sapere e tecnologia, la civiltà attuale è specchio di quella forma di appiattimento psichico che si definisce psicosi, laddove con questo termine si indica una totale frattura del soggetto con la realtà oggettiva o, il che non cambia, un’identificazione adesiva acritica con la stessa con conseguente annullamento della realtà interiore.
Alla base del problema rintracciamo la dinamica desiderio-Legge dove, con questo ultimo termine, intendo riferirmi alla castrazione simbolica operata dal Padre Norma, mentre parlando di desiderio il mio rinvio è a Eros. Eros non si rivolge mai ad oggetti materiali individuati, a cose, è invece anelito e allusione.
Nella sua revisione del freudismo, Lacan afferma che ogni desiderare è figlio di mancanza, una mancanza che non si riferisce a oggetti perché Eros non si appaga nell’uso e nel possesso di cose. Eros rimanda allora a una condizione esistenziale di base: esso è mancanza d’altro che potremmo individuare come mancanza a essere e il suo è desiderio di esistenza. Tra desiderio e Legge non esiste allora contraddizione o conflitto, perché è proprio la Legge simbolica del Padre che, impedendo l’immediatezza del godimento, fa sì che Eros possa desiderare la mancanza. La castrazione del moto cieco pulsionale verso l’evidenza illusoria dell’oggetto rende possibile il passaggio del desiderio al piano simbolico del significato e dunque del linguaggio. Questo
sembra perduto, come se la nostra civiltà si fosse “deculturalizzata” consegnandosi al regno dell’immediato, a un’adesione cieca all’atto rivolto al puro godimento senza la necessaria pausa della riflessione.
L’istinto della riflessione è ciò che costituisce l’essenza e la ricchezza della psiche umana. La riflessione modella il processo di stimolazione e ne guida l’ìmpulso in una serie d’immagini, la quale infine, quando l’impulso è sufficientemente intenso, viene riprodotta. La riproduzione [...] si verifica in forme diverse: o come espressione linguistica diretta o come espressione del pensiero astratto, come azione rappresentativa o come comportamento etico, come ritrovato scientifico o come rappresentazione artistica [...] la riflessione è l’istinto civilizzatore “par excellence”, e la sua forza si palesa nell’affermazione della civiltà di fronte alla nuda natura. (C.G. Jung, Determinanti psicologiche del comportamento umano, in Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino, 1976, p. 136).
Se diamo credito alle parole di Jung, la civiltà in cui viviamo ha perduto il suo slancio creativo, regredendo a uno status di “natura” dove la psiche cessa di rappresentare e dunque manca il riflesso del senso soggettivo di esistenza. Questo discorso potrebbe essere continuato in molti modi, ricorrendo alle metafore junghiane del simbolo, o al linguaggio lacaniano della perdita del Nome del Padre o alla dinamica freudiana Eros-Thanatos. Sarà opportuno evitare troppi riferimenti diversi per non confondere il piano già abbastanza astratto del discorso.
L’idea di base è che il campo di coscienza viene seriamente infiltrato da elementi che definiamo regressivi in quanto arcaici, una specie di “diluvio universale” istintuale che allaga la coscienza riconsegnandola all’Inconscio da cui si è differenziata. Occorre tuttavia specificare cosa si intenda con il termine Inconscio o, per meglio dire, visto che il significato di quel termine lo conosciamo bene o male tutti, la domanda riguarda una specificazione poco dibattuta: quale Inconscio?
Questo ci fa già capire che Inconscio non è termine univoco ma può rimandare a raffigurazioni diverse della mente non cosciente. Freud pose il problema nel ‘22, quando in Al di là del principio di piacere (S. Freud, Al di là del principio di piacere, in Opere 1917-1923, vol. 9, Torino, Boringhieri, 1977) enunciò la dicotomia delle pulsioni. Fino ad allora l’Inconscio era il rimosso, dunque tutto ciò che la coscienza non gradisce e tenta, per altro inutilmente, di espellere da sé.
L’ Inconscio come rimosso non è muto, nel senso che, proprio attraverso il ritorno del rimosso, propone “messaggi” di significati possibili che la coscienza ha il compito di decifrare per tentare di riappropriarsi di un senso non compreso del se stesso.
Questa formulazione dell’Inconscio apparteneva al Freud ermeneutico di cui parla Paul Ricoeur (P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1979) ed “ermeneutico” era l’inconscio che si presentava come interpretazione di significati possibili alle soglie del soggetto. Dal ‘22 in poi tutto cambia perché l’Inconscio ammutolisce e mostra un aspetto di silenzio.
Thanatos non comunica: trascina. È moto arcaico verso la rovina, cieco impulso di niente, divoratore di cose e desideri che “cosifica” immettendoli nel vortice dell’immediatezza del godimento e deviandoli dal senso del significare proprio di un anelito che rimanda. L’Altro da sé (e con ciò intendo tanto la realtà esterna che quella interiore dell’Inconscio) scompare in una desertificazione del soggetto che smarrisce ogni termine di riferimento, confronto e riconoscimento. Con esso scompare il desiderio che desidera la mancanza che, come detto, non è di cose ma di significati che solo la relazione col diverso può soddisfare. Dunque, la psiche mostra un baratro di insignificanza, un Doppio dell’Inconscio che cambia il campo del soggetto che ora non è più in rapporto dicotomico/relazionale con la coscienza, ma la stessa psiche inconscia presenta un duplice volto. Secondo Massimo Recalcati, l’Es, ovvero l’Inconscio solo spinta senza parola, uccide il “soggetto” dell’Inconscio espresso dal ritorno del rimosso, nullifica il linguaggio e riduce la dinamica tra natura e civiltà a un drammatico confronto tra l’esistere di un significato possibile e l’insignificanza assoluta del godimento immediato. L’Es non desidera: travolge. Spinge lontano dal significato di cui l’Altro da sé, cui si rivolge la mancanza che muove il desiderio, è portatore e intrappola nella soddisfazione elementare della cosa che nullifica il soggetto nel narcisismo silente del proprio godimento senza nome. Questo l’Inconscio che infiltra: l’Es in quanto Nulla di Morte psichica. Questo il silenzio di cui la nostra civiltà è portatrice. Occorre tentare di riconoscerne almeno alcuni effetti.
L’evaporazione del Padre di cui parla Lacan indica il venir meno del senso fondativo della funzione paterna alla base dello sviluppo della coscienza e della possibilità di ogni civiltà. Al suo posto appare ciò che Lacan definisce “universalismo” e cioè il più che attuale fenomeno della globalizzazione.
In altri termini, l’universalismo di cui ci parla Lacan è quello prodotto dall’affermazione dell’oggetto di godimento che il discorso del capitalista rende illimitatamente disponibile sul mercato globalizzato. La caratteristica principale di questo discorso sarebbe [...] quella di concretizzare un legame sociale che si istituisce sulla decapitazione della funzione verticale giocata dall’Ideale edipico e che al posto della funzione normativa del Padre impone la potenza reale e immaginaria (non simbolica) dell’oggetto di godimento (M. Recalcati, L’uomo senza inconscio, Cortina, Milano, 2010, p. 37).
Spodestato dal godimento assoluto, il Padre non favorisce più accessi simbolici di significato e la civiltà scade a livelli primitivi di soddisfazione materiale. Dunque civiltà come campo dell’Es: si addensa un silenzio di psicosi.
Per intenderci su questo temine, uso ancora una definizione di Recalcati che mi sembra particolarmente adatta al nostro discorso. Egli si riferisce “alla psicosi come a una posizione del soggetto caratterizzata da un deficit strutturale dell’azione simbolica, da una non operatività del significante a contenere il reale maligno del godimento, dalla tendenza di questo godimento non castrato – non regolato dalla funzione normativa della castrazione – a invadere abusivamente il soggetto” (M. Recalcati, Recalcati, Ibidem, p. 142).
Un soggetto dunque invaso e incapace di simbolizzare, per questo perfettamente aderente alla letteralità delle cose che per lui non possono mai rimandare ad “altro”.
Per descrivere questo fenomeno e il soggetto che ne è espressione, C. Bollas ricorre al termine “personalità normotica”.
La persona normotica è qualcuno di anormalmente normale. Troppo stabile, sicuro, tranquillo ed estroverso. È totalmente disinteressato alla vita soggettiva e tende a badare solo alla materialità degli oggetti, alla loro realtà concreta o ai “dati” relativi a fenomeni concreti [...] la malattia normotica si sviluppa quando il significato soggettivo viene assegnato a un oggetto esterno, dove rimane senza essere reintroiettato e nel corso del tempo perde la nozione simbolica di signifi- cante (C. Bollas, L’ombra dell’oggetto, Borla, Roma, 1989, pp. 143-144).
Ci troviamo di fronte a un eccesso di mondo oggettivo rispetto a quello soggettivo, a quel disturbo psichico che anche Winnicott, nel suo Gioco e realtà (D.W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma, 1972) non esita a definire psicosi. Dunque, una forma di adesione acritica all’oggetto col quale ci si identifica completamente, di modo che “La psicosi vi appare non come rottura con la realtà, ma come eccesso di alienazione, di integrazione, di assimilazione conformistica al discorso comune” (M. Recalcati, L’uomo senza inconscio, op. cit., p. 23).
Alla scomparsa del Padre segue la dissoluzione del senso soggettivo e il mondo appare popolato da “ombre oggettuali” prive di significazione e di linguaggio che non sia ricorso amorfo all’immediato. Questo fenomeno è evidente in moltissime forme di adesività sociale ed è facile riconoscerlo non solo in tutti gli “ismi” da cui la società tanto occidentale che orientale è afflitta, ma anche in altri fenomeni non meno macroscopici come l’appartenenza a partiti e movimenti politici per mero calcolo personale con conseguente scadimento della politica stessa a mezzo di arricchimento privato che non trascura qualunque forma di appropriazione, corruzione e ladrocinio generalizzato. Spicca la sparizione del “soggetto di cura” della polis pubblica come di quest’ultima, ridotta a mero campo di sfruttamento dove non è raro cogliere sentimenti di approvazione e benevola invidia per chi è stato più “furbo” degli altri, con fenomeni di identificazione al Leader/ Padre/Ladro/Corruttore che risultano per lo meno desolanti per ogni coscienza superstite.
Nel vasto campo delle sparizioni non si registra soltanto l’evaporazione del Padre ma anche di ogni sistema di valori, ormai sostituito dal lassismo più assoluto con ricco condimento di menefreghismo e disinteresse. Al massimo, si registra qualche “prurito” reattivo capitanato dal qualunquista di turno, oltre urlacci da strada inneggianti ad una ulteriore parcellizzazione separatista priva di qualsiasi fondamento in un minimo di ragionamento basato sul reale.
Un nichilismo sotterraneo si è diffuso nella società rendendola non solo muta ma priva di speranza. In tale società disperata colpisce l’atteggiamento e insieme il destino dei giovani, tesi unicamente al rimedio dello stordimento tramite droghe, psicofarmaci e sballi di ogni tipo. Privi di desiderio, passano ore svagate di fronte a qualche bar, in attesa che la sera li spinga branco in locali ubriachi dove annegare nell’alcol e nel frastuono l’angoscia che li rosicchia. Nei casi peggiori, formano squadracce minorili per vincere la noia – dicono, quando la polizia li arresta e chiede ragione di atti di violenza senza senso. Nella sottrazione di orizzonte in cui si aggirano, la loro soggettività in formazione non ha modo di dispiegarsi ed essi ascoltano inconsapevolmente “l’ospite inquietante” che ha ormai occupato le stanze delle famiglie. Verrebbe da dire che l’Edipo non tramonta mai e che la nostra è in realtà l’epoca del tramonto del Super-io fonte di morale e norma interiore.
Incapaci di insegnare una qualunque parvenza di linguaggio, le famiglie si riducono a ricoveri di sonno e, quando l’alba si affaccia, i ragazzi tornano nei letti che le madri e i padri evaporati hanno loro apprestato per lasciarli ibernare in uno stato di assenza di stimolazione. Prede della “Cosa”, essi vogliono scarpe firmate, divise firmate, mutande firmate e chiappe osteggianti firme di condivisione corporale per sopperire desolanti mancanze di senso di identità. Pestano con scarponi (firmati) strade irreggimentate d’indolenza. Firmano il registro del nulla e la giornata passa. Quanto alla formazione culturale, per loro (e per le famiglie che tacciono) non è più neppure un optional.
Per dirla con Spinoza, viviamo in un’epoca dominata da quelle che il filosofo chiama le “passioni tristi”, dove il riferimento non è al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla disgregazione e alla mancanza di senso che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre a cui l’Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà (U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Roma, 2010, p.98).
All’interno di queste “passioni tristi”, se il Padre è evaporato, chiediamoci dove sia allora finita la madre. André Green sostiene che siamo tutti figli di una madre morta. Cosa significa? Significa che la madre ha fallito e si è inconsapevolmente posta come oggetto muto di introiezione: essa non ha insegnato alcun linguaggio. Il linguaggio che la madre insegna è quello del sentimento. Accogliendo le angosce senza nome del figlio, la madre le restituisce significativamente come sentimento possibile, un vissuto dunque elaborabile e comunque gestibile, perché la madre lo ha già “lavorato” per lui. Questa opera di significazione è mancata. La madre, perduta nelle cose del mondo, totalmente” normotizzata”, restituisce linguaggi “cosificati”, consegnandoci “passioni tristi” e non gestibili, perché nessuno vuole “pensare” la tristezza. Il figlio, lontano dal sentimento, riduce tutto a oggetti muti cui aderire come la madre (non) ha insegnato “e questo perché il cuore non è in sintonia con il pensiero e il pensiero con il comportamento, perché è fallita la comunicazione emotiva e quindi la formazione del cuore come organo che, prima di ragionare, ci fa sentire che cosa è giusto e che cosa non è giusto, chi sono io e che cosa ci faccio al mondo” (U. Galimberti, Ibidem, p. 53). Un mondo ormai totalmente consegnato all’Es, ovvero a un Inconscio senza soggetto come la società che lo riflette.
Lo statuto comune codificato e benedetto dalla società è allora: “una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, fermo restando la salute” (F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, in Opere, Adelphi, Milano, 1974, vol. VIII, 3, fr.14).
Nell’orizzonte chiuso del non senso, dove tutto appare perduto e la civiltà evapora nell’assenza di valori, norma e desiderio, si apre tuttavia una strada nel mare. È la “via del viandante” che Galimberti traccia parafrasando il Nietzsche della Gaia scienza. Nell’assenza di idee che cancella ogni meta e visione del mondo, nel fallimento degli oggetti interni significanti che consegna lo sviluppo del soggetto al nichilismo, la civiltà silente rinuncia persino agli Assoluti cui, da Eraclito in poi, si era aggrappata per scansare il divenire da e verso il Nulla. Al posto di Immutabili che parlavano una lingua di contraddizione e false rassicurazioni, la civiltà ha collocato nuovi Feticci, come il Mercato e la Finanza che non parlano alcuna lingua. Nel silenzio, scompare ogni meta, ma il “Nomadismo è la delusione dei forti che rifiuta il gioco fittizio delle illusioni evocate come sfondo protettivo. È la capacità di disertare le prospettive escatologiche per abitare il mondo nella casualità [...] non pregiudicata da alcuna anticipazione di senso, dove è l’accadimento stesso, l’accadimento non iscritto nelle prospettive del senso finale [...] a porgere il suo senso provvisorio e perituro” (U. Galimberti, op. cit., pp. 143–144).
L’etica del viandante, allora, come antidoto per il nichilismo di Thanatos. La capacità di intraprendere un viaggio senza appigli, trovando il senso del se stesso nel naufragio dell’esistenza che ogni uomo deve affrontare, come sosteneva Kierkegaard, un naufragio che è valore relativo e senso relativo in un mondo spogliato di assoluti falsi garanti di significati precostituiti e sensi finali preformati e mai individuati. Un mondo dove il Padre evaporato resuscita nella testimonianza che ogni uomo riesce a offrire e trasmettere in un linguaggio aperto che è etica personale, trasmissibile e intrasmissibile allo stesso tempo, nella misura in cui è esempio da intuire, non da seguire alla lettera.
Un linguaggio di cui ogni soggetto è autore, come del proprio silenzio. Un Padre Norma che, pur castrando gli impulsi suicidi del figlio verso l’atto, castra se stesso perché capace comunque di ammettere la trasgressione e dunque l’apertura verso un linguaggio diverso. Un linguaggio di un Padre che, deviando il figlio dall’oggettualità dell’esistenza, non preclude la Madre che trasforma il non senso in sentimento ed accosta le emozioni senza nome alla capacità di nominare del pensiero. Un linguaggio che non cade nelle cose, che non è codifica passiva della parola del Padre, ma invenzione che su quella parola si fonda trascendendola. Un linguaggio d’acqua, mutevole e trasparente e tuttavia profondo abisso. Linguaggio d’onda, scosso dal vento che frastaglia nell’orizzonte vuoto di pretese e muove, senza sapere dove, verso l’Altro marino cui s’accosta. E diventa parola.
Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave! Abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle – e non è tutto: abbiamo tagliato la terra dietro di noi (F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, Adelphi, Milano, 1965, vol. V., 2, p. 129).
Id: 3543 Data: 26/11/2024 12:13:47
*
- Arte
La forma dell’informe
In un'epoca come la nostra dove tutto è merce e il discorso del capitalista (J. Lacan) domina le nostre vite senza che ce ne rendiamo conto; in un'epoca come la nostra dove la tecnologia non è più servizio ma padrone e investe la nostra inconsapevolezza assimilandoci allo strumento di turno, l'arte – che dovrebbe costituire baluardo certo (d'incertezza) – è asservita a sua volta alla logica spersonalizzata e spersonalizzante della merce e si trasforma in oggetto di esibizione, di potere, di violenza contro il senso nascosto all'interno di uno stupore che non suscita più.
Dove, all'interno dell'arte, un segnale di resistenza, un rimando a un altrove scomparso, a un senso sommerso che ci protegga dalla banalità del letterale; dove la meraviglia e il vuoto, da riempire di vissuto straordinario (al di là dell'ordinario)? Dovremo forse comportarci come quel personaggio di Bernhard che ogni mattina si recava al museo, sedendosi sempre di fronte allo stesso quadro (T. Bernhard, Antichi Maestri)? Sarebbe inutile: quel personaggio non ne traeva altro che la ripetizione vuota della vita.
Dove, allora, un moto di resistenza, se l'arte stessa si trasforma in espressione del banale, ripetitività e apologia della catena di montaggio (Warhol) in cui noi stessi siamo inseriti?
Eppure l'arte non è quello che la abbiamo fatta diventare; siamo noi che, con la nostra visione asservita, la riduciamo a quei termini minimi. L'arte allora reagisce. Come? Se osserviamo la sua espressione, ci accorgeremo che è vuota.
Si guardi, ad esempio, Hopper che, nelle sue tele, riproduce la paralisi del tempo e il nostro esservi invischiati senza averne coscienza. L'arte reagisce allora con la violenza di un'espressione diventata muta che comunque parla per chi la sa ascoltare. Il suo “altrove” si impone, proprio di fronte a noi che siamo “qui”, in un luogo strettissimo, del tutto insufficiente. Tuttavia, per rintracciare un “altrove” che rimandi a un senso occorre interrogare. Dove l'assente? Forse in una presenza che è soltanto apparente mentre, in realtà, restituisce altro.
Si prenda Van Gogh, “fino al terribile quadro finale, l'autoritratto, l'ultimo, quello in cui Van Gogh è assente, ma in cui parlano in modo terribile le sue tracce che si scavano in esso” (F. Rella, Forme del sapere). La sua è una presenza “assente”, rivolta altrove, ma non verso l'infinito: ci ricorda la morte.
O si consideri l'opera di Kafka. Come scrive Adorno “Da nessuna parte in Kafka traluce l'aura dell'infinito, da nessuna parte si dischiude l'orizzonte. Ogni proposizione è letterale, ogni proposizione è significante. Le due cose non sono fuse, come vorrebbe il simbolo bensì separate da un abisso. E da questo abisso barbaglia il crudo raggio della fascinazione” (Adorno, Appunti su Kafka).
Dunque, arte rimanda a abisso. L'abisso non è riducibile a concetto; occorre una visione diversa.
“Si considera un oggetto da molti lati diversi senza comprenderlo tutto – perché un oggetto preso in tutto il suo insieme perde di colpo il suo volume e si riduce a concetto” (Musil L'uomo senza qualità). Sembra allora che anche la presa di coscienza di un oggetto (artistico) sia insufficiente e ne stravolga il messaggio riducendolo ad un unico aspetto. Come procedere?
“... il saggio procede in questa resistenza al concetto frantumando l'oggetto stesso, frantumando ogni pretesa di totalità e compiutezza... L'oggetto verso cui il saggio si china viene scheggiato. La sua superficie è incrinata. Di lì esso si sporge verso chi lo interroga e di lì entrano in lui le domande che di fronte ad esso si sono generate. Le domande si incorporano così all'oggetto, ed è questo che ora ci interroga: interroga noi che lo interroghiamo” (F. Rella, op, cit.).
Cosa ci chiede Pollock con i suoi “paesaggi neuronali”? Cosa ci chiede Rothko con le sue “finestre” aperte sull’interno? E Kline, con le sue linee nere in campo asciutto, dove ci vuol condurre? Forse verso domande.
Cosa ci chiede l'oggetto (dell'arte)? Di non ridurlo a cosa, a oggetto di mercato. Di ascoltarlo e, facendolo, ascoltare noi stessi, lasciandoci penetrare dalla sua incompiutezza per compierlo, generando in noi un vissuto significante che la coscienza tradurrà in significato. Da informale a forma e da immagine a parola.
Il potere costituito, oggi la finanza e il denaro, ha sempre tentato di assimilare l'arte ai propri canoni. I potenti della terra si sono sempre circondati di artisti da ridurre al proprio capriccio. Spesso ci sono riusciti, spesso no. Caravaggio ha dipinto il “sacro”, ma rivestendolo di un umano
dissacrante che non si lascia ridurre a semplice contemplazione metafisica. Michelangelo è stato costretto a piegarsi al potere del papato, ma ha dimostrato, in un contatto ineludibile, che Dio ha bisogno dell'uomo per esistere.
Il potere, il Leviatano, pretende che l'arte vesta i suoi stessi panni e si lasci comprare. Spesso ci riesce. “Eppure, anche appese alle pareti di un museo, le opere di Francis Bacon o di Mark Rothko continuano a proporre un'altra storia rispetto alle narrazioni omologanti. La scarnificazione di Alberto Giacometti ci riporta comunque a un livello dell'umano abissale” (F. Rella, op. cit.) e dall'abisso, come abbiamo visto, sale una domanda che chiede di essere interrogata. Non ci si siede a contemplare un'opera o a leggere un libro; si lascia che essi ci contemplino e ci leggano, per quanto quell'operazione possa risultare “perturbante” (S. Freud), come sempre dovrebbe essere un dialogo.
In questa nostra modernità senza senso, che uomo siamo diventati? Deleuze risponde che siamo “macchine anonime, macchine desideranti, macchine molecolari e macchine del potere (F. Rella, op. cit.). Macchina allora l'arte, ripetuta meccanicamente, metodicamente, messianicamente sul dio senza nome della rete, in attesa di un consenso che non si rifiuta mai.
“E alla fine”, scrive ancora Rella citando Deleuze, “un processo di disumanizzazione: il gioioso divenire altro, il divenire inumano dell'uomo”.
Il moderno, con tutta la sua sterilità, non nasce oggi; si tratta di un processo lungo che viene da lontano e che qui non posso riassumere. Basti dire che “Benjamin, attraverso Baudelaire e la Parigi del XIX secolo è penetrato nella cultura e nei linguaggi del secolo XX, è ha proposto una visione della storia e del tempo e della redenzione di ciò che ci è stato sottratto, che ci si propone ancora oggi, nella nostra modernità estrema, come un compito” (F. Rella, op. cit.).
Scrivere è camminare, il cammino della riflessione.
Riflettere è un sobborgo. Ci vivono i delusi. Raccontano frammenti; non li ascolta nessuno.
Id: 3530 Data: 16/11/2024 10:16:02
*
- Letteratura
Alessandro o della verità
riflessioni su letteratura e "sistema" attraverso la pagina di Arno Schmidt
La pagina di Schmidt
“52 ANNI E 118 GIORNI: Dapprima uno si era messo a fischiettare. – Quando ripassarono straccamente un’altra volta, il fischio si era tramutato in canto nasale: “Oh, signorina Mirjam quando ballo con lei – za za, za za”, il resto onomatopea, schiocchi di lingua e ft ft; l’altro, probabilmente più anziano rise ringhioso. – Bella luna; quello che tocchi è d’argento. “ (Gadir, in Alessandro o della verità, Einaudi, Torino, 1965).
Arno Schmidt (1914 - 1979) è, con Doblin e Grass, uno dei più grandi esponenti dell'espressionismo tedesco. Poco noto in Itala, le sue opere sono state tradotte in molte lingue. Una di queste, Alessandro o della verità, mi capitò tra le mani nel 1974, su suggerimento di Alfredo Giuliani, critico letterario, poeta e scrittore oggi scomparso. Rimasi folgorato. Leggere Schmidt è come essere afferrato da un vento che solleva e trascina fino al volto sgusciante della luna. A volte abbatte, altre ti lascia andare dolcemente per poi inanellarti ancora nelle spirali del suo soffio enorme senza trovare mai una soluzione. Un vento senza approdo. Non vorresti approdare.
Leggere Schmidt è perdere ogni sistema di riferimento. Se mai credevi di aver letto, se sentivi di accedere a un qualsiasi movimento letterario, un luogo, quale esso sia, ripudierai a favore dell’immaginale: quello l’unico sfondo.
Tutto decade, tutto si sconfessa; persino i grandi della letteratura ottocentesca e degli inizi del novecento assumono un aspetto più dimesso, a volte persino futile. “Dove mi trovo?” Finisci col domandarti. La risposta è: nelle pagine di Schmidt. Pagine irriferibili a qualcosa che conosci, allucinate, esasperate, in cui le parole si mescolano in forme non immediatamente pensabili e tuttavia immerse in una profondissima cultura capace di evocare l’impensato ed inventare mondi. Pagine singhiozzanti, spesso frantumate da una punteggiatura ossessiva, puntigliosa, che finisce per imporsi come un testo nel testo. E te ne chiedi il perché. La risposta alla fine emerge: quella punteggiatura è creazione di tempo, serve a scandire il tempo di lettura e a rafforzare determinati passaggi, a renderli volutamente più “parlati”. Una pagina viva: parla, sussurra, a volte canta. Grida. Ma la devi seguire; è una pagina esigente e può anche essere chiusa bruscamente.
L'inafferrabilità di Schmidt riflette l'inafferrabilità della letteratura. Essa è invenzione, creazione da un nulla sottostante, muto, ma che chiede di parlare. Per sua stessa natura, la parola ha voce duplice, a seconda del narratore: banale e ripetitiva o inaspettata creazione di linguaggio nuovo. Ciò dipende dal fatto che il narratore sia servo del sistema di riferimento dominante o, al contrario, recalcitri, sfugga, detesti le strettezze del già conosciuto/già pensato e smania per essere esso stesso voce letteraria, capace di reinventare una lingua ormai esausta, decaduta, spenta, come ogni simbolo quando muore. Schmidt è allora simbolo, un creatore di quel "non ancora" che ancora non esiste e attende di esser detto. Leggere Schmidt è, dunque, inevitabilmente, dire.
Il libro, Alessandro o della verità (Einaudi, Torino, 1965), fu pubblicato, dopo aspre questioni e rimaneggiamenti. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, il giovane poeta Lampone di Samo deve raggiungere lo zio, generale del Grande Alessandro, presso Babilonia. Per farlo, si accompagna a una singolare carovana di attori girovaghi, finendo inevitabilmente per inoltrarsi in inestricabili conversazioni su Alessandro e il potere da lui incarnato e innamorarsi della prima donna: Monica.
“lei, misurata al massimo, virginale, castigata – ah, tutte cose che non è certamente. E la maschera d’avorio sopra il calice del bavero.”
Monica, Agraule, Pocahontas, Anna, nell’ultima pubblicazione italiana (in realtà la prima di Arno) Il Leviatano: le donne di Schmidt. Disincantate, calcolatrici, fredde, sempre meravigliosamente irraggiungibili, perché le donne di Schmidt sono la nostra anima, perduta e disattesa, che dall’ombra in cui la abbiamo relegata ci osserva e ritorna per incantarci ancora e, inevitabilmente, ritirarsi delusa, specchio della nostra freddezza e di un mutismo indotto, perché non siamo capaci di dirla e neppure lontanamente di amarla.
Alessandro è l’incarnazione del Leviatano, la bestia dell’ignoranza, del potere cieco, della violenza istintuale, del culto inossidabile e pazzesco del se stesso che non somiglia a nulla di umano; una nuda incarnazione del potere, qualsiasi la forma. È l’assassino che spiana città e continenti, passa sopra a tutto e chiunque pur di raggiungere i suoi scopi che neppure sono tali, perché non sono altro che espressione di un istinto di potenza e di una frattura originale all’interno del Sé, e dunque nulla hanno di sensato. In pratica, quello che oggi definiremmo uno psicopatico. In realtà, dovremmo conoscerlo bene, se solo pensassimo alla schiera infinita di dittatori e satrapi di vario genere che si sono alternati nel mondo, anche ultimamente ed anche nel nostro disgraziato paese, Contro di lui, si schiera l’intelligenza di pochi come Pitea o Licofrone o Ipponatte o il sergente profugo del breve romanzo, Il Leviatano, tutti destinati a perire.
Prendiamo Pitea, ad esempio (d’altra parte, ho cominciato proprio con lui e la sua cella in una fortezza cartaginese). Ebbene, Pitea non riuscirà a fuggire; sognerà soltanto la sua fuga e il suo sarà un sogno di morte.
Nel porto allucinato di Gadir, di fronte a una nave che non c’è, Pitea sogna la sua libertà dalla bestia che opprime.
“Ultimo ottenebramento: Vento nebbioso, fradicio, sommerge la montagna con frastuono d’organo, rotola sopra boschi ululanti. Aspirai profondamente e rantolai, gargarizzai fuori con beatitudine insensata: verso la libertà.”
“A sera: nuvolaglia di tempesta si aduna.
Ho aggirato già da un pezzo la montagna; in basso si stende Gadir, con i suoi vicoli ben tracciati, con i sobborghi dove incrociano a volo i piccioni.
Otto navi stanno all’ancora nel porto, oscillano; due davanti all’isola di Erythia, una, nera, qui di fronte, sulla sinistra, molto più in basso rispetto a me (un’ora di strada per arrivarci): tenterò con quella”.
Salirà su quella nave e salperà: verso la morte, nella cella mai abbandonata.
Né altro vede il giovane Licofrone, il cui destino sarà segnato dal potere ottuso incarnato da un finanziere di Roma (e la di lui figlia) e dal vescovo al suo seguito, il temibile Gabriele, colmo di costrizioni che dispensa sotto forma di fede.
« Questi è il nostro universalmente riverito Gabriele di Thisoa: – – » (inchinarsi educatamente: il prete di casa, pare. Forse anche il precettore nello stesso tempo). –
« – e qui la mia figliola Agraule : – – »
Capelli scuri le incorniciavano il volto. Pallida, clorotica, il naso aguzzo, con sguardi neri (solitamente, gli occhi umani formano segni di infinito; in questo caso, una formula fissa).
Una formula fissa. Come la cosmogonia ecclesiale che Gabriele impone ai due giovani, del tutto inesatta e fantasmatica, come Lico ben sa, grazie agli insegnamenti di filosofia e fisica ricevuti dal suo amatissimo maestro Eutochio, costretto a riparare in Persia per sfuggire le persecuzioni del vescovo. Senza tuttavia cedere.
“E già di nuovo a oriente: tramava a uncino la luna variopinta; verdi intrichi, viluppi gialli, fili rossi, (il gomitolo ancora stava sotto l’orizzonte), scialli azzurri. “Stasera ci sarà il sereno: vieni all’osservatorio, allora, intesi?!” : “Con piacere, maestro!””
Perché, come diceva Eutochio, i centomila anni della metafisica sono finiti e sono cominciati gli anni della fisica. Un sistema cominciava a cadere.
La caduta dei sistemi
Definirei sistema un aggregato di riferimento collettivo cui l’individuo non dovrebbe mai accedere, pena la rinuncia alla propria intelligenza.
In tutte le sue formulazioni e distinzioni, lo Stato è l’organizzazione “sistematica” per eccellenza. Schmidt identifica lo Stato e il sistema che in esso di incarna con una mostruosità che opprime e schiaccia l'individuo cui impone modi di vivere e pensare. Non era il solo.
“Io non chiedo che si sostituisca lo Stato con una biblioteca – benché quest’idea abbia visitato più volte la mia mente –; ma per me non c’è dubbio che, se scegliessimo i nostri governanti sulla base della loro esperienza di lettori, e non sulla base dei loro programmi politici, ci sarebbe assai meno sofferenza sulla terra”. (I. Brodskij, Dall’esilio, Adelphi, Milano, 1988, p. 53).
Sono convinto che Schmidt avrebbe approvato incondizionatamente.
Un sistema non è sempre evidente; spesso è occulto, difficile da individuare. Non per questo meno resistente.
“Funzioni intellettuali, proprie dei sistemi di divieti di una forma sociale, hanno assimilato le procedure linguistico–concettuali ai processi naturali scanditi da causa ed effetto. Ora, l’assunzione che la coerenza e il senso della condotta intellettuale siano archiviati in un modulo preformato, in un repertorio di competenze precostituite, rappresenta un’estensione impropria delle relazioni naturali al dominio delle sequenze costruttive nel corso delle quali, passo per passo, si formano i discorsi coerenti. Il presente diviene a questo punto una ritualizzazione del passato.
[…] Il mentalismo, le filosofie e le metodologie del ‘pensiero’, ‘mente’,’interiorità’ hanno occultato l’aspetto costruttivo del nostro sapere, svolgendo una funzione nella nostra forma di vita, paragonabile a quella esercitata dall’ipotesi teologica”. (A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Einaudi, Torino, 1979),
Non solo il sapere sedimentato, ma anche la consuetudine, ovvero un sedimento non saputo, è parte integrante di un sistema e contribuisce al suo mantenimento. Come scrive Carlo Ginzburg:
“In ogni caso queste forme di sapere […] non venivano apprese dai libri ma dalla viva voce, dai gesti, dalle occhiate; si formavano su sottigliezze certo non formalizzabili, spesso addirittura non traducibili verbalmente; costituivano il patrimonio in parte unitario, in parte diversificato, di uomini e donne appartenenti a tutte le classi sociali. Una sottile parentela le univa: tutte nascevano dall’esperienza, dalla concretezza dell’esperienza. In questa concretezza stava la forza di questo tipo di sapere, e il suo limite – l’incapacità di servirsi dello strumento potente e terribile dell’astrazione.” (Ibidem, p. 81).
Una ragnatela pseudorazionale si intesse intorno al modo di sentire, pensare, vedere il mondo, informando queste funzioni psichiche del non senso dell’inattuale, imprigionandole all’interno di un già visto, già pensato, comunque mai davvero consapevolmente. Come scrive ancora Gargani:
“Si chiama crisi della razionalità la percezione che la casa del nostro sapere è di fatto disabitata […] È in questa situazione di transizione che si esperisce l’impressione che vi sia un sapere non esplicitato o non portato pienamente a coscienza al di là di quello di cui disponevamo; ossia sentiamo che il sapere e la nostra consapevolezza non riescono più a coincidere come accadeva nel sistema chiuso di quelle convenzioni”. (A. Gargani, a cura di, Ibidem, p. 46).
A questo punto sarebbe lecito chiedersi quale sia l’origine di un sistema e a cosa esso tenda, ma è un discorso che condurrebbe troppo lontano. Chi avesse voglia di approfondire può leggere il volume 8 delle Opere di C.G. Jung, La dinamica dell’inconscio, edito da Boringhieri e il libro di E. Severino, La tendenza fondamentale del nostro tempo, edito da Adelphi. Sulla base di quelle letture mi sentirei di proporre la seguente conclusione: un sistema è una manifestazione di strutture psichiche arcaiche legate all’istinto. Esso è per ciò stesso essenzialmente conservatore e avverso a qualunque forma di evoluzione. Nasce da un nulla rappresentativo ed è esso stesso un nulla che genera nulla e nullità. Riconoscerlo e combatterlo, in qualsiasi sua forma, è questione vitale.
Vivere nell’inconsapevolezza passiva e involontaria di un sistema fa scadere Il simbolo a segno e la possibilità di significare cede all’insignificanza della ripetizione sterile, come se si vivesse in un passato che non si vuole lasciare tramontare, un grembo materno ormai troppo stretto che, tuttavia, non si riesce ad abbandonare. Schmidt scalciava.
L’appartenenza inconsapevole ad un sistema riguarda molte altre forme culturali, non ultima l’arte. Per fare alcuni esempi, il “classicismo” ha resistito violentemente agli “impressionisti”, definiti dai membri del potere “la vergogna di Francia”. Per rompere il predominio dell’armonia ed aprire la musica ad altre possibilità linguistiche è stato necessario Schoemberg e la rivoluzione atonale da lui portata avanti. O ancora, “Nella musica di Mahler e nella polemica che essa rappresenta nei confronti di linguaggi istituzionalizzati, saturi, si può avvertire lo sforzo di fissare un nuovo paradigma di visione della vita umana, emancipata dalle convenzioni di codici usurati, attraverso l’impiego di sonorità che sembrano provenire dai padiglioni delle bande militari, della orchestre dei giardini pubblici.” (A. Gargani, a cura di, op. cit. p. 46). Solo che nei “giardini pubblici” abitava l’anima popolare cui Mahler ha dato espressione sinfonica. Per aprire la letteratura a forme linguistiche e narrative diverse dal romanzo tradizionale, abbiamo dovuto attendere Doblin, Musil e Schmidt. Il primo, per quanto grandissimo, ancora legato a certe forme narrative tradizionali e, per ciò, accettato; il nostro, ferocemente osteggiato, quando non ignorato, dalla critica ufficiale del tempo. Ma non tutta.
“Un ragazzo matto. All’inizio si pensa: stupidaggini. Poi ci si arrabbia. Un uomo evidentemente che si ritiene un genio e si comporta di conseguenza. Si prosegue a leggere. Si è incantati. Si è commossi. Poi ancora snobismi. Poi immagini splendide. Espressionismo con tre punti esclamativi.” (In Introduzione a Leviatano o il migliore dei mondi, Mimesis, Milano–Udine, 2013, p. 9).
Vento
Nelle notti di brughiera, ai margini della palude e dei suoi occhi: Schmidt.
"Ah, la greve risacca dell’aria! Un battello di nebbia scialuppa a lungo nel porto erboso, e naufragò poi esitante sotto gli alberi. Lasciò cadere mani assieme a dure lacrime nelle acque nere, la sua voce strisciò al suolo; le spalle uno poteva tirarle a sé, il viso non ancora.” (Paesaggio lacustre con Pocahontas, Zandonai, Rovereto, 2011).
Cosa muoveva Schmidt? La moglie - Alice - racconta che qualcosa lo afferrava e dalla sua bocca cominciavano a fuoriuscire parole, come un fiume di carta. Tuttavia non basta. Probabilmente una profonda volontà distruttiva di tutto ciò che è conforme a un limite imposto ottusamente, un’enorme insoddisfazione e un bisogno quasi sovrannaturale di fuga, evidenziati soprattutto in Enthymesis, ovvero Q.V.O. (in Alessandro o della verità, op. cit.) contribuivano al suo impulso creativo. C’era tuttavia anche un fortissimo bisogno di sfuggire dal caos della Germania post bellica, da lui raccontata nella “Trilogia”, in particolare in Specchi neri (Lavieri, S. Angelo In Formis, 2009). Tuttavia anche la necessità di ordinare il caos interiore in cui si dibatteva. Schmidt, infatti, scriveva dove capitava, spesso su foglietti volanti, difficili da recuperare, come ci racconta Dario Borso nella sua introduzione a Paesaggio lacustre con Pocahontas (op. cit.). Forse ordinare e sfuggire ad un tempo una forza oscura che si agitava in lui come fonte espressiva insopprimibile, che lo afferrava costringendolo a sciorinare parole a bassa voce, ad essere praticamente tutt’uno con quelle parole spesso inevitabili.
Schmidt non era Schmidt: era il suo dire. Sul piano personale, al di fuori degli scritti, la sua esistenza era un trascinarsi da un’ispirazione all’altra, spesso allucinazione, senza cura dei giorni.
Come scrive Brodskij nel suo Dall’esilio (I. Brodskij, Dall’esilio, op. cit., p. 60): “Il poeta, ripeto, è il mezzo di cui la lingua si serve per esistere. O, come ha detto il mio amato Auden, è colui in cui e per cui la lingua vive. Io che scrivo queste righe scomparirò; e scomparirete voi che le leggete; ma rimarrà la lingua nella quale esse sono scritte e nella quale voi le leggete: rimarrà non solamente perché la lingua è cosa più duratura dell’uomo, ma anche perché più di lui è capace di mutazione”.
Alessandro o della verità è scomparso ormai da anni dalla scena letteraria italiana. I dieci lettori italiani di Arno Schmidt, come amaramente li definisce Claudio Magris, non hanno molto da rimpiangere: il libro l’hanno letto. Resta l’ottusità del sistema, in questo caso quello editorial/culturale vigente nelle patrie galere. Poco male: chi lo possiede potrà sempre rileggerlo. In segreto.
Questo articolo, già pubblicato sulla Rivista Fermenti, è stato richiesto in Germania dalla Fondazione Arno Schmidt e inserito nella bibliografia ufficiale del grande autore tedesco.
Id: 3437 Data: 05/09/2024 11:34:46
*
- Letteratura
La Stiva
Il Minotauro è un animale esausto, ma non credo se ne sia accorto, chiuso com’è nella malinconia.
Dunque dove mi trovo? Questa stiva non è un contenitore. Non tutto è disponibile a comando. Devo passare la domanda al revisore ed aspettare pratiche – che si compiano, dico – sperando che si trovi la bisaccia dove ho messo i ricordi.
Spesso cortocircuiti (se si crea un conflitto). E mi sento inevaso.
Se la cosa riesce, potrebbe generarsi un’alluvione. E allora stracci, idrovore, pompe di calore per asciugare il senso che rimane.
Dunque leggere titoli. Sui contenuti meglio sorvolare.
Ora, la stiva è un luogo galleggiante dove la notte abita tranne poche fessure. Magari un Monastero.
Molto simile a un ventre, potrebbe essere quello di tua madre, se non fosse che lo conosci benissimo avendoci abitato, mentre questa è simile all’ignoto. Per questo induce desideri, inquietudini, paure. Cosa, ad esempio, dietro quelle casse? O peggio, dentro. O all’angolo del buio più lontano, quello dietro quell’altro? Meglio tornare in-dietro.
Con cautela: si potrebbero incontrare ricordi.
Si apre a caso (cioè, togli il cellophane al mondo) e scopri che una tal signora “aveva un culo di vetro sul quale si poteva leggere il medioevo” (H. Miller, “Tropico del cancro”).
Ora, non è cosa di tutti i giorni leggere il medio evo sul culo di una donna, cosa che farei volentieri per svariate ragioni, ma il futuro non era contemplato. Nemmeno che il tropico avesse il cancro. Quindi, rivolgersi altrove.
Scopri allora che ti è arrivata una lettera, da un certo Baranowicz che abita in cima al mondo. Scrive di una donna. Mi scrive. Io non la conosco.
“Si chiama Alja e sta zitta quasi tutto il giorno. Lascio che abiti qui, le do un letto e così vive accanto a me. Posso darle anche dei soldi se vuoi che venga da te. Ma posso anche tenerla qui. È lo stesso per me! Scrivimi a Irkutsk fermo posta. Ogni mese Isaak Gorin, il venditore di grammofoni, ritira la mia posta.
Ho anche acquistato da lui un grammofono, e alla donna che sostiene di essere tua moglie piace ascoltarlo. A volte piange persino. Forse piange per te, almeno io penso – e allora può essere che anche a me vengano le lacrime.” (J. Roth, “Fuga senza fine”).
Questo succedeva mentre a Vienna si suonavano mazurke anche dentro le cripte (J. Roth, “La cripta dei cappuccini”) e qualcun altro emigrava in America, lasciandosi dietro un mondo inabile, un figlio inabile e un’anima disabilitata, come l’Europa degli Ebrei che vanno. Gli capita anche di non riuscire a riconoscere uno straccio di mondo perché era rimasto insieme al figlio inabile.
E un giorno gli amici, vedendo del fumo uscire dall’appartamento, entrano e trovano che sta bruciando tutti i vecchi libri. “Che fai?” gli gridano. E lui: “Brucio Dio!” (J. Roth, “Giobbe”), mentre a Venezia gli angeli girano solo di notte e io non posso dormire (I. Brodskij, “Fondamenta degli incurabili”).
A Vienna comunque Mitzi non mi lasciava in pace, nonostante le avessi comprato cento statue di cera con cui giocare, lei e quell’idiota del figlio (che poi era anche mio, sembra). Così mi sono sparato (J. Roth, “La milleduesima notte”).
Sempre meglio che a Berlino, dove qualcosa ti dice di darle il cuore altrimenti viene a prenderselo da sola, e hai voglia a rispondere “un momentino...”. (A. Döblin, Berlin Alexanderplatz”).
Quindi sali su un treno, e mica lo sai dove stai andando e qualcuno dice:” Và al diavolo”.
“Certo generale, o dovrei dire tenente? Scusatemi signora, ho buscato un avvelenamento da gas a furia di essere comandato di corvèe in cucina, e da allora la mia vista non è stata più la stessa. Avanti verso Berlino! Ma sì, certo siamo su Berlino, sono su di te, Berlino. Ho il tuo numero. Niente migliaia, niente centinaia e nemmeno un indegno zero di soldato semplice (molto semplice), Joe Gilligan in ritardo per le patate, in ritardo per il servizio, in ritardo per il rancio anche quando il rancio è in ritardo. La statua della libertà non mi ha mai visto e se mi vorrà guardare dovrà chinarsi su di me”. (W. Faulkner, “La paga del soldato”).
E ad Alexanderplatz non c’era più nessuno.
In un’altra cassa mi trovavo a Zlotogrod e facevo il verificatore. Tutti i pesi erano falsi.
Non me ne fregava niente: io volevo stare con Eufemia, anche se non aveva un culo di vetro.
Eufemia stava con me, nell’osteria della frontiera, per il tempo che poteva. Ma tornava l’inverno, e con l’inverno passava il colera ma ritornava l’uomo cui apparteneva. C’era poco da verificare: gli apparteneva, almeno d’inverno. A Zlotogrod l’inverno è lunghissimo.
E allora una notte il gendarme Piotrak mi carica su un carro. Su un carro mi carica e mi scarica davanti all’ospedale, per sentirsi dire dal medico: “Costui è morto. Perché ce lo porta qua?” (J. Roth, “Il peso falso”).
Capisci? Da una cassa all’ospedale. E nemmeno ci dovevo andare!
E allora è meglio andare in un’altra cassa, dove ci trovi dei mattoni e ti puoi costruire una stanza. E tutti ti scambiano per un rabbi, un santo cui chiedere consigli, mentre sono soltanto un peccatore, un avventuriero, uno di quelli che corrono sulla corda per non trovarsela al collo. E dopo i fatti di Eufemia, credo sia meglio che le donne siano loro a morire. Io mi costruisco una stanza, senza porte, senza finestre, soltanto uno spioncino, per tenerci dentro i miei peccati e i miei istinti irrefrenabili. Li freno io, li freno! Coi mattoni. E non venitemi a chiedere cosa dovete fare: fatelo da voi! (I. Singer, “Il mago di Lublino”).
Ma non chiedetemi neppure di ascoltare la radio se non ne avete una (stava in un’altra cassa). Non me lo chiedete, altrimenti mi devo inventare di averne una mentre non ce l’ho, e vi devo dare le notizie che sperate di sentire, mentre questi ci ammazzano uno a uno e ci fanno lavorare come se non fossimo morti. E vi devo dire che arrivano gli Americani, ma non ne ho la minima idea.
Poi gli Americani arrivano davvero, ma quelli intanto (quegli altri), si sono convinti che una radio ce l’ho davvero, nonostante il divieto di averne, e mi ammazzano. Così quando quelli arrivano, voi avete avuto la conferma di una notizia che non avevo ma che vi ho dato. E io sono morto. (I. Singer, “Jacob il bugiardo”).
Quando sono morto le ho chiuse; ho chiuso tutte le casse. Ho cercato di uscire dalla stiva ma non ci sono riuscito, perché ho capito che non sono io a stare nella stiva, ma la stiva è dentro di me. E c’è stata per cento anni, di solitudine, solo che non c’erano alberi dove pisciare e i cent’anni non finivano mai.
Ma se sono morto come faccio a camminare? “Mentre io, prima che Karrer impazzisse, camminavo con Oehler solo di mercoledì, ora, dopo che Karrer è impazzito, cammino con Oehler anche di lunedì… E senza esitare ho detto a Oehler: bene, camminiamo anche di lunedì, ora che Karrer è impazzito ed è allo Steinhof”. (T. Bernhard, “Camminare”).
E a furia di camminare mi sono trovato in un cesso pubblico, a sorvegliare le pisciate degli altri, dopo anni di strada a suonare un organetto, sai, quei vecchi attrezzi pieni di vecchie canzoni, e avevo una gamba sola per via della guerra. Per questo avevo un organetto.
Stavo in un cesso pubblico a fare il guardiano, sperando in qualche mancia. Avevo un pappagallo sulle spalle e a un certo punto il pappagallo si è messo a volare, lì, nel cesso, e le sue ali frusciavano come credo possa frusciare solo la morte, ma non le sentivo. Non sentivo le ali del mio pappagallo: non lo sentivo volare. Neppure quando si è posato sulla mia spalla”. (J. Roth, “La Ribellione").
“E allora succede che anche Horace non li udiva. Non udiva le urla di quello che si era bruciato. Non udiva il fuoco, anche se il fuoco continuava a vorticare verso l’alto con la stessa intensità come se vivesse di se stesso, e senza alcun rumore: una voce infuriata, come in un sogno, che usciva ruggendo in silenzio da un placido nulla”. (W. Faulkner, “Santuario”).
E da quel nulla esce fuori che Dio viveva a Parigi, anche se non lo sa. E quando mi sono trovato davanti a Lui, senza una gamba e senza neppure l’organetto, mi ha chiesto cosa volessi. “Voglio andare all’inferno!” ho risposto (J. Roth, “La ribellione”) "e un battello gridava dalla Senna, un altro rispondeva e tutti seguivamo il corso della corrente. La seguivano tutti e che non se ne parli più” (F. Céline, “Viaggio al termine della notte”).
Id: 3391 Data: 07/06/2024 12:01:02
*
- Letteratura
Il caso Thomas Bernhard
“Lo stato di totale indifferenza in cui mi trovo, così Karrer,
è uno stato filosofico da cima a fondo”.
(T, Bernhard, “Camminare”, Adelphi, Milano, 2018)
Non mi era mai capitato di leggere di fila tre romanzi di uno stesso autore. In genere, quando ho finito di leggere un romanzo di un determinato autore, quando ho finito di lasciarmi penetrare dal suo pensiero, di pensarlo; di vivere il suo sentire, di sentirlo; di condividere insomma il suo mondo, di penetrarlo come se fosse mio, abitarlo, percorrerlo, inseguirlo a volte; quando ho finito di fare tutto questo, passo ad altro. Intendo dire ad altro autore, mondo, pensiero, sentimento, condivisione, inseguimento, se occorre. Questa volta no. Questa volta, terminata la lettura di un romanzo di Bernhard, ne ho letto subito un altro e, terminato anche quello, un altro ancora. Nell’ordine, mi riferisco a “Camminare”, “Antichi Maestri”, “Perturbamento”. Alla fine ho letto anche tutti gli altri. Ho camminato con lui, a lungo; non sapevo perché.
“Mentre io, prima che Karrer impazzisse, camminavo con Oehler solo di mercoledì, ora, dopo che Karrer è impazzito, cammino con Oehler anche di lunedì...perché non c'è nulla di più orribile di dover camminare da soli di lunedì”. (T. Bernhard, Camminare, Adelphi, Milano, 2018).
Terminata la compenetrazione con un certo mondo – vedremo quale – ho desiderato non uscirne, restarvi dentro, percorrerlo di nuovo anche se in altro libro. Ho desiderato sentire ancora quei pensieri, inseguirli, esserne inseguito, perché Bernhard, se provi a lasciarlo, ti insegue, e non è facile liberarsene. Il suo è un veleno sottile, avvolgente, che può creare una dipendenza. È come la campana di un paese, un paese piccolo, estremamente definito, privo di sorprese: ti suona nella testa, senza sorprese.
Un paese minuto e, proprio per questo, inesorabile: non se ne esce, perché il mondo è tutto lì. Non ne esiste un altro. Una specie di prigionia; senti che ti opprime, ma non vuoi uscirne, Cosa al di fuori? Certamente non Bernhard, non il mondo minuscolo e terribile che stai abitando, ma è di quello che hai bisogno. Un paesino piccolo e terribile, che somiglia solo a se stesso. E si ripete, si ripete ininterrottamente: un labirinto da cui non si può uscire.
Quella campana suona, rintocca, ti penetra, ti perseguita, ti affascina, ti assorda, ma vuoi continuare a sentirla. È un suono martellante ed avvolgente al tempo stesso. Ti martella e ti avvolge in spirali di parole che creano intorno a te un labirinto di pensieri di cui non trovi l’uscita. Respiri male, non respiri, vorresti fuggire ma non sai come né da dove. Non c’è luogo e non c’è tempo nel pensiero di Bernhard: sottrae punti di riferimento. Tutto si riduce a lui e in lui si estingue. Leggere Bernhard è come impazzire. Per questo continui a leggerlo: per evitare di impazzire.
Non parlerò di quei romanzi, non ne traccerò la trama: non esiste una trama. I romanzi di Bernhard non sono avvenimenti, luoghi, persone. Si tratta di un monologo, un soliloquio estremo, ma non in prima persona: è un discorso riferito. In pratica, è qualcuno che parla di qualcuno e, parlandone, lo fa parlare. Ma chi parla non appare mai, tranne che per riferimento. A volte, si inserisce anche un terzo personaggio, sempre riferito e, comunque, anche chi riferisce non racconta in prima persona: riferisce. Tutto è indiretto.
La scena è unica, stabile, non cambia mai. Che sia una strada, un palazzo o un museo, la scena è fissa, come fissi sono i personaggi che da quella scena non si muovono. Nei romanzi di Bernhard, in pratica, non accade niente, tranne che una fissità continua di parole. Noto di sfuggita che, nei suoi romanzi, non esistono capoversi.
Accadono parole. Un flusso di pensiero ininterrotto, analitico, freddo, seghettante e ripetuto, che si allontana e torna, ripetendo temi attraverso frasi ripetute cui, a volte, si aggiunge un’unica parola: da ripetere, alla fine della frase già ripetuta. E così via, di seguito.
Un pensiero ossessivo, al limite della follia, tanto che, seguendolo e volendolo seguire, sei portato a chiederti se non stai diventando pazzo. I libri di Bernhard andrebbero chiusi di getto, dopo poche righe. Né riaperti. L’ho fatto più volte, riaprendoli sempre. L’ho detto: non si esce da quel labirinto; non si vuole uscire. A un certo punto è inevitabile chiedersi: ”perché fa così?” La risposta è: per non impazzire.
In ultima istanza, Bernhard rinchiude il proprio pensiero in un manicomio privato, interiore, dove non c'è cura e si è liberi di essere pazzi. Bernhard scriveva per evitare di impazzire sentendosi libero di essere pazzo. Nel manicomio chiuso dei propri soliloqui ossessivi egli costruiva un contenitore, un vero e proprio contenimento alla follia che altrimenti lo avrebbe travolto. I romanzi di Bernhard sono mura mentali costruite per contenere un flusso incontrollato di pensieri che altrimenti lo avrebbero fatto impazzire. All'interno di quel luogo senza cura ma sicuro, Bernhard poteva controllare il flusso che lo pensava e renderlo proprio, altrimenti ne sarebbe stato vittima. Non che quella costruzione fosse volontaria; era tuttavia salvifica.
Cosa esprime quel pensiero? Disgusto. Per qualcuno, per qualcosa? Per tutto. Un disgusto, direi, cosmico, assoluto, globale, che finisce col disgustarsi del disgusto stesso. Una critica sociale che coinvolge tutte le forme dell’esistere cui, inevitabilmente, l’uomo dà vita. Oggetto primario di accanimento è lo Stato e l’orrore cui lo Stato ha dato forma e sostanza corrompendo l’uomo che, da parte sua, sembra essere stato estremamente corruttibile, addirittura lieto di esserlo. Perché l’uomo è una mostruosità, un errore, anche nell’Arte. E la storia, la storia umana, nella visione di Bernhard, è semplicemente una storia morta.
“Dunque l’arte è senza dubbio quella di sopportare l’insopportabile e di non sentire ciò che è orribile come tale, cioè orribile. Definire quest’arte come la più difficile, è ovvio. L’arte di esistere contro i fatti, dice Oehler, è l’arte più difficile. Esistere contro i fatti significa esistere contro ciò che è insopportabile e contro ciò che è orribile, dice Oehler. Se noi non esistiamo costantemente contro ma solo costantemente con i fatti, dice Oehler, andiamo a fondo in brevissimo tempo. Il fatto è che la nostra esistenza è un’esistenza insopportabile e orribile, se esistiamo con questo fatto, dice Oehler, senza esistere contro questo fatto, andiamo a fondo nel più miserabile e nel più comune dei modi… E’ sempre un problema di freddezza mentale e di acume mentale, dice Oehler. La maggior parte delle persone, dice Oehler, non ha né freddezza mentale né acume mentale e non ha neppure intelletto. L’intera storia sino ad oggi ne ha dato senz’altro prova. Ovunque guardiamo, né freddezza mentale né acume mentale, dice Oehler, il tutto è una gigantesca storia, spaventosamente lunga, priva di acume mentale e di freddezza mentale, e quindi priva di intelletto. Se guardiamo alla storia, qui deprime in particolare la totale mancanza di intelletto, per non parlare poi di acume mentale e di freddezza mentale. In tal senso non è un’esagerazione dire che tutta la storia è una storia totalmente priva di intelletto, ragion per cui è anche una storia completamente morta”. (Thomas Bernhard, Camminare, Adelphi, Milano, 2018)
Questo l’uomo e il mondo. Anche il mondo in sé, a prescindere dall’umano: la natura è semplicemente un terribile orrore.
Tutto è corruzione perché lo Stato corrompe. Tutto è stupidità perché lo Stato è stupido. Tutto è infame perché lo Stato è infame. Lo è anche la Chiesa e qualsiasi forma cui l’uomo abbia dato vita, perché lo è l’uomo. Noto di sfuggita che Bernhard non parla mai di Dio: non ne vale la pena.
Al termine della lettura ti viene inevitabilmente da chiederti che tipo d’uomo sia mai stato costui. Ne esce un’immagine fredda, solitaria, profondamente amareggiata, ma sorretta da un’intelligenza implacabile. Ne esce anche una totale mancanza di sentimento. Bernhard pensa, non sente. Non sente nulla. E tuttavia non è vero, perché Bernhard è anche e soprattutto una profonda forma di amarezza.
Non riporterò le circostanze della sua vita; chi vuole potrà facilmente informarsi. Dirò soltanto che, nonostante il disgusto e l’amarezza, Bernhard non ha mai rinunciato alla vita. Leggendolo, viene in mente – come lui stesso dichiara – che l’unica forma possibile sarebbe il suicidio. Tuttavia. Bernhard voleva vivere; voleva vivere intensamente e fino in fondo il disgusto profondo della vita. Tutto si riduce a un disgusto “pensato” dell’umano, talmente freddo e analitico da sembrare disumano. Bernhard, tuttavia, non riesce ad evitare l’amarezza. La sua è un’amarezza talmente profonda che ha bisogno di rinchiuderla in un labirinto di parole per non doverla sentire. Il più delle volte ci riesce, ma la sua amarezza traspare, esce dalle pagine, ti invade, perché Bernhard ne scrive e tu ne leggi. Alla fine, il disgusto e l’amarezza (persino per il disgusto) sono gli unici pensieri/sentimenti possibili da cui ti vorresti liberare al più presto e nei quali vorresti, tuttavia, restare, perché non puoi fare a meno di provarli e, inevitabilmente, condividerli.
Per Bernhard i pazzi siamo noi, una folla confusa, una massa informe incapace di pensare autonomamente. Passivi e orribili, pieni di stupidità e perversioni, pronti a seguire senza la minima capacità critica le linee di una vita pre-figurata da chi è pre-figurato a farlo.
Credo fosse un uomo deluso, un “soccombente” tra i tanti che non ammetteva di essere tale. Non poteva evitarlo: se si fosse concesso anche solo un briciolo di sentimento di pietà, sarebbe senz’altro impazzito e noi non avremmo letto il lato meraviglioso di una follia contenuta e lucida che ha contemplato per tutta la vita, permettendoci di contemplarla. E accusandoci di farlo.
Id: 3355 Data: 22/04/2024 12:04:51
*
- Arte
E. Hopper: l’attimo senza tempo
E. Hopper: l’attimo senza tempo
di Giovanni Baldaccini
Scrivere di Hopper non è compito semplice: sembra scrivere di nulla.
Molti ne hanno parlato e molte sono le definizioni dell’uomo e della sua pittura. Di volta in volta i suoi quadri sono stati espressione di silenzio, alienazione, assenza, solitudine ed altre categorie più o meno adatte a classificarli. Io non trovo una categoria adatta. Per me Hopper è un’assenza talmente estrema da sfuggire a qualsiasi definizione. A mio parere, Hopper esce dal tempo e il tempo è categoria di qualsiasi realtà si voglia parlare. Nella realtà codificata delle sue astrazioni materiali, Hopper mi sembra fuori dal reale.
Tuttavia Hopper esiste – o meglio, esistono i suoi quadri. Hopper dunque è reale, ma di una realtà diversa, perché Hopper annulla il tempo e dunque la stessa possibilità di essere reale. Questa affermazione andrà giustificata.
“In quei territori dell’estremo spaesamento contemporaneo, infatti, incontriamo presenze spettrali che si aggirano tra luoghi desolati, nascosti dalla banalità del quotidiano, dall’eterna ripetizione di gesti automatici e inautentici. Tutto appare sprofondato nel presente dove ormai nessun evento può più davvero aver luogo perché lo spazio di manifestazione nella vita ordinaria sembra completamente saturo di accadimenti sempre identici. Il tempo insomma si chiude, bloccato nel suo movimento di sistole e diastole, in un presente atemporale ben lontano dall’istante kairotico e destinale. Non c’è spazio per l’eterno né per il suo ingresso nel tempo attraverso l’attimo, non c’è aíon possibile ma solo ossessiva ripetizione che frattura le estasi temporali disperdendo irrimediabilmente télos, skopòs éschaton. Non resta che l’ipostasi del presente con l’opprimente pesantezza dell’esistere” [Levinas, E., Il Tempo e l’Altro (1948), tr. it. di F.P. Ciglia, Genova, Il Melangolo, 2001].
Dunque Hopper annulla la ripetizione del banale e chiude il tempo rifiutando in tal modo l’insensatezza di un esistere che è ossessione inconsapevolmente ripetuta, ma non credo che l’attimo, che Hopper fissa nei suoi quadri, non apra spazi d’eterno. Di questo parlerò in seguito. Per ora dirò che Hopper “tiene insieme le cose”.
In un campo
io sono l’assenza
di campo.
Questo è
sempre opportuno.
Dovunque sono
io sono ciò che manca.
Quando cammino
divido l’aria
e sempre
l’aria si fa avanti
per riempire gli spazi
che il mio corpo occupava.
Tutti abbiamo delle ragioni
per muoverci
io mi muovo
per tenere assieme le cose.
Mark Strand, Tenendo le cose assieme
da "Sleeping with one eye open"
Nella fissità atemporale delle sue rappresentazioni, Hopper evita la dispersione. Egli fissa infatti i suoi personaggi/paesaggi nello spazio racchiuso e immobile della tela, evitando che soffrano del tempo, che soffrano il suo trascorrere meccanico, che si annullino nel tempo insensato del mondo. In ultima istanza, Hopper tenta di evitarne la morte.
Nell'annullamento temporale, i quadri di Hopper sono uno squarcio d’eterno. Cancellando il tempo, tenendo insieme le cose nell’attimo che non sfugge, fissando uomini, donne, paesaggi, muri, città e qualsiasi altra cosa capiti sotto i suoi occhi, persino una pompa di benzina, Hopper evita che muoiano disperdendosi nella banalità delle definizioni e consegna i suoi oggetti a un eterno senza tempo che tuttavia è tempo nella misura in cui li definisce in un “al di fuori” irreale, una metafisica del reale che egli ricerca e fissa nell’eterno senza tempo della sua visione che annulla le categorie del quotidiano. In ultima analisi, Hopper teme la morte. La teme a tal punto da estenderne il concetto persino alle cose: Hopper voleva salvare le cose dalla morte.
Sovrano è l’attimo, sottratto a qualsiasi forma di fluire e, con ciò, scomparire. Hopper rende eterna l’antitesi dell’eterno, cioè l’attimo, e in questo modo ferma il tempo che va verso la morte. Questa l’eternità che Hopper rappresenta nell’irrealtà tangibile delle sue tele, dove tutto è sospeso, diafano, non concreto, persino il colore, persino la luce, spesso limitata a un particolare e comunque impalpabile.
Città impossibili, quelle di Hopper, città che non esistono e tuttavia esistono. Come le sue donne immobili, come temessero persino di respirare. Nulla respira in Hopper e noi che lo osserviamo non possiamo che trattenere il fiato per paura che le sue "cose" possano scomparire.
“Nei quadri di Hopper possiamo guardare le scene più familiari e sentire che sono essenzialmente remote, addirittura sconosciute. I personaggi guardano nel vuoto. Paiono essere altrove, persi in una segretezza che i dipinti non possono svelare e che noi possiamo solo cercare di indovinare. È come se fossimo spettatori di un evento cui non siamo in grado di dare un nome. Sentiamo la presenza di ciò che è nascosto, di ciò che senza dubbio esiste ma non viene rivelato. Formalizzando l’intimità, fornendole uno spazio in cui può venire osservata senza essere violata, il potere di Hopper viene esercitato nei nostri confronti con estremo tatto”. (Mark Strand, Edward Hopper, un poeta legge un pittore, Donzelli, Roma, 2016).
Non è l’attesa dell’inatteso, come dice Derrida, a caratterizzare il nostro tempo. Ciò che sopravviene è ciò che sappiamo da sempre senza conoscere e ci rifiutiamo di ri-conoscere. Osservando un quadro di Hopper, quel che ci perturba (S. Freud, “Il perturbante”) è la presenza assente di una conoscenza, quel “conosciuto non pensato”, secondo una definizione di C. Bollas, che ci sorprende perché non abbiamo il coraggio di pensare e conoscere l’inevitabile attesa/disattesa del non tempo.
Una coscienza diversa: questa la proposta di Hopper. Una coscienza che non ignora ma non sa, che fluttua nella fissità, che sospende il giudizio, il valore, la sostanza e si presenta di fronte all'ignoto non per conoscerlo, ma per esserne parte. Hopper è parte del suo dire, un non-dire oleoso che sguscia mentre assimila, confonde mentre osserva, propone l'improponibile di un tempo che non è per sfuggire al suo tempo senza voltargli le spalle. Un inconscio che si fa figura: questo mi sembra Hopper.
Nell'inconscio non esiste coscienza del tempo. Esso è psiche atemporale. Tuttavia, anche il non-tempo parla. Lo fa nel sintomo e in qualsiasi altra forma d'espressione rivesta questa terra. Il mondo di Hopper, e il mondo in generale, è un immenso teatro rappresentativo, una serie ininterrotta di simboli che si propongono e propongono una significatività senza parola che, come tale, è in attesa d'esser detta. Quando ciò avviene, la proposta si rinnova.
Hopper, tuttavia, non vuole che si dica: il suo linguaggio muto fissa ogni parola. Di Hopper non si può parlare. Si può soltanto osservare, tentando di non essere risucchiati nella fissità impalpabile del suo non dire.
Hopper è un simbolo muto, e nel frastuono insensato del banale, che si ripete inutilmente lungo secoli di aspettativa di dire, egli ci dice di osservare un silenzio che parla di silenzio.
Hopper, in ultima istanza, fa parlare ciò che vede nel mondo: il silenzio del non tempo della morte,
Nel frastuono a-significativo del mondo risuona la voce di Thanatos che Hopper tenta di far tacere sospendendo il tempo e facendoci ascoltare, attraverso i suoi quadri, il silenzio del significato, il nulla muto della nostra epoca.
Id: 3350 Data: 16/04/2024 12:03:56