chiudi | stampa
Raccolta di articoli di Sandro de Fazi
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
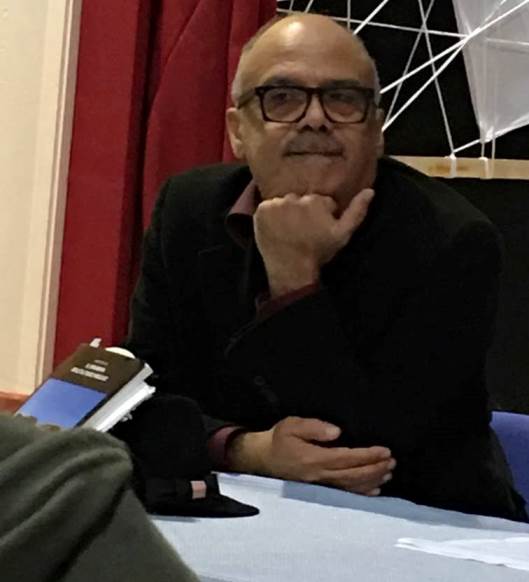
*
- Letteratura
Il poeta frenetico
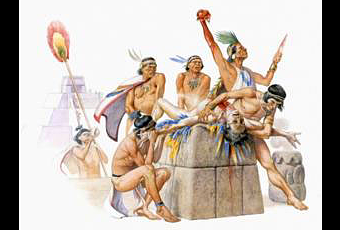
Non si insiste sufficientemente sul carattere selvaggio della mentalità greco-romana – è tra l’altro la tesi fondamentale de I Greci e l’irrazionale di Eric E. Dodds (introduzione di Maurizio Bettini, nuova edizione a cura di Riccardo Di Donato, presentazione di Arnaldo Momigliano, Milano, BUR, 2009) – in quanto un pregiudizio neoclassicista tuttora dilagante si rifiuta di affrontare la questione in termini antropologici. Winckelmann, ricollegandosi al Rinascimento e a Michelangelo – ossia, sublimando le disarmonie del vero disegno dei greci in perfezione assoluta – operava una specie di sublimazione della sublimazione. Ma gli interventi psichici interiori rappresentati demoniacamente e/o divinamente furono alla base degli stessi meccanismi mitologici che, per ragioni estetiche, peraltro non disprezzabili, Winckelmann preferì descrivere stabilendo una specularità tra esteriorità e interiorità: «Se il senso esterno è giusto, ci possiamo augurare che quello interno sia altrettanto perfetto: poiché esso è un secondo specchio nel quale, attraverso il profilo, riconosciamo i tratti essenziali di noi stessi» (Il bello nell’arte. Scritti sull’arte antica, a cura di Federico Pfister con uno scritto di David Irwin, Milano, SE, 2008, p. 82).
Per i romani delle età successive il discorso si differenziò solamente di poco, tant’è vero che le molteplici facies di civilizzazione anche nel passaggio dalla repubblica all’impero continuarono a insinuare l’immagine del “poeta frenetico”, includendovi Virgilio e Orazio, secondo una concezione già presente in Democrito che prevedeva un fare poetico μετ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἱεροῦ πνεύματος (fr. 17 e 18), portando a esempio direttamente Omero (fr. 21). Analogamente , sul piano politico le Idi di marzo furono inutili in quanto l’anarchia era strutturalmente insita nel popolo romano e saperla arginare – dare l’impressione di una ricomposizione di qualcosa di unitario e pacifico che non era mai esistito, nemmeno adesso – fu intervento meritorio di Augusto, erede del cesarismo ma che di fatto salvò la civiltà romana permettendole di identificarsi in un unicum tanto definitivo quanto mutevole.
Id: 1092 Data: 03/06/2014 23:02:25
*
- Filosofia
Ars rhetorica
Cicerone è stato allo stesso tempo un oratore e un teorico dell’oratoria, la pratica e la teoria si compenetrano l’una nell’altra traendo spunto dall’esperienza tanto dell’avvocato quanto del politico. Prima della svolta filosofica degli ultimi, desolati anni, tanto l’oratore quanto il retore collimano col filosofo al punto di accusare Socrate di aver provocato una frattura epistemologica tra retorica e filosofia (De oratore, 3, 60). Allo stesso modo è oratore il filosofo che insieme alle res mostri anche i modi espressivi e filosofo è l’oratore che nell’inventio si avvalga di sapienza come di ars rhetorica ai fini della dispositio e dell’elocutio, provvisto di utilità pratica e funzionale alla vita politica, la retorica essendo parte non tecnicistica dell’oratoria anche nelle fasi conclusive della memoria e dell’actio. Cicerone preferisce l’Aristotele induttivo a quello deduttivo, fermo restando il dubbio, ben messo in luce da Antonio Manzo, se a determinare la sua scelta "non sia stata la mancata o tardiva conoscenza di un Aristotele perduto dagli Antichi fino all’edizione curata da Andronico di Rodi (circa la metà del secolo I a.C.) e conservatosi ancora ai tempi presenti, invece di quello perduto per noi, ma noto agli Antichi" (La formazione retorica di Cicerone, in Scripta philologa, Roma, Nova Millennium Romae, 2003, p. 237).
Così Lucio Crasso nel De oratore contrasta Antonio, che da parte sua svaluta la retorica non riconoscendone il potenziale dialettico e psicologico, attenendosi ai loci communes, mostrandosi cioè riduttivo verso i luoghi specifici propri dell’oratoria. Cicerone dunque prima di diventare filosofo fu retore nel senso più vicino ad Aristotele, che prescriveva la logica nella retorica, e si era distanziato dalla techne elaborata da Ermagora di Temno.
Id: 1058 Data: 27/04/2014 00:24:15
*
- Filosofia
I grandi intellettuali sono ambigui: anzi, ambivalenti
La scrittura di Toni Negri: mi riferisco a questo Spinoza e noi (Udine, Mimesis 2010, tr. dal francese di Vittorio Morfino). Intanto è singolare l'introduzione, dove l'A. esordisce in prima persona («Scrissi quel libro in carcere») fornendo il senso della sua esperienza diretta e poi verso la fine va decisamente parlando di sé in terza, come in una sorta di spersonalizzazione e teorizzazione estrema o sdoppiamento autocritico («Infatti, Negri e i suoi amici dovranno almeno concedere che», «Non è questa (di Negri) una teologia politica vera e propria?»), al punto che, a un certo momento, non riuscivo a raccapezzarmi e mi sono chiesto di chi fosse l’introduzione: ma di nessun altro, non c’è dubbio, se non di Negri! Nei capitoli che avanzano con rigorosa scienza, dove l’argomentazione è serratissima, all’improvviso si trova la reiterazione dei tre punti di sospensione à la Céline: da una parte a riprodurre una mimesi del parlato ex tempore o occasioni colte a braccio sine scripto, appunti o spunti improvvisi e dall’altra vi sono ipotesi o proposte teoriche estemporanee al modo del Collège de France («... la schizofrenia, l’emergere e/o il superamento del limite... un orizzonte qualche volta quasi naturalista... Deleuze-Guattari alla ricerca dell’utopia del 'valore d'uso'?...»), per tornare in seguito alla sistematicità del discorso. Questo metodo ricco di suggestioni significative, non scevre da ambivalenze concettuali e provocazioni per il lettore, trovo abbia del fascino.
In definitiva Toni Negri propone di iscrivere Heidegger, contrapponendogli Spinoza, nel pensiero reazionario, anzi di denunciare tout court quel pensiero come reazionario «non solo perché esso è probabilmente legato alle vicende del movimento nazista e fascista» (op. cit., p. 55) ma anche perché quella concezione dell’essere «pone il destino come affogamento dell’essere – è un serpente nero. Heidegger ci strozza» (ibidem). Fino a che punto è accettabile questa proposta?
(19 dicembre 2013)
Id: 1044 Data: 15/04/2014 20:41:01
