chiudi | stampa
Raccolta di articoli di Timothy Megaride
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
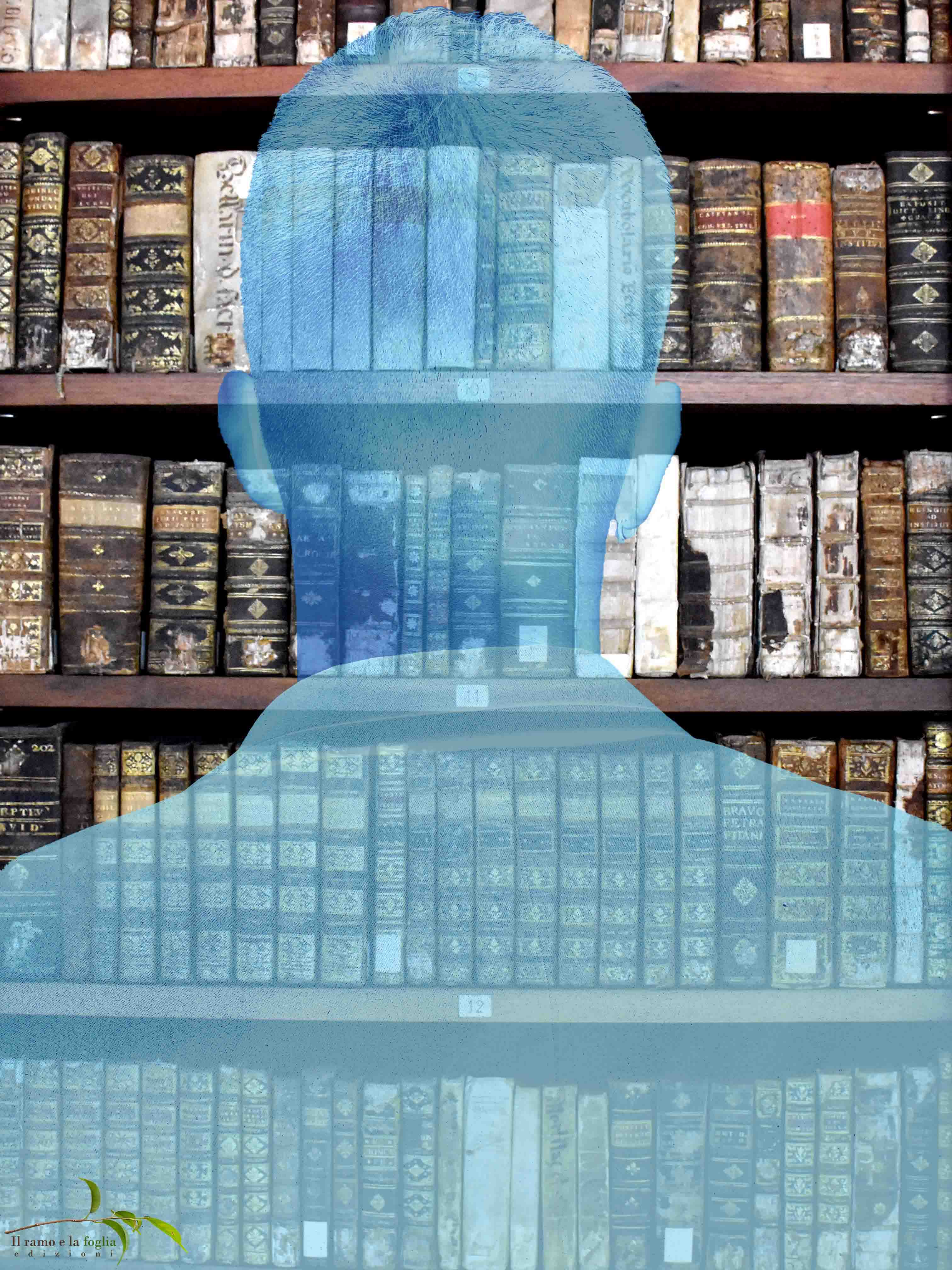
*
 - Letteratura
- Letteratura
Lasciatemi divertire!
Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi così
come una
cosa
posata
in un
angolo
e dimenticata
Qui
non si sente
altro
che il caldo buono
Sto
con le quattro
capriole
di fumo
del focolare
[Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, Natale]
«È del poeta il fin la meraviglia…»[1], scriveva Giovan Battista Marino quattrocento anni fa, chiosando in tal modo la poetica che fu detta barocca, alla quale l’attuale in qualche misura somiglia, se è vero che ne è emblema la tenace volontà di destar stupore e assai spesso schiamazzo, il primo teso a coprire il grigiore e il tedio della routine, il secondo a vincere il frastuono che le fa da bordone.
L’arte evolve e diventa espressione corale della quale lo stesso fruitore è artefice, con l’applauso e la mimesi, lo spitting vocale e il karaoke. Siamo tutti ideatori e beneficiari dell’arte globale che tutto fonde e confonde per approdare alla babele delle forme, al guazzabuglio degli stili, alla sinestesia bipolare dell’occhio e dell’orecchio.
In principio era il dagherrotipo. Fiat lux! Ed essa stessa, la luce, sottrasse al pittore il talento prospettico facendosi fedele riproduttrice del reale o, quanto meno, della sua illusione. Non sono, queste, conquiste del secolo in cui il verosimile e il vero furono i valori più celebrati dalla ciancia erudita? Accidenti all’ipometropia! Costoro fissavano l’attimo, tralasciando il divenire che tutto trasforma, rigenera e degenera, modifica e forgia come vuole la saggezza platonico-eraclitea che recita, a mo’ di mantra, Panta rei. Ed ecco, infine, il portento dei fratelli Lumière che ben si accompagna al dinamismo marinettiano nella commistione che, in effetti, realizzò interamente il progetto di rappresentare il tumulto. Ecco la settima arte ingurgitare le previe nell’amalgama dell’artifizio globale e globalizzabile. C’è qualcuno che oggi ignora le fantasmagorie del cinema o della televisione, ancelle incluse? Al dì presente non v’è cane che non eserciti il vizio o vezzo del guardare e dell’esser guardati, del riprendere e del farsi riprendere dall’occhio inquisitore di una telecamera o cinepresa entro le scenografie di uno sconfinato spettacolo con gustoso contorno di effetti speciali, anzi specialissimi. Tra i quali il rimbombo della grancassa che impera, impietosa, a segnare il ritmo forsennato, a dispetto della discrezione dei timpani nella musica che fu detta sinfonica e che antepose l’armonia al fracasso.
È dunque barocca e futurista la nostra età, invasiva come una metastasi, tale da produrre una celere evoluzione della specie che, relegando l’homo sapiens alla paleontologia, genera l’homo videns, come volle l’ottimo Giovanni Sartori[2]. Dubito che esista anche l’homo audiens, quale la cagnara dominante farebbe suppore. Grugniti e ululati non hanno sintassi. Nessuno produce suoni intelligibili e l’organo deputato alla decodifica si pone in quiescenza da sé. Nulla si dice e dunque nulla si ascolta.
Nelle more qualche oscuro poetucolo si guarda intorno e sorride, emulo di Palazzeschi che assai per tempo capì l’andazzo:
«Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente!
Non lo state a insolentire,
poveretto,
queste piccole corbellerie
Sì, c’è ancora qualcuno che coltiva l’arte minore, anzi minima, della parola e, in assoluta solitudine, estraneo alla smargiassata corrente, come il leopardiano pastore, (vecchierel stanco, infermo, / mezzo vestito e scalzo) s’aggira tra antichi ruderi e da lì trae ispirazione per qualche scherzuccio di dozzina che gli riscaldi il cuore e ne consoli altri al suo adiacenti. Col sorriso sulle labbra e l’animo in pace del saggio, scrive storie dal sapore antico, come “L’imitazione del vero” di Ezio Sinigaglia[4] che ho appena finito di leggere per gentile segnalazione di un amico che conosce le mie debolezze per la parola ben scritta.
Il romanzo breve o racconto lungo è una fiaba a tutti gli effetti, benché di magico non abbia altro che i marchingegni lignei assemblati da Mastro Landone, manufatti stupefacenti che, pur sembrando portenti, sono opera d’ingegno. Sembra questo Mastro Landone un progettista di Ikea o Foppapedretti ante litteram, non senza ammiccamenti al noto Geppetto di Collodi. E soffre, poveretto, d’indicibile ardore per il garzoncello di bottega che la Provvidenza gli ha inviato in soccorso per sbrigar minute faccende e apprender l’arte sua. Non si tratta dello struggimento ascetico di Gustav von Aschenbach, né tampoco il suo Ganimede somiglia a Tadzio e alla sua statica ideale fissità. Qui si tratta di carne e sangue, di bramosia e pirotecnica ormonale.
«Iniquo giudicava il crudele castigo di dovere ogni giorno, con quello del suo vagheggiar lussurioso, lo spettacolo dell’innocenza di Nerino paragonare, d’ogni vaga speranza nella sua vergogna orbato restando. E tuttavia ogni mattina, d’un breve ed agitato sonno destatosi, allo spettacolo di quell’innocenza com’ad una festa Mastro Landone correva».
Né l’innocente Nerino, il garzone, sfugge alle istanze della verde età.
«E poiché ha fatto ancor nel suo perfetto equilibrio la Natura ch’ad ogni morte una vita e ad ogni ombra una luce e ad ogni fuoco un’acqua corrisponda, agevolissima cosa è pei fanciulli il trovar l’acqua in sé medesimi ch’il fuoco donde sovente avvampano ha la virtù per alcun tempo d’estinguere. Talché, pur nella sua innocenza, aveva anche Nerino facilmente la fonte di quell’acqua trovata e con piacere grandissimo ad essa sovente s’abbeverava».
In altri termini, come ogni adolescente che si rispetti, Nerino si fa le sue brave seghe, in una falegnameria, come ognun vede, luogo ideale per adoprar l’utensile idoneo a tagliar ceppi ed apprenderne il moto oscillatorio che al sussulto approda. Troppa fatica per un giovinetto smilzo al quale la duplice cura può sottrarre vigore e beltà. È per questo che il buon Landone, prodigo d’ingegno e di perizia, gli fabbrica, a sua insaputa, la macchina del sesso ad azione che ben può dirsi manuale. Non eran tempi di dispositivi tecnologici avanzati e l’industria dell’autoerotismo era di là da venire. Ne usa e abusa il piccolo Nerino del marchingegno che la mano esperta di Landone sa ben far funzionare. Fino a quando… Beh, scopra il lettore il resto della fiaba. Di trama esile ed essenziale, ma di dicitura arguta e maliziosa, d’una malizia sorniona che attinge alla prosa barocca, nell’ampio e avviluppato periodare, nella fantasiosa selezione lessicale, nella patina di arcaico che il costrutto latineggiante le conferisce, nei chiaroscuri degli interni descritti, nella poca luce di una candela o d’una feritoia che esalta il dinamismo delle figure come in un dipinto di Caravaggio.
«Or che quella stessa visione ogni notte pel suo pensiero solamente fluiva, Mastro Landone, levatosi, entro il cerchio di luce com’entro la gabbia del suo tormento movendo, al tavolo come per l’innanzi sedeva ma, in luogo di macchine, fanciulli sulla carta versava».
L’aggraziato corpo di Nerino emerge nella penombra della bottega tal quale gli adolescenti di Caravaggio dalle sue più celebri tele. V’è carnalità nei corpi umani maschili della pittura barocca, così che l’occhio quasi ne percepisce la tensione omoerotica.
Per altro verso il profluvio di tropi e perifrasi ammantano di un velo di verecondia la materia scabrosa e le danno la levità della facezia. Si legga l’arguto sofisma col quale si dà ragione delle pratiche omofile:
«Mentre ch’il prendere piacer da sé stessi, essendosi ch’il proprio sesso non può esser ch’il medesimo, è lussuria e sodomia. Da ciò discende che tutti i fanciulli, finché di fanciullezza non escono, son lussuriosi e sodomiti, e che tutti i sodomiti e i lussuriosi son tali per la cagion che son rimasti fanciulli».
In altri termini, la masturbazione altro non è che pratica omosessuale, essendo il soggetto e l’oggetto del procacciato piacere la medesima persona. Come la volti o come la giri, le femmine maneggiano una vulva e i maschi un pene.
Resta da chiedersi perché Sinigaglia vesta la povera materia di sì sontuosa veste formale. Azzardo un’ipotesi che il lettore o l’autore medesimo possono più o meno condividere. Dicevo di Barocco, di Seicento, di cultura delle forme e di concettismo. Dell’arte ho già evidenziato l’esantema ornamentale, il gioco di luci e ombre, l’enfasi dello stupefacente, la prosopopea (si pensi all’Azzeccagarbugli manzoniano), l’immaginifico. Sul versante letterario operano fantasiosi narratori come Giulio Cesare Croce (1550-1609), Giulio Cesare Cortese (1575-1622), Giambattista Basile (1566-1632). Più o meno coeva, in Italia, è la nascita e l’enorme diffusione internazionale della Commedia dell’Arte, un genere di intrattenimento che sbeffeggia senza ferire e fa ridere sovrani e cortigiani. A questo vitalismo smodato fa da sfondo la cupa cultura delle Controriforma, formale, retorica, parolaia, pedante. Ogni opera prodotta, per ingegnosa che sia, subisce il vaglio di conformità alla dottrina cattolica. Lo scherzo e lo sberleffo hanno scarsa censura, perché cosa frivola e indegna di particolare attenzione da parte del censore di turno, benché capiti che la facezia sia mordace e ben poco ortodossa. Licenziosa quanto basta a sfuggir la sferza.
Non identica licenza possono consentirsi uomini di scienza quali Copernico e Galileo, individui propensi alla verità del fenomeno in sé oltre l’apparenza superstiziosa dell’osservatore. È giocoforza che la mannaia dell’Inquisizione s’abbatta su di loro.
Ora, se voi ponete come sfondo alle nostre presenti esistenze i fondamentalismi e gli integralismi, i terrapiattismi, le taumaturgie, le liturgie magico-rituali, le coreografie apotropaiche, i negazionismi, i creazionismi, i complottismi e quant’altro alimenti l’immaginario a discapito della verità, vi imbatterete nella cosiddetta cultura di massa che vuol dire anche globale, cioè potenziale mercato al quale l’industria non meno globale propone-impone prodotti di serie.
Alla produzione di serie non sfugge la cinematografia, la televisione, l’editoria, le quali assoldano il fior fiore degli esperti sia nel settore del maketing, sia in quello afferente della produzione. Realizzano articoli tecnicamente ineccepibili, ovviamente a scapito della poesia, della creazione artistica, della libera espressione dell’individuo. Limitandoci alla letteratura, si può certamente affermare che non è lo scrittore/poeta a generare lo stile, ma è lo stile a generare lo scrittore, laddove lo stile è dettato dal gradimento dell’acquirente/lettore. I suoi canoni sono insegnati in scuole e università deputate che di gusti del pubblico ne sanno una più del diavolo. L’arte cede il passo alla tecnica. Certo, sto riprendendo alcune tesi che Walter Benjamin profuse nel suo saggio più celebre, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, non perché disapprovi la sua argomentazione, ma perché la società di massa non è, oggi, esattamente la medesima che il filosofo tedesco si prefigurava. Che l’aura sacrale debba essere sottratta alla produzione artistica mi trova d’accordo; meno propenso sono ad accogliere la sudditanza dell’individuo al gregge. Certo non desidero neppure il contrario, cioè che il gregge si sottometta al narcisista del momento. Dunque, non ne vengo fuori. Mi aiuti chi legge queste note a sortir dalla pania. So solo che i sequel, i prequel e le serie mi molestano alquanto. Preferisco il croco, il fiore solitario dei prati deserti, il poeta che lavora di cesello e “scioglie all’urne un cantico che forse non morrà”.
Così immagino il buon Sinigaglia, chiuso nel suo studiolo, intento a sbozzar parole e fonemi, lontano dalla caciara, sornione nel tepore antico di un ciocco ardente del camino. E recita a mente:
«Infine io ò pienamente ragione,
i tempi sono molto cambiati,
gli uomini non dimandano
più nulla dai poeti,
e lasciatemi divertire»!
Id: 2752 Data: 08/02/2021 10:34:40
*
- Letteratura
Remo Rapino, scrittore neorealista
Da "il tetto", n. 340, novembre-dicembre 2020
Remo Rapino, scrittore neorealista
“Ce steva nu scarparo puveriello,
chiagneva sempe ca purtava 'a croce...
'A sciorte lle scassaje 'o bancariello
e pe' se lamentá... perdette 'a voce!”
[Giovanni Capurro, Totonno ‘e Quagliarella]
“Anche se questa non è una favola per bambini
bisogna che io cominci scrivendo C’era una volta,
perché era proprio una volta che c’era un bambino”
[Andrea Bajani, Un bene al mondo]
«Ogni storia di uomo, matto o normale, è una mescolatura delle stesse cose, na cascanna di lacrime, qualche sorrisetto, na cinquina di gioie di straforo, e un dolore grosso come quando al cinema si spengono le luci». E ogni vita, a suo modo, è eroica.
Molto prima che la scrittura fondasse la Storia, l’oralità trasmetteva la memoria di vite trascorse, risuscitando uomini vissuti in epoche remote. L’oralità era già epica e diceva di avventure sovrumane, di guerre e sconfitte, di lutti e rovine, di amori e portenti. Gli aedi di allora deducevano dalle sepolture la materia del racconto e si aggiravano, ciechi, tra le macerie di un tempio o di una città distrutta per trarre ispirazione. I ruderi che ancora oggi ammiriamo sono in realtà sepolcri. Sotto archi e trabeazioni corrosi dal tempo vissero degli uomini.
Fu così che Edgar Lee Masters fece parlare i suoi morti, fu così che dalle tombe Foscolo trasse i suoi intramontabili versi. L’epitaffio ci dice che la tomba ha un senso per i vivi, ci dice che lì, in quel punto, ci sono i resti di un uomo che fu.
Remo Rapino[1] è il Foscolo degli esclusi, mimeticamente “vernacolare” e, proteso a echeggiare la voce di un’esistenza dimenticata, “scioglie all’urna un cantico / che forse non morrà” (Manzoni). No, non celebra Napoleone. Andiamo, il grande condottiero lo trovate in tutti i libri di storia, magari strade e piazze ne ricordano le gesta. Napoleone lo conoscono tutti, ma Bonfiglio Liborio chi lo conosce? Nessuno, statene certi, nessuno! Tranne Remo Rapino che, un giorno, aggirandosi tra le tombe di un cimitero abruzzese, nella zona di Chieti più o meno, così, per caso, legge su una lapide di marmo liscio e chiaro, con lettere di oro, finto però, che va a finire che se sono di oro vero, come ci sta per il mondo un sacco di malagente ladresca, uno di notte se lo può arrubbare, dopo non si legge niente…, ecco, dicevo, gli pare di leggere il seguente epitaffio o, quanto meno, il suo progetto, un modo come un altro per sbeffeggiare la morte:
QUI finalmente RIPOSA
LIBORIO BONFIGLIO
Fiommista
Nato 22 agosto 1926 morto (ce lo mette il marmista)
Aveva gli occhi uguali a quelli di suo padre
Volare oh oh nel blu dipinto di blu (se ci capa)
Quasi un secolo di storia nazionale emerge dallo sproloquio di Bonfiglio Liborio, scritto sempre così, non diversamente da tutti gli altri personaggi del libro, prima il cognome poi il nome, com’era uso un tempo nei pochi momenti ufficiali delle umane esistenze italiche, negli atti pubblici, nei registri scolatici, a militare; il nome, il connotato che fa di noi degli individui, ciascuno unico con la sua sensibilità e la sua biografia, veniva sempre dopo, a tutto vantaggio del tratto clanico che ci faceva branco a nostra insaputa.
È tutta un’altra storia, ovviamente, una storia miope che farebbe storcere il naso agli storici di professione, ma forse più vera perché riferita da un testimone che l’ha subita senza mai veramente comprenderla. Il Fascismo e la guerra, il lungo dopoguerra e la ricostruzione, il boom economico e le lotte operaie, lo stremismo politico e le stragi impunite, gli anni di piombo (molto in sordina e c’è un motivo) e la legge Basaglia che chiude i manicomi; e poi via, di corsa, verso il riflusso, il berlusconismo e gli epigoni confusi di inizio millennio.
A farne le spese siamo stati noi, cioè, scusate, volevo dire è stato Bonfiglio Liborio, uno qualsiasi, un perfetto sconosciuto, uno dei tanti. Posso permettermi di dire “uno di noi”? Certo. Quelli che finiscono nei libri di storia o danno il loro nome a una strada sono un’esigua minoranza. Nessuno si ricorderà di noi, mettiamoci l’animo in pace. Allora ben venga questo bel monumento al defunto ignoto che Rapino erige per noi. Sì, perché dentro Bonfiglio Liborio ci siamo davvero tutti, anche se abbiamo visto ben poco mondo e tutt’al più abbiamo fatto il militare a Cuneo, come recitava l’ottimo Totò. No, Liborio non lo ha fatto a Cuneo, ma in un paese che si chiamava Tauriano di nome e Spilimbergo di cognome. Ha ventun anni e a casa non lascia nessuno, anzi nessuno va a salutarlo alla stazione, neppure quella Giordani Teresa della quale si è innamorato e che resterà per sempre l’amore mancato della sua lunga esistenza.
Poi il mondo lo vede da migrante, prima in una Milano fredda e nebbiosa che pare uscita dalla penna di Testori, poi in Emilia e Romagna che sembra guardare ancora con gli occhi dell’amato Pascoli. È operaio in un’epoca in cui impera ancora il fordismo e il lavoro in fabbrica appare tal quale ce lo rappresenta Chaplin in Tempi moderni. È alla Ducati che Liborio manifesta il suo unico vero atto di ribellione a un destino crudele. Dà di matto e finisce prima in galera e poi in manicomio. Non è davvero pazzo, è solo stravagante, una cocciamatte così come egli stesso si definisce (Però mica è tanto matto il nostro Liborio, gli diceva il dottore Mattolini Alvise).
La legge 180 che, nell’intenzione del legislatore, voleva essere una conquista civile è per lui la condanna alla solitudine e alla marginalità sociale. Dopo quarant’anni fa ritorno al paese, dove la nomea di cocciamatte lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. L’onirico e visionario banchetto con cui dice addio al mondo è la sarabanda dei ricordi, la grottesca adunata delle scorie umane che hanno segnato i passaggi cruciali della confusa memoria, Maccarone a parte, il suo rivale in amore. È il miracolo dell’immaginazione, in realtà l’unico miracolo del romanzo; qui non c’è religione, liturgie carnascialesche a parte, benché Liborio vada in chiesa e talvolta preghi, non, come accomoda dire / al mondo, perché Dio esiste: / ma, come uso soffrire / io, perché Dio esista. (Caproni)
Il libro abbonda di riferimenti letterari, benché il mélange linguistico faccia pensare al dialetto abruzzese italianizzato dell’illetterato. Si vede che Rapino è un lettore di Giorgio Caproni. Attraverso Liborio non solo gli rende esplicito omaggio, ma ne riecheggia la religiosità a-teologica, disperatamente laica. I versi citati appartengono alla lirica “Lamento (o boria) del preticello deriso”, nella quale l’inesistenza di “Dio” fa eco alla sua rima di un “io” parimenti inesistente.
Per altro verso e in contesto differente, lo sguardo di Liborio alla prostituzione è già tutto dentro la lirica di Caproni:
Eppure, fu in quel portuale
caos, ch’io mi potei salvare.
Che dirvi, se la vera autrice
della mia conversione
(ma sì: non ho altra ragione
da addurre) fu una meretrice?
A condurre Bonfiglio al postribolo è il suo commilitone, Venturi Ermes, un personaggio su cui mi piacerebbe indugiare ed aprire un capitolo lungo come un trattato. Lasciamo perdere. Questo Venturi Ermes gli fa conoscere i piaceri della carne, a pagamento e in uno degli ultimi bordelli prima che la legge Merlino li chiudesse. Poi Liborio, quando racimolerà un po’ di denaro, ci andrà da solo a puttane, quelle dei viali, e sarà per lui terapeutico, come per tutti noi, per cambiare il sangue e alleggerire la testa dai pensieri e dai rumori oppure cancellare per un poco la fila degli sfortunamenti. Sarà una vecchia baldracca, sorda e malconcia, a tenergli compagnia nel tratto finale del suo impervio cammino. Alle sue solitarie e sbrigative esequie presenzierà, unico partecipante, come un vedovo sconsolato.
Per chi non ha nulla, ma proprio nulla, può anche essere consolante la pietà di una puttana che gli schiocca un bacio a distanza, sulla punta delle dita, ma quello non si pagava.
Lo so, la letteratura sociale abbonda di personaggi del genere. Sono presenti nel cinema come nel teatro. Liborio da bambino mi ha fatto più volte pensare ai tanti bambini della letteratura ottocentesca, a Dickens per esempio. Le umiliazioni e le sconfitte del Liborio giovane, un po’ socialista di Nenni, un po’ comunista di Togliatti, mi evocano Zola, Verga. Penso ai tanti piccoli artigiani, operai, contadini, pastori di Bernari, Pratolini, Alvaro, senza considerare che anche la letteratura anglo-americana non si risparmia nel tratteggiare con efficacia la condizione degli umili e diseredati. Ma il romanzo che ho percepito più prossimo a questo di Rapino è senza dubbio “La malora” di Beppe Fenoglio, certamente per l’invenzione linguistica che gli è affine, ma anche per scagionarlo dalla tentazione di ascriverlo a un meridionalismo di maniera. Qui il Meridione non c’entra, come è da escludere il vittimismo di cui la letteratura meridionalista gode fama. C’entra la marginalità sociale, la “nullità” della maggior parte dell’umanità, a dispetto delle dichiarazioni di intenti di ideologi, politici e capi religiosi. Le belle parole e le pie intenzioni giustificano l’esistente, non ne prospettano il superamento. Non è avvenuto in passato, non avviene oggi. Solo che oggi, in questo nuovo millennio colmo di belle tecnologie, noi dimentichiamo che i quattro quinti dell’umanità è esclusa dalla Storia e che i Bonfiglio Liborio sono tutta l’umanità negata. Ci piace celebrare inesistenti supereroi, civiltà aliene, poliziotti fascinosi che mettono in prigione i cattivi e sbrogliano improbabili matasse. Per non guardare in faccia la realtà, per non assumerci le nostre responsabilità di patenti schiavisti. Siamo onesti: nessuno di noi rinuncerebbe ai suoi privilegi per realizzare un mondo più equo. Siamo una specie maledetta. Solo l’estinzione, che certo avverrà in un lontano futuro, potrà cancellare le nostre colpe.
A fine lettura ho trattenuto la lacrimuccia che stava lì lì per scapparmi. Non voglio assolvermi. Così come non assolvo gli stremisti di un tempo che pretendevano di parlare alle vaste masse. Liborio si reca all’Università di Bologna ad ascoltarli; non ci capisce un tubo. Nessuno capiva un tubo delle loro dotte analisi, per quanto pretendessero di interpretare bisogni e aspirazioni altrui. Non capivano che Liborio aveva gusti più raffinati. Gli piaceva “Miracolo a Milano” di De Sica. Il neonato all’inizio del film dovrebbe avere oggi l’età di Remo Rapino. Magari era lui, chi può dirlo. È nato sotto un cavolo, come nelle favole. Oppure lo scrittore abruzzese ha voluto rendere omaggio a uno dei più celebrati e discussi film neorealisti. Sarebbe plausibile. Totò il buono di Cesare Zavattini potrebbe ben essere stata la fonte letteraria di questo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”.
©Timothy Megaride 2020
Id: 2745 Data: 19/01/2021 12:05:36
*
- Letteratura
La febbre di Jonathan Bazzi
Sono nato a Rozzano ma non so menare, leggo, scrivo, balbetto, mi piacciono i maschi. Ecco alcuni dei tratti distintivi di Jonathan, il protagonista e io narrante di Febbre[1]. Se ne possono aggiungere altri, tutti desumibili dal racconto: a Jonathan non piace il calcio, ama giocare con le bambole, ha ascendenze meridionali in entrambi i rami della sua famiglia. Si può proseguire, ma mi fermo qui; in caso contrario dovrei scrivere un trattato, un genere che di questi tempi ha scarsa o nessuna popolarità.
Isolando ciascuno di questi tratti ottengo altrettante categorie mentali, tutte precostituite in qualche misura, tutte ascrivibili a qualcosa che somiglia all’imprinting. Si potrebbe fare un test: io scrivo Rozzano e voi mi dite cosa vi evoca. Potrebbe venir fuori una cosa del genere: Rozzano, Rozzano… una tipica banlieue italiana popolata da immigrati, ultras, manovalanza mafiosa, spacciatori di droga, puttane, lenoni, casalinghe teledipendenti e via discorrendo; nella babele delle parlate regionali e della sottocultura neomelodica o pseudo-rapping rinvieni il quoziente intellettivo medio della comunità nella stentata licenza media (scuola dell’obbligo) conseguita per esasperazione, in tal caso degli insegnanti che non vedevano l’ora di togliersi dai coglioni un branco da fare invidia al Signore delle mosche, salvo poi imbattersi nel branco successivo probabilmente peggiore di quello appena licenziato.
Buccinasco, Corsico, Assago, Rozzano: posti da cui vengono un sacco di rapper, posti da cronaca nera. Le sparatorie, la rissa col morto, le baby gang, le infiltrazioni mafiose.
In un contesto del genere i tratti leggo/scrivo/balbetto/mi piacciono i maschi identificano una tipologia umana che il sistema immunitario della comunità identifica come virus da combattere, una pericolosa minaccia alla salute del corpo sociale. Direi che il povero Jonathan sta alla comunità di origine come il virus dell’HIV sta all’organismo umano. Lo si argina, lo si imprigiona, ma non lo si elimina del tutto, almeno per ora. Fatevene una ragione: dovete convivere con la sieropositività e con Jonathan che la rappresenta di diritto. Le leggi, quelle di quest’ente un po’ bizzarro che si chiama Stato, un organismo che, per sua prerogativa, qualche mezzo per contrastare le vostre istanze ce l’ha, vi impediscono di mettere alla gogna un povero scemo; gli antiretrovirali, intanto, fanno abbastanza bene il loro lavoro e arginano in maniera accettabile la minaccia dell’AIDS.
Il resto lo deve fare Jonathan da solo, completamente da solo. È nato in un deserto, mica è colpa sua? Non ha una mappa, non ha il GPS, non ha un compagno di viaggio né una guida a pagamento. Che deve fare per sopravvivere? Procede empiricamente, per tentativi ed errori, con legittime esitazioni e ripensamenti. Prova a orientarsi con gli astri, qualche volta ci riesce, qualche volta si arrende, ancora poco colto e poco smaliziato per riconoscere la solidità e l’attendibilità dei punti di riferimento che arbitrariamente si è dato. Si ritrova in una selva oscura ché la diritta via era smarrita, preda di lupe fameliche, leoni e lonze. I segni dello smarrimento sono tutti nell’enuresi notturna, nella balbuzie, nella prolungata suzione del biberon. Un bravo strizzacervelli capirebbe di che si tratta, potrebbe anche tentare di porvi rimedio, ma probabilmente nelle banlieue non sanno neppure che esistono gli strizzacervelli. Virgilio va in soccorso ai poeti, mica agli sfigati di Rozzano!
Ci sarebbe la famiglia alla quale fare appello, la sbandierata e celebrata famiglia costituita da due ragazzini incoscienti che il caso e la necessità hanno voluto matrici più che genitori: sospetto che non bastino due gameti combinati dal caso a determinare la dignità genitoriale. Tutt’al più ti trovi dinanzi a padri e madri che non hanno avuto / per voi mai una parola d’amore, / se non d’un amore sordidamente muto / da bestia, e in esso v’hanno cresciuto, / impotenti ai reali richiami del cuore (Pasolini, La ballata delle madri).
Mi dispiace, c’è poco da fare, Jonathan è un corpo estraneo, intruso, esattamente come il temuto virus dell’HIV. Alcuni reietti come lui si suicidano ancor prima di raggiungere l’età della ragione. Altri tentano la fuga, ove possibile, salvo poi accorgersi di passare dalla padella alla brace. Per i dannati della terra no hay patria no hay matria (Lydia Cacho) che li protegga. È inutile assumere altre identità, altri tratti distintivi (tutte le identità che ho provato ad assumere prima o poi hanno ceduto). Sono mere definizioni, astrazioni, prefigurazioni, pregiudizi. Non resta che essere se stessi, con tutti i rischi e le conseguenze del caso. L’esilio è privilegio e rifugio degli spiriti eletti. Lo spazio dell’esilio diventa quello della protezione. Va a finire che produce poemi che trasmettono alla posterità la potenza dei cambiamenti epocali. L’ho pensato, confesso che l’ho pensato leggendo Bazzi.
Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco de lo essilio prima saetta. […] E quel che più ti graverà le spalle, / sarà la compagnia malvagia e scempia / con la qual tu cadrai in questa valle, […] Di sua bestialitate il suo processo / farà la prova; sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso (Dante, Commedia, Paradiso XVII).
Così Jonathan migra nei templi del sapere della Milano bene; passa per un idiota per l’ingorgo della parola che gli muore in gola; è fatto oggetto di sberleffi e derisioni. Gli insegnanti medesimi sono bestie addomesticate. La routine uccide i loro entusiasmi, ammesso che ne abbiano e non siano finiti in cattedra per ripiego. Quando non parli, sono i primi a pensare che tu sia scemo. Al branco dei millennials insegnano soprattutto la ferocia del privilegio. Allevano fighetti strafottenti: ti conosco mascherina!
Solo et pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti, / et gli occhi porto per fuggire intenti / ove vestigio human l’arena stampi (Petrarca, Canzoniere XXXV).
Non è un male questa seconda fuga. Jonathan se ne sta in disparte, ma intanto impara a conoscere se stesso, benché i sentieri che percorre siano tutt’altro che agevoli. L’adolescenza è un vero calvario per gente come lui. Nelle more scopre un nuovo ghetto nel quale rifugiarsi, ancora più squallido, forse più deprimente. Finisce nelle maglie della rete che tutto fagocita e stritola. Una cosa la impara di sicuro: lui non è l’unico al mondo. Dietro l’anonimato di nickname e profili più o meno fasulli si nasconde una marea di froci world wide web. Sembrerebbe non essere più solo, ma è l’inganno dei sensi che bramano compiacimento. Adolescenza: il timore in mano agli ormoni. Sesso senza poesia, scopate selvagge nei luoghi più impoetici che si possa immaginare. Dei suoi partner occasionali sa poco o nulla e lui è solo un qualsiasi oggetto di trastullo per loro. Meno di zero, ai limiti dell’invisibilità. Le poche pagine dedicate alle avventure-disavventure sessuali sembrano uscite dalla penna di Jean Genet, uno dei miti più celebrati del ghetto omosessuale, quasi a dimostrare che lo stereotipo del gay effeminato è appunto un cliché legato alle culture locali, molto coltivato in Italia, Spagna, America latina, India e Thailandia, cioè nei paesi caldi. Nei paesi freddi del mondo pare vincente il modello di una virilità esasperata ai limiti del ridicolo. Tom of Finland è un mito ancora oggi; molti scimmiottano nei costumi e nelle pose i suoi giovanottoni iperdotati. Non c’è gay pride famoso in cui non ne compaiano i figuranti. Un recente biopic di Dome Karukoski ricostruisce la vicenda umana e la personalità dell’artista finlandese. A giudicare dai comportamenti e dalle pratiche esperite, i primi partner di Jonathan ben potrebbero apparire nelle illustrazioni di Touko Laaksonen, magari senza esserne completamente consapevoli. Manipolano un fiore in boccio senza neppure rendersi conto del profumo che emana. Solo uno, che io ricordi, pare essere consapevole della distanza d’età che separa il fiore dal tronco scabro della piena maturità. Si astiene dallo sfiorarlo. Gli altri adombrano l’abuso sessuale ai limiti della pedofilia. Non si può neppure fargliene una colpa; Jonathan non si sottrae al rito, vi partecipa deliberatamente.
Approda al liceo artistico, in ritardo di due anni, forse per lui l’habitat più congeniale. I ragazzi dell’artistico sono più estroversi, qualche insegnante pare più estroso e Jonathan è un creativo. Fa la scelta giusta. È a scuola che maturano le amicizie più solide, è nel suo ambito che i ragazzi più sensibili possono imbattersi nel conforto della solidarietà e dell’approvazione. Lo so con certezza: nello schifo totale della scuola puoi anche trovare la mente illuminata in grado di capirti, di accettarti e di farti accettare. Il lavoro è tutto sul fronte dell’autostima. Secondo me un insegnante dovrebbe fare solo questo: lavorare sull’autostima dei suoi allievi. Una personalità in formazione ha innanzitutto bisogno di conferme. Il successo scolastico alimenta la fiducia. Marcare, marcare ogni singolo successo. Andiamo, che vi costa dire bravo a un vostro studente alla prima occasione possibile? Certo non dovete prenderlo per i fondelli, se ne accorgerebbe. Deve avere effettivamente qualche merito, per minimo che sia. Bisogna dirgli: bravo!
Il successo scolastico fortifica Jonathan, lo rende più espansivo, più saldo sulle sue gambe. Comincia a coltivare amicizie più solide, più vere, per nulla virtuali, fatte di calore umano e capacità di ascolto, di pacche sulle spalle e incoraggiamenti. Non gli evitano gli smagamenti per il ragazzo sbagliato, ma si tratta di un quasi coetaneo ed è già qualcosa. Quanto all’oggetto del vagheggiamento, direi che non merita tanto struggimento, ma Jonathan non può saperlo. Forse oggi lo sa, anche se non potrei giurarlo. Nella trappola si può cadere a qualsiasi età perché risponde alle istanze degli ormoni più che alle nostre superiori capacità critiche. Se ne avessimo all’atto della passione incontrollata, ci accorgeremmo che l’oggetto del nostro innamoramento è non solo una creatura comune, ma è spesso mediocre oltre ogni ragionevole dubbio. Lo apprendiamo col senno di poi, non durante la fase dell’affanno. Spogliato dell’aura graziosa di cui lo abbiamo circonfuso, resta la sua nuda e cruda fragilità umana, mediocrità inclusa.
A scatenare l’ultimo casino è una febbricola persistente, la medesima che dà il titolo al romanzo. Sul piano strettamente formale genera la struttura dell’opera. Ad ogni fase del percorso diagnostico-terapeutico corrisponde un frammento di memoria, così che tutta la vicenda oscilla tra presente e passato. I capitoli dedicati a cronaca e memoria si alternano. Il sintomo ha funzione analoga alle madeleine di Proust. Non suoni azzardato il paragone, i tempi sono cambiati, anche le banlieue allevano scrittori. Così l’azzardo valica i limiti del bon ton letterario: vedo in Jonathan qualcosa tra il Picaro del terzo millennio e l’eroe romantico, tra maledettismo e Beat generation, con la differenza che il nostro Kerouac in sedicesimo bazzica spazi più angusti ed ha solo le gambe come mezzo di locomozione.
Non so neanche andare in bicicletta senza rotelle: nessuno me l’ha insegnato, né papà, né mamma. Li vedo troppo poco, non ci hanno pensato. Imparerò a dodici anni, ma mai davvero. Basterà un niente per buttarmi a terra: un piccolo gradino, un dislivello, un’altra bicicletta che mi passa vicino e mi fa venire l’ansia, le rotaie del tram. Mai bicicletta, mai macchina, mai motorino. Non ci sono soldi, la patente la fai quando sarai più grande. Andrò sempre e solo a piedi.
Guardate i passi malfermi e incerti di Jonathan nella prosa scabra con cui Bazzi ce li racconta. Periodi brevi, paragrafi difformi per lunghezza e sequenzialità, spesso ridotti al nocciolo di una sola parola, dietro la quale non è solo la pausa dettata dalla fatica, ma anche l’intensità della riflessione. Frequente il ricorso all’ellissi. Il presente narrativo, nel rendere astante la scarpinata, la rappresenta affannosa. Are you ready, boots? Start walkin'. These boots are made for walking (Lee Hazlewood).
Il regista di un possibile road movie dovrebbe avere come modello Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede) di Schlesinger ed inquadrare le gambe di Jonatham che da sole esprimono il tortuoso percorso della sua formazione.
Intendo dire che Bazzi, a dispetto della volgarità presente, si inserisce in un’illustre tradizione on the road che ci dice di uomini che hanno tentato di abbattere le mura di un ghetto, qualunque esso sia, patria compresa. I ghetti nascono da un tratto specifico (il colore della pelle, l’etnia, il comportamento sessuale, l’identità di genere) e da quello fanno derivare suggestivi corollari che non stanno né in cielo né in terra e che suonano come istigazione a delinquere: i neri puzzano (ne ho conosciuti di profumatissimi), ebrei zingari e slavi sono untermensch mostruosi (ne ho contemplati di talmente belli da darmi sgomento), i froci sono deviati o depravati o malati (ne ho incontrati di moralmente rettissimi, graziosissimi, sani, colti e intelligentissimi). Persino le donne un tempo erano considerate inferiori, tali da interdire loro istruzione e professioni. Molte culture ancora le ancorano a un unico tratto (femmina d’uomo) per arginare la forza che promana dalla loro intraprendenza, intelligenza e capacità decisionale, una roba che i maschi se la possono ficcane nel culo la loro ridicola appendice: cazzoni sono e cazzoni rimangono! I ghetti sono il terreno più fertile per alimentare il pregiudizio. Possono apparire protettivi, in realtà al loro interno ci si sbrana, che siano moderne periferie urbane o natii borghi selvaggi: … Né mi diceva il cor che l’età verde / sarei dannato a consumare in questo / natio borgo selvaggio, intra una gente / zotica, vil … . (Giacomo Leopardi, I canti XXII, Le ricordanze). Bazzi chiosa: Rozzano mi odia. Rozzano l’ho odiata.
Potrei proseguire all’infinito, indicandovi nomi luoghi e circostanze, parallelismi e dissonanze, ma mi fermo perché, come diceva Manzoni, non si può scrivere un libro per giustificarne un altro. Voglio aggiungere questo: c’è solo una cosa che è davvero contro natura ed è il pregiudizio, la vera e unica malattia mai debellata. I veri virus sono più equanimi, più democratici, non tengono conto di confini, muri, condizioni economiche e sociali; il pregiudizio separa, classifica, seleziona secondo criteri del tutto arbitrari e discriminatori. Sapete cosa diceva Sartre degli Ebrei? Affermava che ebrei erano quelli che gli altri chiamano ebrei. Una parola (una successione di fonemi, una breve teoria di grafemi) non dice nulla dell’umanità che il lemma designa. La nuda parola vino fa inorridire i sommelier. Occorrono ben altri tratti, ben altra competenza, ben altro gusto per designare la qualità di un vino. Noi esseri umani siamo ben più preziosi e speciali di un pregiatissimo vino: siamo unici e irripetibili. Per quanti tratti possano attribuirci, mai cancelleranno la nostra unicità. Dovremmo essere preziosi gli uni per gli altri, invece perdiamo del tempo prezioso per sbranarci a vicenda.
È per questo che apprezzo Bazzi. Appartiene alla genia dei transfughi, dei trasgressori, dei disubbidienti e non sparge neppure una goccia del nostro sangue. Sapete chi furono i suoi antesignani, almeno secondo una diffusa e ben nota mitologia? Si chiamavano Adamo ed Eva. Già, Adamo! È davvero singolare che la prima creatura umana fosse un transessuale o intersessuale, almeno prima che una mutazione estraesse Eva dal suo corpo, lasciandogliene però la memoria genetica, come peraltro Eva non dimenticherà mai di essere stata in un altro corpo. Ecco perché i due furono alleati quando sfidarono il Boss dei boss, ciascuno recava nei geni la traccia dell’altro: l’intesa fu pressoché perfetta. Quel burlone di Satana suggerì loro: Cerca una maglia rotta nella rete / che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! / Va, per te l’ho pregato, - ora la sete / mi sarà più lieve, meno acre la ruggine… (Eugenio Montale, Ossi di seppia, In Limine).
Ogni rete ha una maglia allentata, la via di fuga che dà impulso al lungo e tortuoso cammino della Storia. Ne è valsa la pena, non ho dubbi. Decenni orsono un giovane epigono degli antichi transfughi, un militante per i diritti civili[2], denunciò il Führer eccelso per i genocidi di Sodoma e Gomorra. Penso che avesse più o meno l’età di Bazzi. A tutt’oggi ancora non c’è stata una Norimberga per l’antica mattanza. Tuttavia, quel libro fondamentale nella lotta per i diritti civili suppongo sia finito nelle mani di Mario Mieli, allora ventiduenne, e in seguito in quelle parimenti dissacranti di Pier Vittorio Tondelli. Fu assai utile per i ragazzi italiani dell’epoca. Jonathan Bazzi viaggia sulla stessa corriera.
© Timothy Megaride 2019
Id: 2713 Data: 24/11/2020 12:51:05
*
- Letteratura
Un romanzo all’arsenico
«Tre personaggi che la vita ha maltrattato», recita il risvolto di copertina. Tre dei tanti, tantissimi, troppi che la vita maltratta, includendo tra essi l’autore del libro, al quale la vita è stata scippata prima ancora che incominciasse ad averne il sentore.
Questa volta, però, Carlotto non chiude il romanzo1 col consueto cazzotto nello stomaco che ti lascia senza fiato. Il salvagente miracoloso che lancia fa supporre un possibile appiglio di salvezza. Restiamo tra i flutti del male, ma un sostegno l’abbiamo. Gesù, da non credere, soprattutto se si tratta di uno scrittore che del genio del male ha fatto la musa ispiratrice!
Ora sembra che sorrida e che ci faccia sorridere nell’intessere la trama avvincente del racconto. A me evoca la sottile ironia di Joseph Otto Kesselring in “Arsenico e vecchi merletti” o il delizioso e dissacrante intreccio del “Girotondo” di Arthur Schnitzler. Carlotto è probabilmente giunto al punto della croce dove son corti i giorni e l’ore brevi e guarda intorno a sé l’ombra del mondo e la gente che passa ed il suo cuore. Parafrasando Fortini intendo dire che lo scrittore padovano, raggiungendo la soglia dell’età dei bilanci, si sia voltato indietro ed abbia visto l’accidentato cammino appena percorso come uno spettacolo farsesco al quale guardare con ironico distacco. «La vita è una solenne fregatura», tanto vale prenderne le dovute distanze e riderne tra i fumi dell’alcool che scontornano le cose e te le fanno apparire irrelate, pazzamente assurde, prive di senso e fuori misura. Entro uno scenario surreale sembriamo tutti marionette o forse, trattandosi di un veneto, maschere della Commedia dell’Arte. Recitiamo stereotipi e di stereotipi ci imbeviamo, quotidianamente, senza soluzione di continuità. Voi cosa vi aspettereste da un attore porno e gigolò, da una puttana e da un’anziana travestita? Se non state pensando a una barzelletta e non avete mai dichiaratamente fruito dei loro servigi, pensate senz’altro alla feccia della società. Aggiungete al gruppetto una specie di investigatore privato dai modi spicci e, qui e là, qualche delinquentello di mezza tacca, spacciatore di droga o truffatore, e il gioco è fatto. Certo, una spruzzata di rom col condimento di qualche immigrato non starebbero male nel quadro complessivo della vostra rappresentazione mentale del male. Una volta che avete ben tracciato il perimetro entro il quale inquadrare tutta la vergogna possibile, vi sentite sicuri della vostra integrità. Complimenti, siete a pieno titolo cittadini di questo nostro fantasmagorico presente! «Persone normali. Come gli uomini che in privato inviano a Nanà primi piani dei loro cazzi con richieste di incontri. Padri di famiglia, onesti lavoratori, elettori coscienziosi».
È l’immagine più rassicurante che diamo ai turisti che ci onorano delle loro visite. Ne ridono, lo so bene, e non a torto. La nostra patente ipocrisia li fa ridere, bontà loro! A me invece viene da piangere, come accade al povero Bonamente Fanzago; col quale ho molto in comune, lo strazio innanzitutto, poi una non ordinaria dabbenaggine, oltre all’ineludibile prostituzione.
Mi consola il fatto che a dare spettacolo non siamo solo noi. Guardo agli altri paesi cosiddetti sviluppati e penso che, quanto a pacchianate, poco o nulla hanno da invidiarci. Penso al top, agli Stati Uniti per esempio, dei quali siamo tutti diventati emuli e propalatori. Ci abbuffiamo di hamburger agli additivi chimici e patatine fritte bisunte, indossiamo snapback cap col logo di college che mai frequenteremo, calziamo sneakers targate Nike, festeggiamo Halloween, guardiamo regolarmente film e serie televisive prodotte a Hollywood e via discorrendo, con buona pace di sovranisti e autarchici. Non siamo in un vecchio film con Alberto Sordi. No, siamo proprio noi, al presente indicativo. Indicativo di che? Beh, scopritelo da soli!
So che leggerete il libro perché fa proprio al caso vostro. Troverete leccate di passere, pompini e massaggi prostatici come in un film porno d’autore, a seconda dei gusti. Vi scandalizzerete senz’altro perché voi mai scopereste una ragazzina e men che mai vi fareste inchiappettare. Voi siete gente morigerata tutta famiglia e religione. Non ho alcun dubbio. Leggete gli articoli dei giornali firmati da un certo Pietro Maria Belli, sicuramente il più onesto, il più equanime, il più obiettivo ed informato dei giornalisti italiani, guardate Sanremo e Barbara D’Urso, partecipate a uno dei format di Maria De Filippi, condividete ogni notizia che avete udito dal cugino della cognata di una vostra amica, il quale informatissimo cugino è testimone oculare dell’asino che vola. L’hanno detto persino in televisione. TV docet, lo sapevano persino gli antichi romani!
Quant’è bello vivere tutti i santi giorni in un fastoso reality! Si chiama così perché è più reale della realtà. Jim Carrey e il suo Truman Show ci fanno un baffo.
Ricevo quotidianamente, via mail, sms o whatsapp, notizie rassicuranti circa il mondo ideale nel quale ci è dato di vivere, anche quando ne annunciano la fine per bocca dell’autorevole e compassato Nostradamus. Provengono quasi tutte da persone laureate, dunque affidabili. Non aspettatevele da me, che laureato non sono e a stento ho imparato l’italiano da una badante moldava e da un giovane immigrato del Burkina Faso.
Lo chiamano shitstorming e serve a farci individuare i cattivi che attentano al nostro quieto vivere. Io sono un pessimo divulgatore, lo riconosco, sicché non solo cestino gli autorevoli comunicati, ma rimuovo i mittenti dai miei contatti. Sono troppo intelligenti per le mie capacità di comprensione. Mi molestano, che posso farci. Mi fanno sentire un imbecille. Lo sono, lo riconosco. Però, andiamo, abbiate un minimo di comprensione: se sono nato scemo non è colpa mia. Vado cercando il pelo nell’uovo: pretendo di conoscere la fonte della notizia, voglio che sia firmata e certificata dal notaio, invoco la scienza. Sono un rompicoglioni della malora. Capisco bene che evitiate di leggermi o di ascoltarmi. Se aggiungete che compro anche i libri di Massimo Carlotto e me ne compiaccio, trovo più che giusto che mi evitiate come la peste.
Allora io suggerisco la sua più recente pubblicazione ai boccaloni come me che, poco fidandosi, si fermano a pensare e cercano il pelo nell’uovo anche ne “La signora del martedì”. E ne trovano di peli in quest’uovo, beninteso peli pregiati tanto da formare una vera e propria pelliccia.
«Dal confessionale si passava alla canonica, dove ben presto arrivava anche il marito geloso, che non resisteva al fascino della governante del curato. Una storia tutta casa e chiesa. Il genere, particolarmente apprezzato in Paesi cattolici come l’Italia e la Polonia, iniziava a piacere anche negli Stati Uniti, dove i sensi di colpa della Chiesa romana hanno sempre destato curiosità morbose» Si tratta del soggetto di un film porno, come ognuno intende. Più oltre potete leggere: «A quarantun anni doveva difendersi con le unghie e con i denti dalla concorrenza. E per fortuna che nel genere casa e chiesa non erano ammessi i neri. Ormai quelli spopolavano, anche perché venivano pagati meno degli altri. Il mondo a luci rosse era esattamente lo specchio di quello in cui si blaterava di diritti, di legge e di Dio». In un sistema competitivo come il nostro l’industria della pornografia è uno dei settori più instabili perché i gusti cambiano più o meno come le mode ed occorre stare al passo coi tempi. La concorrenza tra gli attori è spietata: «Un giorno, un ragazzo dai capelli ricci con un fisico da palestra e un cazzo di tutto rispetto, che aveva abbandonato l’università perché troppo faticosa, gli aveva detto che nel porno era finito il tempo dei gagà. E si riferiva proprio a lui». In altri termini, pornodivi ed escort quota cento se la possono togliere dalla testa; a stento arrivano a quota quaranta e sempre che abbiano iniziato per tempo l’esercizio della professione.
Nel rigo seguente c’è una chicca: «L’immagine di quel giovane borioso, molto somigliante a un politico dall’aria ottusa che in quel periodo imperversava nei notiziari, lo irritò…». Non saprei dire se il “politico dall’aria ottusa” sia lo stesso al quale sto pensando. Del mio ho una specie di conferma per conoscerne alcuni elettori ed elettrici. Quando ne parlano non pare che lo vogliano votare, sembra piuttosto che vogliano fargli un pompino e, nel segreto dell’urna, apponendo la crocetta sul suo nome, sono certo che abbiano un orgasmo. Non mi fa meraviglia: politica e sesso sono un binomio inscindibile.
Per concludere questo breve excursus sulla trainante industria del porno, ecco l’ultima citazione: «In genere i film invecchiano nel giro di pochi mesi, per essere poi contrabbandati da certi trafficanti nei Paesi di stretta osservanza islamica». Saranno così allupati quei poveri ragazzetti barbuti che si accontentano di Moana Pozzi, Ilona Staller e Rocco Siffredi. Quanto a quest’ultimo, pare essere rigorosamente rispettoso del familismo italico e che i suoi giovani rampolli siano propensi a seguirne le orme, parola di Barbarella. Il web e le fanzine confermano. Di ragazzi con corpi analoghi sono piene le palestre italiane, ma non hanno grandi possibilità se non sono figli di Rocco Siffredi.
Massimo Carlotto si mette di nuovo in gioco e non manca di farci riflettere sulla sua personale vicenda giudiziaria, sia pure adombrandone l’odissea legale con l’analoga della protagonista del romanzo, Alfonsina Malacrida. Qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie quando afferma che «Per evitare la galera, soprattutto se sei innocente, bisogna guardar lontano». La mente va a “Il fuggiasco”2 il romanzo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Mi sa che, quando all’epoca (1994) uscì il libro, non dovette mancare il benpensante di turno che gridò allo scandalo per il credito letterario concesso a un noto “ex galeotto”. Che volete farci: quando i media emettono a priori una sentenza, non c’è garantismo né presunzione d’innocenza che tengano. Lo avete dimenticato il caso Pinelli? E chi ha memoria di Aldo Braibanti, puta caso uomo di lettere come Carlotto? Il nostro paese è così; lo dimostrano le stragi impunite, i depistaggi, la collusione politica-mafia, la corruzione mai arginata. Noi non vogliamo essere informati, vogliamo solo essere rassicurati nelle nostre convinzioni e nei nostri pregiudizi. Così i media non ci forniscono informazione, ma corteggiano i nostri umori e le nostre personali convinzioni. Se non lo fanno perdono consensi, cioè falliscono. Le trasmissioni televisive di grande successo mentono sapendo di mentire e le loro conduttrici e conduttori sono assai più puttane della povera Nanà. La quale, anche se sotto pseudonimo pubblica libri per bambini di gran successo, tali che persino il commissario Michele Pagano, titolare delle indagini che la riguardano, li legge ai figli, diventa improvvisamente improponibile nelle vesti di apprezzata scrittrice di fiabe; quando si scopre che è stata anche una puttana, la musica cambia: prevale l’immagine della prostituta, ritorna a essere protagonista di una «notizia da sbattere in prima pagina». Guardate, nessuno sa chi sia veramente Nanà né conosce la sua poco confortante storia personale, nessuno sa del suo dolore, del suoi sentimenti, delle sue emozioni. Ciò che conta è come il pubblico dei lettori o spettatori se la prefigura, a dispetto di ogni verità. Sarà «fatta a pezzi e giudicata colpevole in nome di quella giustizia emotiva che domina il paese e che ai poliziotti può tornare utile…». Dei meriti letterari di Alfonsina Malacrida la gente se ne infischia. Le sue doti non rientrano in alcun modo «nel profilo criminale redatto dai giudici» che l’hanno già condannata una volta.
Il cinico Pietro Maria Belli pensa bene di trarne profitto eccitando la fantasia malata del suo pubblico. «Altro che articoli, quella vicenda era pronta per un instant book di sicuro successo».
Nei giorni in cui leggevo il libro scorrevo i più noti quotidiani nazionali. Gossip e Sanremo occupavano il grosso delle pagine. Nella more passava la notizia di un probabile secondo caso Regeni. A chi frega? Chi è questo Patrick George Zaki, studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto e torturato? Che rottura di coglioni! Lasciateci godere la bella arena dell’Ariston con Morgan che s’azzuffa con non so chi e Achille Lauro che finalmente realizza il sogno di tanti italiani, scopare con un maschio in vesti da femmina o viceversa, non ho capito bene. Zaki, Zaki? Sarà uno di quegli immigrati che rompono il cazzo. Che se ne restasse nel suo paese!
© Timothy Megaride 2020
1 Massimo Carlotto, La signora del martedì, edizioni e/o 2019
2 Massimo Carlotto, Il fuggiasco, edizioni e/o 1994
Id: 2712 Data: 21/11/2020 19:54:59
*
- Letteratura
In nome e per conto della comune umanità
da il tetto, n. 334, anno LVI, novembre-dicembre 2019, pp. 76-84
«Anni settanta nati dal fracasso
s'aggrappan tutti alle cose di sempre
qui c'è uno scemo che s'aggrappa invece
ad un bambino morto di dicembre».
[Paolo Pietrangeli, I cavalli di Troia]
Certe verità non hanno nulla di assoluto e incontrovertibile; appartengono piuttosto al novero delle possibilità. Approssimative per difetto di prove, possibili per profusione d’indizi contestuali. È forse uno dei non rari casi in cui l’empirismo muove un passo indietro e lo cede al metodo ipotetico-deduttivo che, procedendo dalle circostanze, focalizza il fatto per logica inferenza, approssimandosi a esso, mai centrandone il nucleo rivelatore.
Non c’è serio investigatore (né uomo di scienza o storico) che possa sentirsi autorizzato a una simile procedura; è consentito solo al letterato, il quale può bene affermare di sapere senza avere le prove.
È dunque opera di letterato il bel libro di Antonio Iovane[1] che qui provo ad analizzare e capire, senza la pretesa di riuscirci. Ascrivibile, per certi versi, al genere romanzo storico, se malauguratamente la Storia non richiedesse tempi più lunghi e documentazione più probante per ricevere l’opinabile crisma dell’imparzialità. Perché sarà pur vero che la storia la scrivono i vincitori (avendo il privilegio di conoscere qualche storico, mi consento di affermare che si tratta di un luogo comune, probabilmente vero per un modo arcaico di fare storia), ma qui si dà voce anche ai vinti, se in bibliografia compaiono i nomi (e che nomi!) degli sconfitti. Per farla breve, penso che l’aggettivo “storico” sia riduttivo e semplificativo perché, a dispetto della presenza nel libro di persone “vere” esistenti o esistite e della cronaca di fatti accertati, le passioni legate a quella cronaca sono ancora vive e tutti noi ancora percepiamo le conseguenze degli anni di piombo, non solo perché molti dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni sono tra noi, ma anche perché il terrorismo, comunque si manifesti e qualsiasi ne sia il movente ideologico, lascia strascichi che investono più generazioni, non diversamente dalle guerre, certamente latrici di morte, distruzione e rovine. Ho letto sul volto di giovani e giovanissimi i segni di un antico misfatto del quale non sono stati né potevano essere testimoni. Nell’uccidere un loro antenato abbiamo sacrificato qualcosa della progenie, assai prima che questa venisse al mondo. Persino Iovane, che all’epoca dei fatti riferiti era solo un bambino, pare che soffra e che, nel suo dire, intenda trasferirci la sua pena.
L’autore si è servito degli archivi dei giornali e delle emittenti televisive, di una nutrita bibliografia, forse di qualche testimonianza per darci una possibile narrazione di circa un decennio di storia nazionale, dal 1969 al 1979, con un epilogo che giunge al 1982, anno del rapimento Dozier e simbolicamente della disfatta delle Brigate Rosse. L’escalation della violenza e del terrore è rappresentata da una specie di diario delle giornate cardine del conflitto armato che vide combattere su opposti e impari fronti il gruppo marxista-leninista e lo “stato padrone”. La dietrologia è implicita per gran parte del lungo racconto, si fa più esplicita, insinuante e drammatica nel finale, che fa pensare a un giallo senza il piacere della scoperta dell’assassino. Risponda chi legge queste note: che cosa asciuga bagnandoti? Salvatore, un personaggio cardine delle vicenda, non sa rispondere. Lo fa per lui Ornella Gianca, una giornalista in gamba, ma la soluzione le resta strozzata in gola. Salvatore non l’ode, è già lontano e, quale carabiniere, da allora in avanti si occuperà sempre più di mafia e sempre meno di terrorismo.
L’enigma vero resta irrisolto o perché chi sa non dice o, se dice, lo dice solo a se stesso e dunque è come se non dicesse. I misteri italiani sono così, da sempre. Le Brigate Rosse ebbero una regia diversa dai riconosciuti capi storici? È credibile che il terrorismo di estrema sinistra fosse parte integrante della stessa strategia della tensione dalla quale la vicenda prende le mosse? Chi lo volle e perché?
Mi viene in mente l’affermazione di un altro personaggio simbolico, Antonio, un giovane cameramen, ballerino affetto dalla Febbre del sabato sera: «Non sarà Dalla Chiesa che sconfiggerà le Brigate Rosse. … Sarà John Travolta». Sennonché penso che l’attore ballerino non abbia inventato se stesso e forse non sono stati neppure i suoi registi e sceneggiatori a concepirlo, ma qualcuno che non vuole essere nominato. Travolta sembra il naturale approdo della strategia della tensione, degli anni di piombo e della lunga scia di sangue che, come fiume in piena, travolse uomini e valori: il riflusso, il disimpegno, l’effimero, l’ignoranza dei giovani hanno una data di nascita e un movente, la drammatica fine di un innocente e il plumbeo grigiore degli anni più bui della storia della Repubblica. I giovani volevano sole e vita, volevano danzare e cantare, avevano gridato scemo scemo nelle piazze, una stupidità sembrerebbe, in realtà il loro slogan di rivolta alla solfa sanguinaria della redenzione rossa: il potere nasce dalla canna del fucile. Non redimi nessuno se uccidi un innocente. La realtà è quella che osserva Jacopo Varega detto Vladimiro, un brigatista “tipo” in clandestinità. Scruta, a distanza di sicurezza, i suoi genitori. «Guardavano Scene di un matrimonio. Non stavano abitando l’angoscia, ma vedevano tranquillamente alla TV il film di Bergman in sei puntate sulla crisi della coppia. Io pensavo alla rivoluzione e loro guardavano un film sulla crisi della coppia. … loro guardavano Liv Ullmann ed Erland Josephson che mandavano in pezzi il loro matrimonio. So perché provai rabbia. Roba come quel film, le lettere sull’adulterio al Corriere della Sera o le sale da ballo erano contro di noi. Noi risvegliavamo le coscienze mentre gli altri si rifugiavano nell’effimero dell’amore e del divertimento». Sesso, droga e rock and roll; polizziotteschi, commedie sexy all'italiana e Bruce Lee; Teatro 10, Rischiatutto, Canzonissima, Senza rete, Milleluci, Adesso musica (lanciò i Matia Bazar citati nel libro), Cantagiro, Un disco per l’estate, Festivalbar, Ieri e oggi, programmi popolari e seguitissimi, furono, col contestato Lucio Battisti, l’effimero che impazzava presso “le grandi masse” negli stessi anni in cui per le strade d’Italia si sparava. La controrivoluzione aveva già vinto ancor prima che la rivoluzione cominciasse. I brigatisti, imbevuti di una rappresentazione mitica della realtà, prigionieri di una dottrina utopistica (forsanche distopica) che somiglia assai più a una religione che a un progetto politico, non sanno fare i conti con la società loro contemporanea, non sanno leggere i segni dei tempi, colpiscono quelli che loro definiscono “simboli”, ignari della verità incontrovertibile, ora e per me incontrovertibile, che nessun essere umano può essere un simbolo, per il semplice motivo che vive, respira, prova gioie e dolori, pensa, sceglie, agisce, ma cambia anche idea e disdice quello che ha detto, si contraddice perché il tempo, nel modificare lo scenario, modifica l’attore. Il simbolo è statico, l’uomo è dinamico. I brigatisti di allora, ora ultrasettantenni, sono la prova schiacciante dell’azione plasmante del tempo. Si dedicano ad attività di pubblica utilità: espiano, come ogni buon cattolico che si rispetti, il loro personale peccato originale.
Venivano tutti dalla cultura cattolica, essendo nati e vissuti in un paese che ciucciava cattolicesimo col latte materno e tuttora lo ciuccia, beninteso non il cattolicesimo possibilista postconciliare, ma ancora essenzialmente controriformistico, fatto di forme, simboli e viete liturgie. Non si tratta di una religione, ma di una cultura e uno stile di vita. Già allora qualcuno diceva di loro: hanno cambiato religione, ma restano dei monaci. I rituali formali del cattolicesimo tradizionalista ci sono tutti, parzialmente attinti dall’arcaico cerimoniale ebraico. Ecco l‘agnello di Dio, ecco il capro che assume su di sé i peccati del mondo, il capro espiatorio, la vittima sacrificata a un’idea percepita come divinità: «… ripetevo a memoria alcuni brani dei Manoscritti economici filosofici come un rosario» - dichiara Jacopo. I suoi epigoni contemporanei leggono versetti coranici e chiamano santa la loro guerra. I libri cambiano, ma restano sacri e indiscutibili. Chi li discute non è degno di vivere. Bella prospettiva, per la Storia, per la conoscenza, per la civiltà!
Preferisco parlarne con Moreno. Lui è stato operaio, ha seguito la vicenda da una prospettiva interessante, anche se temo guardasse Scene di un matrimonio in compagnia di sua moglie. Nato nell’immediato dopoguerra in una delle tante città italiane devastate dai bombardamenti, da bambino ha conosciuto le privazioni, la miseria, la fame, la pediculosi, il tifo e la dissenteria. I dopoguerra sono così. Molti della sua generazione ce l’hanno comunque fatta, hanno lottato, patito e infine hanno trovato un lavoro in fabbrica. Si sposò con una maestrina, ebbe due figli. Oggi è vedovo. I figli sono entrambi laureati, sposati, vivono ambedue lontani. Ora se la cava da solo ed ha una sua calma saggezza. Non l’ho mai udito lamentarsi di nulla. Mai! Dopotutto si sente fortunato: in casa sua entravano due salari, all’epoca ancora una rarità e una fortuna. Erano salari bassi ma bastevoli a far vivere dignitosamente quattro persone. Proprio sul principio degli anni Settanta le paghe presero a migliorare, sia nel pubblico impiego sia nel privato. Trovavi nelle case, oltre al televisore, anche il frigorifero e la lavatrice, per lo più comprati a rate. Riuscivano a portare al mare, per un paio di settimane, i loro figli. Li mandavano a scuola, all’epoca già formalmente aperta a tutti. Liceo, capite! E poi l’università. Tutto questo tra gli anni Settanta e gli Ottanta.
Sono le donne che fanno gli uomini – mi ripete spesso. – Elvira fece me. Io, dopo le elementari, ho frequentato per tre anni la scuola di avviamento professionale. Dopo la quale ho fatto il tornitore per quattro anni, fino a quando, per un colpo di fortuna, sono entrato in fabbrica. Grande azienda! Orari e turni da contratto, niente più lavoro nero, sfruttamento sì, ma non paragonabile a quello subito durante gli anni dell’adolescenza. Elvira mi educava, oltre ad amarmi, mi educava alla responsabilità, alle cose serie e importanti della vita, alla lettura dei suoi numerosi libri. Mi ha reso felice e responsabile. Eravamo entrambi orgogliosi dei nostri figli. Loro infine ce l’hanno fatta e oggi conducono una vita davvero decente. I loro figli, miei nipoti? Sono ragazzi di oggi. Sanno poco o nulla delle nostre vite. Sono un po’ viziati, come tutti, stanno perennemente a smanettare sui loro smartphone. È così che sono andate le cose.
Gli ho regalato il romanzo di Iovane perché mi sarebbe piaciuto confrontarmi con lui. Lo ha letto in due giorni per poi dirmi che, sì, gli è piaciuto molto, ma che gli ha anche messo una gran tristezza addosso. Mi dispiace, non volevo; volevo solo parlarne con lui, con uno che è stato in fabbrica per quarant’anni e che gli anni di piombo li ha vissuti.
Hai fatto bene. Mi hai fatto conoscere un libro e uno scrittore dei quali ignoravo l’esistenza. Penso che di un libro del genere ci fosse bisogno. Sicuramente non è tutto, ma è equanime e non si ferma alla cronaca. Nessuno dei personaggi è un simbolo; di chiunque si tratti e comunque la pensi, l’autore mette in campo degli esseri umani, non dei simboli. È vero che divide la società italiana in categorie, ma non può fare altrimenti se intende rappresentarla nella sua interezza. Ecco gli attori: le Br, i nemici delle Br, lo stato, i giornalisti, la società civile, gli altri. Uno schema, certo, ma uno schema credibile per rappresentare una realtà complessa e dinamica. Hai notato come cambia prospettiva a seconda dei gruppi che rappresenta, i quali hanno, come nei film, protagonisti, comprimari e comparse? Il racconto è rigorosamente in terza persona, a parte la testimonianza di Jacopo, che si racconta da solo perché drammaticamente rappresenta il nocciolo del dramma collettivo. Cazzo, Timothy, quanto è umano! Per la verità non c’è personaggio che non abbia una sua vita privata indegna di considerazione. Il personale è politico! La lezione proveniente dal femminismo militante qui è come il motivo ispiratore del romanzo. Guarda la storia della famiglia Fornati o quella dell’ex partigiano Rocco. Osserva Paolo Galbiati, Marina e Salvatore. Dio, quanto è bello e tenero il personaggio di Salvatore De Rosa. Vi trovi l’eco della celebre polemica pasoliniana a proposito dei fatti di Valle Giulia. “Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti! / Perché i poliziotti sono figli di poveri”. Di Pasolini Iovane pone in esergo una citazione da “Petrolio”. Evidenzia l’edipo irrisolto di tanti giovani di allora. Non puoi uccidere tuo padre se ne ignori la storia. Devi sapere chi è tuo padre prima di superarlo. E comunque l’uccisione di Edipo è metaforica. Tu non uccidi nessuno. Vai oltre, fai storia, non fermi la storia.
Quando obbedisci ai Comandamenti, non fai politica, ti guadagni il paradiso; va bene, non ho dubbi che vada bene! Però mi pare acquisito che il paradiso non sia di questo mondo. La gestione di questo mondo è gestione politica e la politica, ahimè!, non è una scienza esatta. La politica, per altro verso, non la pratica alcuna divinità; è solo ed esclusivamente responsabilità degli uomini. Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong furono esseri umani come noi e non mi pare che siano tra i redattori della Bibbia o del Corano. Mettiamola così: a rivoluzione finita le BR avrebbero realizzato la “dittatura del proletariato”. Sarebbe stata stalinista e poco leninista. Qualcuno mi spiega quale voce in capitolo aveva il proletariato con Stalin? Nessuna. Se avesse provato a dissentire sarebbe finito nei gulag, fatto salvo il valore supremo dello stacanovismo, che probabilmente è qualcosa di peggio della catena di montaggio. Ecco la prospettiva di quel moto “rivoluzionario”. Per altro verso lo Stalin nostrano avrebbe dovuto fare i conti col proletariato italiano degli anni Settanta, non con quello russo del 1917. Com’era il nostro proletariato? La famiglia tipo operaia era costituita da padre operaio, madre casalinga e figli. Benché non mancassero i qualunquisti e persino qualche fascio, di solito il padre votava Partito Comunista e la madre Democrazia Cristiana. Un compromesso storico alla carlona, del genere bonario di Peppone e don Camillo. Gli operai comunisti andavano in chiesa e si segnavano, celebravano per lo più il matrimonio religioso anche dopo l’introduzione del divorzio e del nuovo diritto di famiglia, facevano battezzare i figli, li mandavano al catechismo, gli facevano somministrare i sacramenti dell’eucarestia e della cresima, celebravano il Natale e la Pasqua. Non solo per compiacere le loro consorti, ma anche per dare ai loro figli la percezione di essere parte di una cultura comune. Con che cuore avresti tolto loro la gioia del presepe o del regalino sotto l’albero di Natale? Come avresti potuto escluderli da una ritualità tanto consolidata senza privarli del bene prezioso dell’infanzia? I padri avevano sofferto e anche tanto! Non volevano che i figli pagassero ancora per una guerra che sembrava non finire mai.
La condizione operaia migliorava, lentamente, ma migliorava. I più anziani volevano gettarsi alle spalle la tragedia della seconda guerra mondiale, erano stufi di morte e distruzione. In un primo momento, diciamo fino a Sossi, le BR godettero di qualche simpatia da parte del ceto operaio. Agitavano le acque e lo facevano in maniera più irruenta del pachiderma sindacale. Poi, quando si diedero alle gambizzazioni e agli omicidi, cominciarono a perdere consenso. La gente comune non capiva e non avrebbe mai capito. I loro proclami erano incomprensibili, le foto che ritraevano i sequestrati sembravano manifesti di lutto. I brigatisti erano lugubri e tristi, uccidevano i sogni, cancellavano nei fatti le speranze. Hai visto come li rappresenta Iovane? Non sorridono mai. Sesso e amore sono banditi dai loro discorsi quasi fossero non istanze umane ma privilegi borghesi. Hai letto cosa Gaia afferma delle prestazioni sessuali di Jacopo? Hai visto come reagisce lui? Ti sei interrogato sui suoi sentimenti per Irene, sui suoi moti di gelosia, sulla repressione di tutto ciò che in lui resta di umano? Ci sono ammazzamenti che sembrano stupri, quasi la compensazione di un erotismo negato.
Castelporziano fu catartico: non solo per la voce del mitico Allen Ginsberg, ma anche per quel senso di riscatto che il libero sesso consentiva ai fricchettoni del momento. Negli anfratti della boscaglia potevi vedere giovani corpi confondersi ben oltre gli amplessi di genere. Il femminismo che aveva per anni rivendicato il diritto individuale alla proprietà e gestione del corpo ora quel diritto sputava in faccia a chiunque passasse nei paraggi. I corpi si sceglievano liberamente, senza più inibizioni né condanne. Ecco ciò che molti volevano: appartenere a se stessi, esprimere la loro identità. Diritti civili! Chi riuscì a interpretare questo bisogno diffuso vinse la partita. Non il campionato. Mentre in altri paesi democratici sembra vinto il campionato, da noi occorre ancora combattere per la bacchettoneria di ritorno che sempre serpeggia nei bacati di mente di tutte le dottrine, qualsiasi ne sia il colore. La laicità, che dovrebbe impregnare la politica, è emarginata dal 1922 nel nostro paese. Qui da noi la guerra santa è prassi comune. La figura di Montanelli, in verità alquanto iconografica, è intrigante per questo. La letteratura può anche consentirsi un po’ di retorica. Il celebre giornalista è rappresentato come un galantuomo, a dispetto di una biografia non sempre all’altezza della fama di cui gode. Bella la sequenza in cui Lucio Aliberti (definito democratico) va a rendere omaggio all’avversario politico ferito dalle BR. Sembrano due cavalieri usciti dalla penna di Ariosto. L’immaginario collettivo così si rappresentava alcuni avversari politici, concorrenti, non nemici da denigrare o trucidare. Forse ne esistevano.
Abbiamo i cervelli in fuga? Per forza! Chi ha un cervello e ha il vantaggio di saperlo usare cerca luoghi migliori in cui vivere. Il paradiso in terra non esiste, ma esistono paesi in cui la qualità della vita supera di gran lunga l’angustia della terra natale, la grettezza e l’ipocrisia del “paese orribilmente sporco”.
Ancora Pasolini. Pare che Iovane ne tenga sott’occhio gli scritti polemici. Il poeta friulano dichiara che Moro è “colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 a oggi”. Intanto è Aldo Moro che viene rapito e poi ucciso dalle BR. Per quale crimine, se davvero fu un ripiego il suo rapimento? Andreotti, Fanfani e Cossiga erano inavvicinabili. Moro era l’anello debole della catena. Ti fa pensare al predatore che nel branco erbivoro adocchia la preda meno protetta, l’azzanna, la divora.
Fu uno stillicidio di cinquanta giorni in cui non più il politico, ma un sessantaduenne inerme, marito, padre e nonno, provava a esorcizzare il senso di estrema solitudine nella quale viveva a motivo della cattività. Le foto mostravano un volto prostrato dal dolore. Il cofano aperto di una Renault rossa parcheggiata in via Caetani esibì alla comune pietà il corpo senza vita di un vecchio indifeso e fece versare non poche lacrime ai tanti che, quant’anche non lo avessero amato, non lo avevano mai odiato. E molti si chiesero: perché?
Fu quella la vera sconfitta delle BR. Avevano colpito al cuore qualcosa che apparteneva, se non a tutti, alla maggioranza del popolo italiano: l’umanità.
Ricorda, Timothy, non si governa nessuno in nome e per conto di un’idea; lo si fa in nome e per conto della comune umanità. A me sembra la lezione del bel romanzo di Antonio Iovane.
Non ho osato interrompere la lunga e calorosa perorazione del mio amico Moreno, uno dei tanti operai in pensione. Se fossi l’autore del libro, chiederei a lui di presentarmi al pubblico.
Timothy Megaride
Id: 2710 Data: 20/11/2020 12:43:16
*
- Letteratura
L’escapismo identitario di Elena Ferrante
da il tetto, n. 335, anno LVII, gennaio-febbraio 2020, pp. 84-89
Bugie, bugie, gli adulti le vietano e intanto ne dicono tante. Beh, non solo gli adulti, anche i bambini le dicono, sia pure senza il calcolo dei grandi. La menzogna è un po’ il sale dell’esistenza. Si mente per pietà, per vergogna, per proteggere, per celare. Il mondo al quale approdiamo alla nascita è già una menzogna, inautentico per scarsa o nessuna cognizione di sé, per l’insopprimibile impulso alla mistificazione. È lo schermo alle nostre paure, alle insicurezze, alle angosce. Mascheriamo le rughe per parere più giovani, tingiamo i capelli per il medesimo motivo, indossiamo abiti che ci rendano gradevoli agli occhi altrui, convinti di non esserlo nella nostra nudità senza artifizi o belletti.
Se l’infanzia è immaginifica, l’età adulta è mistificatrice, consapevolmente ipocrita sia che coltivi come una religione il familismo, sia che ne dissolva le dinamiche nella comunità sociale dei sodali e degli eletti.
«Vittoria e Costanza erano donne così diverse, tutto in loro divergeva. La prima non aveva istruzione, la seconda era coltissima; la prima era volgare, la seconda fine; la prima era povera, la seconda ricca».
Vittoria è la vestale del familismo, Costanza lo è delle buone maniere e del viver civile: due convenzioni apparentemente in conflitto, in realtà due facce della stessa medaglia che paiono ignorarsi per guardare verso opposti poli, in realtà in simbiosi per appartenere allo stesso conio. Il simbolico connubio tra i due universi che Elena Ferrante ci ripropone è rappresentato da un braccialetto che passa di polso in polso senza badare alla condizione civile o sociale di chi lo indossa. È solo un oggetto, non ha nulla di magico o di taumaturgico, a giudicare dalla cognizione che ne avrà Giovanna (Giannì in allocuzione), la protagonista narratrice del romanzo[1], dopo averne sentite tante, ma davvero tante, intorno al monile.
È una ragazzina di tredici anni alla quale i turbamenti della pubertà disveleranno “la vita bugiarda degli adulti” attraverso un percorso doloroso che sembra concludersi, tre anni dopo, con una fuga verso prospettive supposte meno anguste e più consone alla costruzione di un’identità non indotta dalle convenzioni. I temi cari alla Ferrante ci sono tutti: l’infanzia e le sue illusioni, la cognizione dolorosa della complessa realtà, il bisogno di verità oltre la finzione delle rappresentazioni. Chi sono io e che cosa voglio al di fuori della gabbia rassicurante delle consuetudini? Per saperlo devo sfuggire alle maglie di una rete soffocante, dall’ottusa sentina delle tradizioni, dall’ostentato perbenismo dei benpensanti. Immagino Giovanna come una sorta di pervicace viaggiatrice, borsa da viaggio sempre a portata di mano, in fuga perenne da tutti i vecchi vincoli. È per questo che ho pensato a una sorta di escapismo identitario che induce allo straniamento etico e culturale. Sennonché - mi pare ovvio - ovunque tu vada ti imbatti nelle coordinate di sistemi che non hai mai scelto e che possono essere più o meno angusti, a seconda di chi li ha concepiti. Non esiste la dimora di noi stessi. La fuga diventa la condizione perenne di chi non si accontenta del già detto, del precostituito, del preconfezionato. Non resta che la peregrinazione: è il nostro destino, è la Storia! È fuggito un tempo Andrea, fugge Roberto, il suo giovane omologo, fuggono Giuliana e Tonino, fugge Ida, infine la stessa Giovanna. Senza considerare che gli altri si agitano parecchio, confusamente, privi come sono di strumentazione idonea alla burrascosa navigazione. Sembrano palle da biliardo che battono una sponda e tornano indietro segnando angoli eterogenei fino a quando la forza d’attrito non ne vanifichi il moto e le costringa alla stasi; si muovono, non agiscono. Sono come acque chete che, a lungo andare, si trasformano in pantani, maleodoranti come pisciatoi, come i cessi dei treni, di dubbia utilità o valore parimenti alle appendici che i soliti maschietti narcisisti esibiscono a mo’ di scettro. Riferendosi a Corrado, il più inerte della combriccola del Pascone, Giovanna afferma che dai suoi pantaloni veniva fuori un disgustoso e greve odore di latrina. Non è soltanto la dissacrazione della virilità presunta padrona, è la ribellione alla supremazia maschile che suppone la donna mite e sottomessa ai suoi desideri. Giovanna non si lascia fottere, non si lascia chiavare. Lei, indiscutibilmente, non è Vittoria e mai lo sarà. Opera delle scelte, agisce, benché, tra tutte le possibili opzioni, finisca nella degradante esperienza di una deflorazione senza slanci e senza desideri, impoetica quanto basta per distruggere il romanticume diffuso nei romanzi rosa di cui sua madre cura l’editing e che le è stato quasi imposto come prontuario della felicità coniugale. Il suo partner è un teppistello da strapazzo, figlio (sembrerebbe) di un temuto camorrista, avvocato di professione, delinquente per istinto.
Sullo sfondo c’è di nuovo Napoli, come ne L’amore molesto[2], nella tetralogia[3], ma anche, imprescindibile background sociale, ne I giorni dell’abbandono[4], ne La figlia oscura[5]; si tratta della consueta contrapposizione di due comunità apparentemente incompatibili, ma osservate da una diversa prospettiva. L’ascesa si fa discesa; lo sguardo questa volta cala dall’alto, dall’Olimpo all’Ade. Ed tutt’un’altra storia!
«Mi muovevo con l’indice per San Giacomo dei Capri, arrivavo a piazza Medaglie d’oro, andavo giù per per via Suarez e via Salvator Rosa, giungevo al Museo, facevo tutta via Foria fino a piazza Carlo III, giravo per corso Garibaldi, prendevo via Casanova, raggiungevo piazza Nazionale, imboccavo via Poggioreale, poi via della Stadera e, all’altezza del cimitero del Pianto, scivolavo per via Miraglia, via del Macello, via del Pascone eccetera, col dito che scantonava nella Zona industriale color terra bruciata».
Per chi conosca la città è davvero una discesa agli Inferi. La meta è nota, anzi notissima ai vari Andrea, Roberto, Giuliana, Corrado, Tonino, Margherita, Vittoria, che vi sono nati e/o vi vivono e che, in qualche misura, riproducono i tratti di un’umanità che davvero puoi vedere se ti avventuri fin laggiù, un posto orribile ove non c’è niente di interessante da vedere. Ne sanno qualcosa persino Costanza e Mariano che pure appartengono, per diritto di nascita, alla Napoli dei quartieri alti.
L’autrice sembra farlo apposta a darci con precisione topografica i nomi dei luoghi e, dove non li riferisce, ce ne dà le coordinate. Non è difficile identificare il liceo Garibaldi (già presente ne “L’amica geniale”) dove insegna Nella, la madre di Giovanna, oppure il Genovesi, ove probabilmente insegna suo padre, o il Sannazzaro, la scuola che la narratrice frequenta. Ci dice che suo padre la conduce in una friggitoria nei pressi, a pochi passi da piazzetta Fuga dov’è la fermata della funicolare. È noto a molti napoletani il fast food ad angolo tra via Kerbaker e via Cimarosa, vi si servono panzarotti e pastecresciute, il cibo di strada che fa gola non solo ai residenti ma anche ai turisti che vi si sono recentemente convertiti. La Ferrante sembra affermare la sua “napoletanità” come marchio di fabbrica. Non potrebbe essere altrimenti: conosce a menadito la città, la sa leggere e interpretare, ne sa intendere gli splendori e le miserie, ne rievoca gli altalenanti umori, ne rappresenta le insanabili cancrene. Ed è, a mio avviso, di “giù Napoli”, proveniente da una famiglia che non aveva nemmeno gli occhi per piangere. E che dire del dialetto parlato che padroneggia come una popolana incolta, un’eloquio fuori d’ogni convenzione, brutale, violento, aggressivo, enfatizzato da una gestualità esasperante, sbraito come un latrato, visceralmente aderente agli stati d’animo dei locutori, smaccato contraltare allo scilinguagnolo dei quartieri bene?
Della scrittrice Elena Ferrante possiamo saper poco o nulla, ma non possiamo non riconoscerne l’estrazione. E non s’incazzi, come fa di solito quando, a torto o a ragione, lo si accosta a lei, il suo equivalente maschile, Domenico Starnone, il quale nei suoi romanzi e racconti bazzica gli stessi luoghi, rappresenta identici conflitti, ricalca, tra disgusto e assuefazione, un lessico di eccitante sgradevolezza, ma anche la fonetica sguaiata di una collettività idrofobica. Sarà un caso che i loro più recenti romanzi[6] risultino pubblicati nello stesso mese dello stesso anno, sia pure per editori differenti? Ci sono affinità? Sì, ci sono, come tra altre loro rispettive opere. Non importa chi sia l’una e chi sia l’altro. A me interessa rilevare che, tra la vasta produzione degli scrittori napoletani, loro due siano i meno celebrativi, meno oleografici, meno folcloristici. Rappresentano Napoli senza compiacimento, rifuggono i luoghi comuni, ne denunciano le asperità e il degrado, lo fanno con una prosa che raschia via i belletti e ti mostra il volto di una vecchia bagascia deturpato dagli stravizi. Napoli è questo, checché ne dicano i suoi applauditi cantori; buoni questi allo schiamazzo che allieta i pacchiani banchetti dei camorristi.
Va bene per i turisti che non sanno, non intendono sapere e non capiscono; va male per chi, suo malgrado, è costretto a viverci senza il conforto della legge che regola la civile convivenza.
Il degrado al quale giunge Giovanna è simbolicamente rappresentato dal suo discendere da San Giacomo dei Capri al Pascone, da “su Napoli” a “giù Napoli”. Eppure osservate bene dove consuma il suo ultimo atto di ribellione: in un pied à terre di Via Manzoni. Siamo a pochi passi dal sontuoso appartamento di Posillipo in cui suo padre è andato a vivere con la nuova compagna. L’abitazione di un distinto professore è contigua al troiaio di un camoristello di mezza tacca che vive all’ombra del padre avvocato allusivamente colluso, quasi a voler mostrare che la prossimità tra i due universi sociali è di fatto concorso. C’è da giurarci che è così! I progettisti dell’edilizia residenziale della collina di Posillipo sono architetti e ingegneri di qualche fama; la speculazione delle “mani sulla città” è opera di legulei al servizio o alleati del pappatore politico. Questa è Napoli, una melma dalla quale o fuggi o ti ci impantani. Non lasciatevi sedurre dallo scilinguagnolo, una trappola nella quale sta per cadere la povera, smarrita e invaghita Giovanna. È seducente lo scilinguagnolo, non c’è alcun dubbio; ma è anche un dolce veleno che ti accoppa furtivamente. È affascinante il venticinquenne Roberto, come lo era il padre della protagonista da bambina. Ma Roberto è l’ultima trappola tesa alla povera Giovanna; vi sfugge per un mero accidente. E progetta di raggiungere Tonino, l’unico personaggio maschile di un qualche spessore nella mediocrità del molteplice e vario “virilume” presente nel romanzo. Tonino sa cosa sono la prepotenza, l’arroganza, la violenza e, volendo, ne sa fare anche uso, come dimostra la scazzottata al cinema Modernissimo. Ma scientemente vi rinunzia a vantaggio dell’impagabile dignità di appartenersi, di abitarsi, lontano dal postribolo cittadino.
Ce n’è di gente come Tonino a Napoli, benché sia quasi invisibile. Meglio così! Se non puoi fuggire, cerca di non farti notare, parla il meno possibile o taci. Si può essere comparse con grande dignità. Recita pure la tua scena muta nella messinscena della vita bugiarda degli adulti.
La tua giornata di lavoro è appena terminata. Fai ritorno a casa, chiudi bene porte e finestre, siediti nella tua comoda poltrona consunta dall’usura, accendi il lume, apri il romanzo di Elena Ferrante e perditi per qualche ora. Hai trovato finalmente la tua dimora, il luogo in cui, finalmente!, puoi abitare te stesso.
Timothy Megaride
[1] Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, edizioni e/o 2019
[2] Elena Ferrante, L’amore molesto, edizioni e/o 1992.
[3] Si tratta dei quattro volumi che costituiscono la saga: L’amica geniale, e/o 2011; Storia del nuovo cognome, e/o 2012; Storia di chi fugge e di chi resta, e/o 2013; Storia della bambina perduta, e/o 2014.
[4] Elena Ferrante, I giorni dell’abbandono, edizioni e/o 2002
[5] Elena Ferrante, La figlia oscura, edizioni e/o 2006
[6] Il romanzo di Domenico Starnone, Confidenza, Einaudi 2019, è apparso pressoché in contemporanea con “La vita bugiarda degli adulti” della Ferrante.
Id: 2708 Data: 19/11/2020 12:32:18
*
- Letteratura
La parata di Dave Eggers - Obbligo o verità?
da il tetto, n. 336-337, anno LVII, marzo-giungo 2020, pp. 143-146
Scrivo nei giorni del coronavirus. Di un romanzo[1] che, a giudicare dal clima che si respira, pare profetico. Nella traduzione di Francesco Pacifico è il primo che Feltrinelli dà alle stampe di uno scrittore americano, Dave Eggers, già noto al pubblico italiano per i precedenti libri pubblicati da Mondadori. La sua generazione ha molto da dire, molto da raccontarci, per essere figlia legittima di questa nostra complessa e caotica contemporaneità. Eggers lo fa da una posizione di tutto rispetto, immerso nel buco nero del presente che tutto fagocita e maciulla e nulla fa distinguere di ciò che un tempo poteva essere definito e catalogato. Sarà per questo che i personaggi del romanzo non hanno un nome e li si identifica con un numero o un particolare dell’abbigliamento, un grado di parentela, il genere, l’età? Sono Quattro, Nove, Medaglione, Cugino, una donna, un vecchio, un bambino. La caratterizzazione fisica allude a un tratto (Un ricciolo nero gli copriva sbarazzino l’occhio sinistro), uno solo, che salta all’occhio, la tipizzazione culturale mette a confronto due mondi contrapposti, l’opulenza e l’indigenza, la tecnologia e i suoi detriti presumibilmente tossici, il primo e terzo mondo oleograficamente intesi. E poi comportamenti che, in qualche misura, ci dicono che, talvolta, siamo ancora uomini e non automi.
Direi che, nella produzione più recente, Eggers approda all’essenzialità del romanzo filosofico e tende a dimostrare un assunto che si dispiega dinanzi ai nostri occhi come ineludibile verità, inesorabile sentenza: siamo mostri sanguinari agiti da un congegno a orologeria che ripete pedissequamente le battute da copione di uno sceneggiatore cinico e imperturbabile. La carneficina avviene sotto i nostri occhi, ma noi ne siamo ben distanti, nel ventre protettivo di un aereo che ci riporta al mondo preteso civile e ci restituisce al confortante calore delle acquisite e consolidate certezze. È un po’ come assistere a un film dell’orrore con la consapevolezza che è solo un film, un modo come un altro per aumentare la frequenza cardiaca e dirci che un cuore, forse, ce l’abbiamo e che, volendo, potrebbe anche battere. La reazione di attacco o fuga cessa presto quando il pericolo è virtuale, mediatico nella fattispecie, esattamente come in un film.
L’azione si svolge in un paese tropicale del terzo mondo. Quale? Uno qualsiasi. Le immagini della televisione e del cinema ce li rappresentano allo stesso modo: caldo appiccicoso che ha per sfondo un deserto, una savana o anche una foresta. Qua e là qualche dissestato villaggio di sventurati.
La guerra civile è appena cessata e l’opera di riappacificazione tra esercito governativo e ribelli è in corso; è simbolicamente rappresentata dalla costruzione di una strada che unisce la due aree del paese che si sono combattute, la più ricca e sviluppata con la povera e depressa. La carrozzabile che le unisce rappresenta la speranza di una minore povertà, di una più efficace integrazione, la concreta possibilità di curare gli ammalati in un vero ospedale. Prima che il tracciato fosse completato, per raggiungere un luogo di cura occorrevano giorni di viaggio; ora, appena l’asfalto ne avrà rivestito la massicciata, coprire 230 kilometri di distanza sarà questione di poche ore, con un pick-up o una moto. Lungo il percorso la popolazione dei villaggi già si attiva per fornire raffazzonati servizi ai venienti viaggiatori, con improvvisati posti di ristoro o minuto commercio: è l’estemporanea economia della ricostruzione postbellica.
Due contractor del primo mondo, retribuiti da una multinazionale, devono asfaltare la massicciata in un paio di settimane, quante ne mancano alla grande parata che il governo illegittimo ha previsto per celebrare la pace e inaugurare la nuovissima via di comunicazione. Dieci-dodici giorni sembrano pochi per il completamento dell’opera. Sono in realtà più che sufficienti a giudicare dall’avanzata tecnologia impiegata: una sofisticata macchina asfaltatrice che riveste l’impiantito di bitume limitatamente tossico e di presa rapida a una velocità di 40 kilometri giornalieri o anche più se la solerzia di Quattro, il primo e più esperto dei due contractor, nonché manovratore della RS-80, fosse sostenuta dal suo più giovane e inesperto collega, Nove, il cui semplice compito è precederlo a bordo di un quad per mantenere sgombero il lineare percorso da uomini, cose e animali. Ma Nove è tutt’altro che ligio al dovere e assai poco sollecito alle rigide direttive dell’azienda. È un agente del caos: devia dal percorso, sparisce per lunghe ore, confonde il povero Quattro, il quale spesso si trova a risolvere i problemi che il collega gli crea. Ne è molestato oltre i limiti della sopportazione, medita di denunciarne il comportamento, ne auspica la sostituzione, ma sa pure che i capi non gradiscono l’onere di questioni che Quattro può risolvere da solo. Per il poveruomo non v’è altra soluzione che tollerare le malefatte dello scapestrato collaboratore e provare come può a porvi rimedio. Fino a quando Nove non si ammala gravemente e sembra assai prossimo alla morte. Il lavoro ha una brusca battuta d’arresto, il rischio di non rispettare le consegne è altissimo. Ma Quattro non può abbandonare Nove, deve prendersene cura. Lo assiste e intanto profonde energie nel portare a compimento l’impresa, non senza l’aiuto di qualche indigeno parimenti interessato al completamento dell’arteria, sia pure per motivi personali e ben lontani dalla logica produttiva. La narrazione si fa incalzante e tale da coinvolgere il lettore nella lotta contro il tempo.
In assenza di coordinate geografiche e contesti storico-politici, la vicenda diventa emblema di generiche dinamiche postcoloniali che ben rappresentano il tipo di relazione che intercorre tra l’Impero e la pletora di stati nominalmente sovrani sorti sulle macerie di storiche guerre d’indipendenza. Sembra di capire che questa non c’è mai stata e che l’antico dominio sopravvive nella forma del controllo economico dei territori un tempo soggetti allo straniero e oggi retti da governanti corrotti proni alla volontà dell’ex dominatore. Eggers ce ne ha già dato più esplicita testimonianza in un bel libro del 2007[2], i cui temi sembra ora riprendere in una prospettiva storico-esistenziale che afferisce a una sorta di ineludibile condizione: siamo tutti vittime e carnefici in un mondo nel quale lo stato perenne di belligeranza è forse l’unico vero volano dell’economia. E tuttavia, perché il congegno funzioni, è necessario che sia spettacolarizzato e scorra davanti ai nostri occhi come un film d’azione. All’orrore ci si abitua quando appare distante dalla quotidiana esperienza, tranne il caso in cui la sventatezza dei nostri ragazzi scambia per avventuroso lo spettacolo guardato a distanza e ne sia attratta come da un potente stimolante. Parte, il nostro figliolo o il nostro giovane amico, animato da un impulso di generosa vitalità che lo spinge a lanciarsi nella mischia, ignaro dei pericoli che corre, senza schermi e senza preventivo addestramento. È incosciente il nostro ragazzo o desidera semplicemente vivere senza vincoli di sorta perché è nella sua età e nella sua condizione scandagliare il caos?
La prudenza di Quattro non frena Nove. Le regole del gioco, percepite come una necessità di sopravvivenza dal più anziano, sono viste come intralci dal più giovane. Si configura così la dialettica intergenerazionale: una sorta di relazione pedagogica che oppone regola e prudenza a spontaneità e indiscipina. Quattro sa, per maturità e competenza, che attenersi alle consegne è l’unico modo per uscire indenni dalla trappola del subbuglio tribale; Nove dello scompiglio si nutre, per intrinseco, istintivo spirito d’avventura. Quattro medita di liberarsi del pericoloso e scapestrato collega; ma, quasi come un padre che tema di far peggio, non dà mai seguito alle deliberazioni, anzi si fa carico di tutte le malefatte dell’altro, fino a provarne pena e a tentare ogni azzardo per salvargli la vita. Vince Quattro perché, a dispetto degli imprevisti, completa il suo lavoro e salva anche la vita all’irresponsabile gregario.
La prosa scarna, disadorna, essenziale evoca la scabrosità dei luoghi, le insidie del territorio inospitale. Il lettore, tenuto col fiato sospeso per i 230 kilometri del tragitto narrativo, trae per un attimo un sospiro di sollievo. Poi, inattesa, come in un noir che si rispetti, giunge la crudele staffilata e scompagina l’apparenza della ritrovata normalità. Il caos torna a fagocitare le nostre illusioni per dirci che stiamo tutti giocando una partita che non ha regole, a dispetto della prudenza dell’impietrito protagonista, il giudizioso ed empatico Quattro.
Scrivo nei giorni del coronavirus. Siamo tutti in attesa della palingenesi. Seppelliti i morti e guarite le ferite, dovremo riprendere la partita e sarà una competizione ancora più dura: la prospettiva di una nuova e più terrificante crisi economica ci attende al varco, almeno secondo quanto affermano i media. Già si prefigurano le nuove prede da spolpare e noi, ignari cacciatori delle future battute di caccia, saremo esattamente come Quattro, disciplinati e guardinghi, pronti ad accettare la sfida di un gioco al massacro del quale ignoriamo la strategia. Il dilemma permane: obbligo o verità? Il primo salva l’impresa globale, la seconda sacrifica le future generazioni all’altare dell’illusione perduta.
Timothy Megaride
[1] Dave Eggers, La parata, Feltrinelli 2019
[2] Dave Eggers, Erano solo ragazzi in cammino, Mondadori 2007
Id: 2707 Data: 18/11/2020 21:15:56