chiudi | stampa
Nicola Romano
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
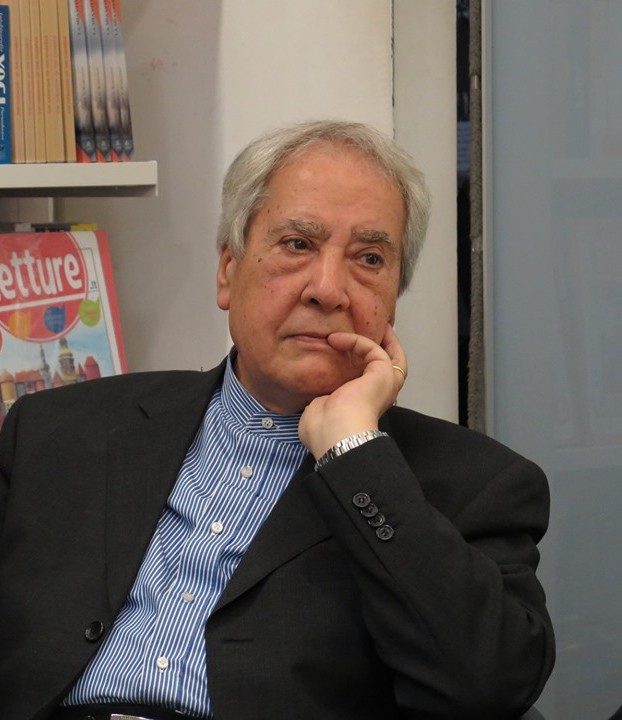
*
Novità editoriale
«VORAGINI ED APPIGLI» - ( poesie) - Ed. Pungitopo, 2016
(dalla prefazione di Giorgio Linguaglossa)
Con il suo caratteristico tono sobriamente dissonante, a metà tra il calligrafismo e la didascalia stilizzata, questa raccolta di Nicola Romano si rifugia nell'elegante fattura del settenario come per prendere le distanze da tutto ciò che non può entrare in quel metro breve.
Sicuramente, l’ironizzazione e la parodia della tradizione crepuscolare italiana sono uno dei cardini della poesia, o meglio, della poesia dell'autore. Il suo progetto di operare una «discesa culturale» di bachtiniana memoria nella poesia italiana, ha avuto successo, è un’operazione utile come può essere utile ogni operazione di «discesa culturale» in presenza di una tradizione che sta in alto. Ma l'autore non si limita ad una mera «discesa culturale», opera anche una «risalita» mediante l’adozione di un metro breve, il classico settenario, posizionato come metro esclusivo di questo poemetto. Metro della tradizione burlesca che l'autore ripropone nella sua traslazione dal burlesco all'ironico. Personalmente, nutro molti dubbi sulla utilità e sulla efficacia, oggi, in Italia, di una «discesa culturale» che non venga accompagnata anche da un riposizionamento verso l'alto, siamo già scesi così in basso che ogni forma d’ironizzazione rischia di cadere nel vuoto da cui proviene. Così, il poeta dei nostri giorni deve saper modulare entrambe le opzioni metriche e stilistiche, deve oscillare sapientemente tra la «discesa» e la «risalita»; ed è quello che fa il Nostro, il quale lascia oscillare il dettato poetico tra i due poli mediante l’adozione di un punto di vista serioso e supercilioso sulla realtà. Cioè, per l'autore siciliano è serioso ciò che non appare esserlo, è serioso lo stile dilemmatico che oscilla tra un più e un meno, tra i due poli inconciliabili sopra detti. Semmai, il problema per il poeta è il «vuoto» della società italiana. Ed è con questo problema che si misura il «finto vuoto» dei versi di Romano, fatti apposta per attirare e fagocitare il «vuoto». È la sua risorsa strategica, l'ultima, direi, quella di riformulare il «vuoto» ricorrendo ad una testuggine di parole indurite nei settenari, brevi, rapidi, superciliosi, ultra minimalisti.
La poesia del nostro autore sospende la «normalità», la «rovescia» ma, rovesciandola, la lascia intatta, anzi, la rende maggiormente visibile, la invita a sopravvivere, non a «rigenerarsi», perché Romano è un poeta dei nostri tempi, un poeta disilluso che ha smesso da tempo di credere, sa bene che qui si tratta del capitale finanziario il quale ama i minimalisti perché lo lasciano stare lì dove lui può proliferare, a lui vanno bene i patemi d'animo e le rimembranze del cuore come anche la cronaca nera e la cronaca rosa, entrambe de-sostanzializzate e de-realizzate, nonché tutto ciò che sa di sentimento del tempo olistico e solitario.
Id: 1680 Data: 09/02/2016 14:22:21
*
in Oltre parole - Festival del verso corrente
Dal 6 all'8 Novembre 2014 a Palermo, presso la ex Real Fonderia Orotea alla Cala, si svolgerà la manifestazione che porta il titolo di « in Oltre parole - Festival del verso corrente», inserita nella più ampia "Settimana delle culture". L'evento, progettato e realizzato con grossa convinzione dai giovani scrittori Cinzia Accetta e Domenico Stagno, prevede incontri aventi per oggetto la comunicazione e la scrittura in genere, e inoltre vi sono inseriti dei laboratori e dei dibattiti specifici con delle librerie indipendenti e con dei blogger letterari. Sono pure in programma alcune esibizioni musicali. Per quel che riguarda la poesia, il top si avrà nella giornata di venerdi 7 novembre allorquando, oltre ad un laboratorio con degli studenti e ad un open mic con Giorgio D'Amato, per una didattica poetica sarà tenuta un'intervista a Roberto Deidier, poeta e docente universitario, che in quell'occasione presenterà anche il suo recente libro "Solstizio" edito da Mondadori. Seguirà una lettura curata dagli attori Patrizia D'Antona e Francesco Giordano per "10 tempi diVersi", incontro con 10 poeti siciliani diversamente impegnati in una ricerca di linguaggio.
Id: 1392 Data: 31/10/2014 11:51:47
*
Intervista a cura di Giovanni Dino
- Cos’è per te la poesia, e che posto occupa nella tua vita?
Il concetto di poesia ha sempre avuto una valenza soggettiva derivante dal bagaglio culturale ed emozionale di ciascuno di noi, e quindi aveva ragione Borges quando diceva che poesia vuol dire tanto ma vuol dire pure niente. Esistono numerose definizioni che messe insieme non riescono a restituire una precisa definizione sulla consistenza della poesia, e forse è meglio così. Per me la poesia rappresenta un recinto dell’anima, dove mettersi al riparo da tutti quegli eventi che non appartengono alla storia intima ed essenziale dell’uomo. Facendoci l’abitudine poi diventa un modo di essere e di vedere le cose del vissuto. Pur riconoscendone il grande valore umano, vorrei tanto dire che essa occupa il primo posto nella mia vita, ma non è così dal momento che, per questioni di sopravvivenza, bisogna avere a che fare con le stizzose pratiche della quotidianità e della sopravvivenza. Per vivere esclusivamente di poesia bisogna essere sufficientemente ricchi oppure poveri in canna, non c’è una via di mezzo.
- La voce del poeta si fa sentire nella società come nel passato oppure è una blanda figura rappresentativa di bella mostra chiusa/relegata nei libri?
Evidentemente non esiste più il poeta di corte, o quello che riesce a smuovere le folle o le coscienze, nel nostro tempo oramai sono in declino le ”autorità” sociali ed istituzionali. I tempi della poesia sociale sono regolati pure da momenti politici di una certa particolarità; finiti questi, essere poeti (specialmente oggi) è un fattore quasi privato, una nobile dedizione da condividere con pochi compagni di tenda e niente più. E comunque è un peccato disperdere le potenzialità che può avere la poesia nell’ambito della comunicazione fra esseri umani, si può partire da un qualsiasi verso per giungere poi a grossi temi pratici o esistenziali. Ne è prova il famoso “M’illumino d’immenso”.
- Chi è il poeta oggi, e qual è il suo identikit psicologico, spirituale, morale, culturale e politico?
Il poeta di oggi, come quello di ieri, cerca una sua verità relativa per dare un senso a tutto ciò che esiste o che è in divenire. Deve essere certamente dotato di buone risorse indagatorie, non disgiunte da una certa dimestichezza con la scrittura che deve essere possibilmente creativa. Fare un identikit è difficile, si può trovare un buon poeta anche fra chi non ha un’elevatissima cultura, o fra chi non è molto impegnato in ambito sociale o politico, perché il pretesto poetico nasce da un desiderio di conoscenza e dalla voglia di rendere più armonica la realtà.
- Ma scrivere poesie serve più a sé stessi o agli altri?
Serve principalmente per spiegare a sé stessi la vita, per cercare di decifrare in forma analitica e letterale tutti quei fenomeni che vanno a sviluppare un’elaborazione a livello interiore. Se in questa elaborazione resa poi in forma di scrittura qualcun altro (il lettore) s’identifica, vuol dire che la poesia, per trasposizione, è servita anche agli altri e diventa quindi “messaggio”. Aggiungo, inoltre, che un lettore può “sentire” attraverso una poesia delle cose diverse da quelle che ha provato l’autore, per cui i punti di osservazione possono essere tanti e diversi fra di loro.
- La poesia educa, consiglia, fa riflettere, e a cos’altro serve?
La poesia educa al sacrificio, all’impegno ed alla ricerca, richiede mezzi e strumenti che non vengono insegnati in nessuna scuola, al contrario dei musicisti che godono del conservatorio o del pittore che gode dell’accademia di belle arti. Bisogna comunque puntualizzare che “fare poesia” è ben diverso dallo “scrivere poesie”, altrimenti non ci s’intende. La poesia, in definitiva, insegna a trarre l’elemento “impalpabile” da quel che di materiale ci offre la vita di tutti i giorni. Il poeta è come un fisico, deve far passare la “materia” dallo stato liquido/solido allo stato “gassoso”. Dedicarsi alla “parola” è un grosso sacrificio, è più comodo stare seduti, immobili e lasciarsi prendere dalle immagini di ogni tipo che scorrono dinanzi agli occhi.
- Perché quasi tutti i giovani scrivono poesie quando s’innamorano, ma poi abbandonano questo approccio con i versi?
Perché il periodo dell’innamoramento è il primo momento in cui si smuovono in modo sensibile le corde interiori, e per capire cosa succede dentro ci si confronta e conforta con la scrittura. Occorrerebbe continuare con questa pratica ogni volta che colpisce, in senso positivo o negativo, qualche accadimento emozionale, e quindi affinare poi, con l’ausilio dei mezzi a cui ho accennato, il proprio modo di comunicare attraverso immagini particolari e soluzioni espositive di un certo effetto, aiutandosi magari con delle metafore o con semplicissimi accostamenti linguistici. La poesia nasce sia dalla gioia che dal dolore, ma il risultato che si ottiene è sempre gioioso.
- Ma è proprio vero che oggi il popolo dei poeti e di coloro che decidono di racchiudere i propri pensieri nella scrittura sono molto di più rispetto al passato?
In questo momento di grandi risvolti tecnologici e informatici, di comunicazione di massa e di globalizzazione l’uomo, secondo me, è sempre più solo e, quindi, cerca rifugio nell’intimità del proprio essere, che non può volere sempre ciò che gli viene proposto a fini commerciali da diverse parti. Arrivati a un certo punto di saturazione, si ha bisogno inevitabilmente di trascendenza, per cui la conseguenza naturale (ed auspicabile) è quella di rivolgersi alle arti in genere e, soprattutto, alla religione. Pertanto, è meglio un popolo di poeti che un popolo di perditempo.
- Da quanto tempo scrivi poesia, e quali sono gli autori del passato che più prediligi?
Ho cominciato in età matura, verso i 30 anni (ora ne ho il doppio), perché prima sentivo qualcosa dentro ma non la sapevo esprimere a dovere, poi il tutto è venuto fuori con forza ed ha richiesto una necessaria disciplina formale. Fra gli autori italiani del recente passato prediligo i poeti Alfonso Gatto, Cristina Campo, Sandro Penna, Bartolo Cattafi, mentre fra gli stranieri la mia attenzione va a T.S. Eliot, Neruda, Raphael Alberti, Paul Celan.
- Quali opere hai pubblicato, e quali sono i premi più importanti ricevuti?
Tra libri e “plaquette” ho fin qui pubblicato undici raccolte di poesia, che vanno dal 1983 al 2003. I premi dei concorsi letterari sono serviti per verificare i miei lavori e per trovare lo sprone a continuare. Al di fuori dei concorsi che lasciano il tempo che trovano, esistono “premi” di altra natura che consistono in riconoscimenti e confronti con amici e con gente comune, oppure con personaggi “veri” del mondo letterario nazionale.
- Nel 1997 sei stato chiamato a rappresentare i poeti e la poesia dei siciliani in Irlanda; puoi parlarcene?
E’ stata un’esperienza unica e nata per caso: insieme ai poeti Maria Attanasio e Carmelo Zaffora, anch’essi siciliani, e con la partecipazione dell’attrice Mariella Lo Giudice dello Stabile di Catania, sono stato invitato dall’Istituto italiano di cultura a Dublino per tenere degli incontri di poesia in varie città irlandesi. Oltre che a Dublino, ci hanno portato a Belfast, a Derry, a Letterkenny e in altri paesi del Donegal, una regione settentrionale dell’Irlanda. Abbiamo conosciuto altri poeti irlandesi che recitavano i loro testi in lingua gaelica, abbiamo incontrato italiani che vivevano in quei luoghi, ma soprattutto siamo venuti a contatto con una realtà umana e paesaggistica veramente interessante e che ci ha arricchiti moltissimo. Ad un incontro mi hanno chiesto di fare un parallelo tra la Sicilia e l’Irlanda, ed io ho parlato di similitudine fra le due “isole”, tutt’e due collocate geograficamente alla periferia dell’Europa, che in quel momento avevano in comune una certa “condizione”: per loro il separatismo e per noi la mafia. Inoltre, ho accostato quello che per loro è il mito celtico alla nostra mitologia greca, cosa che è piaciuta tanto. Ecco, lì i poeti sono tenuti in maggior considerazione, lo Stato gli sovvenziona un tot di pubblicazioni all’anno, e se vengono invitati a delle manifestazioni vengono giustamente ricompensati, anche…con dei cavalli.
- Hai diretto una rivista, presentato libri, partecipato a giurie di concorsi letterari, collaborato a quotidiani e periodici; parlaci della tua vita di poeta, di giornalista, di scrittore.
Per come ti accennavo poco fa, mi piacerebbe fare tutto questo a tempo pieno, aggiungo che sono anche ”paroliere” regolarmente iscritto alla Siae. La scrittura mi affascina, mi fa sentire più partecipe al mondo, mi fa entrare in sintonia con il battito del tempo, mi restituisce un senso di appartenenza ad una comunità umana che ha bisogno di scambi intellettuali e di ragionevoli determinazioni. La scrittura viaggia, ti mette in contatto con tanta gente, ti apre degli orizzonti che non potevi prevedere prima.
- Ti sei mai adoperato per promuovere nuovi talenti?
Pur avendo fatto anche l’operatore culturale, non sono mai stato un talent-scout, nel passato ho solo incoraggiato qualcuno che già dalle prime battute dimostrava di avere una buona intuizione, e in linea di massima non mi sono mai sbagliato.
Id: 1135 Data: 29/10/2013 14:13:31
*
Intervista a Nicola Romano, di Maria Gerace
Nicola Romano, autore di una lunga serie di raccolte poetiche, nasce a Palermo nel 1946, e tuttora vi risiede. In veste di giornalista pubblicista tratta argomenti culturali e sociali su diversi quotidiani e periodici. Il suo recente lavoro poetico, Gobba a levante (Pungitopo Editrice), rappresenta, rifacendoci alla definizione di Paolo Ruffilli che ne ha curato
Ne Il mio rione colpisce molto la bellissima quanto eloquente immagine che ci restituisci del tempo, un tempo che «smemora stagioni», «annerisce sulle case», e altrove si materializza come fatto di «giorni che immemori cadono e veloci». Con il trascorrere delle epoche, la percezione che di esso si è avuta ha subito una significativa accelerazione e una conseguente contrazione. Come giudichi quest'umanità impegnata nella sua folle corsa contro un tempo che sembra sfuggire a ogni tentativo di razionalizzazione?
Mentre noi facciamo discorsi raffinati e che ci arricchiscono dentro, parallelamente scorre una parte di mondo che non sfrutta a dovere il suo tempo oppure che fa del tempo un’arma per prosperare economicamente, e pure in maniera spudorata ed arrogante. La concorrenza, la comunicazione mediatica, i “last minute”, il “prendi ora e paghi fra sei mesi” ormai sono operazioni che tendono a razionalizzare interessi di parte, ma che in definitiva concorrono a deformare ed a strozzare il tempo puro.
La comunicazione è quel processo che indirizza l'agire sociale; attraverso l'apprendimento della parola l'uomo, inserito nel processo comunicativo, interagisce, a diversi livelli, nella e con la società. Più volte nelle tue liriche valuti, giudichi e analizzi il senso, il peso, più in generale, il ruolo delle parole.
Generalmente, nelle conversazioni, Io sono di poche parole proprio perché assegno ad esse molta importanza, le ritengo un preciso veicolo per la diffusione del messaggio e penso, inoltre, che nella loro scelta esse debbano contenere la vera essenza di quel che si vuole comunicare sia a livello d’informazione che a livello letterario. Malgrado il pensiero sia così complesso da non poterlo esprimere per iscritto con adeguata corrispondenza, nella scrittura le parole escono dall’inconscio, quelle che vengono fuori non possono essere sostituite da altre, se arriva quella vuol dire che contiene la giusta tensione nonché i suoni e i segni di quel che si è maturato dentro e che s’intende trasferire. Io ho avuto il bene di ascoltare in privato le conversazioni del professore Giuseppe Cottone, morto in piena lucidità intellettuale all’età di 104 anni, il quale era un cultore ed un ammiratore del “logos”, di quella parola che chiede attraverso il poeta di ottenere un’esistenza nuova. In buona sostanza, si può addirittura asserire che a volte, a prescindere dai contenuti, l’intero paradigma di un testo, formato da un insieme di parole, può essere materia stessa di quella poesia, come diceva il poeta americano Allen Ginsberg.
Io guardo con diffidenza coloro che scrivono fiumane di parole e che magari pubblicano ogni due anni; il problema non è quello di scrivere poesie con belle parole ma di esprimere possibilmente poesia attraverso un processo che è difficile da spiegare e che comunque non autorizza a fare altrimenti. E, visto l’argomento, assegno molta importanza anche alla parte tecnica del testo poetico, perché un testo si va ad offrire agli altri e così come noi ci imbellettiamo prima di uscire da casa, anche una poesia deve essere resa gradevole dal punto di vista formale, senza eccessi comunque e senza mettere su una sartoria del verso.
Nella tua ultima silloge, Gobba a levante, vi sono diversi richiami alla memoria. Quanto forte è per te il nesso esistente tra memoria e “radici”, in riferimento al singolo individuo, a una generazione o all'intera collettività?
Io non sono per le raccolte a tema, ma riconosco che quest’ultimo libro contiene una base memoriale dovuta anche al raggiungimento di un certo stadio della vita in cui le rivisitazioni arrivano in maniera spontanea e naturale. Potremmo dire che l’esercizio della memoria rappresenta una vita sovrapposta a quella che praticamente si conduce, buona parte dei nostri giorni – specialmente quelli della mia età - la passiamo nel giardino della memoria anche perché essa, oltre ad accompagnarci ed a rappresentare un ambiente di ripescaggio, ci fornisce anche delle opportune istruzioni necessarie ad affinare quello che potrà essere il nostro futuro. E la memoria inevitabilmente affonda nel terreno su cui si sono sviluppate le proprie radici, intese come sviluppo complessivo della propria personalità. La memoria, e tutto quanto il resto dell’essere sensibile, si può dire che possiede una sua geografia connaturata all’ambiente fisico e culturale di ogni individuo, non disgiunta dagli accadimenti conseguenti alla condizione sociale ed all’epoca in cui si è vissuti. Il nesso pertanto è molto stretto: lo specifico ricordo si fa memoria attraverso il filtro del modo di essere di ognuno, fino a diventare memoria.
Oggi, però, sento più disgregata la “memoria collettiva”, ognuno sembra andare per strade diverse, e più difficile sembra instaurare un vero dialogo o un confronto che sia.
Ti servi delle parole e le plasmi in modo da suggerire al lettore delle immagini suggestive che comunicano la sensazione di vivere nei tuoi versi e di fare, attraverso essi, esperienza delle contraddizioni del quotidiano. Sebbene oggetto della tua analisi poetica sia una dimensione esistenziale frenetica – contenitore di stress, interruzioni, sottrazioni, ansie – il linguaggio utilizzato per la sua descrizione è, al contrario, pacato e riflessivo.
Nella sua sintesi il linguaggio risulta pacato dal momento che è stato mediato ormai dall’esperienza maturata negli anni. Agli inizi, quando la porta della poesia mi appariva invalicabile, molto robusta e quasi blindata, i miei versi risultavano più impulsivi, più taglienti (come fiamma ossidrica) e supportati da un linguaggio forse molto più sperimentale ed invasivo, ma col tempo i contenuti e le forme si sono andati delineando con maggiore chiarezza, la porta è apparsa più leggera e per la qual cosa la chiave da usare ha avuto minori dentature. E questo è stato riconosciuto anche da alcuni critici. D’altronde la parte difficile sta nel fare poesia con parole semplici, e in tal maniera ne guadagna pure la comunicazione che risulta più im-mediata.
Non si possono trasferire paturnie, schizofrenie e malesseri esistenziali in maniera eccessivamente personalizzata o gridata, ma occorre fare in modo che un’intuizione, appena descritta, possa diventare la più universale possibile, cioè fare in modo che gli altri si possano riconoscere.
Nel mondo occidentale viene data grande importanza alla parola parlata, di contro la cultura orientale dedica molta attenzione al silenzio. Viviamo una realtà fatta di eccessi, tra i mali che affliggono le nostre società vi è anche un'esuberanza nell'utilizzo di parole non ponderate, responsabili dirette di notevoli incomprensioni. In Aspetterò con ansia tu parli di «dimenticare / il nome delle cose / [...] ricominciare dell'eden / con una nuova mietitura di parole» e in Penitenza definisci le parole «pellegrine dell'aria / acerbe e menzognere». Quanto è importante recuperare la dimensione del silenzio, del "mettersi in ascolto"?
E’ proprio così, oggi la parola risulta molto inflazionata, sembra avere perso il senso ed il proprio peso specifico e, come se non bastasse, inoltre viene stravolta e deturpata dalla pubblicità e dalla tecnologia informatica che ha contaminato con un abbondante lessico straniero. Per questi ed altri motivi oggi è molto problematico porsi in ascolto o saper ascoltare il prossimo, perché innumerevoli sono gli attentati, gli equivoci e le distrazioni che la vita ci propina, ma bisogna comunque non perdere l’abitudine a ritrovarsi con se stessi e con gli altri. E’ una questione, ormai, di sopravvivenza.
Il silenzio sta nel “prima” e nel “dopo”, è la migliore piattaforma da cui partire per iniziare ogni manifestazione umana, ma è pure la stazione di arrivo, il luogo in cui si esaminano i comportamenti e l’operato che è stato posto in essere. Non ci può essere azione senza un preventivo ed intimo silenzio e non ci può essere un resoconto senza il supporto d’una onesta disamina anch’essa silente. E la “parola”, intesa come prodotto finale di uno stato contemplativo, ha il dovere di rivelare la dimensione di quel silenzio che l’ha generata, così come la pausa che segue si deve sciogliere in una sorta di eco interiore, per verificare gli effetti della comunicazione inviata o ricevuta. Per non dire che anche un testo scritto contiene i silenzi dei passaggi da una parola all’altra, delle pause, dei puntini di sospensione, degli spazi bianchi delle pagine…
Sappiamo che la prima cosa creata è stata proprio la parola, attraverso quel “fiat lux” che ruppe i segreti del cosmo, e quindi vuol dire che prima di essa c’era il nulla, le tenebre, il silenzio, e allora dovremmo recuperare tale stato primordiale per poi dare spazio alla “bellezza” che ne consegue.
I tuoi versi, con il loro incedere meditativo a volte quasi mistico, manifestano la dimensione della fede: che ruolo ha quest'ultima all'interno della tua poetica?
Penso che i percorsi che portano alla Fede in primo luogo, ed alla poesia in seconda istanza passino necessariamente attraverso una condizione di trascendenza, che si rivela indispensabile per tentare il raggiungimento di qualche possibile verità, anche se non assoluta, o per cercare i presupposti per un’auspicabile evoluzione spirituale. E per raggiungere tali traguardi viene in aiuto il processo della meditazione. Se devo proprio dire, non vedo e non sento misticismo all’interno del mio fare poesia, ma il tema religioso che appare ogni tanto fa parte di una mia presa di coscienza del fatto che dentro la religione cristiana vi sono grossi insegnamenti di civiltà umana. E siccome uno dei compiti della poesia deve essere quello d’inseguire un certo impegno civile, ecco che molte ispirazioni possono giungere inconsciamente da una dimensione “altra”. D’altronde la poesia vuole ricomporre armonie, vuole assemblare elementi dispersi e vaganti, praticare una specie di rilegatura che evoca il “relego” latino.
Per non dire che poesia e religione si mutuano la stessa grazia della parola.
Id: 851 Data: 20/08/2012 09:01:25
*
XXXVIII Premio di poesia «Città di Marineo»
Il Premio internazionale "Città di Marineo" verrà assegnato all'attrice Pamela Villoresi.
Marineo, Piazza del Castello, 2 settembre 2012, ore 18
Id: 850 Data: 19/08/2012 15:36:29
*
La bellezza e la rovina - Poeti a Menfi
incontro di letture di poesia con i poeti:
Sebastiano Burgaretta
Roberto Deidier
Nino De Vita (Premio Viareggio 2012 per la poesia)
Biagio Guerrera
Josephine Pace
Nicola Romano
Francesca Traina
Interventi di Giovanni Sollima (violoncello)
Id: 849 Data: 19/08/2012 15:21:33
*
GOBBA A LE VANTE di Nicola Romano - poesie
Relatori: Roberto Deidier, Franca Alaimo e Tommaso Romano. Letture a cura di Rosalia Billeci. Ingresso libero.
Id: 664 Data: 02/12/2011 17:59:55