chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Alberto Rizzi
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
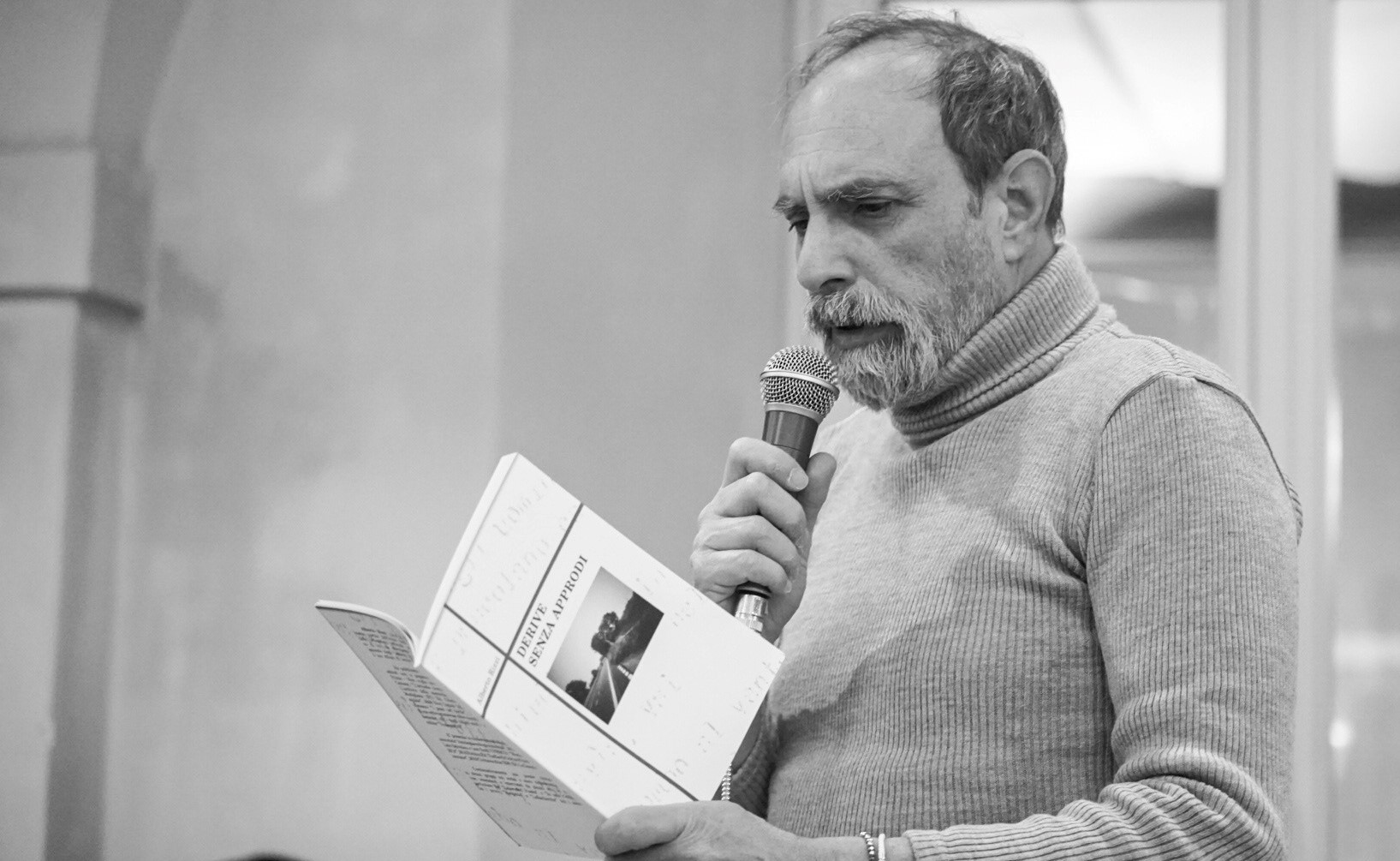
*
’Aggrappato a un sogno’
Tutti i giorni per ore ho tenuto l’occhio incastrato a due stecche della veneziana, un dito a separarle appena. Finché lei passava per il marciapiede opposto.
La mia sicurezza di una vita, fino a ieri.
A volte mi perdevo pure a guardare i dettagli che il mio occhio riusciva a cogliere nell’attesa di quel suo uscire, o rientrare a casa: anni fa per un po’ un ragno fece la sua tela sfruttando alcuni coppi del tetto che fa angolo con la mia stanza. Ne osservavo i movimenti quando la riparava, quando imbozzolava le sue prede; sempre pronto a ributtare l’occhio sul marciapiedi di sotto, appena qualcuno entrava nel mio ristretto campo visivo.
Dopo quasi un mese scomparve, non so perché: preso da un uccello, immagino, o da qualche insetto più forte di lui.
E con lui immaginavo la mia vita, la mia costrizione, la tela che avevo tessuto e dalla quale spiavo lei: compagni di prigionia, se non proprio di cella.
Mai colsi, di lei, un particolare preciso; mai il colore degli occhi, per esempio: era il mio sogno vivente, che regalai alle deformità del mio corpo, alla purezza della mia mente; a entrambe le cose per le quali la crudeltà degli altri mi ha sempre escluso.
Ieri c’erano sia nebbia che luna (vedo tanto cielo che città, da queste fessure), ma della città vedo solo case; so che esistono giardini, parchi; se apro le ante alle volte odo un treno passare dalla ferrovia non lontana. Ma per me tutto questo non deve esistere: esistono solo i muri e le finestre che si aprono nei condomini di fronte; e so che dietro quei vetri ci sono solo vuote sagome umane, pronte a deridermi se solo potessero vedermi.
Così è sempre stato, così pensavo sarebbe sempre stato, fino a ieri.
Sapevo la persona che si fermava appena uscita dal bar di fronte, qualche volta guardava in alto non a caso; che la donna che indugiava un attimo di più a quella finestra, guardava in questa direzione non a caso: era sapere chi c’era dietro questa finestra, in questa stanza; era la speranza di cogliere la deformità, come se la deformità non fosse in loro: cuori, menti, occhi un coacervo di piaghe.
Per questo solo ciò che è impalpabile – le foglie secche che cadono, la sera che porta pietà agli occhi – mi fu amico; per questo solo potevo aggrapparmi a ciò che no era materiale: la sua immagine e le fantasie che ne facevo nascere, non la sua mano.
Fino a ieri, quando ho capito che non l’avrei più rivista: ho capito che i camion del trasloco che avevo visto andare e venire qualche giorno fa, erano venuti per lei. Che la loro banalità, la banalità della vita che mi è negata, mi aveva portato via il mio sogno.
La luce fredda dei lampioni mi ha aiutato ad aprire la finestra nella notte non ancora fredda di Settembre, la veneziana finalmente tutta alzata; quella luce che aveva ucciso la poesia del buio amico mi ha aiutato a salire su una sedia e a scalciar via, con essa la mia vita, così deforme per gli altri.
Mi vedano pure domani; vedano il mio corpo deforme, il mio occhio fallato che mai invece ha visto. Quello buono rimane spalancato e fisso su ciò che rimane del mio sogno: quei pochi coppi da tempo disabitati, quei metri di marciapiede da lei percorsi; l’unica bellezza che il giorno mi donava.
Id: 5312 Data: 15/02/2022 21:30:31
*
La donna e la strada
È una strada come tante, come tante ce ne sono in campagna tra fondovalle e prime colline. Una delle tante strade bianche che, tra saliscendi e curve, ti fanno lasciare alle spalle la città e tutto quello che in quei luoghi sa di tristemente umano.
E come tutte quelle strade, quando è appena piovuto, è meglio. Perché il cielo senza sole le dà un colore diverso ogni volta; e tramuta in segni e macchie ogni dettaglio di alberi, di cespugli, di ogni cosa.
E perché c’è il vento: anche il vento è sempre diverso a ogni pioggia, a ogni temporale; e diverso rimane anche dopo che l’acqua non scende più.
Appaiono diverse le persone che incontri, suonano diverse le frasi che ci scambi, quando le conosci, anche se sono quelle dette da sempre.
Sono diversi gli incontri che si fanno, come nella sera incipiente di alcuni anni or sono, quella donna immobile e scarmigliata accanto a un albero, la sua chioma anch’essa scarmigliata dal vento.
Un incontro di cui nulla ricordo con precisione: il suono del vento che percorreva la landa, quello dei miei passi sul ghiaiume, la qualità della luce in quella giornata, i gesti di quella donna e l’impressione che le sue mani mi abbiano toccato.
Quel momento è annebbiato, bombato, confuso nel mio ricordo. Tutto si mostrò differente nel mio percorso di ritorno.
E quando nell’abitudine percorro questa strada, penso sempre che non ho mai più rivisto quella donna da allora (si voltò e riprese il cammino, o la sua figura svanì dolcemente al seguito di quel vento?), pur nella sicurezza della sua esistenza qui o in un altrove che sia; pur nella sicurezza del paesaggio quasi del tutto confermato nel trascorrere degli anni…
Id: 5292 Data: 23/01/2022 21:20:39
*
Tutto in un respiro
TUTTO IN UN RESPIRO
Sono io quella che vedo dalla finestra occhi capelli labbra tutto sulla spiaggia su quella riva mi guardo mi vedo io e i miei gesti passo e lascio orme passiamo e lasciamo orme no solo io o solo lui le lasciamo no solo uno dei due vorrei ma non c’è vorrei ma non c’è io o lui e tutto sta tra le mie braccia i castelli di sabbia le piume di gallo le conchiglie e i loro frammenti i brandelli degli abiti io passo e passo controvento il vento mi spazza il vento porterà via tutto le piume i frammenti i brandelli e mi lascia la storia la mia storia la nostra storia che vedo dalla finestra tutto su quella spiaggia dove muovo i miei passi meccanici io senza lui la spiaggia che si fa duna per il vento per il cielo per afferrarlo e i fiori nelle mie braccia i fiori che cadono dalle mie braccia e i brandelli i brandelli che cadono dalle mie braccia (brandelli delle mie braccia) i frammenti che cadono da dovunque e ogni parte di me che si fa tutto ogni tutto di me che si fa parte in quello sforzo mentre crollano i castelli di sabbia mi vedo che mi fermo mi fermo su quella spiaggia su quella riva la mia stanchezza contro la marea calante sintonia con la marea calante con frammenti piume brandelli e questa mia stanchezza queste orme che si sono fermate mesi e mesi fa che non ci sono più mi hanno legata coi loro fili qui non mi muovo non parlo non riesco a dire da allora che ti amo prima mi muovevo ma non dissi prima potevo prima prima ero movimento e Amore prima potevo esser tutto.
Ora sono io quella alla finestra.
Io quella fuori dalla finestra, lungo il mare.
Io che sono pazza.
Id: 5255 Data: 29/11/2021 15:13:45
*
Parco d’autunno
PARCO D’AUTUNNO
Saranno passati cinquant’anni, dall’ultima volta che ci incontrammo, che fu quando ci lasciammo. Qui, nello stesso parco dove la nostra relazione ebbe inizio.
Il cancello è arrugginito, ma riesco a passarlo lo stesso, senza sforzo per fortuna.
I grandi alberi mi accolgono con i loro rami imperlati di muschio, le foglie che stanno cadendo in questo autunno inoltrato, uno spesso strato di muschio anche sui tronchi verso nord; non ha piovuto, ma l’erba è bagnata, perché c’è quasi sempre più ombra che sole e la guazza notturna ora non s’asciuga nemmeno quand’è pomeriggio.
È bello il contrasto tra ciò che è apparentemente morto, come queste siepi alla mia destra, ormai nude, e l’erba al suolo: che in certi punti ha un colore nuovo, malgrado l’inverno debba ancora cominciare.
Riconosco gli alberi uno a uno, ricordo quello che ne dicevamo io e lei e sono certo che anche i due grandi cedri del Libano, messi a segnare la biforcazione del sentiero riconoscono me. Lo sento. Mi avvicino e provo a toccare quello di destra. E proseguo.
Il grande padiglione Liberty che accoglieva le nostre confidenze, i nostri abbracci, è sempre là: lungo la vegetazione incolta del sentiero che piegava a sinistra, uno scheletro di ghisa sverniciato. Solo i tavoli di marmo sono rimasti, del vecchio arredo: sbrecciati qui e là e anneriti dall’umido, ma troppo ingombranti per essere portati via. Ora l’arredo è le trine dei ragni, anche loro imperlate dell’umidità di questa stagione.
Come appoggiato a uno di quei tavoli, lascio che i ricordi mi tornino dentro: per primo quello della frase, incisa su un banco di scuola, che fece iniziare la nostra relazione. Una scritta che recitava tristezza, quasi a presagire la fine non voluta, quella fine che da allora mi porto dentro e che mi fa tornare a volte qui, malgrado il peso degli anni.
E con i ricordi, mi ritornano le immagini: lei la posso vedere come fosse allora, lei e le altre persone che venivano qui, gli altri amici… Come se il tempo si fosse fermato. Immagini che m i riportano indietro a uno di quei grandi cedri.
Fanno male; fanno male come ogni altra volta. E capisco che anche stavolta è il momento di andare. Anche l’ultima immagine che sempre mi rimane di questo luogo, questo prato che malgrado la stagione fa intuire la serenità della vita che continuerà alla prossima primavera, fa male.
Ma non riesco a non tornare qui, di tanto in tanto. Saranno cinquanta, gli anni trascorsi da quando lei mi lasciò? O saranno cinquanta dall’ultima volta che sono tornato qui? Il tempo ha preso un’altra forma, da quando mi fermai a dondolare da un ramo di quel grande cedro del Libano, quello che indica il sentiero che nel parco piega a sinistra.
Non che il tempo abbia più molta importanza. Ma ancora non riesco a non tornare qui.
Id: 5253 Data: 28/11/2021 09:47:24
*
Il giorno libero
Si era scelto una vita da scapolo e un lavoro sulla strada; e arrivato ai cinquanta, gli erano comparsi come da copione i primi malanni, oltre ad avere una madre ultraottantenne ricoverata in casa di riposo, ma che non poteva certo dimenticare là come una radio fuori uso in una cantina, fingendo che non esistesse. Per fortuna il suo datore di lavoro era comprensivo e quando ne aveva bisogno, sia per lui che per lei, gli dava giornata libera, senza creargli troppi problemi: dopotutto avevano iniziato trent’anni fa quasi assieme, lui era uno dei suoi primi autisti.
Così si poteva prendere il lusso di gestire quella giornata coi suoi tempi, per esempio alzandosi e facendo colazione alle 10: come quel giorno, mentre nella strada di sotto la vita quotidiana aveva già preso da un po’ il suo ritmo. Un rumore secco e improvviso si sovrappose a quelli della gente e delle auto; un rumore che il ricordo della vita militare e di qualcuno dei film che ogni tanto vedeva, gli permisero di riconoscere subito.
“Sono arrivati anche qui.”, pensò.
Con cautela si avvicinò alla finestra; mettendosi quanto più possibile di sguincio e scostando appena la tendina, poteva vedere la via d’infilata. Alla sua imboccatura uno zombie in nero gridava qualcosa in arabo, brandendo un Kalashnikov.
“Non è la mia guerra…”, pensò. Non aveva una gran cultura: aveva iniziato a fare il camionista, subito dopo aver terminato una scuola professionale; ma era sempre stato curioso e si era tenuto informato come meglio poteva. E c’erano diverse cose, che non lo convincevano. Per carità, Assad sarà anche stato un gran figlio di puttana: ma era di sicuro nemico giurato di quei fanatici. Quanto all’ISIS riceveva soldi da alcuni Paesi arabi, che a parole li combattevano; e i governi europei, compreso il nostro, con quei Paesi ci facevano affari. Che senso aveva? Un mese prima la Turchia aveva abbattuto un cacciabombardiere russo, che bombardava le basi del Califfato; e la NATO, che assieme alla Turchia sosteneva di essere in prima linea in quella guerra, aveva detto che sì, ci poteva anche stare…
No, alla faccia di giornali e televisione, il conto non tornava. Ma per gli altri pareva proprio che non fosse così. Quelle volte che le discussioni coi colleghi erano finite sull’argomento, quando aveva cercato di far notare queste contraddizioni, non aveva avuto la minima soddisfazione: le risposte erano andate dal chiudersi nelle spalle con rassegnazione, agli sfottò di qualcuno molto vicino alla Lega.
Nel frattempo lo zombie in nero si era fermato di fronte a uno dei primi negozi della via, uno che vendeva soprattutto hi-fi, e aveva appena svuotato un caricatore sulla vetrina; ricaricò l’arma e ne vuotò un altro. C’erano di sicuro delle persone dentro, ma non si capiva se stava mirando a loro, o se si divertiva a fare a pezzi tutti quegli oggetti superflui. Poi si era piazzato in mezzo alla strada e aveva cominciato a guardare in alto, sparando qualche colpo contro le finestre dei palazzi e continuando a urlare slogan.
Lui si ritirò un attimo e quando torno a spiare, quello aveva ripreso ad avanzare; udì i rumori di due auto che partivano a gran velocità. Lo zombie in nero si inginocchiò con calma e sparò una serie di colpi singoli contro di loro: uno stridore di lamiere gli fece capire, che una delle due auto era stata fermata, mentre il rumore più lontano dell’altra significava che ce l’aveva fatta. Quanti minuti erano passati? Tre, quattro? Il suo primo impulso era stato quello di afferrare il cellulare e chiamare le forze dell’ordine; ma poi aveva lasciato stare: chissà quanti l’avevano già fatto. E come mai non si sentivano sirene? Altra cosa che non quadrava.
Lo zombie in nero si era rialzato e stava sparando una raffica in aria, girato verso l’imboccatura della strada. Questo permise a lui di osservare un po’ meglio: c’erano due corpi all’inizio della via, seminascosti dalle auto e dagli angoli dei caseggiati; poi notò un anziano, rannicchiato come poteva dentro un androne quasi a metà della strada. Gli tornò alla mente che, alle medie, il professore di Storia aveva narrato di quando un vecchio era entrato in un teatro ateniese pieno zeppo di gente; e nell’indifferenza generale solo gli ambasciatori di Sparta si erano alzati, per cedergli uno dei loro posti riservati.
“Adesso si è arrivati che mandano dei disperati, strafatti di tutto, ad ammazzare della gente qualunque.” – Pensò. – “Ma la solidarietà è da un bel pezzo, che l’hanno ammazzata.”
L’anziano doveva essere molto fortunato; o lo zombie proprio strafatto, perché l’aveva superato, sempre rimanendo in mezzo alla strada. Più probabilmente le auto in sosta glielo avevano nascosto. Lo vide deviare improvvisamente verso il marciapiede di sinistra; lui sapeva che lì c’era un negozietto di alimentari, conosceva bene i gestori, naturalmente; si sentì una raffica, seguita da tre colpi singoli. Lo zombie in nero uscì gridando ancora e agitando il fucile.
“Non è la mia guerra, maledizione.”, pensò. Corse nella stanza vicina ed estrasse da uno stipetto la semiautomatica, che teneva sempre carica e che portava con sé nei suoi viaggi di lavoro. Calcolò che, quando fosse scomparso dalla sua visuale e tenuto conto che abitava al secondo piano, sarebbe stato a dodici, forse quindici metri sotto di lui; al poligono se la cavava bene, ma quello era tutto un altro affare: e lo zombie aveva di sicuro un giubbotto antiproiettile addosso, quindi provare a mirare alla testa, era un lusso che non poteva permettersi.
Quando non lo vide più, aprì di colpo la finestra, si sporse impugnando l’arma con entrambe le mani e gli esplose contro sei o sette colpi, mirando dalla cintola in giù. Un paio presero il bersaglio alle gambe e quello gridò e cadde, girando su se stesso. Lui si fiondò lontano dalla finestra, rotolando sul pavimento fino a rintanarsi nell’angolo alla sua destra.
Lo zombie in nero urlò un ultimo slogan, poi un’esplosione feroce mandò in frantumi i vetri di tutto l’isolato. Le sirene della polizia ancora non si sentivano.
Id: 3705 Data: 04/08/2017 19:09:21
*
Un gran bel colpo d’occhio
Ho sempre avuto un debole per i viadotti; in senso estetico, intendo, e soprattutto quando viaggio in autostrada. Non credo che i progettisti ci abbiano pensato a questo dettaglio, ma spesso e volentieri ti regalano dei paesaggi stupendi.
Più di tutti mi piacciono quelli che iniziano all’uscita di una galleria; già quando se ne sbuca fuori, su qualsiasi strada, ti si allarga il cuore, specie a chi – come me – soffre di una leggera forma di claustrofobia: beh, con un viadotto subito dopo è meglio, molto meglio, no? Purtroppo non ci si può fermare, ma se non devo proprio andare di fretta, quasi sempre rallento un po’, specie su quelli che valicano gli Appennini; e se qualcuno dietro prende a strombazzare, che si fotta…
Ho girato tutta l’Europa, ne ho visti migliaia; e in Italia quelli che mi son piaciuti di più sono i due che stanno sulla SS 647, quando si va verso Campobasso lungo il Biferno. C’è un rapporto odio-amore nei loro confronti, perché da un certo punto di vista sono un cazzotto negli occhi, un insulto alla tutela del paesaggio, come solo in un Paese del Terzo Mondo come l’Italia può succedere: però due viadotti che si snodano per chilometri, in parte piantati in mezzo a un lago (quello artificiale di Guardialfiera), non ti lasciano indifferente.
Molto affezionato sono anche a certi altri, magari corti ma che ti aprono uno squarcio particolare su certe vallate a mezza costa, come quelle che punteggiano la costiera ligure. Ci vedi all’inizio solo il bosco che ne ricopre i versanti, giù fino alle vallate sottostanti; e quando ne hai visti dieci, venti di scorci così, mentre si percorre l’autostrada che da La Spezia va a Ventimiglia, quella vista può lasciarti alla fine indifferente; però a un certo punto noti un gruppetto di case, una masseria abbarbicata su quei pendii, che davvero ti vien da pensare che solo a dorso d’asino si riesca ad arrivarci; ma non puoi fare a meno di notare come sia perfettamente inserita nel paesaggio: per dov’è messa e per com’è fatta, a cominciare dai materiali.
Allora, mentre rallento e rischio lo strabismo - perché con un occhio devo seguire la strada, mentre con l’altro tento di tenermi dentro quell’immagine per più tempo possibile - prima penso che mi piacerebbe abitare in quella casa, poi che in quel punto della Terra sembra che ce l’abbia voluta mettere la mano di Dio; e poi che gli ingegneri che hanno cementificato e asfaltato mezza Italia, devono essere dei coglioni: come ho appena scritto, non credo che abbiano pensato “adesso il viadotto lo piazzo proprio così, a quell’altezza, in modo che quelle case si vedano al meglio”, devono esserci riusciti solo per caso.
Adesso ci sto camminando, su uno di questi viadotti d’autostrada che da Roncobilaccio vanno verso Firenze; ho la mia pettorina catarifrangente addosso e ho lasciato l’auto come se fosse in panne appena prima del suo inizio, ma senza i blink accesi: non voglio che qualcuno pensi che ho bisogno di una mano. Vero che gli italiani sono un popolo di ebeti, tanto che non si fermerebbero nemmeno se ci stessi stuprando un bambino, su questo viadotto: ma non si sa mai, è stagione turistica e sulle autostrade di stranieri ce n’è a frotte...
Tornando a me, su Internet c’è il sapere del mondo: in neanche mezza giornata ho trovato tutto quel che si deve conoscere – a cominciare da lunghezza e diametro della corda, in rapporto al peso corporeo – per impiccarsi a regola d’arte; anche come fare e posizionare il nodo scorsoio, perché ti rompa l’osso del collo al primo strappo: che l’idea di crepare strozzandomi il respiro poco a poco, mi dà un po’ fastidio. E cammino e penso al gran colpo d’occhio che ne verrà a chi, dal fondovalle però, vedrà il mio corpo nero immobile, come un filo a piombo proprio al centro della campata. È quasi il tramonto, ci sarà anche il controluce giusto.
Id: 3697 Data: 27/07/2017 20:46:51
*
Neutro e impossibile
Adesso sono qui. Da un po’ di tempo sono qui, per la verità.
A proposito di tempo, qui ti fanno perdere il senso anche di quello.
Non è necessariamente un male: capisci così che in fondo il tempo è una faccenda personale; ho imparato a usare i battiti del mio cuore, il numero dei respiri, per contare il tempo.
Qui fanno perdere il senso a molte cose: ai ricordi, tanto per cominciare; o ai colori. Cioè, ci provano: che ci riescano o no, dipende da te.
Oggi ho riso tanto; ho riso tanto e loro non capivano.
Tutto bianco: bianco attorno, vestito di bianco su un letto bianco. E gli uomini che vanno e vengono – a numero di battiti del cuore o di respiri precisi – anche loro sempre vestiti di bianco.
Questa notte urlavo in silenzio, urlavo dentro tutta la mia rabbia per il tempo marcito qui, strappato alle mie cose care, alle cose alle quali tenevo e inchiodato a questo luogo neutro, urlavo a Dio, urlavo all’Universo tutto. Urlavo dentro di me quelle storie che ti raccontano da bambino sull’angelo custode che ti starebbe sempre accanto per proteggerti; e su quei santi che affrontavano pericoli orrendi e venivano regolarmente salvati da un angelo, appunto, dall’intervento di Dio.
Oggi ho riso tanto.
Vaglielo a spiegare, a quegli schifosi tutti vestiti di bianco, come sia possibile che a un uomo da quattro giorni con la camicia di forza addosso, compaia lungo tutto il corpo una striscia color verde speranza…
Id: 3679 Data: 08/07/2017 10:53:41
*
Dea cacciatrice
Li ho tenuti tutti.
Lo so, ci sono punti di vista differenti sulla faccenda del proprio passato, se sia possibile o inutile tentare di dimenticarlo, con tutto quel che ne consegue in fatto di teorie, corollari, percorsi da seguire.
Io lo sai, il passato l’ho sempre guardato in faccia; ho sempre guardato in faccia anche il presente, per la verità; il futuro no: come fai a guardare in faccia qualcosa che deve ancora essere? È stato così anche stavolta; e per il resto adesso tocca a te pensarci.
Ci sono cose che non ti ho detto; e non so se ho fatto male o bene, però adesso è il momento di parlarne. Volevo farlo più tardi, ma va bene lo stesso.
C’è un libro che mi è sempre piaciuto molto, ed è il Mahabharata; per la verità la cosa che mi piace di più, che penso sia più utile, ne è l’inizio. Quando il Principe Arjuna chiede a Krishna perché deve prender parte a questa guerra di famiglie imparentate fra loro – compresa la sua – e lui non sa, non vuole schierarsi, proprio perché è uno dei guerrieri più forti e con più forti legami di sangue. E il dio gli risponde: “Arjuna tu che cosa sei?” e lui risponde “un guerriero” “E qual è il dovere di un guerriero?” lui risponde “combattere”, “Ecco allora tu combatti, non te ne deve importare niente se vinci o se perdi, se sei dalla parte giusta o se sei dalla parte sbagliata, meno che mai ti deve importare di quali saranno le conseguenze ultime delle tue azioni: perché a te non compete governare il mondo, a te compete soltanto, come ogni altra creatura, di fare al meglio delle tue capacità quello che ti è toccato in sorte di fare. Gli dei guideranno il mondo”.
C’è molto da discutere su queste frasi, per la verità non è che sia d’accordo su tutto: per cominciare, bisognerebbe capire cosa abbiano in mente questi dei per noi… Discuterne un po’… Però questa frase m’ha accompagnato nei momenti più importanti della mia vita, quasi sempre me la son trovata davanti, quando c’erano in ballo le scelte più difficili.
Avere avuto una vita tutto sommato facile come la mia, come la nostra, non significa che ad un certo punto uno non debba fare delle scelte, che la mettono in discussione perlomeno in qualcuno dei suoi aspetti fondamentali.
Sai che ho cominciato a sparare praticamente da bambina; a scuola stavo sempre con le altre, giocavo sempre con loro, con le bambole e tutto il resto, come qualsiasi bambina. Ma tutte le volte che si andava alle giostre, smaniavo solo per il tiro a segno; non c’erano santi, dovevo sparare; e se non sparavo, sapevo che sarei rimasta a guardare i palloncini che scoppiavano, i barattoli che venivano buttati giù dai piombini anche per delle mezz’ore.
E sai che andava a finire che mamma e papà mi accontentavano: poi a quell’età riuscivo a usare solo la pistola ad aria compressa, con tutte e due le manine che la tenevano come potevano. I risultati però c’erano, almeno contro i palloncini. Lo sai, ho ancora due peluche che vinsi allora e sai anche quanto mi sono sempre stati cari.
Poi in vacanza, quando con la compagnia si andava alle sale giochi, nessuno mi batteva a quei vecchi tiri a segno meccanici, che adesso fanno tanta tenerezza, al confronto con le play-station… Davvero, me li son sempre messi dietro tutti quanti, tutti i ragazzi della spiaggia, così che mi avevano soprannominata subito Calamity Jane.
E sai anche quanto mio padre mi spalleggiava; l’amore per le armi, la perizia nel tiro me l’ha messa senz’altro lui nel sangue, lui che si è sempre fatto un vanto dell’esser stato tiratore scelto in Nord-Africa; e che non gli pareva vero di avere una figlia da far crescere nella sua passione, lui che – come da manuale – avrebbe voluto come primo figlio un maschio.
Niente di strano che se la ridesse della grossa, quando portavo via le pistole giocattolo al mio fratellino, scatenando le sue inevitabili crisi di pianto, vero? Nulla di strano che mia madre lo rimbrottasse, rinfacciandogli – per fortuna senza una gran convinzione – in che diavolo di modo intendeva farmi crescere.
Dal tiro a segno dei baracconi a quello vero il passo fu breve; mi appassionai presto alla severità dell’aria compressa, e altrettanto presto me ne staccai: ero affascinata dalla reazione dell’arma da fuoco, dal rinculo che si deve saper gestire con tutto il corpo e che con un’arma pneumatica naturalmente non c’è; l’odore della polvere da sparo, anche, contrapposto all’asetticità dei padiglioni di tiro. Abbandonai senza troppi rimpianti quella disciplina, nella quale ero una promessa, come dimostrano i trofei che ben conosci.
Posso dire d’averle provate tutte: dall’automatica calibro 22, alla carabina di precisione, dalla 44 Magnum a tamburo che ti spacca il polso ogni volta che tiri il grilletto, al sovrapposto per il tiro al piattello. E anche lì con qualche bella soddisfazione.
Poi ci fu la mia prima battuta di caccia; continuo a ricordarla per le punzecchiature che ricevetti per tutta la mattinata dai miei compagni, visto che ero l’unica donna; e di cui quella che mi fece ridere di più fu “Chi ha legato quella ragazza al fucile?”, per via della mia statura. La disse un attempato signore, peraltro sempre cortese e attento verso di me e gli altri due giovani che, come me, erano alla loro prima esperienza. E alla quale ribattei tre ore dopo, abbattendo d’istinto un lepre col mio primo tiro.
Sarebbe stato una figura importante nella mia vita ma, a ben vedere, ci furono altre circostanze, altri segni che avrei in seguito dovuto considerare altrettanto importanti. Per esempio, il fatto che quasi sempre riuscissi a centrare la preda al primo colpo, mi spinse ad interessarmi, col tempo, alle armi a colpo singolo, a palla; fino a diventare l’unica donna, credo, ad andare a caccia con un fucile ad avancarica.
E a proposito di segni, con l’andar del tempo mi accorsi che i migliori risultati nella caccia li ottenevo – com’era stato quel giorno - in luna crescente, mentre i migliori risultati nel tiro in luna calante. Oppure come certi nomi – Francesco, prima di tutto – si accompagnassero alle occasioni importanti della mia vita: Francesco si chiamava il cacciatore di cui ti ho scritto appena sopra, un Francesco è tutt’ora il mio migliore amico; e un Francesco sai chi è stato…
All’epoca stavo con Guido, il mio primo “fidanzato serio”; devo ammettere che di uomini non ne capivo molto: non solo perché avevo diciassette anni, quando cominciò la nostra storia, ma perché il tiro prima e la caccia poi, assorbivano tutte le mie energie; per non parlare della scuola e di qualche amicizia femminile che ero comunque riuscita a mantenere, malgrado i miei hobby.
Per la verità col senno del poi, credo che, inconsciamente, attraverso quelle due discipline stessi costruendo il mio carattere, la mia persona, più che con qualsiasi altro interesse o frequentazione.
La disciplina interiore e fisica necessaria a conquistare la sicurezza nella posizione di tiro e in tutte quelle operazioni che devono essere svolte meccanicamente, durante una gara, senza perdere concentrazione. L’allenamento fisico che occorre per una battuta di caccia, se la fai seriamente; la concentrazione che bisogna mettere nel seguire e riconoscere le tracce, nel capire quando è il momento di sparare; questione di disciplina anche lì.
Tutto questo assorbiva il meglio delle mie energie, anche mentali, e non lasciava molto spazio a pensare ad altre cose. Conoscevo molto meglio la mentalità di un fagiano, quando a ventidue anni la scoperta di un suo tradimento – ultimo di una lunga serie, peraltro – a cinque mesi dal nostro matrimonio, mi colse del tutto impreparata. Vedi le coincidenze significative? Mi ritrovai come un animale abbattuto da un colpo inaspettato, perché tirato d’istinto…
Fu un periodo bruttissimo; mesi a macerarmi per prendermi tutte le colpe, quando l’unica colpa – come succede sempre in questi casi – è solo quello di aver concesso fiducia ad una persona che non la meritava, ignorando tanto certi indizi quanto i suggerimenti di chi mi stava davvero vicino. Di quel Francesco, per esempio. Pare quasi che dia più fastidio l’ammettere una colpa in fondo lieve come l’essersi fidati, che il male che ci si fa, accollandosi invece colpe gravi e inesistenti.
Col senno del poi è facile dire “avrei dovuto fare così”; consoliamoci dicendoci che, sempre col senno di poi, meglio che il castello di carte sia crollato allora che dopo. Superai la cosa immergendomi nel fare le cose che amavo di più, il lavoro nello studio notarile e la caccia. E facendo a me stessa il giuramento più stupido che si possa fare in queste circostanze: che mai e poi mai mi sarei più innamorata.
Passarono tre anni, tre anni e mezzo; il tempo preciso non lo ricordo e per la verità non ha molta importanza. Ricordo però la data: il 22 Aprile.
Gran bella giornata, piacevolmente calda; partiti due giorni prima del week-end per una partita di caccia in Friuli sui monti ai confini con l’Austria. Arrivati sul posto, il classico chalet di montagna, ci ritroviamo in dodici a scherzare e a passare il tempo in qualche passeggiata nei dintorni. C’erano stati piovaschi, nei tre o quattro giorni prima della battuta, ma pareva che tutto sarebbe andato per il meglio.
Invece feci una cosa un po’ stupida, allontanandomi dal gruppo durante la pausa del pranzo; non era la prima volta e di per sé non è che sia una cosa stupida, quando ci si mette d’accordo di ritrovarsi un’ora dopo o giù di lì. Purtroppo non si mette mai in conto il destino, sotto forma di un passo falso, tornando al punto d’incontro di fretta, perché si era lasciato passare troppo tempo a guardare i paesaggi, a studiare qualche orma.
Un passo falso che ti butta giù per un pendio e verso un canalone fitto d’alberi; che per fortuna ti frenano la caduta, ma ti rompono una gamba e una spalla; la qual cosa ti fa rimanere svenuta per diverse ore, finché si scatena un temporale: e fra i tuoni, la pioggia che ti bagna e il dolore torni in te, accorgendoti che sono quasi le cinque del pomeriggio; e naturalmente quasi trent’anni fa non era come adesso che ci sono i cellulari.
Quante volte ti ho raccontato questa storia? Così sai già come andò a finire: che sentii passare un paio di volte l’elicottero del soccorso, dal quale però non mi si poteva vedere; e che a un certo punto sentii una voce che chiedeva se c’era qualcuno: muovendomi più o meno inconsciamente, avevo dato un lamento e avevo fatto cadere un sasso.
Ironia della sorte aveva fatto sì che fossi rotolata per quel pendio fino ad una decina di metri dal sentiero che gli correva sotto; e che i miei compagni ci fossero passati e ripassati, di lì, ma mentre ero incosciente. E, naturalmente, che l’uomo che stava terminando la sua passeggiata serale, si chiamasse Francesco. Rimasi quasi tre settimane in ospedale, un po’ in Friuli e poi nella città dove abitiamo; lui venne una volta in ospedale, tre giorni dopo che ero stata ricoverata, per sapere come stavo. Tutte cose che sai.
La cosa che non sai, è quello che ci dicemmo tre mesi dopo che ci eravamo messi assieme – non so cosa mi spinse, già al momento di quella sua visita, a chiedergli l’indirizzo per scrivergli: io ho sempre sostenuto con tutti che era perché si chiamava Francesco, ma in cuor mio so che non è così; e che non fu nemmeno, perché già me ne stavo innamorando - ma non ho mai ritenuto di doverti dire: troppo diversi siamo, tu e io, perché abbia ritenuto utile farlo. Ma ora, visto il momento…
Tu sai che Francesco non cacciava, ma conosceva quei monti e le abitudini dei suoi abitatori – animali e piante; lui per la verità non faceva distinzione – meglio di chiunque altro. Io pensavo che non gli sarei piaciuta per questo, o almeno che sarebbero nate discussioni interminabili, nelle quali avrebbe cercato di farmi cambiare idea. Lo pensavo perché aveva certe convinzioni così radicate, che lo immaginavo impaziente di convertire gli altri.
Nulla di tutto questo: mi spiegò a fondo le sue ragioni, in un paio di occasioni nelle quali fui io, per la verità, ad affrontare l’argomento, ma alla fine mi disse: “Ma tu, cosa ti senti di essere? Ti senti questo impulso a cacciare così dentro di te, da considerarlo il fondamento della tua personalità?” E io gli risposi: “Sì, non è il mio mestiere; ma sì, per essere quello che sono, è davvero importante.”
E allora lui mi fa: “Ecco allora tu continua a cacciare: non te ne deve importare niente di quello che pensano gli altri – ascolta le loro ragioni come hai fatto con me; e se te lo chiedono, spiega le tue – ma non preoccuparti nemmeno delle conseguenze: perché è nell’ordine della Natura uccidere ed essere uccisi. La cosa fondamentale è che tu lo faccia per uno scopo – mangiare, usare una pelliccia – senza fingere che questo sia uno sport. Per il resto pensa solo a fare meglio che puoi quello che sai fare: che è poi quello che qualsiasi essere vivente dovrebbe sforzarsi di fare”.
È stato questo o, se preferisci, anche questo, a farmi capire che era la persona per me. Tutto il resto è venuto di conseguenza: il matrimonio, la nascita di Lorenza… E lui che se n’è andato troppo presto, dopo appena cinque anni che stavamo assieme. Ma quell’insegnamento è rimasto, come io sono rimasta quella di quand’ero piccola, che ti rubavo le pistole giocattolo.
Caro fratellino, tu sai come sto; sai quanto sia stata dura in questi due anni e mezzo, come io abbia lottato in tutti i modi: è una malattia che quasi mai perdona e anche se ci siamo attaccati tutti quanti a quel “quasi”, non è andata come si sarebbe voluto. E allora io mi ricordo di quello che ho imparato, che ho sempre saputo, cioè quella che sono: e allora, qual è la cosa che so fare meglio? Cacciare.
Così adesso vado a caccia: ho preso una delle vecchie pistole, di quelle che usavo per il tiro a segno, non certo l’arma che preferisco: non sarebbe giusto usarla per questo, tanto so che da quella distanza non sbaglierò il colpo. Vado a caccia del mio male: lo guarderò negli occhi e lo finirò. Finirò anche me? Non credo, lo sai come la penso; anche questo me lo insegnò Francesco: qualunque cosa accada, noi si continua.
Scommettiamo, fratellino?
Id: 3640 Data: 27/05/2017 12:26:47
*
Storia di fra un po’ di tempo
Io sono convinto che ci si abitua a tutto, col tempo non ci si fa più caso e tutto sembra normale: come se ci fosse sempre stato.
Così io lo so, o meglio lo sento, questo paesino già povero di gente non era tanto deserto, tempo fa (qualche settimana? qualche mese? qualche anno?); eppure nessuno sembra farci caso ed anch’io ho l’impressione di abituarmi all’idea.
E apparentemente non c’è niente di mutato, nel paesaggio attorno: solo le case che - anche se sono in buono stato come prima - ora ti accorgi da un non so che, che pare non ci viva nessuno. E le poche persone che incontri per strada, fanno fatica anche a salutarti. Pare che continuino a vivere, ma solo per se stesse.
Poi – almeno a me – capita di vedere cose strane.
Due mattine fa tiro su la persiana di camera mia e vedo, sui campi qua dietro, una specie di piccolo dirigibile, che evoluisce in modo strano. Era fatto come un dirigibile, appunto, ma sarà stato lungo non più di una ventina di metri; e l’involucro era mezzo di plastica bianca e lucida, l’altra metà tutto sfinestrato e trasparente, come il cellophane di certi pacchetti di alimentari.
Dalle manovre che faceva si capiva che era in difficoltà: perché andava di qua e di là, ma con dei cambi di direzione che nessuno se li sognerebbe, in un veicolo del genere; e poi non riusciva ad alzarsi di più che qualche decina di metri dal suolo. Alla fine, quando ormai era vicinissimo a terra ed era chiaro che non poteva più farcela, è andato giù pian piano, negli ultimi metri, ondeggiando come una foglia secca; e, all’ultimo momento, tutte le parti si sono ripiegate su se stesse, fino a far venir fuori una struttura simile a quel marchingegno, il LEM, che nel 1969 scese sulla Luna.
Una volta che si era piantato così goffamente al suolo – e finalmente facendo un po’ di rumore – si apre un portello in alto e se ne esce un tizio, in tuta lucida, una via di mezzo fra quella di un pilota e quella di un motociclista, anch’essa bianchissima; si toglie il casco e appare una faccia giovanile e sorridente. Lui mi guarda e mi fa, scendendo la scaletta: “Beh certo, è un po’ da perfezionare… Non è così facile tenerlo su, ancora.”
E io: “Ma come fa a farlo muovere così?”
Quello mi fa cenno di seguirlo, sempre con quel sorriso aperto e rassicurante: “Se vuole saperlo, mi venga pure dietro: il laboratorio è proprio là in fondo.”
Lo accompagno e arriviamo dopo qualche centinaio di metri a un parallelepipedo basso e bianchissimo costruito quasi sotto l’argine del fiume che passa per di qua: un laboratorio non grande ma pieno di sale pulitissime e vuote di gente, solo computer e tantissima luce. Dentro ci si muoveva uno scienziato (lo si capiva dal camice), un uomo anziano basso di statura e con tanti capelli bianchi, un sorriso aperto e rassicurante.
Cortesissimo, mi ha spiegato diverse cose; ma che io sia dannato se adesso me le rammento.
E poi, chi se lo ricordava che lì c’era un laboratorio per esperimenti di aeronautica? A me sembrava che fino al giorno (alla settimana? al mese?) prima, ci fosse una vecchia porcilaia.
Ma farò l’abitudine anche a questo. Come al paese ormai deserto, la maggior parte andata via. O forse morta? Non so perché, ma ho l’impressione che in molti siano morti… Questo paese con le botteghe vuote, ancora con i generi in vendita esposti alle vetrine e non un granello di polvere. Le poche persone che t’incontrano per strada e ti passano via senza dirti niente, anche se ti guardano, se ci guardiamo.
Curvi e affaticati, perlopiù. Forse anch’io appaio curvo e affaticato. Ma non abbiamo nulla da dirci.
Tornando indietro da quel laboratorio, son passato davanti ad una delle poche case ancora abitate. Ci vive una vecchia, è una delle poche persone che ancora parla un po’, almeno con me. È una di quelle vecchiette sempre attive, non molto alta, vestita quasi sempre di bianco - o se no, di chiaro - tanti capelli bianchi, un sorriso aperto e rassicurante; quando la incontro mi viene in mente la nonna dei cartoni animati che in casa ha Titti.
Salgo da lei e parliamo un po’, mi mostra le sue piante, che cura con grandissima attenzione; confesso che ce ne sono di strane, che non mi ricordo di aver mai visto; del resto gliene avevo appunto portate un paio, che avevo raccolto tornandomene da quel laboratorio; e non chiedetemi perché erano strane: in fondo erano solo piccoline, con qualche fogliolina verde, impolverate; malridotte come se avessero avuto poca acqua. Ma, onestamente, io le sentivo strane, come se nemmeno quelle le avessi mai viste prima.
La signora mi ha offerto un the, mentre si parlava, mi ha ringraziato molto per quelle due piantine, che adesso – mi diceva – stanno crescendo una meraviglia; poi mi ha congedato, sempre con quell’amabile sorriso aperto.
Sono tornato a casa – che poi è poco più in là, dall’altra parte della strada – in questa giornata di sole, nessuna persona in giro; nessun’auto, nessuna bicicletta.
Nessun rumore nemmeno dal viadotto dell’autostrada a un paio di chilometri da qui; e sì che giurerei che una volta il traffico si sentisse di continuo, specie quando il vento soffiava da quella direzione.
Da quanto tempo (un giorno? una settimana? un mese? anni? da sempre?) sarà così, ormai? Non importa; ci farò l’abitudine.
Id: 3603 Data: 28/04/2017 13:08:32
*
Bruno
Bruno: sinonimo di “antipatico”.
Cioè, Bruno (il tizio che da un paio d’anni è venuto ad abitare nell’appartamento di sotto al mio) mi sta proprio antipatico; e non solo a me, ma a tutto il condominio.
Non è né bello né brutto, ha un fisico che se solo andasse un po’ in palestra (come faccio io anche quattro volte alla settimana) non sarebbe male, ma lui mi ha sempre detto che non gliene importa granché, e io mi chiedo come farà a rimorchiare.
Anzi, cosa vuoi che rimorchi… Oltretutto sta antipatico anche a tutte le altre inquiline, compresa mia madre: pensate che alla Giulia (che ha poco più di sedici anni, ma si è fatta venire un fisico da urlo per farsi prendere come velina), quando lei gli ha chiesto “Mi faresti sentire un po’ dei tuoi CD? Dopotutto sono una bella donna, o no?”, Bruno le ha risposto: “Che mi hai preso per un pedofilo? C’hai bisogno di un’altra decina d’anni, per essere una donna…” Figurarsi come c’è rimasta: non che lei volesse filarselo, ma stava provando se con quel fisico riusciva a far arrapare qualcuno di trenta, quarant’anni, cioè quelli che possono farle fare la velina.
Poi quello che da fastidio, che lo rende insopportabile, è che non ti da mai soddisfazione: sa parlare di calcio come pochi (l’ho sentito io, in portineria, neanche dieci giorni fa), ma non tifa; non ha neanche la televisione, ma sa un sacco di cose, di quello che succede in Italia e fuori e spara giudizi che sono tutti veri, ma che ti fanno sentire un mezzo deficiente: perché a quelli come noi, di tutte queste cose non ce ne frega niente. E, visto che non ha la TV, cosa fa invece di guardare Costanzo o “Uomini e donne” o “L’isola dei famosi ”? Ascolta musica, chiaro! E legge un casino di libri, chiaro!
E alla fine, quello che mi fa - e ci fa - incazzare veramente, è che si permette pure il lusso di preoccuparsi degli altri, come se di questi tempi non ci fosse niente di meglio da fare!
Allora, questo è successo un paio di mesi fa, me l’ha raccontato l’Alfonso, quello del quarto piano, che di balle giuro che non ne ha mai detta una, a parte quelle alla moglie, e questa l’ha vista e sentita lui. Era in centro, in uno di quei posti che non trovi un parcheggio neanche a svenarsi: lui (Alfonso) sta camminando e vede Bruno che arriva in macchina e si ferma in uno spazio libero fra due altre auto. Scende, fa per mettere il disco orario, ma guarda per terra e vede quei segni gialli che dicono che lì non si può, ci vanno gli handicappati, e come abbia fatto lui a vederli, che son tutti mezzo cancellati, solo dio lo sa. Incrocia lo sguardo di Alfonso (che ormai gli era arrivato a mezzo metro), si salutano e poi Bruno fa: “Ma guarda se è modo di tenere i parcheggi: uno neanche se ne accorge, che qui non può fermarsi…” Risale in macchina e riparte!
Dico, riparte!! Con la fatica che si fa a trovare un posto in centro che non sia a pagamento! E chi se ne frega se ci sono gli handicappati che vogliono girare in macchina! Se sono handicappati, cosa ci vogliono fare con la macchina?
Insomma, non ne possiamo più di uno come lui, che si vede proprio che lo fa per darsi un tono e mortificarci ogni giorno. E così abbiamo deciso che dobbiamo togliercelo dai piedi.
Io mi sono offerto volontario, sono uno dei più giovani in questo casermone e, con tutta la palestra che ho fatto, sono sicuramente più forte di lui; sarà una cosa semplice: scendo, suono e invento una scusa (non che voglio in prestito un libro, figurati se quello ci casca), ma quando apre lo spingo dentro e gli spacco la testa a bastonate, poi faccio un po’ di casino e siamo già d’accordo fra tutti noi inquilini che son stati gli albanesi o gli zingari, ce ne sono due o tre qua intorno che chiedono la carità ai semafori.
Da quando mi sono proposto, poi, la Giulia mi guarda con certi occhi, che son sicuro che non aspetta altro che lo faccia, per darmela.
A dirla tutta, non sono tanto sicuro. Cioè, sono più giovane e più forte, vabbe’, ma chi si fida di uno come quello? Cioè, ti dà l’idea di essere uno che ha sempre pronta la risposta per tutto, anche a botte; magari mi tocca scoprire proprio oggi, che è pure cintura nera di kung-fu. Magari è uno che c’ha un coltello nascosto nella manica della giacca, come ho visto in un film…
Insomma, non sono tanto sicuro, ma adesso vado giù e ci provo.
Id: 3500 Data: 11/03/2017 12:13:48
*
Marianna al bivio
La città era un brivido di gelo; nient’altro.
Non sapeva come fosse finita lì, in quella stazione nella quale aveva passato la nottata, scossa dal rotolare cadenzato dei treni alle sue spalle; ma in quella circostanza contava poco. Tanto, non si sarebbe potuta permettere un albergo; tanto, non era venuta per restare. Uscì ad affrontare le strade di periferia e la neve sovrana che le ricopriva di calma uniforme.
Della notte ricordava poco e oltretutto di ricordare le importava meno; nessun sogno particolare, il rumore dei treni che ogni tanto la faceva riemergere, quasi naufraga, alla superficie del sonno; aveva avuto la certezza che qualcuno (più d’uno: extracomunitari? tossici? barboni?) ogni tanto le si fosse avvicinato. Aveva confidato nel mazzo di chiavi stretto fra le nocche della destra, le loro punte sporgenti in fuori come un tirapugni: non era accaduto nulla.
Ad ogni modo i pensieri non l’avevano abbandonata, nemmeno in quel sonno agitato. Scappare di casa a sedici anni per andare ad una festa in una città straniera? Strafarsi di alcool e chissà che altro con un paio di amiche? No, non l’avrebbe fatto, se non fosse stata certa che ci sarebbe stato “lui”: lui che sapeva di angelo caduto nel modo di vestirsi, di muoversi e di guardare; che aveva incontrato per caso e che l’aveva lasciata con una promessa; lui che le ricordava i suoi sogni ad occhi aperti, in faccia alla copertina di qualche CD.
Lui che, durante quella festa, l’aveva solo salutata e stretta in un abbraccio di circostanza, per dedicarsi subito ad un’altra.
E adesso, perché aveva quei due segni sul viso, quei due lividi di cui nulla ricordava? Era così normale avanzare in mezzo alla neve di quelle strade viste prima solo di sfuggita, con indosso un giubbotto che non ricordava suo, e sotto il leggero vestito della sera di festa, pizzi e plastica nera? Si tastò quei due segni e, mentre continuava a camminare verso nessun dove, ebbe come un capogiro, una vertigine, un ritorcersi in negativo del paesaggio attorno con il nero per il bianco e viceversa.
E allora abbassò gli occhi e la vide, emergente dal nigrore che segnava la strada, come un relitto mezz’impaltato nel fango del fondo di una palude: carne aperta da coltello, i due lividi sul viso ben noto da cui nasceva una domanda.
“E’ questo il mio destino?”
“Forse.” – Le mormorò la voce dentro.
“Forse non è una risposta: è né sì né no, né carne né pesce.”
“È vero; però è in questo modo che stanno le tue cose. Tutti voi scegliete senza accorgervene: siete ogni momento di fronte a dei bivi, le direzioni sono preordinate, ma la scelta è libera; e c’è sempre una scelta. Questo è uno di quei momenti, così rari ormai per voi umani dopo epoche andate nelle quali non era così, quando è possibile rendersi conto delle conseguenze di tali scelte.”
“E chi dovrei ringraziare per questo?”
“Non ti è concesso, per ora, di sapere.”
Provò con qualche altra domanda, ma la voce le si era taciuta. Ai suoi piedi solo la carcassa di un grosso ratto, il ventre squarciato e svuotato dagli artigli di un qualche predatore; attorno i colori erano tornati naturali, dominante di bianco nei rumori attutiti delle rare automobili, nelle sue ossa che tremavano a ritmo col gelo mattutino. La stazione da una parte, la città dall’altra.
Marianna si guardò intorno e scelse la direzione.
Id: 3493 Data: 28/02/2017 15:59:44
*
Nel bagno
Ho acquistato alcuni anni fa una casetta in piena campagna - quattro stanze più un piccolo bagno e garage - e senza nessuno nelle vicinanze; carinissima, appena sufficiente per le necessità di quel single che sono.
Perciò voi adesso state già pensando a chissà quali orribili storie di solitudine invernale, con la nebbia ed il buio, e i gufi che lanciano i loro lamenti nel più puro e banale stile dark; oppure, visto il titolo, che dal sifone del water strisci fuori qualcosa di immondo, come in “Quello che uscì dalle fogne di Chicago”, chi si ricorda di certi vecchi classici di “Urania”? No, niente di tutto questo.
E’ solo che in bagno ciascuno di noi ci passa certi “tempi morti” (scusate lo humor nero involontario), e già che è lì unisce l’utile al dilettevole; non serve che vi faccia l’elenco dei passatempi inventati dalla mente umana e dai gusti dei singoli, per far scorrere quei minuti: per quel che mi riguarda e ammesso che la cosa possa interessarvi, io mi limito ad osservare. Cioè, semplicemente sto lì seduto e mi guardo attorno, guardo fuori da uno spiraglio della finestra e vedo una striscia del campo a fianco, che cambia colore con le stagioni; o, più spesso, guardo i particolari della stanza: lo stato dei muri, se è ora di dare una pulita al lavandino o alla doccia, e così via.
Beh, lo so che l’avrete sentito dire già un’ira di dio di volte, ma le cose più nascoste sono quelle messe meglio in vista.
Il pavimento del mio bagno è di piastrelle, come penso sia la maggior parte dei bagni che si rispettino; non sono quadrate, ma rettangolari - come dei mattoncini, quanto a dimensioni - e sono nere con dei guizzi di smalto rosso che a me han fatto pensare subito a delle fiamme.
Però non ci ho mai trovato niente di inquietante in questo, finché qualcos’altro non ha attirato la mia attenzione: in mezzo a quelle “fiamme”, in una piastrella c’era una faccia. Ho guardato e riguardato, ma davvero era la faccia smagrita di un uomo, disperata e perciò contorta nei lineamenti; poi - guarda e riguarda - eccone un’altra, tre piastrelle più a destra: poco più di un cranio, coi suoi bei buchi per le orbite e la bocca. E un’altra ancora, questa di profilo, su una delle piastrelle della fila di fondo alla parete: forse una donna dall’ampia capigliatura riccioluta e con la bocca dilatata in un urlo. Alla fine ne ho contate diciannove.
A poco a poco, l’angoscia m’è cresciuta dentro; ed ora, davvero, non so cosa fare. Non faccio altro, ormai, che pensare e ripensare a come possano essere finite lì in quei pochi centimetri quadrati di ceramica; e a come tirarle fuori.
Per la prima cosa ho le idee ormai abbastanza chiare: il fuoco e l’anima, che è spirito, ovvero un qualcosa di sottile ma molto vicino al fuoco. Mi immagino il gran caldo del forno di cottura della fabbrica, il fuoco che si riflette sulla massa non del tutto solidificata delle piastrelle, anime che vagano – sono dappertutto, mica solo all’inferno o in paradiso – e che da quel fuoco, da quel calore sono attirate, come da un vortice che acchiappa e giù risucchia, ciò che di leggero v’è alla superficie dell’acqua. Anime che, attirate e trascinate da quel vortice, incapaci per un attimo di reagire, si sono trovate imprigionate in quella vischiosità; e che poi, fissate in un muto grido di dolore, altro non possono fare che fissarci nell’attesa di un aiuto.
Ma davvero, non so cosa fare, né per loro né per levarmi dall’angoscia che la loro vista mi dà, che mi sta facendo diventare insopportabili quei cinque minuti che ogni tanto al giorno mi capita di passar là dentro.
La cosa più ovvia e immediata che ho pensato sarebbe romperle: ma basterebbe, o non farebbe altro che aggiungere dolore a dolore? Oltretutto le piastrelle sono cementate al solaio, dovrei comunque svellerle ammesso che, così spezzata nell’immagine, l’anima riesca a liberarsi. Anche raschiare la superficie fino a cancellarle, non so se servirebbe: sarebbe più o meno la stessa cosa, l’anima riuscirebbe a ricomporsi, dopo? Senza contare, anche qui, il dolore, ancora peggiore che un colpo secco, provate voi a passarvi della carta vetrata sulla faccia, non so se rendo l’idea.
Non so. Fuoco contro fuoco. Riportare le piastrelle ad una temperatura che le fluidifichi di nuovo. Dovrei dare fuoco alla casa?
Id: 3486 Data: 19/02/2017 19:30:00
*
La metamorfosi
Lo sapevo che sarebbe finita così; me la sentivo. E fesso io che ho sempre dato retta agli amici, che dicevano in coro di non preoccuparmi, che il tempo aggiusta tutto e son crisi passeggere… E qualcuno ci faceva pure dell’umorismo, già che c’era.
Un fidanzamento da favola, una luna di miele da favola; poi, dopo qualche mese di matrimonio, le prime crepe. Mia moglie che comincia ad accampare scuse, che comincia a farsi musona; che ti fa osservazione per uno spillo fuori posto, e sembra che le cerchi apposta le occasioni per sminuirti. Che poi si sa, in quanti ci saremo passati, in mezzo ad un andazzo del genere?
E io, con pazienza, a sopportare, a cercare il dialogo.
A volermi assumere ad ogni costo le colpe, pur di far andare avanti il rapporto; pronto persino ad andare dallo psicologo, che quasi subito finì col dirmi: “Guardi, lei è assolutamente normale, e anche queste crisi, appena dopo il matrimonio, lo sono.”
Fesso. Anzi fessi tutti e due: lui a sparare di queste cazzate e io ad andarci.
Con l’andare del tempo le cose non miglioravano per niente, anzi a livello di rapporti fisici si erano fatte per me quantomeno imbarazzanti: il massimo della soddisfazione lei lo ricavava facendomi mettere in ginocchio; e mentre mi masturbavo, lei - standomi dietro con addosso solo una specie di camice da infermiere - mi colpiva con forza in testa con una ciabatta, gridando “Dalli alla blatta! Dalli alla blatta!”.
“Un semplice, banale caso di invidia del pene. Una cosa da niente, che si risolverà da sola col tempo.”, sentenziò come al solito lo psicologo deficiente.
E poi altri segni premonitori, altre frasi: “Quando non riesci a capire, perché non usi le antenne?”; oppure: “Smettila di toccarmi, con tutte quelle zampacce!”.
Avrei dovuto capirlo; e fare qualcosa. Invece niente, solo pazientare e sperare: del resto, quando c’è l’amore di mezzo…
Così ora sono qui, mi ha rinchiuso di soppiatto mentre mi lavavo i denti, e da quasi tre giorni mi trovo nel bagno del nostro appartamento al dodicesimo piano di un condominio pieno di vicini di merda, perché tanto è inutile gridare: perché nessuno sa nulla di nessuno, nessuno sente nulla, e se sente fa finta di nulla.
Sono tre giorni che ormai tiro avanti solo con sorsate d’acqua dal rubinetto, ma credo che lei abbia proprio deciso di finirla; è uscita venti minuti fa e di sguincio dalla finestrella posso vederla: è lei quella che sta ritornando qui dal centro commerciale di fronte. È quella che spinge decisa un carrello colmo solo di bombolette di insetticida.
Adesso ho capito cosa vuole fare.
Che Dio mi aiuti.
Id: 3232 Data: 26/05/2016 12:10:42
*
25 - Un dubbio inquietante
25. UN DUBBIO INQUIETANTE
“Le sirene continuavano a sentirsi, ogni tanto,senza che potessero suggerire una direzione precisa.”
(Periferia e centro città, 04-05/11/1979)
“La cosa migliore è trovare un posto in periferia, dove ciascuno si fa i fatti propri. E più gente c’è, meglio è. Anche a questo ci pensiamo noi.” Così gli aveva detto Marco.
E adesso Walter era lì, nell’appartamento al terzo piano di un condominio appena fuori città, affittato da un prestanome del fratello di Buio, con accanto una varia umanità di piccolissima borghesia e proletariato che avrebbe fatto la felicità di qualsiasi agit-prop della sinistra extraparlamentare. Dove, per inciso, ciascuno si faceva i fatti propri.
Dal telefono a gettoni fuori dal Vikin-go! Dario gli aveva biascicato che la macchina di Campice era partita e che gli altri le stavano dietro. Poi era salito sul motorino ed era corso a spararsi in vena la generosa dose che suo fratello gli aveva messo in mano (solo dopo la telefonata) perché si sforzasse con la maggior professionalità possibile di far da palo.
Avevano fatto qualche prova, alcune notti prima, e Walter aveva calcolato più o meno bene i tempi: in auto, ci voleva una decina di minuti dal luogo dell’agguato al rifugio. Presto si erano sentite diverse sirene, da quella zona, segno per lui che ci avevano almeno provato: ma loro avrebbero dovuto esser già lì al sicuro.
Non fece caso ai primi cinque minuti di ritardo. Quando salirono a dieci s’innervosì. Ai quindici si rese conto che qualcosa doveva essere andato storto e si buttò fuori dall’appartamento a testa bassa, giù per le scale, fuori del portone, via di corsa in strada e poi a nascondersi nell’androne di un’altra palazzina, cinquanta metri più in là. Il tutto con addosso la precisa sensazione del fiato sul collo di una mezza dozzina di digossini, che lo avrebbero inchiodato a terra infilandogli la canna d’una Beretta in bocca.
Non accadde nulla del genere e, quando riprese un po’ di lucidità, si rese conto di aver fatto più o meno la cosa giusta: se qualcosa era andato davvero storto, rimanere nell’appartamento significava cacciarsi in trappola da soli. Beh, lì in strada uno come lui non passava inosservato, ma per fortuna non c’era nessuno in giro anche se non era ancora l’una di notte, neppure l’ombra della pula e, da dov’era, poteva tener d’occhio benissimo l’ingresso del palazzo, casomai gli altri fossero arrivati.
Mentre i minuti passavano, rimuginò sul da farsi. Telefonare a qualcuno del gruppo, nemmeno a parlarne: l’unico telefono fisso che avrebbero dovuto usare stava nell’appartamento, per il resto solo cabine pubbliche. Andare a casa, neppure: se la Digos si stava muovendo, quello sarebbe stato il primo posto in cui avrebbe cercato. Lara, no: abitava per conto suo, ma lui aveva avuto la massima cura di tenerla fuori, malgrado le sue rimostranze sulla base del classico ritornello che “quando c’è da far qualcosa di serio, che non sia scopare, i compagni non considerano alla pari le compagne”. Fuori o non fuori, la Digos si sarebbe occupata anche di lei, al momento giusto: meno sapeva, meglio era per tutti, lei per prima.
Gli balenò un pensiero: “Cazzo, sono in clandestinità!” Certo, in mezzo a quella faccenda in clandestinità ci si sarebbe trovato automaticamente, ma a lui non era mai accaduto di non avere un tetto fisso sopra la testa, di dover preoccuparsi di cambiar posto una notte sì e una no per poter dormire. Una cosa è pensarci, magari mitizzando le gesta di chi in quel modo ci aveva passato anche mesi, un’altra è trovarcisi in mezzo all’improvviso, dopo aver assunto il ruolo di quello che rimaneva chiuso nell’appartamento a “interrogare” il prigioniero, finché non avessero deciso se mollarlo o spostarlo più lontano, e aspettare un riscatto. Questo sarebbe stato un èscamotage e doveva servire a mantenere i rapporti con Marco, che avrebbe man mano deciso sul da farsi.
Decise che comunque non poteva starsene lì; andò su e giù per qualche strada, sempre riparandosi nelle ombre di un portone, quando sentiva avvicinarsi un’auto, e cambiando marciapiede se avvistava rarissimi passanti che gli venivano incontro. Le sirene continuavano a sentirsi, ogni tanto, senza che potessero suggerire una direzione precisa: “Stanno facendo i posti di blocco,” pensò. A ogni macchina che sentiva arrivare o che vedeva, si stringeva al muro, ma ne vide una sola dei Carabinieri, e senza nemmeno il lampeggiante; né notò, per quello che gli parve, qualcuna di quelle auto civetta che si sapeva potevano essere in giro. Si ritrovò a chiedersi se fosse un buono o un cattivo segno.
Per altro quel “dottor Brusiani” era stato molto chiaro: se gli altri fossero stati presi, doveva riuscire a superare la notte e fiondarsi appena possibile presso lo studio del più noto penalista locale, col quale si sarebbero concordate le modalità della sua consegna, questi erano i patti. Fondamentale era perciò che gli sbirri non lo beccassero prima. Doveva passarle da qualche parte (magari in un bar, visto che la colazione era un aspetto da non trascurare, pur essendo in clandestinità?). Dove e come poteva passare quella notte, visto che oltretutto poteva muoversi solo a piedi, visto che le macchine le avevano lasciate in posti diversi e lontani da lì, perché dopo il rapimento si sarebbero mossi solo con moto o motorini?
Dopo un’altra mezz’ora di girovagare si ritrovò nei pressi di quei giardini dove era solito incontrarsi e parlare con Riccardo e decise che sarebbe stato meglio per lui ritirarsi lì, su una panchina fuori vista, meglio se non lontana, per precauzione, dalla ferrovia: scavalcò con goffaggine la cancellata contando di aspettare lì l’apertura dei giardini, alle otto e mezza, e di uscirne, vedendo di non farsi beccare dai custodi, per correre all’appuntamento.
Sonnecchiò per un po’, in quelle poche ore, tentando di cogliere i suoni del parco. Quando a quei suoni si unirono le voci degli uomini che aprivano il cancello e iniziavano a svuotare i cestini, si alzò e, facendo bene attenzione, riuscì ad allontanarsi come aveva previsto.
La città si stava animando, malgrado il cielo grigio. Sì, c’era più polizia in giro, e poi capannelli di persone vicino alle edicole: tutte le locandine dei giornali parlavano a caratteri cubitali del “Rapimento del geom. Campice”, del “Rapimento di un noto imprenditore e politico”, di “Ritorno del terrorismo rosso”.
S’intrufolò in uno di quei capannelli, dimentico del rischio, per quanto fosse improbabile che qualcuno lo riconoscesse e avesse motivo per collegarlo a quanto accaduto e rimase a studiare quei titoli per un po’: c’era qualcosa che non capiva, maledizione, se la cosa veniva descritta in quel modo, come se il rapimento avesse avuto successo. Passava da una locandina all’altra con gli occhi sgranati e il cuore che gli montava in gola. Non aveva spiegazioni, solo la sensazione di essere stato in qualche modo fregato, pur senza capire come, da chi e perché. Ma non aveva nemmeno più scelta e proseguì, arrivò al portone in centro senza intoppi, suonò, disse la frase convenuta, entrò.
Meno di dieci minuti dopo, arrivò Marco incazzato come una iena, lo prese per il bavero spintonandolo al muro di una stanza vicina e gli urlò fra i ceffoni che gli tirava: “L’avete preso, no? E cosa ci state facendo, adesso, pezzo di merda?” E Walter, come un pezzo di merda, restava a bocca aperta in mezzo a quella confusione di sberle, senza potergli nemmeno rispondere il più classico dei “Non lo so, cazzo, compagno! Parliamone!”
(tratto dal romanzo breve "I pesci nel barile",
Vicenza 2013, Ed. Saecula - anche in e-book)
Id: 3213 Data: 05/05/2016 09:49:27
*
14 - Celebrazione e idillio
“Si erano persi una frase importante, con cui Walter aveva concluso il brindisi...”
(Un’osteria ai piedi delle Prealpi vicentine, 29/09/1979)
La trattoria poco sotto un colle e a metà strada fra due paesi era gremita come sempre il sabato sera, quando si avvicinava l’autunno e la prossimità dei monti rendeva fresco il clima anzitempo che altrove.
Avventori di ogni tipo la frequentavano, e quella sera una delle stanze era occupata da una compagnia straboccante di voci e bestemmie, canti vibranti fra il goliardico e il rivoluzionario, rutti, risate, rumore di stoviglie e tutto quanto poteva caratterizzare una brigata di extraparlamentari sulla trentina e il cui tasso alcolico era già abbastanza elevato al momento dell’arrivo.
Walter era il perno della situazione, l’anfitrione e il festeggiato per i suoi trentaquattro anni, verboso come da tempo non s’era visto. I suoi “cazzo, compagni” contrappuntavano qualsiasi suo discorso, fosse il far fretta a un cameriere o il commentare qualsiasi fatto, personale o politico.
Una nobile gara di bevute caratterizzava quel pasto a base di robuste portate contadine, gara nella quale erano testa a testa impegnati Danilo, Marò e quattro compagni che venivano da altri gruppi. Nessuno poteva fare a meno di notare come, da quando Violetta se n’era andata, Walter fosse tornato a essere quello di sempre, simpatico e accattivante, in bilico tra sfottò e inconcludenza, tra una furbizia di corte vedute e una superficialità che lo portava a sdrammatizzare ogni cosa. E che, da quando aveva trovato quel nuovo lavoro, aveva anche qualche soldo in più nelle tasche di cui non faceva mistero, soprattutto a favore dei suoi compagni: ai quali così non mancava mai un bicchiere pieno, quando si trovavano insieme.
Gigi cercava il modo di restare almeno un po’ con Edna, monopolizzata però dalle compagne del suo gruppo, che facevano crocchio a sé. Anche pensare alla scusa di un ballo, era inutile: cantare si cantava, ma due chitarre non valevano molto come orchestra da ballo e quindi avrebbe dovuto inventarsi dell’altro.
Che cosa lo attirava in lei? Si rispondeva, e rispondeva a qualcuno che aveva mangiato la foglia, che, visto che sembrava starci, una bella scopata ci sarebbe potuta sempre scappar fuori, e non sarebbe stato un peccato: si era accorto che alcuni dei compagni più anziani non la disprezzavano fisicamente e ricordava una sera a casa di Guglielmo, quando sia lui che la moglie avevano sostenuto che era l’unica ad essere un po’ equilibrata, in quel pollaio di erinni che era il Rosa Luxemburg.
Poteva bastare o c’era qualcos’altro? Ma Edna, cosa provava? Al tavolo vicino, uno degli ospiti in crisi etilica spazzolava via le stoviglie, per sfidare un Danilo altrettanto inciuccato a braccio di ferro. Ma i suoi pensieri non si interruppero. Se era così emancipata, così femminista, pensava Gigi, di certo non mirava a una relazione duratura, la minaccia più seria che una donna potesse portare a un uomo. Di sicuro, dunque, anche lei voleva solo darsi a un po’ di bel tempo.
Edna sarebbe voluta restare per tutto il resto della serata con Gigi, se quelle tre compagne, con le quali condivideva un po’ troppo di tutto, l’avessero voluta mollare almeno per mezzo secondo. Chi se ne fregava se non c’era musica per ballare? Se quei due compagni con le chitarre un po’ scordate non valevano certo un’orchestrina, non si poteva uscirsene fuori e ballare in silenzio nel cortile vicino agli alberi, inventandosi la musica nella testa?
Sapeva che cosa la attirava in lui. Era, in fondo, ingenuo: e perciò ancora buono e sincero, con gli ideali puliti per cui a volte veniva pure canzonato da qualcuno nel gruppo. Ed era magro, lucido nei movimenti come lei pensava dovesse essere il suo uomo.
Questo per lei bastava. Ma Gigi? Urla belluine, che segnavano il culmine dei brindisi dedicati a Walter, la distrassero da questi pensieri, e distrassero pure Gigi. Si ritrovarono accanto, nel vociare degli altri compagni, fra i tappi di prosecco che saltavano. Si guardarono negli occhi e uscirono assieme.
La mezzanotte era da poco passata e il buio entrava nel suo culmine: era già parecchio fresco, e questa era una buona scusa per stare vicini. Gigi ebbe la felice intuizione di stare zitto. Lei non disse molto e insieme raggiunsero uno dei sentieri che si dipartivano dalla piazzola dietro l’osteria e trovarono intimità ai piedi di un albero.
Si erano persi una frase importante con cui Walter aveva concluso il brindisi, e alla quale non tutti, a causa del baccano e dell’alcool tracannato, avevano dato il giusto peso: “Compagni, la prossima settimana ricominciamo a trovarci: è ora che questo gruppo organizzi qualcosa di serio e che mostriamo chi siamo, cazzo!”
(tratto dal romanzo breve "I pesci nel barile",
Vicenza Ed. Saecula 2013)
Id: 3186 Data: 07/04/2016 09:02:59
*
8 - Grandi manovre
“Insomma, vuoi combinare un ‘affare Moro’ in piccolo…”
(La sede di una delle maggiori imprese edili in città, 11/08/1979)
“Abbiamo un’apertura, Sergio.”
“Spiegati meglio,” rispose tra il serio e lo svogliato l’Onorevole,
al quale questi termini da stratega cinese non piacevano per niente.
“Ho studiato la situazione, per Campice, e non se ne parla proprio di esporci direttamente. Però c’è un piccolo gruppo dell’ultrasinistra che ha appena perso il proprio capo: da quel che sono riuscito a sapere, giudico che uno dei suoi membri sia ricattabile.”
“Un sicario da quell’ambiente? Brillante davvero, come no? Sarebbe così che vorresti togliermi le castagne dal fuoco? Anche se fosse, come la mettiamo con quelli della DIGOS, con quelli dei servizi? Ti sei rincoglionito, o non sai più com’è facile infiltrare un gruppo come quello?” Sergio Valle si era sempre fatto vanto di trovare un punto debole nelle strategie che di volta in volta gli proponeva Marco, il quale gli era decisamente superiore per intuito e capacità.
“Appunto: l’infiltrato era il capo.”
“Dio, che fessi…” (Ecco, altro che punto debole, anche stavolta mi ha fregato: meglio che cominci ad ascoltarlo).
“Senti, uno di loro ha problemi di lavoro, e non solo quelli: posso provarci, anche perché per ora non pare che la Digos ci metterà dentro qualcun altro.”
“Ammesso questo, sei sicuro che sia la gente giusta?”
“Sicuri in queste cose non lo si è mai. Però ho letto i rapporti al riguardo e penso che la cosa si possa fare. Già m’è costata un’ira di dio. Anzi, è a te che tutta questa faccenda costerà parecchio…”
“Mai quanto ci rimetterei se andiamo avanti così e lo lasciamo fare. Per non parlare della faccia che ci perderei nel Partito. Ma pensi davvero che per farlo cagare sotto basteranno quattro molotov?”
“No, non con quattro molotov: con quattro giorni nelle mani di quei cazzoni. E poi, quando ne viene fuori, in un modo o in un altro gli si fa capire che è successo, perché certe cose non le deve fare.”
“Insomma, vuoi combinare un ‘affare Moro’ in piccolo… Potrebbe andare, sì!”
“Potrebbe, sì e tanto non abbiamo molte soluzioni: t’ho detto che direttamente non possiamo muoverci, e t’ho anche detto della mala cosa ne penso. Se qualcosa poi va storto, comunque lui coglie l’antifona. In ogni caso da fuori sembrerà tutto un affare politico, così che dovremmo starcene lontani dai guai.”
Marco conosceva benissimo l’uomo per il quale lavorava ora e per il cui padre aveva lavorato in passato: dopo un lungo silenzio che sembrava aver concluso il discorso, era giunto il momento di insinuare un dubbio.
“A proposito di guai, suoi ma anche nostri: non pensi che in questo modo potremmo finire col fargli un favore? Politicamente, voglio dire: sai la pubblicità che gli può venire da un guaio come questo?”
“Sì, sì, ho capito cosa intendi. Ma non ci sono elezioni in vista e poi, chi lo conosce Campice? Mica è Berlinguer o Andreotti… Dopo un mese, chi vuoi che se ne ricordi? No, no Marco: muoviti e toglimelo dai coglioni.”
Marco uscì dall’ufficio, il passo lungo e deciso, la giacca impeccabile, senza un’occhiata per nessuno: il suo piano aveva già preso forma, e come prima mossa sarebbe bastata una telefonata.
Sergio questa volta non si affacciò alla porta, per seguirlo con lo sguardo. Restò invece a rimuginare se quella mossa fosse giusta o meno, calcolandone a mente costi e benefici. Mentre si convinceva che sì, non c’era altro da fare, si meravigliò che il cicalino dell’interfono non fosse più squillato, muto da almeno un’ora, da prima che iniziasse quel colloquio. Lo prese come un segno di buon auspicio e rivolse la mente altrove.
(tratto dal rromanzo breve "I pesci nel barile",
Vicenza, Ed. Saecula 2013)
Id: 3185 Data: 06/04/2016 16:45:24