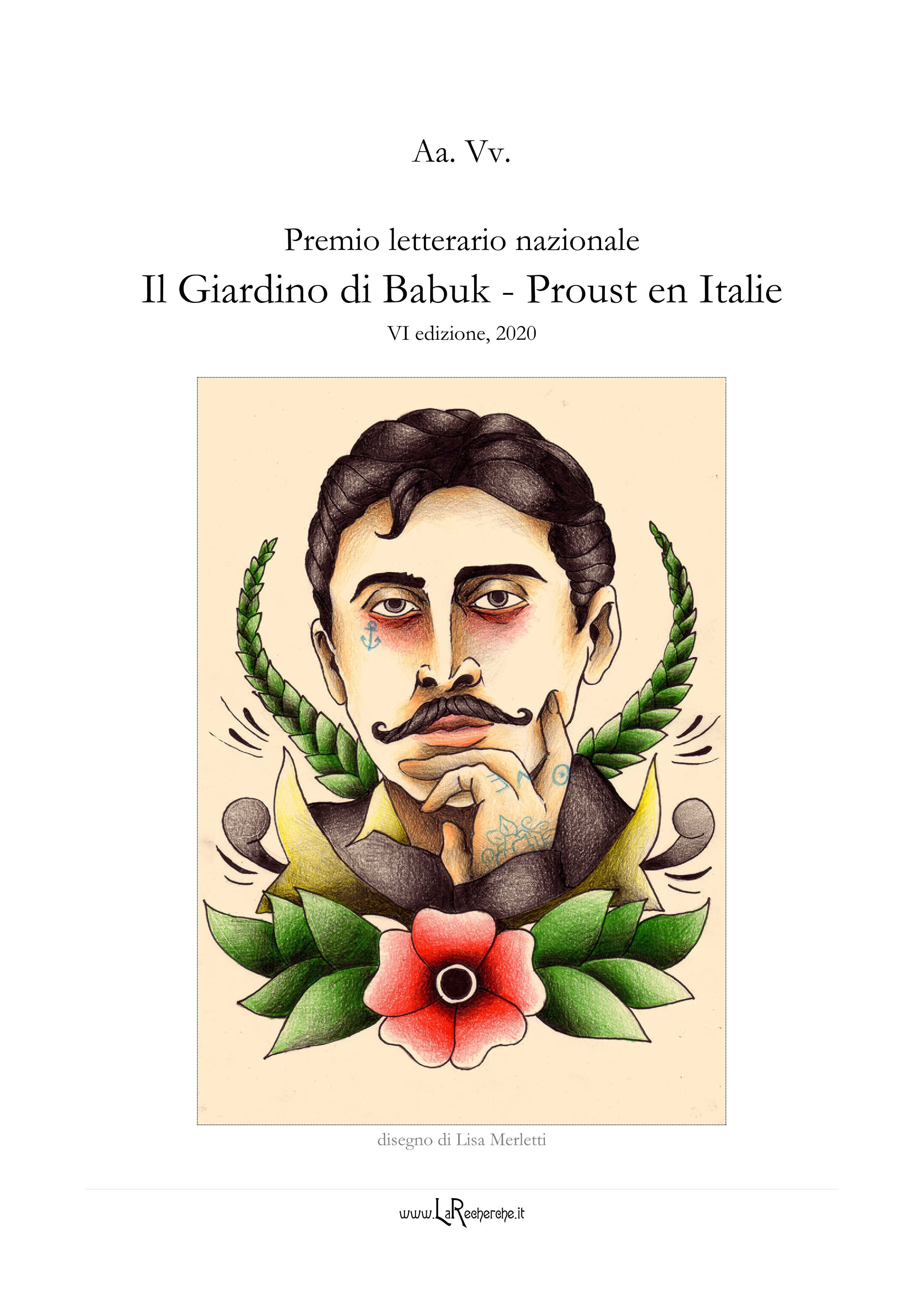chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Sara Galeotti
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
*
Il senso di una fine
[ Opera prima classificata al Premio letterario nazionale “Il Giardino di Babuk – Proust en Italie”, VI edizione 2020, nella Sezione B (Racconto breve) ]
L’alba sale lenta, spennellando d’arancio e rosa le pieghe di un cielo d’ombre. A est, oltre la duna mobile dei campi, comincia a intravedersi una bava di luce, ma è una ditata sottile, intimidita – pare – dal blu vellutato nel quale galleggia ancora il piatto rotto della luna.
Prima di partire credevo che tramonti e aurore colassero da una tavolozza prevedibile, quadrucci d’un mestierante abile, sì, ma poco fantasioso. Sudando il Camino[1] ho invece scoperto che davanti all’oceano, là dove s’incuneano le falesie e l’orizzonte spuma in nebbia, il sole annega nel vino nuovo, non nel sangue. Quando poi risorge – cauto – s’aggrappa al sudario della notte quasi fosse un Lazzaro incredulo.
È un pensiero empio, il mio – ne sono consapevole – eppure, dei camminatori di San Giacomo, resto probabilmente l’unico penitente.
Mio padre è morto ad aprile; il più crudele dei mesi l’ha contagiato con la sua carsica ferocia e l’ha rapito un giorno di vento. Se n’è andato come voleva, il vecchio: in fondo a un crepaccio delle Pale di San Martino, bagnato dal riverbero polveroso di un’alba da cartolina.
Per chi non lo conosceva, un tragico incidente, di quelli con cui la montagna ti educa all’umiltà e al rispetto.
Per me, che non lo vedevo da un lustro, un atto d’orgoglio. Gli avevano diagnosticato da poco un principio d’Alzheimer, m’hanno detto: saltare nel vuoto dev’essergli parso preferibile all’infinita agonia della demenza; al trasformarsi in un lucido osso di seppia trascinato dal mare del niente.
Gli serbo rancore, per questo? Sì, gli serbo rancore, ma credo sia un bene.
Il rancore, per quanto doloroso, non è indifferenza.
Rancore è il nome che assume l’amore quando la vita lo sporca.
I primi pellegrini s’incamminarono per Santiago de Compostela al tempo delle Crociate. Gelati dalla neve dei Pirenei, bruciati dal sole degli altopiani, li animava la stessa fiamma per cui tanti sarebbero crepati in Terra Santa: una cieca, ostinata, disperata devozione. Il viaggio rappresentava, allora come oggi, un prolungato atto di fede e di penitenza. Avvolti dalla nebbia, i viaggiatori abbandonavano il passato e il futuro, scoprendo il tempo immobile di Dio nel rosario di passi estenuati che li accompagnava sino alle spoglie del martire.
Mentre mastico una mela seduto su un vecchio tumulo, penso alle donne e agli uomini partiti senza più tornare, vittime dei briganti, delle tempeste, della fame. Donne e uomini dei quali resta un’eco stenta, trascinata oltre le falesie dall’aria azzurra dell’oceano.
Il Camino de Santiago punta a ovest, sempre e solo a ovest; è un sentiero di tramonti e di morte. Forse è per questo che sono qui, tra pascoli e pietre grigie: per scoprire il senso di una fine liberandomi dall’ossessione delle ore – del prima e del dopo. Oppure perché, più di tutto, m’è sempre mancata la pazienza con cui i santi aspettavano Dio, la Provvidenza, l’illuminazione.
Se Lui esiste, preferisco andarGli incontro camminando.
Se Lui esiste, mi deve almeno una birra.
*
Non ho mai conosciuto mia madre. Era una donna d’abbandoni, di quelle che non guardano indietro, persino se alle spalle lasciano un uomo incredulo e una larva urlante. Negli anni l’ho pensata spesso, senza però cercarla. Suppongo sia stata una forma di codardia, la mia: non volevo scoprire, oltre la polvere del risentimento, lo scintillio di un affetto che mi avrebbe condannato al desiderio.
Il vecchio m’ha cresciuto solo, svezzandomi con l’asprezza delle montagne che l’avevano chiamato al mondo e lo infestavano ancora, come un’infezione dell’anima. Mi ci portava ogni estate, senza domandarsi mai se quelle erte brulle, quelle verticalità spietate, quei paesotti ciechi, condannati dalla miseria, fossero un orizzonte adatto al bambino prima, al ragazzo poi.
Non credeva nella democrazia, lui, perché non era democratica la natura. In vetta arrivavano i più forti, quelli che non cercavano scorciatoie, ma sapevano soffrire.
Mi preparava a una vita di pugni chiusi e denti stretti, spigolosa com’era tagliente lui, ossa e tendini mal cuciti.
Assentivo per paura di uno sguardo storto, di un giudizio che mi avrebbe costretto a sentirmi meno figlio, rifiutato due volte.
La Galizia è una terra fiera, aspra come ogni luogo in cui l’uomo sia più ospite che non padrone. Arranco lungo uno sterrato che pare infinito, accompagnato dai richiami di uccelli che non ho mai imparato a riconoscere.
Il Camino è ben tracciato: conchiglie stilizzate anticipano la meta e i gruppi si fanno più animati e ciarlieri. Ne ho incontrati molti, di viaggiatori, giovani e vecchi, credenti e scettici. C’è chi macina chilometri per sfida, chi per preghiera. Chi ha qualcosa da trovare, chi ha smesso di cercare da settimane. Alcuni domandano ‘perché sei in viaggio?’; altri tacciono, perché per primi non avrebbero una risposta.
Cammino per vincere il dolore.
Cammino per sentire il mio corpo.
Cammino per ricordare.
Cammino – forse – per salutare mio padre. Per sorprenderlo – vivo – negli intervalli illusori di un tempo assente.
*
Da Naunina a Timau, da Ovaro a Lauco, tagliando per pievi desolate, croci puntate al cielo in un’accusa muta, gli uomini ascoltano i boschi, le donne, la terra. Albe scolorite salutano il risveglio, gonfie di un’umidità che l’inverno tramuta in morsi; che tu sia maschio o femmina, impari il lessico segreto degli ippocastani, finché, a trent’anni, non diventi legno a tua volta, scolpito dalla fatica, bruciato dal gelo. Là, dove il tempo è morto con Dio, la povera gente campa ancora come nei giorni del ferro e della pietra. Persino la lingua pare rimasta intoccata dall’anno Mille: un dialetto duro quanto le montagne che regalano il pane e la fame.
Cleulis è persino troppo stento da dirlo un paese. Quattro casacce in croce s’arrampicano per un’erta stretta, incisa come una ruga millenaria lungo il costone franoso. Difficile dire chi e perché abbia scelto di vivere dove un mulo conviene più d’una jeep, ché tra i sassi non c’è trazione valga tigna e zampe robuste. Lì è nato mio padre. Lì mi trascinava a forza, sordo a ogni protesta.
Mi svegliava ch’era ancora buio – due fette di salame, pane di segale, un bicchiere di grappa –, poi si camminava e camminava e camminava, preparando l’ascesa. Il vecchio rispettava solo i rocciatori, perché, a suo dire, erano tra i pochi che meritavano la montagna. Chi guadagnava la valle sugli sci, scodellato in cima da un ovetto di vetro e acciaio, non avrebbe compreso mai il lessico segreto delle vette. Guardava ai monti come a una metafora della vita, mio padre, per questo parlava poco, bestemmiava volentieri e non mi permetteva di rallentare.
Nel ricordo, m’accorgo che abbiamo condiviso molto nei nostri reciproci silenzi, colmando l’interlinea delle informazioni essenziali. Allora, tuttavia, pensavo a essere altro. Altro da lui, da quella crudeltà sempre a stento trattenuta, da lupo alla catena.
L’ho perso nell’inventarmi una vita diversa, ma ci siamo trovati a lungo, prima di smarrirci.
*
Ultreya! Suseya!
L’essenza del Camino è il motto con cui t’incoraggiano i galiziani e i pellegrini che incontri lungo la strada. Riconoscerci è facile: siamo quelli coperti di polvere, che zoppicano su vesciche aperte e fissano lo sguardo a una meta invisibile. Quelli che piangono sudore e lacrime, che parlano da soli, che a volte cantano stonati la gloria di Dio o di Sanremo.
Ultreya! Suseya!
Tradurre il saluto dei camminatori di San Giacomo non è facile, soprattutto l’ambiguo ‘suseya’. Vai avanti! Stai su, viaggiatore! ma anche Spingiti oltre! Cresci!
Un chilometro dopo l’altro, lungo tratturi accidentati che muoiono in faggete o si snodano attraverso praterie stoppose, il nastro della vita tende piuttosto a riavvolgersi, quasi guardarsi dentro e guardarsi indietro siano la stessa cosa.
Carlos, un catalano con il quale ho coperto il tratto da Triacastela a Portomarín, prima che deviassi per Vigo, m’ha detto una sera: «Esiste un momento, nella storia di un uomo, in cui l’unico confessionale che serve si chiama coscienza. Essere adulti vuol dire inginocchiarsi e parlare e basta. Senza scuse».
Stava calando la notte, così il caldo umidiccio che ci aveva tormentato tutto il giorno. Lontana, tra prati di un verde scurissimo, insolitamente intenso, arrivava la voce del buio – il frusciare dell’erba, la sega impazzita di una cicala, il ronfare pigro di un’automobile.
Se era un invito a pregare insieme, non l’ho colto, schiavo del mio riserbo o forse di un terrore antico: davanti all’altare non ho mai smesso di sentirmi un postulante indesiderato. Uno, per altro, cui abbiano riservato l’ultimo numero per rivolgersi allo sportello dei reclami.
Ultreya! Suseya!
Forse crescere vuol dire trovare la pazienza d’arrivare in fondo alla fila.
Il giorno in cui il vecchio è morto non ci parlavamo da due mesi. Avessimo prima discusso; ci fossimo insultati o persino presi a pugni, avrebbe avuto un senso: invece è bastato che non sollevassi il telefono e componessi un pugno di cifre, perché il nostro legame tenuissimo s’interrompesse.
L’ho compreso tardi, ma gli affetti somigliano al letto d’un fiume; li soffoca la pigrizia, l’incuria, il ‘ci penserò domani’. Poi scopri che un domani non esiste e a te restano solo le sterpaglie limacciose dei cattivi pensieri.
*
A Santiago de Compostela mancano poco più di venti chilometri. Cammino da oltre tre mesi; deviazioni e soste mi hanno rallentato, eppure, al tempo stesso, avvicinato al cuore del viaggio.
Mio padre mi spintonava sulle ferrate con impazienza, quasi salire in alto, sempre più in alto, fosse l’antidoto per l’infelicità inevitabile dei giorni. Quasi i problemi s’ammucchiassero in basso e tu, aggrappato a un costone, potessi salutarli senza pensieri.
Mio padre era uno di quelli che saliva per non scendere. Lo faceva rapido, pochi gesti netti, nervosi, carico come una molla. Il Camino, invece, mi ha insegnato a rinunciare; a capire che, velocemente, non si arriva da nessuna parte – ci si accartoccia, se mai, contro la linea di un orizzonte tanto deformato da non possedere più alcuna poesia.
Mi ha ricordato, il Camino, che è bello e dignitoso il coraggio d’una sconfitta ammessa, perché è lì che mette radici la speranza. La ripartenza.
Per la lapide ho scelto una fotografia in cui il vecchio non è vecchio per niente, benché abbia il viso inciso da rughe profonde, tracce d’una storia inventata dal sole per coprire i solchi della nostalgia.
La mia faccia, ora.
La stessa che ho incontrato, senza quasi riconoscerla, qualche sera fa.
Tra le vigne alla periferia di Pontevedra spiccava, ritorto, lo scheletro d’un albero addobbato di specchi; li usano per tenere lontani gli uccelli, ma c’era, in quella vista, qualcosa d’abbastanza maligno da scoraggiare persino i cristiani. Eppure mi sono avvicinato. Ho guardato.
Sotto il porpora slavato del cielo vespertino, circondato dal baluginio sinistro di mille luci, ho scavato sotto la pelle e gli anni, trovando mio padre.
Ho provato rimorso per non aver tentato prima, per non aver capito che eravamo due estranei solo a un’occhiata superficiale; uno sguardo autentico, invece, e avresti capito che la nostra era la distanza imposta da un amore suppurante. Il galleggiare sulla superficie, per il terrore di scoprire una bocca aperta sotto il pelo dell’acqua.
*
Domenica sarò a Finisterre, là dove il mondo finisce e comincia l’oceano. Là dove i peccati si lavano col sale e col sole. Là dove ti aspettano una conchiglia, una croce, una pietra.
Là dove saluterò mio padre, dopo averlo conosciuto un passo dopo l’altro.
Là dove il mio affetto avrà, infine, la forma stessa dell’acqua in cui m’immergerò: infinita, come la montagna d’un gigante, e inafferrabile, quanto il tempo che ci è stato restituito.
[1] Nel riferirmi al ‘Camino de Santiago’ ho preferito utilizzare lo spagnolo anziché l’italiano.
Id: 4813 Data: 04/04/2020 19:18:49