chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Paola Salzano
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
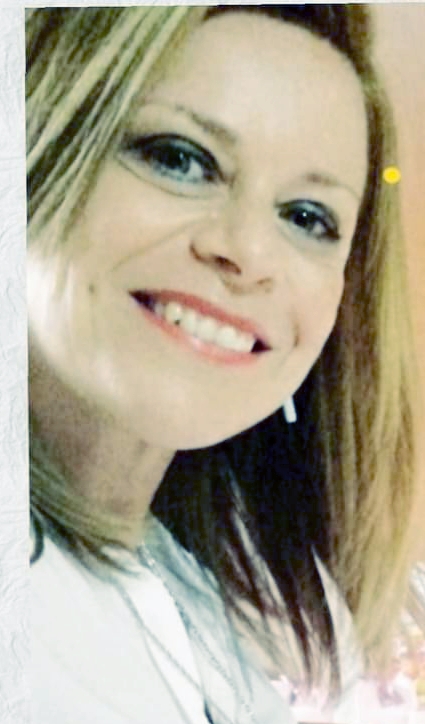
*
Come le foglie
Lea adorava novembre, un mese che invita alla calma e alla riflessione.
Mentre i suoi amici lo ritenevano un mese cupo, una triste parentesi prima dell’euforia natalizia, lei accoglieva l’invito di novembre a rallentare e a riflettere su ciò che valeva la pena di conservare o lasciare andare. Proprio come le foglie dorate, pensò Lea, che si lasciano cadere senza opporre resistenza, fiduciose in una futura rinascita.
In un pomeriggio umido e lattiginoso stava preparando la sua torta di mele che profumava di burro e di cannella, ma di tanto in tanto lanciava occhiate in tralice verso il display del cellulare, poggiato sulla credenza.
Da troppo tempo aspettava quella telefonata. Si era forse illusa ancora una volta?
Perché le persone ti seducono con le parole e poi scappano senza spiegazioni, si chiedeva, mentre infornava il dolce palpitante di lievitazione.
Impostò il timer e si avvicinò alla finestra sull’altro lato della cucina, quella che dava sul giardino, non prima di aver preso dal microonde una tazza di thè fumante.
Mentre sorseggiava la bevanda calda e l’aria sprigionava in modo sempre più intenso l’aroma di cannella, una leggera pioggia aveva iniziato a tamburellare sui vetri.
Lea vide dalla finestra l’ultima foglia staccarsi lentamente dalla siepe e adagiarsi sul lastricato bagnato del giardino. Cominciò a mettere ordine nei pensieri.
Era inutile opporsi, rifletté, era arrivato il momento di lasciare andare il suo amore, e in quell’autunno stranamente mite, forse avrebbe dovuto voltare pagina.
Bevve l’ultimo sorso di thè e si dispose ad assaggiare il frutto del suo lavoro in cucina.
“Forse è questo il senso della vita”, pensò assorta. “Essere pronti a gustare brevi attimi di felicità”.
Id: 5947 Data: 21/11/2025 15:28:34
*
Il miracolo di una sera
Impaurita, non sapevo dove rifugiarmi, la caligine incipiente formava una coltre densa e grigia che impediva di vedere oltre la punta dei piedi; d’improvviso una luce, forse di un lampione, aprì uno spiraglio nell’oscurità col suo bagliore caldo e avvolgente.
Vidi una figura indistinta avvicinarsi, come se uscisse da un sipario di velluto nero; fu così che scorsi il tuo viso, dall’espressione dolce e allo stesso tempo audace che non ho mai dimenticato.
Ti riconobbi subito, mentre sorridevi e mi tendevi la mano. Ero incredula, non sapevo cosa fare, ma il tuo sguardo rassicurante m’induceva a lasciarmi andare.
Così accolsi la tua mano e ritrovai il calore di allora, come se non ci fossimo mai lasciati e non fosse mai trascorso tutto quel tempo dalla fine della nostra storia.
Ci ritrovammo fianco a fianco, camminando per le vie della città che ha visto nascere il nostro amore e ci ha cullato come una madre amorevole sulle onde del suo mare.
Restammo tutta la notte abbracciati, seduti su una panchina a scambiarci confidenze e a raccontarci il vissuto di quegli anni di assenza. Senza accorgercene fummo sorpresi da un’alba aranciata foriera di un limpido mattino d’inverno, avvolti dalle prime luci che si specchiavano sulle acque del golfo, mentre l’odore pungente di salsedine ci solleticava le narici.
Eravamo di nuovo insieme, immersi tra le onde increspate dei ricordi. Forse è stato un sogno, o forse il miracolo di una sera che aspettavo da sempre: io e te, di fronte al mare, in compagnia del nostro amore.
Id: 5865 Data: 02/02/2025 11:51:52
*
I miei favolosi anni 80
Nel periodo storico in cui le sorti del pianeta erano decise dal presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan e la “perestrojka” del russo Michael Gorbaciov stava rivoluzionando la società sovietica, io mi apprestavo ad attraversare quella fase di grandi cambiamenti nella vita di una persona che difficilmente si dimentica.
Era l’inizio degli anni 80. Da adolescente timida ed impacciata mi affacciavo al mondo con una voglia inesauribile di vivere emozioni e, nell’epoca dell’apparire e dell’affermazione ad ogni costo, desideravo anch’io essere vista e trovare un posto da qualche parte che non fossero la famiglia o la scuola, luoghi che iniziavano a starmi stretti.
Dalla mia terrazza di un condominio alla periferia di Napoli osservavo il mondo come oggi si sbircia sui social network e la mia attenzione cadeva spesso sulle ragazze del mio quartiere che, ancheggiando con fare sicuro e sfrontato, lanciavano occhiate languide ai loro coetanei sui motorini, gettandoli in uno stato di confusione.
Strizzate nei loro jeans Levi’s e avvolte in giubbotti di pelliccia (secondo la moda del tempo), mi facevano molta invidia, non tanto per lo stuolo di ragazzini brufolosi appollaiati sui loro “Ciao”, quanto per quell’atteggiamento da dive vissute molto lontano dal mio modo di essere. Nonostante ciò, e grazie ad amici in comune, entrai nel loro giro ed iniziò così il periodo più esaltante della mia adolescenza. Ricordo l’impazienza di incontrarsi nei pomeriggi sotto i portoni a chiacchierare e ad organizzare uscite per il weekend, sentendoci veramente connessi.
I nostri genitori non stavano tanto a preoccuparsi per i mille pericoli, che forse già esistevano, ma non incutevano ancora tanta paura, per cui riuscivamo a goderci le strade e i luoghi di ritrovo senza troppe ansie. Il capo della comitiva, un tipo amichevole e cordiale il cui sorriso ricordo ancora con nostalgia, trascinava tutti con il suo entusiasmo, coinvolgendoci in mille iniziative.
Nel periodo natalizio ci imbarcavamo in allegre spedizioni nella via dei presepi, San Gregorio Armeno, per ammirare le bancarelle zeppe di pastori di terracotta che avevano le sembianze del goleador Maradona e dell’indimenticato Pino Daniele, accanto a quelle di Giuseppe, Maria ed il Bambino Gesù.
Senza avvertire il freddo e con la sensazione di onnipotenza tipica della gioventù, percorrevamo le vie del centro cullati dalla voce suadente di George Michael nella hit del momento, “Last Christmas”, che proveniva dalle auto ingabbiate nel traffico.
Ma i momenti più attesi della settimana erano le feste del sabato sera organizzate a turno nelle nostre case. Le ragazze curavano nei minimi dettagli il look, sperando di imitare lo stile di Madonna, la star internazionale del momento. Ricordo con quanta cura strapazzavo i capelli, attorcigliandoli in fiocchi di tulle, e impreziosivo le mie orecchie con bigiotteria a forma di croce, cercando di apparire trasgressiva.
Così abbigliate e sotto le luci specchiate della sfera roteante, ballavamo al ritmo della pop music, fino a quando un improvvisato deejay cominciava a rallentare il ritmo, introducendo l’inevitabile pezzo lento.
In quell’attimo la pista da ballo si svuotava, mentre gli angoli della stanza venivano presi d’assalto dagli invitati, terrorizzati dal momento tanto atteso ma anche temuto. Le ragazze speravano di essere invitate a ballare e così, se il miracolo si avverava, si ritrovavano tra le braccia del proprio lui e con gli occhi sognanti.
Nelle vie del centro invece vedevamo sfilare i “paninari”, ragazzi ossessionati dalle griffe che sfoggiavano i giubbotti Moncler e le scarpe Timberland con fare snob, mentre i nostri genitori si lamentavano dei prezzi che salivano in modo inaudito nel vortice consumistico di quegli anni, da cui inconsapevoli venivamo risucchiati.
Nel frattempo volavano i mesi e gli anni fino al sospirato esame di maturità, che decretò la fine dell’adolescenza e di quel decennio per noi esaltante. La spensieratezza era destinata lentamente a dissolversi, ma il futuro si prospettava roseo, con un bagaglio di sogni e progetti da realizzare senza la paura del domani.
Di quel periodo conservo ricordi indimenticabili, alcuni catturati grazie alla mia Polaroid, la macchina fotografica con cui mi illudevo di fissare momenti irripetibili attraverso sbiadite istantanee.
Oggi capita che qualche mio studente mi chieda:” Prof, ma com’erano realmente gli anni 80?”
Non so se furono così belli come li ricordo, rispondo, ma so che resteranno per sempre i miei favolosi anni 80, quando per dire “mi piaci”, lo facevamo guardandoci negli occhi.
Id: 5621 Data: 19/05/2024 16:21:10
*
C’era una volta la favola di una bambina
“Questa sera ti racconterò la storia di un viaggio meraviglioso, di un’avventura che vale una vita intera…”.
Durante una notte piena di stelle, in una casa ai margini del bosco, due occhi si schiusero alla vita, dopo aver fluttuato per mesi nel buio e nel silenzio di un mare misterioso; erano gli occhi di una bambina appena venuta al mondo, annunciata dal canto di fate madrine che, volteggiando attorno alla piccola, le portavano in dono forza, coraggio e sensibilità.
La mamma l’accolse impaziente tra le braccia, ancora confusa dai dolori del parto, mentre il papà osservava emozionato ed incredulo il miracolo che aveva visto compiersi sotto i suoi occhi. Il buon Dio disegnò all’istante sul viso della bambina un incantevole sorriso, ad attenuarne il pianto disperato.
La bimba venne avvolta da coccole e amorevoli cure, imparando che il mondo era un posto meraviglioso, un giardino profumato e pieno di colori; si sentiva davvero fortunata. Trascorse così l’infanzia felice e spensierata.
Passarono gli anni e lei andava incontro al suo destino fiduciosa, inventando nuovi giochi e disegnando, tra sogni e speranze, la sua vita futura. Ma presto capì che non tutto era come aveva immaginato: la madre le insegnò che talvolta bisognava mettere da parte i propri desideri per non recar dispiacere agli altri.
Così ordinava alla figlia di fare la brava quando il padre, tornando stanco la sera a casa, facilmente poteva arrabbiarsi. Lo vedeva in quei frangenti furibondo mentre aggrediva la madre, trasformandosi in un drago sputafuoco da cui era prudente allontanarsi per non essere travolti.
Iniziò a credere che la madre avesse ragione: era meglio non rischiare lasciando stare i capricci, in fondo di coccole ne aveva abbastanza. “Che stupida però a credere di essere così speciale”, rifletté delusa la bambina.
Continuava a fantasticare, ma ora avvertiva un peso sulle spalle, una zavorra che ne rallentava il passo. Affinò l’arte del compiacere, pur di accontentare chi aveva vicino; andava bene così, perché li amava. Diventata una giovane donna decise di spingersi nel bosco incantato che ogni mattina ammirava dalla finestra. Iniziò a camminare e d’improvviso si imbatté in elfi maligni, strani ometti che, non essendo riusciti a diventare maghi, mal sopportavano le ragazze dotate di bellezza ed intelligenza.
Così le prepararono un tranello. Elargendo belle parole a profusione, da abili pifferai la trascinarono in un burrone: lei si disperò, poiché non riusciva più a venirne fuori. D’improvviso apparve una delle fate madrine. “Cara, non disperarti”, le sussurrò in un orecchio. “Ricordati che hai ricevuto in dono la forza: usala e sia quel che sia!”
In lacrime la bambina pensò che la sua buona madrina avesse ragione e, armatasi della forza, pian piano cominciò a risalire dal precipizio. Sicura e decisa, riprese il cammino, meno ingenua di prima.
Lungo la strada le ritornò il buonumore, ma dopo poche miglia ecco comparire dinanzi ai suoi occhi strani personaggi: le streghe arcigne. In origine fate buone, per pigrizia non avevano fatto uso dei doni ricevuti alla nascita e così, invidiose e rabbiose, tentarono di rallentare il viaggio della giovane. Le fecero credere infatti che il mondo fosse una giungla piena di draghi sputafuoco e di elfi maligni, come del resto lei stessa aveva sperimentato, per cui la incitarono a munirsi di una buona corazza, così da potersi difendere.
Confusa ed impaurita, la ragazza indossò un’armatura di ferro, assumendo un aspetto duro come quello delle streghe. Allora mise da parte i sogni e riprese il viaggio nel bosco, guardinga. Si trasformò in una guerriera, anche perché non voleva seguire lo stesso destino della madre, costretta a subire gli attacchi del terribile drago sputafuoco.
Cominciò ben presto a sentirsi stanca ed afflitta. “E se le streghe si fossero sbagliate?”, pensò. Inaspettatamente le venne in sogno un’altra fata madrina. “Cosa fai, bambina, ti arrendi? Hai ricevuto il coraggio: usalo e sia quel che sia!”, la incitò dolcemente. La ragazza si armò di coraggio ed esclamò: “Questa non è la vita che avevo sognato!”. Si tolse l’armatura e riprese con fiducia il cammino, più coraggiosa di prima.
Dopo pochi passi fece un incontro inaspettato: vide arrivare, tra i raggi del sole che faceva capolino dietro le nuvole, un giovane dagli occhi sorridenti, il quale la salutò chiedendole dove stesse andando. “Sto seguendo la mia strada”, rispose la ragazza. Lui fu colpito da questa affermazione, scorgendo nel suo animo tanta sensibilità; in quel momento l’ultima delle tre fatine apparve dinanzi ai due giovani, volteggiando e cantando soavi melodie.
Timido ed imbarazzato il giovane le propose di camminare insieme; lei acconsentì, essendo rimasta impressionata dal suo sguardo, in cui vide riflessa se stessa. Aveva conosciuto l’Amore.
Finalmente insieme trovarono la via d’uscita dal bosco: si presentò dinanzi a loro una radura lussureggiante, allietata dal gorgogliare di un ruscello. I due giovani rimasero estasiati a contemplare quel meraviglioso spettacolo della natura, cullati dalle melodie di uccellini di ogni specie. Non sappiamo se continuarono a camminare insieme per sempre o solo per un tratto. Di sicuro la bambina, oramai donna, non permise mai più a draghi sputafuoco, elfi maligni o streghe arcigne di portarle via i sogni e le speranze.
“E sia quel che sia”, ebbe a ripetersi spesso.
**************
Terminato il racconto la piccola Siria, nel suo lettino, stirò le braccia in un lungo sbadiglio, le palpebre socchiuse per il sonno imminente. “Bella questa storia, mamma… sei sicura che sia una favola?”, osservò con un filo di voce.
“Certo che lo è, amore mio. E’ la favola di ogni bambina”.
“Che riesce sempre a venir fuori dal bosco?”, chiese la bimba, perplessa.
“Sempre. L’importante è che lei abbia tanto coraggio”, rispose la madre in tono rassicurante, mentre le rimboccava le coperte.
A quelle parole Siria diventò pensierosa, mentre con le manine attorcigliava alcune ciocche dei suoi capelli sparsi sul cuscino.
“Da brava, adesso è ora di dormire”.
“Buonanotte, mamma”, bisbigliò la piccola assopita, stringendo forte il suo coniglio di peluche.
La donna le diede un bacio sulla fronte e si alzò per uscire. Fermandosi sulla soglia, la guardò un’ultima volta.
“L’importante è che tu abbia coraggio, bambina mia”, pensò ad alta voce scivolando fuori dalla stanza, mentre Siria si arrendeva al sonno profondo dell’infanzia.
Id: 5034 Data: 03/01/2021 17:03:34
*
Amore impossibile
Cara,
ti ho sempre amato e lo sai. Ti osservo da sempre, ogni secondo, ogni minuto, ogni ora e tutte le notti sogno ancora un tuo sorriso, un tuo bacio o una carezza.
Non riesco proprio a lasciarti andare.
Adoro ogni cosa di te: gli immacolati rilievi, belli da guardare e da scalare e le vaste pianure intervallate da boschi profumati dove poter riposare. Amo quei rivoli d’acqua impetuosi che sfociano in oceani immensi, dove nuoterei come un naufrago in eterno; nei tuoi anfratti misteriosi e profondi invece mi insinuerei sì da perdermi in un carezzevole oblio.
Anche tu di certo mi desideri, lo capisco dal modo in cui mi guardi, e pur temendomi, hai bisogno del mio caldo abbraccio come prezioso ossigeno per vivere. Purtroppo so bene che, se provassi ad avvicinarmi, ti distruggerei, allora resto ad ammirare da lontano la tua inarrivabile bellezza.
E non posso accettare il fatto che molti uomini, fortunati ad averti accanto, non ti apprezzino quanto meriti, sporcando il tuo corpo e calpestando la tua anima.
Tu, amore, sopporti in silenzio, perché hai un cuore grande di madre che non rinuncia ad allattare i propri figli ingrati ed io mi chiedo: quando si renderanno conto dello scempio che stanno compiendo su di te?
Nonostante lo spazio che ci separa, sappi che io mai ti negherò l’appoggio ed il calore di cui hai bisogno.
Terra cara, ti confesso che per me resterai in eterno l’unico grande amore, la sola ragione per continuare ad andare avanti.
Per sempre tuo,
il Sole.
Id: 4902 Data: 27/07/2020 15:45:27
*
Cari professori
“Cari professori,
siamo arrivati al termine del nostro percorso scolastico, un cammino lungo il quale ci avete accompagnato giorno dopo giorno, sostenendoci anche nei momenti di crisi…”.
Era l’inizio del saluto che la classe quinta, sezione U dell’Istituto tecnico commerciale, rivolgeva a tutti gli insegnanti, in persona della rappresentante Martina, durante la cena di fine anno in un’afosa serata di giugno.
Fabrizio Tassi, professore di italiano, ascoltava emozionato, riflettendo a quanta fatica era stata fatta per accompagnare, in un viaggio non privo di scossoni, una classe che si era rivelata sin dai primi anni problematica, come non di rado accade ai giorni nostri: alunni con situazioni familiari complesse, studenti provenienti da altre scuole o con difficoltà di apprendimento, rappresentavano l’universo variegato di quel gruppo. A ciò si era aggiunto un continuo avvicendamento di supplenti, l’aggravante di una situazione già precaria.
Ne era risultata una classe non omogenea, diffidente verso i docenti e difficile da gestire, per le diverse personalità concentrate in un’unica aula. Fin dagli inizi di settembre il professor Tassi, appena nominato dal Preside coordinatore della quinta U, si rese conto che l’ultimo anno non sarebbe stato una passeggiata; era un giovane insegnante, ma la passione per l’insegnamento e l’empatia, di cui era naturalmente provvisto, gli conferivano un infallibile istinto nel valutare le dinamiche tra gli studenti.
Senza indugi prese in mano le redini del corpo docenti e prospettò la situazione soprattutto ai nuovi colleghi, che si trovarono ad affrontare una rogna tra capo e collo, neanche il tempo di varcare la soglia dell’istituto.
L’anno partì al ritmo convulso delle giornate scolastiche; entrare in quell’aula, era come mettere piede nel girone degli apatici: scarso interesse per le materie, poca voglia di collaborare e sostenersi reciprocamente regnavano sovrane. Nonostante l’intelligenza vivace della maggior parte degli studenti, sembrava che niente potesse veramente accendere il loro interesse.
“Cerchiamo di stimolarli al confronto, di proporre spunti di riflessione, ma non c’è niente da fare. Interagiscono poco tra di loro”, lamentavano molti colleghi nelle prime riunioni. Al termine delle vacanze natalizie, Fabrizio Tassi si decise. Entrò in classe e fece capire in modo chiaro ai suoi alunni che diventare grandi voleva dire innanzitutto assumersi delle responsabilità ed il loro atteggiamento non era certo da ragazzi maturi.
Il suo discorso cominciò a sortire i primi effetti nei giorni successivi, quando ci fu un via vai di studenti in sala professori che chiedevano di parlare con Fabrizio. “Prof., noi vorremmo collaborare”, iniziò timidamente la rappresentante Martina. “Il fatto è che alcuni compagni, tra risatine e prese in giro, ci definiscono leccapiedi”. “Ci evitano”, lamentavano altri. “Se chiediamo appunti o schemi, perché magari siamo stati assenti, veniamo accusati di essere lavativi e non abbiamo il coraggio di parlarne con voi insegnanti”.
Fabrizio rimase colpito dalle confidenze dei suoi alunni e si rese conto che il problema non era la volontà di studiare o l’impegno nei compiti. Il problema era la paura. Tanti anni trascorsi sui banchi non erano serviti a quei ragazzi per capire come lavorare in squadra ed avere il coraggio di esprimere le loro opinioni serenamente.
In qualità di professore si sentì responsabile della situazione, allora pensò di parlare alla classe a cuore aperto. “Il motivo per cui venite a scuola non è solo lo studio o il voto, ma soprattutto la possibilità di confrontarvi e crescere insieme, senza inutili condizionamenti”, esordì, sistemandosi con le dita i suoi occhialini rotondi. “Sarebbe bello che tutti vi sentiate a vostro agio e, in caso di problemi, non abbiate paura: alzate la mano, siamo qui per voi”.
Nel silenzio dell’aula i ragazzi si scambiarono parole mute, sottolineate per la prima volta da sguardi di complicità.
Durante i mesi successivi la quinta U cominciò lentamente ad aprirsi con i docenti e ad essere più coesa, mentre si accorciava, tra ansia e sentimenti di inadeguatezza, la distanza alla sospirata maturità.
Nel corso della cena di fine anno, Martina, con un lieve tremore nella voce, concludeva la lettera rivolgendosi proprio all’insegnante di italiano. “Professor Tassi, vorremmo ringraziarla per averci fatto capire che il valore delle persone non si misura da un voto, ma dall’impegno e dalla tenacia nel cercare di migliorarsi…Grazie per esserci sempre stato, dandoci la possibilità di diventare grandi e, se dovesse aver bisogno, non abbia paura, alzi pure la mano!”
A queste ultime parole Fabrizio ebbe un attimo di esitazione, sostenendo a fatica gli sguardi lucidi della tavolata stranamente silenziosa. Visibilmente commosso, riuscì solo ad annuire in segno di gratitudine.
Arrivò l’estate che si portò via gli esami di maturità e la quinta U. Quell’anno il professor Tassi si rese conto di aver imparato un’altra lezione grazie ai suoi ragazzi e crebbe in lui una consapevolezza: magari anche lui, prima o poi, avrebbe alzato la mano.
“Ricordando la scuola in presenza…”
Paola Salzano – Luglio 2019
Id: 4879 Data: 04/07/2020 18:32:23
*
Non mi basti mai
Alice giunse a destinazione in un’afosa mattina di giugno. L’attendeva una Milano assolata, priva di nubi, in contrasto col suo animo cupo, disperato, di chi è ancora al centro di una tempesta.
Era partita mezz’ora prima da Bologna, ripromettendosi di non cedere, ma quando il treno stava per giungere in stazione, non riuscì a resistere ed indossò gli auricolari del suo lettore mp3. La melodia di una delle canzoni di Lucio Dalla, “Non mi basti mai”, rese Alice ancora più inquieta e depressa: quelle note erano state la colonna sonora degli ultimi mesi.
Nel dicembre dell’anno precedente, appena assunta come ragioniera in un prestigioso studio di Bologna, non stava nella pelle per quell’inatteso impiego alla sua prima esperienza significativa di lavoro.
Il colloquio l’aveva sostenuto con Riccardo, uno dei soci dell’ufficio, dallo sguardo comprensivo e i modi cordiali, che subito l’aveva fatta sentire a proprio agio. Tra di loro la complicità fu istantanea, gettando le basi per un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia e sulla stima. I due si trovarono a trascorrere tanto tempo insieme; Riccardo chiedeva spesso il suo aiuto, mentre la donna accettava volentieri di seguirlo in commissioni al di fuori dello studio.
Pian piano Alice cominciò a sentirsi attratta da quell’uomo, di cui ammirava la caparbietà, la determinazione sul lavoro, nonché la disponibilità verso gli altri. Riccardo invece si perdeva in quegli occhi limpidi ed espressivi, quando lei gli parlava dei suoi progetti o snocciolava le ricette dei suoi piatti preferiti.
All’inizio della primavera sbocciò tra i due un sentimento fresco come una brezza d’aprile seppur impetuoso come un vento inarrestabile. Riccardo aveva circa trent’anni, era sposato e padre di un bambino di alcuni mesi, ma nonostante i buoni propositi non riuscì a resistere a quell’amore che stava per travolgerli: l’entusiasmo di Alice ed il profumo della sua pelle gli avevano rubato il sonno e il cuore.
Le uscite di lavoro si trasformarono di lì a poco in passeggiate romantiche, sotto gli interminabili portici di via Indipendenza, da cui si scorgevano le due Torri che emergevano dalla foschia cittadina come alberi di un vascello. Alice aveva l’impressione che gli antichi edifici la scrutassero dall’alto con fare inquisitorio, facendola sentire ancora più colpevole, in quanto era a conoscenza del fatto che Riccardo fosse un uomo impegnato.
Avrebbe voluto scappare, ma allo stesso tempo non riusciva a stare senza di lui. Ogni angolo di strada divenne l’occasione per sfiorarsi furtivamente e gli androni dei palazzi posti appartati dove potersi abbracciare e soddisfare, anche se per poco, l’urgenza del loro amore.
“Dovrei starti lontano”, le disse un giorno Riccardo, durante la pausa pranzo nell’ufficio deserto. “Invece ho bisogno di averti vicino, ho bisogno di te…”. Ricambiato da Alice si lasciò andare al desiderio represso, al riparo da occhi indiscreti e dal giudizio del mondo.
In un pomeriggio di maggio, mentre passeggiavano lungo via D’Azeglio avvolti dalla tenue luce dell’imbrunire, vennero cullati dalla melodia di quella canzone di Lucio Dalla, che proveniva dagli altoparlanti posti ai bordi della strada. Riccardo non poté fare a meno di seguirne il testo: “Vorrei essere l’anello che porterai, la spiaggia dove camminerai…così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai…Tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai…”
Si voltò verso Alice: “Chi ha scritto parole così intense, deve averle vissute almeno una volta nella vita”, osservò commosso. La donna ricambiò il suo sguardo e realizzò di non aver mai amato nessuno come Riccardo.
Sapeva però che lui non gli apparteneva. Ne ebbe triste conferma un sabato, quando, passeggiando per i viali dei Giardini Margherita con un’amica, intravide da lontano proprio Riccardo con a fianco la moglie ed il loro bimbo nel passeggino. Fece finta di non vederli, ma si sentì impazzire e provò un forte senso di nausea. Quell’incontro la riportò con i piedi per terra. L’indomani al rientro in ufficio, si mostrò sfuggente nei suoi confronti.
“Mi vuoi dire cosa ti prende?”, le chiese Riccardo appena ne ebbe l’occasione. “Non capisco…ti ho fatto qualcosa?”
Guardandolo negli occhi, Alice non riuscì a trattenere il pianto. “Mi dispiace, ho sbagliato tutto. Sei un uomo sposato ed io non ho alcun diritto di intromettermi nella tua vita”.
“Se è per questo, abbiamo sbagliato entrambi, anzi io mi sento un marito deplorevole. Ho intenzione di dirlo a mia moglie…”.
“Ma io non voglio privarti della tua vita, soprattutto di tuo figlio. Non riuscirei più a guardarmi allo specchio ed anche tu, con il tempo, mi vedresti come la donna che ti ha allontanato da lui”, replicò Alice con voce roca.
Riccardo la strinse a sé. “Non so cosa accadrà in futuro, ma so che sei tutto per me”.
L’indomani Alice, disperata, rassegnò le dimissioni e in lacrime scrisse un messaggio a Riccardo. “Domani parto per Milano, sarò ospite di mia cugina per qualche tempo”. Poi aggiunse: “Mi dispiace tanto”.
La mattina seguente Alice, seduta al bar della stazione, si aspettò di vedere Riccardo correrle incontro. “Che sciocca”, pensò. Così pagò il caffè e raggiunse il binario.
Il Frecciarossa fendeva l’aria densa ed afosa di Milano centrale, mentre negli auricolari sfumavano le note della loro canzone. Poco dopo la donna recuperò il bagaglio e scese facendosi largo tra i passeggeri; fu allora che vide sua cugina agitare le braccia per farsi riconoscere. Cercò di ricambiare con entusiasmo il saluto, nascondendo lo sguardo arrossato dietro gli occhiali da sole.
Poi le donne si avviarono verso l’uscita, dove Alice finse di ascoltare gli ultimi pettegolezzi di famiglia, ma già nella sua mente si insinuava, prepotente, il dubbio di aver preso la decisione giusta.
Paola Salzano (marzo 2019)
Id: 4868 Data: 14/06/2020 12:41:26
*
Quando la luna
Quando la luna incontrò il mare, avvenne in una notte di mezza estate.
Scelse un incantevole scenario, quello del golfo illuminato a festa di una delle terre più belle del sud Italia, che la guardava estasiato aspettando da sempre giorni migliori per i suoi figli.
Salutata la stella madre all’imbrunire, l’elegante signora si affacciò sul nitido cielo di luglio, indossando il suo vestito migliore: era piena, abbagliante, con i crateri in evidenza. Decisa a conquistare, si fece largo tra le luci della volta celeste, gettando lo sguardo verso il vulcano dormiente che, osservando sornione, le fece l’occhiolino.
Quando la luna incontrò il suo amante ne rischiarò l’ondeggiante superficie, increspata solo da una leggera brezza estiva e si arrese tra le acque in un abbraccio senza tempo. La sua immagine si riflesse nei toni dell’oro, del verde smeraldo e del blu argenteo in quello scorcio di mar Tirreno, offrendo, a coloro che ebbero la fortuna, uno spettacolo straordinario.
Quando la luna fece l’amore con il mare illuminò la cornice della storica città fondata col nome di Parthenope, dal lungomare alle auto in corsa, agli eleganti alberghi e ai ristoranti. Sull’isolotto di Megaride tutt’uno con la costa, l’antico Castel dell’Ovo, dagli imponenti cannoni di guardia, assistette pure lui all’evento; lui che nel corso dei secoli ne aveva viste di tutti i colori, arrossì di colpo, restandone però compiaciuto.
Nella notte magica anche lei era lì, ad ammirare quell’attimo eterno, appoggiata al muretto di una delle strade panoramiche della sua città. Con lo sguardo rivolto verso il cielo, la donna si rese conto che stavolta sarebbe stato difficile lasciare il luogo dov’era cresciuta.
Dinanzi allo spettacolo di terra, acqua e cielo uniti in un abbraccio senza fine, comprese quanto l’amore e la bellezza siano preziose ancore di salvezza, le uniche capaci di dare un senso al nostro essere, in questi giorni persi di paura e scoramento.
Paola Salzano - agosto 2016
Id: 4843 Data: 15/05/2020 10:56:01
*
L’isola
Nel buio della notte estiva, attenuato dal chiarore lunare, la bella signora era distesa sul mare, cullata dallo sciabordio delle onde ed illuminata da un manto di stelle lucenti. Lea, rapita, osservava da lontano quella magia.
Di fronte a sé l’isola di Capri appariva senza un’ombra di foschia, riflettendo nel Golfo di Napoli la propria l’immagine, in cui si distinguevano il volto di una donna ed il suo ventre distesi sull’acqua. La nobildonna era avvolta dall’abbraccio della sua corte regale: la penisola sorrentina e le isole di Ischia e Procida, che da sempre la osservavano con un fremito di desiderio.
Dal terrazzino sul lungomare, Lea assaporava gli ultimi istanti della sua vacanza oramai al termine; erano state settimane rigeneranti, avendo fatto scorta di affetti, di buon cibo e soprattutto di ossigeno, come definiva lo spirito della città che l’aveva cresciuta. Ogni anno vi faceva ritorno ed era un periodo irrinunciabile: finalmente poteva respirare l’aria mite, ma soprattutto l’ospitalità della sua gente. Era partita anni prima per realizzare un grande sogno, ma le radici le mancavano terribilmente; ovunque andasse, era sempre alla ricerca del calore umano che emanava quella terra del sud, spesso martoriata e denigrata, cui sentiva ancora di appartenere.
Scrutando l’orizzonte, la donna non riusciva a staccare gli occhi dall’isola, il luogo dove aveva trascorso tanti momenti spensierati, e d’improvviso fu pervasa da un’inaspettata nostalgia. Si rivide bambina quando, terminata la scuola, si imbarcava nei fine settimana con i genitori sul traghetto al molo Beverello, per trascorrere qualche ora di sole e di mare e tornare a casa all’imbrunire con il viso scottato dal sole, ma felice.
Ripensò poi alle giornate passate a Capri da adolescente assieme agli amici, abbigliata con canotta e pantaloncini, mentre assaporava la soddisfazione di sentirsi diva con i capelli mesciati dal sole ed il colorito caramello sulla pelle; sperava magari di far breccia nel cuore di quell’amico troppo timido per dichiararsi in città.
Le piaceva mischiarsi alla folla dei turisti stranieri sbarcati sulla rada di Marina Grande, per invadere quel territorio scosceso in tutti gli anfratti. Tra risate e giochi d’acqua, trascorreva le giornate sulla spiaggia di Marina Piccola, dall’altro lato del porto, dove lo sguardo si perdeva osservando gli scogli dei Faraglioni, da cui le Sirene di Omero tentarono Ulisse nel viaggio di ritorno verso Itaca. Ricordava ancora il sapore dei gelati alla frutta, gustati al tramonto nella piazzetta avvolta dagli aromi dei fiori capresi.
Lea ripensò a quanti anni erano ormai trascorsi da quando, euforica e determinata, era partita lasciando la sua terra. Allora si sentiva ancora una bambina, nonostante avesse già raggiunto l’età adulta, ma fino a quel momento aveva sempre vissuto nel suo bozzolo, senza mai assumersi grandi responsabilità.
Tutt’a un tratto realizzò di somigliare all’isola millenaria. Una parte del suo essere riluceva come le spiagge affollate d’agosto o le casette linde abbarbicate sulle rocce a precipizio; al contempo vi era in lei una parte sommersa, ombrosa, simile alle grotte di Capri, dove si diceva che spiriti dispettosi attendessero i turisti ignari.
Tante volte era andata a infrangersi contro gli scogli aguzzi, avendo imparato a nuotare disperatamente per scansare solitudine e pregiudizi, temendo a volte di affogare. Nell’esplorare i fondali oscuri, non di rado si era imbattuta in temibili creature, ma era sempre riuscita ad intravedere un appiglio da cui risalire per ritrovare la luce.
La donna si era appisolata sulla sdraio, complice una leggera brezza che le accarezzava il viso, smorzando l’afa serale. “Si è fatto tardi Lea, non vieni a dormire?” Dalla stanza una voce maschile la invitava a rientrare.
“Arrivo”, farfugliò, scossa dal torpore del breve sonno. Quella notte l’isola le aveva ispirato tanti pensieri; ogni volta che tornava a casa, Lea ritrovava una parte di sè. Ora però era tempo di spiegare le vele, non senza aver salutato la nobile signora, scenario di tanti momenti felici.
“Prima di andare, ti prego”, le chiese in una sorta di dialogo intimo. “Tu che da sempre proteggi questo mare ed i suoi figli, se puoi veglia anche su di me, quando sarò di nuovo lontana”.
Le lucine intermittenti che illuminavano l’isola sembrarono rivolgerle un cenno di saluto. Lea rientrò in camera, consapevole che anche stavolta il suo sarebbe stato un semplice arrivederci.
“Napoli per me non è la città di Napoli, ma solo una componente dell’animo umano che so di poter trovare in tutte le persone…”
(Così parlò Bellavista – Luciano De Crescenzo)
Id: 4636 Data: 01/08/2019 18:29:40