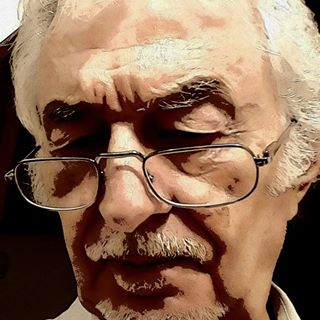|
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
*
Il plotone di esecuzione
Quel giorno lontano, quando fece parte, per la prima e unica volta, di un plotone d’esecuzione, Andrea, pochi istanti prima della scarica fatale, si chiese cosa pensasse il condannato in quel momento.
“Mi stai fucilando? Come può farlo, Andrea, amico mio?”. Ecco cosa stava pensando di sicuro Vanni Autieri, legato alla sua sedia, sguardo al muro.
Andrea, il suo migliore amico, aveva chiesto invano d’essere esentato da quel compito. Inutilmente. Non lo avevano nemmeno ascoltato. E ora era lì e tremava da capo a piedi inginocchiato in prima fila.
Né voleva proprio vederlo, il condannato, nella nuca o nella schiena. Così continuò a guardare, per quei lunghi attimi, solo i piedi della sedia a cui lo avevano legato. E si chiese se gli altri invece, il Vanni, lo guardassero tranquilli; gli altri, che lo conoscevano tutti come lui.
Poi per un attimo, ma un attimo appena perché la cosa era troppo orribile, Andrea si chiese come ci si deve sentire quando tutto quel piombo ti arriva dentro. Fra poco lo avrebbe saputo.
Nei giorni che seguirono si disse che non avrebbe più voluto ricordare quel momento.
Non voleva che questo dolore s’aggiungesse all’altro, che pure non trovava requie da mesi e solo lui sapeva. Lui che, quella strage di venti compagni, avrebbe potuto con più coraggio forse evitarla. Non era forse più colpevole di Vanni? Ma la sua responsabilità non era mai venuta fuori. Lui, per quella colpa, non aveva mai pagato: era rimasta una cosa solo sua, archiviata dentro di lui a doppia mandata, a far del danno.
Solo con la fine della guerra il dolore per quelle cose, non avrebbe saputo dire come, Andrea finì per dimenticarlo. Ma il dolore non si scordò di lui.
Avevamo fatto la Resistenza entrambi, anche se in due diverse vallate.
Dev’essere per questo che Andrea, il mio nuovo paziente, mi aiutò, senza volere, a mettere a nudo, per non dir di peggio, anche il mio cuore di psichiatra e a scriverne qualcosa. E così, pur sapendo, con Allan Poe, che scrivere di un “cuore messo a nudo” era impossibile e che nessuno oserebbe farlo o, ancora, che nessuno saprebbe scriverne se osasse, io ho immaginato di poterlo fare.
Ah, medice, cura te ipsum. Stefano, cura te stesso, prima ancora di curare lui!
Andrea mi aveva cercato un po’ di giorni prima. Non stava bene. Mi disse che da un po’ si svegliava quasi ogni notte in soprassalto, con un urlo soffocato – fucilate anche me! – e si ritrovava madido di sudore. Dopo di che si sentiva spossato tutto il giorno.
Occorre dire che lo avevo già incontrato una volta. Era stato l’anno prima, il nove maggio del ’45, il giorno della sfilata. Era un colosso, biondo e alto, e il lontano tormento in quei giorni pareva non lo toccasse più. I ricordi, per affiorare, hanno bisogno di silenzio. Per far tornare i tormenti, le mitraglie devono tacere. È allora, quando tutto tace, che non ce la fai più.
E anche quel colosso ora non ce la faceva più; aveva le gambe d’argilla. Il viso era pallido, gli occhi allarmati. Emanava da lui una pena angosciosa, alla quale la mia anima, credo, fece subito eco. Fu come una folgorazione: anch'io avevo ferite simili. Se si fosse fermato da me per anni, avrei fatto l’analisi a me stesso. Era, il mio, un disagio molteplice: diffuso come uno sciame che rannuvola l’aria settembrina, profondo come le mie radici, confuso come le parole che gli dissi. L’attaccapanni, la borsa, (posala pure lì), e un gesto senza parole che indicava la sedia su cui poteva sedersi. La mano che gli diedi, l’altra sulla maniglia, quella che mi diede lui, enorme, calda, sudata, i pochi passi per raggiungere la sedia.
Poi abbiamo cominciato.
E siamo andati avanti per due anni, fino a quando, improvviso, mi lasciò.
Non lo rividi mai più. Ebbi notizie, molti anni dopo, della sua morte dal giornale. Andrea si era sparato un colpo in testa nel suo studio di notaio. Le anime belle non reggono a certe cose. Per loro, ci sono fatti che restano sepolti per anni, ma poi chiedono il conto. Anche se Vanni Auteri aveva abbandonato il suo posto in combattimento per paura, lasciando scoperto il fianco dei compagni e meritasse così il plotone d’esecuzione, ecco… aver colpito a morte il suo migliore amico fu un ricordo che non lo abbandonò.
Quanto a me spero soltanto che mi avesse abbandonato per un altro psichiatra. Mi auguro che, dopo la nostra, breve, avesse fatto una seconda lunga analisi.
Di non essere, insomma, il solo responsabile del fallimento di una cura.
Id: 5146 Data: 06/06/2021 14:54:18
*
Fisi, la dea dai verdi capelli
Colori più intensi del normale. E voci. Nella testa e nel bosco. Un bosco che si svegliava; e con lui la collina e il mare. Mare che odorava come sempre, ma sorprendendomi ogni volta, al risveglio, con quella sua aria salata, mentre Fisi, la bella, volgeva, magica e indolente, come fosse ancora in sogno, le sue spalle, intorpidite dalla notte, alle pendici finalmente verdi dei suoi colli. Il suo occhio quieto, posato lieve a oriente, addolciva ritmicamente, con morbidi sguardi, e silenziosi, i chiari riccioli del mare, arruffati ancora, a quella luce, dal loro sonno notturno. Facevo quell’anno l’Università a Fileti, nel profondo mezzodì della penisola, e quel mattino io, Ismaele, ragazzo del nord, scendevo la collina come tanti. Una sciarpa rossa. Uno zaino sulle spalle. E tutto m’appariva come un paradiso classico, un paradiso che, con la sua faccia più bella, volgeva verso il sole, sì che il suo occhio, di nuovo antico e profondo, poteva carezzare, intenso, le valli più ridenti di quella terra che un tempo si chiamava Magna Grecia. E l’odore del mare, gli oleandri, gli ulivi, i miei pensieri e l'epoca in cui vivevo, mescolandosi, generavano in me un paradiso psichico, psichedelico quasi, che stava a metà strada fra l’antica Mileto e l’attuale Big Sur californiana, fra la primavera del pensiero filosofico e quella dell'Acquario. Mi dovetti arrendere a Lei. Per me la bellezza di Fidia, il pensiero d'Euclide e i dialoghi di Platone stavano ancora lì in quei sentieri scoscesi, dove prodigiosa mi avvolgeva, in quel momento, tanta malia, che portava il mio io a sentire tutto questo, invaso dall’inconscio, sedotto, vinto, plagiato. Ma di nessuno, che non vedesse quello che io vedevo, si può dire che conoscesse davvero Fileti. Splendide visioni, frattali incantati e luminosi, perché la venerabile Fisi aveva lì, in quel luogo incantato, davvero superato se stessa. E ora pareva che mi venisse incontro, mentre scendevo, con tutto il suo rigoglio e la perfidia di una donna mandata dagli dei. Ma forse la vedevo solo io. Incauto, ero felice di vederla. Di vedere chi, solo per togliermi ogni difesa, aveva reso Fileti, in quei giorni, una delizia per gli occhi. L’olfatto invece n’era turbato. Il piacere che traevo per quella via era troppo forte e, devo pur dirlo, indelicato. A maggio i fiori erano già esuberanti, per quasi troppa maturità, pur senza segni, ancora, di degenerazione incipiente. Eccitati dai violenti succhi di una terra generosa, mal diluiti da un’acqua scarseggiante, maturati anzitempo da calori tropicali, emanavano nel pomeriggio e verso sera un odore pingue, quasi osceno, che noi al nord non conosciamo. A maggio pieno Fileti s’avvicina al punto di trionfo, e ahimè troppo presto lo tocca. Per questo vi sosta torpida, in questo punto così pieno, più a lungo che può, come una donna ancora bella, tanto che pare voglia non lasciarlo più. Anche quell’anno era come se il tempo a quel punto si fermasse; immobile e riluttante a proseguire verso lo sfacelo: dei fiori, degli uomini, delle loro vicende. Volti tutti a nascondere i primi segni sottili della pienezza avanzata. E per un po’ lo potranno. Finché un infausto giorno un occhio distratto vi si poserà di nuovo, sbigottito e improvviso; e vedrà la disfatta ormai trascorsa, con la sua morte già pronta. Una vita si congeda. Spinta fuori da nuovi bocci e nuovi fiori, pronti a entrare dal basso nel pentagramma della natura. Scendevo dunque la collina, verso le solite lezioni. Ma non ero tranquillo. Sentivo qualcosa di insidioso, pur senza immaginare che il pericolo stava proprio in tutta quella bellezza, ossia in Fisi, che quel giorno incrociava il mio destino, ormai purtroppo in sua balìa. Stordito dai suoi profumi, annebbiato dagli effluvi opulenti, andavo incontro a lei che prendeva possesso di me ad ogni istante, sempre più. Fisi intanto risaliva il sentiero, ancora un poco addormentata. Vedeva da lontano dei giovani che scendevano. Addormentati anch’essi. Ad un tratto però qualcosa l’allarmò. Uno di questi era diverso. Aveva occhi febbrili, inappagati. Occhi penetranti, curiosi e un abbigliamento insolente, con quella sciarpa rossa sul nero del maglione! E non solo. Accadde qualcosa di più. Lei vide, da più segni, che il giovane, per un attimo, s'era anche lui bloccato, immobilizzato, allarmato. Tutto il suo corpo immobile e il viso smarrito mostravano che l’aveva vista, smascherata. L’esuberanza della vegetazione aveva ai suoi occhi ripreso per un attimo le forme divine della grande madre, il suo vero sembiante. Noi dobbiamo lasciarli qui, immobili entrambi. Lui che aspira a spogliarla, lei che si cela sempre più. Ma sappiamo chi dei due è il più forte e che Lei ha già emesso il suo decreto: “Questo giovane ha una smodata avidità di sapere, una fame insaziata. E quel suo passo! Cammina con lo sguardo lontano e perso del predestinato. I suoi occhi febbrili, inebetiti dai libri, non annunciano niente di buono. Bisognerà fermalo. Anche con misure estreme, se dovrò”.
Id: 5144 Data: 05/06/2021 08:02:28
*
Due ragazze
Il barone Von Klar si chiedeva spesso come mai fosse finito lì, in quell’opima e verde pianura, così lontana dalla sua Baviera, così diversa. A questa guerra non lo aveva richiamato la Patria: non era un ufficiale di carriera e ormai l’età per esser richiamato era passata da un po’. Eppure aveva lasciato i figli adorati e la bella moglie, valente pianista e figlia di una delle più illustri famiglie di Monaco, ed era venuto qui a combattere. Il perché non lo sapeva. Sapeva solo che dopo cinque anni di implacabile e fredda follia adesso era lì, a fissare impotente una pioggia finissima che da una settimana annoiava il bel giardino autunnale, e a riflettere sulla sciagurata prosecuzione di una guerra irreversibilmente perduta. Questo! Sì… questo, rimproverava a se stesso: di aver creduto al Führer. Ecco! Forse era partito perché aveva creduto in lui. Era un uomo mite l’aristocratico Von Klar, ma non con se stesso. E quello sciocco slancio sull’onda del ’40 vittorioso ora non se lo poteva perdonare. A questo pensava, con la preziosa tazzina in mano, la silhouette elegante, ancora giovanile, in piedi davanti alla finestra. Era mattino presto. E lui aveva appena terminato la prima colazione e la lettura di alcuni dispacci che erano arrivati la sera prima a palazzo Pallavicino. Ricordava bene il giorno in cui aveva requisito ai proprietari questo gioiello dell’architettura padana. Si era ripromesso come sempre di averne il massimo rispetto. Rispetto non dei padroni, delle cui idee politiche non sapeva nulla, ma di tutta l’arte e la bellezza che il palazzo conteneva. Aveva sempre avuto cura in quei mesi di non sprofondare sgarbatamente nelle poltrone, di non urtare con armi o altro i preziosi mobili, di non abbattere gli alberi più belli per accendere i caminetti rosa. Per questo aveva così disprezzo per il tenente Schwert. Sin dal primo momento che lo aveva incontrato lo aveva trovato bello e cattivo. E non aveva sbagliato giudizio. Non c’era arazzo, vaso, mobile che si fosse salvato dai suoi insulti. Talvolta si sorprendeva a immaginare un qualsiasi Schwert, un qualsiasi nemico invasore ottuso insediato nel suo castello bavarese. Lo stava facendo anche ora: lo immaginava mentre faceva scempio della sua biblioteca o imponeva, insolente, il fango dei suoi stivali ai velluti preziosi o squarciava con la baionetta i dipinti degli antenati. Lo immaginava intento a disegnare con l’acuminata punta di un temperino strategie di battaglia sul suo tavolo Luigi XIV. E stava ancora continuando ad immaginarlo in queste accurate devastazioni, quando i suoi lugubri pensieri furono malamente interrotti. Qualcuno aveva bussato alla porta con alcuni colpi secchi. Anche se deprecava quell’inutile ed eccessiva energia però non sobbalzò; si girò lentamente, e lentamente andò a posare sul vassoio la tazzina del terzo caffè di quel mattino. Poi si sedette. Solo dopo ordinò al subalterno di entrare… chiunque fosse. Purtroppo era Schwert, e ne provò fastidio. La pioggia non cessava da giorni e giorni, e il grande fiume si gonfiava sempre più. Il palazzo era stato scelto anche per quello: era vicino ad una testa di ponte. Nei pensieri di Von Klar quel lungo ponte altro non era che la lugubre via della non lontana ritirata ignominiosa. Sempre che i bombardamenti degli Alleati lo avessero risparmiato sino a quel giorno. Già lo vedeva percorso dalla lunga fila stanca dell’esercito in rotta o prigioniero, che camminava per inerzia, senza più capi, senza bandiera, senza più armi né insensate illusioni. Questi pensieri sembravano, al contrario, non entrare per nulla nelle giornate di Schwert, che entrò ancora una volta energico, ben riposato, e batté i tacchi con forza, come se fosse il primo giorno di guerra. Il barone lo invitò ad accomodarsi e gli indicò con gesto stanco l’altra poltrona di cuoio pregiato; ma dovette notare con fastidio che nel sedersi aveva, con il fodero della Luger, graffiato vistosamente il sontuoso bracciolo di destra. Schwert gli sorrise allegro: del graffio non se n’era nemmeno accorto. Prese invece subito a lagnarsi viziosamente del tempo e che da molti giorni non si andava in città in un buon ristorante e poi a divertirsi, magari con qualche donnina. Pensò alla moglie lontana, Von Klar, e non ricambiò il sorriso. La sera precedente era stata improduttiva per Vera. L’impiego sperato non era riuscita ad ottenerlo. Il commercio del vecchio Braibanti, che lei frequentava per sopravvivere, per sbarcare il lunario assieme a Bianca, non era più nemmeno sufficiente a mantenere i vecchi operai dopo i bombardamenti dell’estate. Era stato lui stesso a dirglielo con sincera mestizia proprio la sera precedente. Lei però si era concessa ugualmente a lui, anche se non serviva più a niente. Provava rabbia anche per questo e si levò dal letto indispettita. Bianca le aveva già preparato la colazione, dando fondo agli ultimi acquisti. Nemmeno sapeva, Bianca, come Vera si procurasse le cose. Soprattutto non sapeva che frequentasse anche i tedeschi. E che quel buon caffè, che ancora quella mattina lei beveva, veniva da loro, dai tedeschi, dal furiere amico di Vera, che lei, Bianca, mai avrebbe voluto nemmeno conoscere. Bianca era una patriota. Esile e fragile non poteva concedersi un impegno più concreto di quello delle sue idee focose, delle sue dispute violente, animate da una passione che la lasciava ogni volta stremata. Aveva sempre rifiutato gli inviti a cena in cui Vera tentava di coinvolgerla. Almeno avrebbe fatto un pasto decente ogni tanto, le diceva. Vera non capiva quella cocciutaggine così priva di buon senso. Diventava talvolta anche furiosa, quando l’amica non si rendeva conto che lei si sacrificava per entrambe. Cosa credeva lei… che lo facesse volentieri tutto questo? Ma lei amava sinceramente la sua amica Bianca e lo faceva con una sua forza fattiva e popolana. Si era assunta la silenziosa tutela di lei, il compito di proteggerla, almeno fino alla fine della guerra, se pure questa… una fine potesse ancora averla. No, questa guerra non sarebbe finita, mai e mai… solo le scorte alimentari finivano e su Braibanti non si poteva più contare. Restavano solo i tedeschi. Bianca doveva arrendersi all’evidenza che Vera andava a letto anche con loro. Così le confessò ogni cosa. – Non c’è più nulla da mangiare, Bianca, sii realista almeno una volta, dio santo! Non ti dico di andarci a letto anche tu, ma almeno… vieni almeno a mangiare. Renditi conto se non altro che, se fosse per te, saresti già morta di fame. Renditi conto da dove viene la roba che hai avuto sino adesso. E non credere che io mi diverta ad andare a letto con chi capita. E non ti dico questo perché sono tedeschi… perché io di politica non me ne occupo e per me son tutti uguali. Bianca restò esangue. Ma l’amica non aveva ancora finito. – Stasera Ludwig non può uscire se non in compagnia del suo maresciallo e mi ha chiesto di portare un’amica. Perciò ti prego, guarda nella dispensa e dimmi cosa intendi fare. I tavoli erano quasi tutti occupati quando entrarono il colonnello Von Klar e il suo ufficiale. E, peggio, era occupato il tavolo principale da quattro posti, vicino all’orchestra, che ogni volta era stato il loro. Ma non ci fu bisogno di chiedere; in pochi minuti venne liberato, come sempre. Piacevano queste cose a Schwert, lo facevano sentire vinci tore. Gli piaceva aver lasciato fuori l’autista nella notte ad aspettarli finché a loro piacesse. Von Klar ne era certo: erano queste piccole prepotenze ancora concessegli ad impedire a Schwert di vedere che la guerra era perduta. Nel microcosmo padano vinceva ancora lui: sui dissidenti, sui partigiani, sulla popolazione inerme. Conservava alto il tono della voce: il mondo era ancora ai suoi piedi. Raramente, ma talvolta sì, Von Klar lo aveva richiamato ad uno stile più sobrio. Inutilmente. Acconsentiva perciò a fatica, e sempre più raramente, a uscire con lui. Ma ancora una volta lo aveva fatto: la noia indubbiamente prendeva anche lui e così le gioie della biblioteca di villa Pallavicino avevano ceduto di nuovo il passo a un perdurante bisogno di vita sociale, sia pur falsata com’era dal servilismo mesto e timoroso che sempre accompagnava la sua comparsa, ovunque andasse. Ma questa volta dovette riconoscere che qualcosa era mutato. Sotto la scorza della solita obbedienza s’indovinava un’attesa: le notizie dal sud giungevano a tutti, e la società civile non poteva non pensare che fra pochi mesi la situazione si sarebbe capovolta. E quella sera il loro tavolo occupato e un diminuito timore, se non proprio un’ostentata indifferenza, annunciavano che il servizio e la deferenza nei loro confronti non erano più i soliti. Questo fece imbestialire Schwert. Si rivolse con furia al cameriere, un attempato e modesto ometto dalla testa pelata e lucida. La sua voce si udì in tutto il locale. Molti visi si volsero, numerose teste si alzarono. Nel tavolo vicino a loro una ragazza si fece dura in viso. Era bionda ed esangue, come una Walkiria triste e passionale. Era una delle ragazze che stavano coi due sottufficiali tedeschi. Gli stessi che erano scattati in piedi poco prima all’ingresso del comandante Von Klar. Schwert le aveva già notate: la bruna gli piaceva molto, una bellezza italica, un tantino sfrontata. L’altra invece, una ragazza gelida, sostenuta… quella no, quella lo irritava, con la sua aria di sfida. I loro sguardi s’incrociarono. – Forse alla signorina dispiace che io dia la sveglia a un suo connazionale? – le disse con malgarbo. Certo, le spiaceva. Non c’era alcun motivo d’inveire, il cameriere non aveva mancato nei sui confronti. La sua era un’arroganza gratuita da truppa d’occupazione. Questo pensava Bianca e glielo disse in faccia. Von Klar notò che Schwert era diventato livido e intervenne prima che la situazione degenerasse. Anche se Bianca aveva infine accettato d’uscire, non era stato senza condizioni. Aveva preteso da Vera, e con forza, che a tavola i due sottufficiali avrebbero evitato ogni accenno alla guerra. Ed era stata muta durante tutto il tragitto dalla loro camera al ristorante. Loro le avevano attese sulla porta, le avevano scortate al tavolo prenotato in buon anticipo, le avevano cortesemente aiutate a prender posto. Erano vicino all’orchestra. Bianca dovette ricredersi; i due erano davvero gentili. Notò in loro solo un tratto di disappunto: era stato quando erano entrati gli ufficiali. Le pareva addirittura d’aver sentito una mezza bestemmia uscire dalla bocca del furiere, mentre scattava in piedi e s’impietriva nel saluto. Il colonnello aveva risposto con un cenno del capo. Per fortuna, pensava il furiere, avevano quasi finito di cenare quando i due erano entrati. Perché da questo momento non si sentiva più tranquillo. Propose agli altri di terminare rapidamente e di finire la serata in un altro locale. Ma Bianca s’era infuriata con Schwert prima che fosse possibile evitare la temuta interferenza. Il colonnello pregò dapprima l’ufficiale di calmarsi. Lo fece sottovoce, a denti stretti, ma infine non poté evitare di comportarsi secondo il suo rango: così si alzò, si appressò alle ragazze, si scusò e le invitò al suo tavolo. I sottufficiali naturalmente erano esclusi da questa cortesia: una regola non scritta lo esigeva. A loro disse solo: – Spero che abbiate comunque terminato di cenare. Fatevi ancora portare vino e bevete alla nostra vittoria. Offro io. Bianca stava per rifiutare con alterigia, ma Vera le strinse un braccio sino farle male. Il furiere e il maresciallo si erano alzati. Ringraziarono il colonnello, dissero che era comunque l’ora di rientrare, e salutarono militarmente. La serata per loro era finita male. Nemmeno al tavolo degli ufficiali le cose erano tranquille: l’ira di Schwert era ancor viva e gli bruciava il petto. L’originaria attrazione per Vera era svanita; ora tutte le sue irose attenzioni erano rivolte a Bianca. La foga sessuale restava, ma aveva cambiato natura: ora voleva una vittima, voleva una donna da percuotere mentre la possedeva. Il bisogno si era trasformato in un’urgenza. Dimenticò la situazione e ogni prudenza. Dimenticò che c’era il colonnello e che il sesso doveva essere rimandato. Si rivolse freddamente a Bianca. – Io spero che un viso così angelico, quasi nordico direi, non nasconda simpatie per la parte sbagliata del suo paese. Ma Bianca non era meno gelida di lui. – Vi considero degli oppressori, molto semplicemente. E lo siete. Non si riesce più a vivere con il vostro fiato sul collo. Ma per fortuna sembra che i giorni dell’Asse siano contati. Von Klar rimase impassibile. Sapeva però che il furore del tenente sarebbe esondato. – Mi dia le sue generalità – le disse. – E anche lei – disse a Vera. – Via… via, non esageri – lo corresse invano il colonnello. Sperava di placare gli animi, ma non ci riuscì. Bianca già s’era alzata e gli aveva buttato in faccia i suoi documenti. Vera tremava come una foglia. E tutto si svolse in un attimo. Lo schiaffo pesante di Schwert si abbatté sul viso di Bianca, che si accasciò piangendo sul tavolo. Solo a quel punto Vera si riscosse. Il tenente non le garbava neanche un po’, ma occorreva recuperare. Così tirò fuori le sue armi. – Sei proprio una sciocca – gridò seccata a Bianca. – E lei tenente la scusi, è ancora ferita per la morte del fratello in Russia. Anche lei colonnello la scusi. Perché non ce ne andiamo in un altro locale? Ormai qui questa sciocchina ha dato abbastanza spettacolo. Ma Von Klar scosse il capo: no, lui non sarebbe andato. – Mi scuso anch’io, ma debbo rifiutare. Andate voi due. Lei tenente dormirà in città, immagino. Io accompagno la signorina Bianca a casa e poi rientro al Comando. Vera stava appiccicata al tenente. Gli serrava il braccio e accarezzava la stoffa del bavero. I suoi occhi dolci lo invitavano: volevano andare soli da qualche parte? Non andarono a ballare o in un altro ristorante. Lei conosceva un albergo dove avrebbero passato la notte, se lui voleva. L’aria era umida, ma non pioveva. Passarono fra le macerie di un quartiere bombardato da poco. Non c’era quasi nessuno per la strada. La strada stessa era un cumulo di detriti non ancora rimossi. Era stato ricavato solo un sentiero in mezzo ad essi, nel centro della via: a questo si riduceva una delle vie più grandi e prestigiose della città! Le venne più volte la voglia di piangere. Che stava facendo ora Bianca, così fragile? Quei maledetti la dovevano pagare. Poteva passar sopra alla politica, alle ingiurie private, alle offese che potevano fare a lei, ma la sua Bianca non la dovevano toccare. Si appoggiò ancor più al tenente, ma in cuor suo l’avrebbe fucilato se solo avesse potuto. Non era la prima volta che il portiere di notte la vedeva. Né era la prima volta che un tedesco dormiva lì con una ragazza. Di solito quelle coppie uscivano al mattino presto, e separate. Almeno questo!, chiedevano le ragazze. – Portaci in camera del vino – disse il tedesco. – E anche qualcosa da metter sotto i denti, – aggiunse Vera – qualcuno mi ha impedito di cenare questa sera. Bevvero un vino scadente e tagliarono pane e formaggio. C’erano anche alcune salsicce, ma erano piccole e dure e nere e non le guardarono nemmeno. Finirono il formaggio, poi bevvero ancora. Infine lei posò con calma il vassoio sul comodino, con le posate e le salsicce, il vino e i bicchieri. Poi cominciò a spogliarlo. Lui la lasciò fare; col vino la rabbia era passata. Poi si spogliò anche lei. Lo accarezzò sul petto, lo fece mettere bocconi e lo massaggiò sulla schiena. Fu allora che l’occhio le andò al coltello sul vassoio e, improvvisa, sentì una gran pena per la sua gente. Il colonnello prima di dormire baciò la foto della moglie e dei suoi due bambini, Hilde e Gerard. Lo faceva tutte le sere. Non li aveva mai traditi, mai. Anche questa volta si era comportato da gentiluomo. Aveva consolato Bianca, avevano cenato, le aveva parlato della Baviera, le aveva detto che la sconfitta della Germania era certa e che presto tutto sarebbe finito. Forse prima di Natale. Poi l’aveva accompagnata a casa. Lei aveva indicato all’autista la via da seguire per uscire dalla città. Loro l’avevano seguita ed erano tornati lenti al grande fiume. Il colonnello voleva che guidasse adagio e senza scosse. Quando entrarono nel viale del palazzo i fari dell’auto illuminarono le magnolie lavate dalla pioggia. Il colonnello osservò che le loro foglie quella notte erano lucenti come non le aveva viste mai. Prima di addormentarsi ebbe ancora un pensiero disgustato per lo sciocco Schwert. Solo la guerra tollera simili individui, si disse, le parti peggiori dell’uomo in guerra trovano cittadinanza e normalità e vengon fuori a frotte. Se gli eventi lo avessero risparmiato avrebbe dovuto affrontare la pace e allora sarebbe stata un’altra storia. La cantina era umida e buia. Bianca rabbrividiva. Non per la sua sorte, che forse aveva più volte desiderato, ma per Vera: col suo carattere impulsivo e fragile l’aveva trascinata in una guerra che non era la sua, in un’avventura che l’aveva portata a morire. Chi l’avrebbe immaginato? Nessuno, eppure per la sua sciocca impulsività gli eventi erano precipitati quella notte. Solo un giorno prima erano affamate e libere: lei politicizzata e sulle nuvole, Vera il suo contrario, disimpegnata e pratica. Poi per amore Vera aveva ucciso. Solo per amore di lei? Bianca sperava di no, sperava che ad armare la sua mano fosse stato anche il desiderio di uccidere l’oppressore. Nel pieno della notte se l’era vista piombare in camera scarmigliata e paonazza: – Gli ho tagliato la gola a quel bastardo! Svegliati, scappiamo. Del portiere non mi fido, mi conosce, di sicuro a quest’ora avrà già trovato il tedesco morto. Dai, vestiti! In stazione domattina presto una corriera per la montagna dovrà pur passare. Intanto dormiremo nella sala d’aspetto. Forse abbiamo qualche ora di vantaggio. Questo tempo non lo avevano avuto. Due ore dopo erano state catturate. Vera aveva confessato il suo gesto, quasi con fierezza… era colpevole, ma solo lei, Bianca no, Bianca dovevano lasciarla andare, Bianca non c’entrava. Bianca era solo una sciocchina che non riusciva a tacere. Una stupida, ecco cos’era! Ma non era servito a nulla. Le avrebbero fucilate il mattino dopo, tutte e due. Parlarono tutta la notte di come la vita si era divertita a capovolgere ogni cosa. Al mattino dopo la guarnigione si risvegliava pigramente, mentre loro percorrevano il lungo corridoio verso l’uscita. Alcune porte sul corridoio erano aperte. Dentro gli uffici c’erano anche delle camicie nere. Uno si lamentò che toccasse sempre a lui fare il caffè. Parlavano di turni, di comandanti fetenti, di stagione del cavolo. Davanti al muro si presero per mano. – Ciao Vera. – Ciao Bianca. Lo sguardo di Bianca cadde sulle mani di Vera. Quelle mani forti avevano ucciso un tedesco. Era piena d’ammirazione. Lei non sarebbe stata capace di tanto. I loro corpi caddero uno sull’altro. Vera aveva ancora il vestito buono, quello indossato al ristorante. – Una puttana di lusso – disse una camicia nera, e sputò in una pozzanghera. Stette lì ad osservare il suo sputo, i cerchi concentrici nell’acqua e, senza motivo, rise. – Se stasera non piove, a puttane ci vado anch’io – disse. E accese la prima sigaretta del mattino.
Id: 5140 Data: 03/06/2021 22:11:13
|