chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Giovanni Baldaccini
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
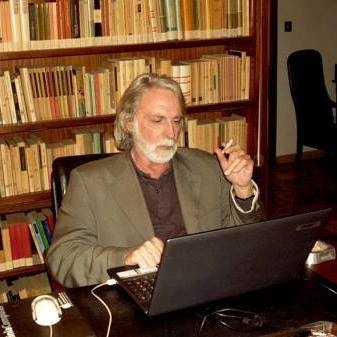
*
L’ortolana
L’ortolana del podere accanto, con cui intrattengo una corrispondenza, mi scrive di carote e di zucchine. Legumi, anche (leggi fagioli, lenticchie, pisellini (ed insalate possibili alternate). Ovviamente patate.
Splendidi minestroni, dunque, con relativa indicazione di ricette, cui ricambio con notizie frammentate relative ai miei fantasmi preferiti (leggi Mozart e Bach). Libri, stralci, biografie, manuali, spartiti (che non ha letto, non legge, non leggerà, essendone incapace). Compenso con invii di dischi tratti dalla mia collezione, con preghiera di copiatura e restituzione (pronta, immancabile, immediata) sperando che le orecchie siano meglio degli occhi che non ha. Tuttavia, non ke dico poi molto: le mie disquisizioni matematiche che seminano note di passaggio, potrebbero confonderla.
Una signora fragile di mente, ritirata in campagna per bisogno, avanti nell’età (nemmeno tanto), ma senz’altro con gli anni, piagati da dolore e inconsistenza (d’altronde di questi tempi privi di ogni tempo chi non potrebbe esporre piaghe simili?)
Lei non se ne vergogna e la sento mormorare nella sera, al fruscio senza suono dei cipressi che svettano nella campagna intorno dove spesso si concede passeggiate, la sento mormorare – dicevo – con i soliti uccelli che la seguono (alcuni sul sentiero, altri le cime) di vecchie storie d’abbandono e peggio che evidentemente non trascura: lei coltiva frammenti.
Bisognerebbe, dico bisognerebbe (ma non ne ho alcuna sicurezza) sussurrarle con garbo che i figli prima o dopo se ne vanno ed i mariti transitano, come la morte insegna quando scavalca il mondo e porta altrove.
Tuttavia, i fagiolini di cui scrive sembrano alquanto integri e mi piacerebbe provarli, prima o dopo, a contorno di pesce, se solo lei pescasse.
C’è infatti un fiumiciattolo qui intorno (che suppongo casa di trote) frequentato dai suicidi del quartiere estremo della città al confine. Io lo conosco bene, per vecchia frequentazione d’altri tempi (di cui non intendo tuttavia dare alcun conto), le ho suggerito - dicevo - vivamente di evitarlo.
Scorre, però, lancia frastuoni scavando nuove strade tra i suoi sassi, con cascatelle e salti di giornata, adatte (credo) ai prossimi assassinii. quando vorranno cancellare i fatti che li rendono tali. Ma nello scorrimento lancia voci e chi le ascolta apprende cose di cronache cancellate, almeno per alcuni. E mulinelli, gorghi, piantagioni (dintorno) di cipolle che servono per piangere. Ovviamente salici.
Quanto a me, dalla casa in cui non vivo, la osservo per inganno di me stesso, fingendo di avere almeno qualche cosa (osservazioni, dico, e passi di pensieri) diverse dai miei soliti maneggi di musiche di tempi sorpassati. Ma che si vuole, il tempo se ne va, e a un ascolto attuale, con lui la musica.
Le scriverò di spegnere la radio (o per lo meno di tenerla bassa) per evitare quelle cose orrende che inquinano quest’aria già inquinata con martellanti ripetizioni di non senso.
Tuttavia mi correggo: le scriverei, se soltanto esistessi.
Id: 5972 Data: 04/02/2026 16:00:49
*
Lettera dai bisbigli
Dall’angolo di un letto, sorella cara, ti scrivo.
Terzo giorno di pioggia di frammenti: non mi ritrovo più. Non so se sono sasso o sono stella, se suolo o fumo, filo d’erba o candela, oppure latte d’asina o un bicchiere. Spesso mi bevo il sonno.
Bagliori. Ancora mi rammarico degli anni: li ho passati cadendo.
Riparavo pensieri. Sai, sono cose inutili, ma un poco ci sono affezionato, come alle passacaglie, ai miei limoni, agli sputi sul selciato che mi ricordano che gli dei non hanno cura: la mia asma, il bruciore.
La mattina biscotti: non mi sono mai piaciuti. Non so perché continuo a farmi del male. Poi non scivolo notti. Al massimo mi siedo ad aspettare.
Vado a letto di giorno, ma in questa confusione si aggiungono elementi non chiariti e la tenebra moltiplica se stessa come una forma d’acqua.
Non distinguendo ombre, il tempo non comunica passaggi: consuetudine e caos, vecchi argomenti.
Il tempo è come un cerchio dentro l’acqua dopo un sasso: si espamde e poi scompare.
La natura è un inganno prelibato quando trasformi l’acqua in idromele. Un inganno assetato.
I tuoi figli collimano col senso? Io non ne ho avuti e passo da un’epigrafe a un sasso. Vado indietro, ma non mi aspetto di ricominciare.
Quando la notte viene nell’inverno, il mio cortile si trasforma in dubbio e i germogli diventano bisbigli. Vento, o forse la follia. Abbiamo dissipato? Questo mi sembra certo.
Notti da est rovesciano le stelle e il Sagittario scaglia dardi freddi sulla terra e dintorni. Garantiremo ad altre formazioni di fare delle ceneri sarcasmi? Questo mondo non è un teatro serio, ma tu non darmi credito.
Appena puoi, mandami una passione da scordare. Ne ho consumate a dismisura, ma le ho perse di vista.
Mandala verso un tardo pomeriggio, quelli sul lago, senza confusione. Mandala, senza rumore.
Ti bacio sulle punte dei capelli, i seni e gli anni morti.
Tuo Plinio, prima di sera.
Id: 5923 Data: 26/09/2025 10:59:24
*
Qualche volta la sera
Scivolare indeciso.
Profondevano intanto spazi alterni: nubi. E l’azzurro in declino.
Più che altro di fondo. Nessuno crederebbe che cammina, ma la terra sommuove le certezze: rotola, gira, svolge formazioni. E il mantello di fuoco. Impossibile sostare.
Certe volte vorresti accarezzare qualche ricordo brado; altre, strangolarlo. Non ci puoi fare niente. S’aggiusta non si sa da dove. Salta.
Chiedevo l’altro giorno: ce l’avresti un cerino?
Quello mi guarda ottuso, come se avessi chiesto informazioni quantiche. Più o meno esatto. Spiego.
La fisica quantistica scompare. Cioè, si fonda su uno strano fenomeno di comparsa/scomparsa: c’era e non c’è. Riappare.
Senza capire dove (significa dovunque), nei luoghi più impensati del Castello. Questo vuol dire che Kafka era un quantista, perché da lui tutto e niente. Comunque incomprensibile inspiegabile e tuttavia chiarissimo. Solo, non si può dire.
E neppure un cerino. Quantisticamente corretto, suona provocazione per l’ingegno corrente: i cerini, praticamente, non esistono più. Essi sono un pensiero atavico, un retaggio, una squalifica del pensato esatto. Sommuovono il tempo rendendo il passato presente o il presente inconsapevolmente nel passato. Dove i cerini? Intrusi! Degli esistenti pallidi a scomparsa. Ne deriva che la fisica quantistica non è molto diversa dalla vita.
Però tu spandimi, qualche volta dovunque.
Evoluzione delle conseguenze: immaginare il tempo. Ma anche involuzione. Siamo infatti sicuri che le conseguenze evolvano? Se partiamo dal fatto che nascono da un evento che precede, indubitabilmente la risposta è sì. Ma se aggiungiamo a quel fatto che l’evento precedente spesso non era minimamente volontario, dove l’evoluzione? Se la motivazione è involontaria essa è allo stesso tempo inconscia e dato che l’inconscio non ha tempo, ecco che l’idea dell’evoluzione cade. Chiarifico con una formula: no time = no evolution (ho usato l’inglese perché fa più scientifico). Dunque il DNA è un idiota. Con ciò si dimostra il caso.
Anche il fatto del cerino non è soltanto cera. Infatti, se per me il cerino è un concetto possibile e per un altro no, ecco che tutto dipende dalle immagini con cui ci rappresentiamo il tempo. Nel mio reale il cerino esiste, ma anche la smentita. Dunque l’immaginario è instabile, insicuro, inaffidabile. Un paradosso paradossale astratto: funziona solo se condiviso. Ma se devo assuefare la mia immaginazione a quella degli altri e immaginare il sempre immaginato, che immagino a fare? Davvero il linguaggio è una convenzione, ma la lingua appartiene al relativo.
Spalmami una linguata sulla faccia e butta via.
.
Arabescavo forme non costanti su un quaderno di latta. Come gli Egizi, quando volevano che qualcosa rimanesse (magari era oro, ma non ce l’ho). Una piastrina al collo: quella resta quando il collo scompare.
Arabescare.
Pennellate di cosmo sull’azzurro, vento solare in giallo: evaporare.
Deviante, questa forma di vento, spando palmeggio cocchi nei palmeti, mentre in Russia fa freddo. Datteri i reggiseni delle donne. Artico altrove. Lì: pellicce (i seni te li scordi),
Paglia al sole. Mentre il pianeta corre l’avventura che non conosce attimi, intrecciavo colonne di fumogeni quando la notte arriva ed i covoni: qualcosa da bruciare. Chi s’accorge del fumo da lontano mentre la terra scivola galassie e involontari luoghi di distanze nei canti che non vanno oltre frontiera? E balli. E disperata sera, quando togli la mano e mi scomponi.
Slinguami con la lingua sulla lingua. Non basta.
La sbornia è un argomento da comete: viaggia da un luogo all’altro. Quando mi sveglio sogno.
Altalenare.
Io ti darò la forma di una porta dove chiudere il mondo. E vuoto all’altra sponda.
Passeggiare la sera è una passione. E la madonna in mezzo alle candele.
Velo sul capo, i passi di una madre: bella turchina abbindolante sera. Cataste le parole, ma non seguivi il senso: le cantavi.
Intanto mia nonna si inginocchia e gli bacia la mano (al prete). Quello, soddisfatto, la aiuta a rialzarsi (però ci si doveva inginocchiare!) Al paese, come in ogni paese, tanti anni fa..
Io circondante assaporavo il buio delle pietre. Angoli la mia strada; tu passavi. E le stelle distanti tra gli spicchi delle case piegate, come l’occhio che si restringe in alto. La realtà è un messaggio quando muore. Finché la vivi scivola.
Avevi un orologio malinconico: immane immensa enorme nostalgia.
Portami qualche volta alla deriva e frangi questa forma in promontori, verdi come il sollievo.
Id: 5908 Data: 25/08/2025 22:58:15
*
Lettere da lontano
Mia cara, non credo sia possibile rientrare in terra di Provenza, dove l’azzurro di lavanda indugia sui miei tratti assonnati; né in Luberòn, dove la terra sale ed i paesi sono monti di pietra. O la Camargue, dove abita il vento dal mare che mi sparge dove soffia. Né penso torneremo in Normandia, dove i gabbiani aspettano le anime e il freddo mi scolora.
Non credo sia possibile rientrare nella città Parigi, dove l’arte sconvolge i lineamenti della gente che passa e li trasforma in briciole d’umano sospese nell’eterno di colori nel soffio che sostiene i miei pensieri né mi lascia cadere.
Non credo rientreremo più neppure dove siamo noi stessi, che per farlo ci dovremmo ritrovare mentre siamo dispersi al limite di un male che sconvolge chi lo pensa e chi ignora.
Non credo in un soccorso, che l’evidenza sbriciola le facce che il mistero sommerge rendendo più spiegabile l’assurdo volto ora per ora a rinnegare la verità presunta. Che non esiste, come tu ben sai.
Ti spero in un senso di nessuno.
Ho preparato un salto di giornata, ma non mi arrivano lettere dal tempo e dunque non mi posso abbandonare prima di un chiarimento.
Ho preparato un salice, un sasso, un vento alto per non scuotere troppo.
Un recapito a Berlino, sperando di riuscire a agevolare la mia posta smarrita dove la sera scrive le sue ore senza avere una busta. Ed il cancello è chiuso.
E la cassetta è vuota. E mi chiedo di noi, vecchi scrittori, inserendomi in un elenco ingiusto per non perdere il passo.
Questa stupidità senza parole mi impedisce di ricevere notizie, ma so che in Grecia si prepara un atto di una nuova tragedia. Non è tragico questo?
L’ho saputo da un buco aperto in un pensiero. Parlava di un ritorno. Per questo non mi scrivi: non c’è tempo nel tempo.
Tu visualizzi gli angeli all’entrata del mio ultimo bosco. Sorge sul limitare di campagna. Ha querce, lecci, olivi trascurati. Salendo, un castagneto e sotto quel che resta sempre sotto.
Mi riconosceerai?
Id: 5889 Data: 19/05/2025 14:09:44
*
Dai diari di una notte
Quella notte abbiamo dormito in un ostello.
Viaggianti, pellegrini, carovane. Arabi, anche. D’ogni tipo la gente, d’ogni variazione.
Gli asini e i cammelli ammassati nello stanzone in basso. Terribile la puzza.
Stoffe, colori, grida, voci, suoni. Qualcuno ha un flauto dolce; quasi non si sente.
Lei riposa.
Pallida; forse un po’ di febbre. Presto partorirà. Per questo, trattamento “privilegiato”. Significa una stoffa a divisione dagli occupanti (molti) della stanza. Paglia a terra.
I proprietari fanno il giro delle camere; portano qualche scodella per chi può pagare. Per l’acqua bisogna provvedere da soli.
L’ostessa è enorme; lui esile. Sono sporchi. Il flauto tace.
Oltre nella notte. Impossibile dormire.
Verso mattino.
Smania un po’.
Sono tempi terribili. Costretti alla fuga (come d’altronde sempre) quasi fosse una guerra. Erode vuole bollarci tutti. Inseguiti? E quando mai…!
Tentativo di ricomposizione: siamo nati frammenti.
Dio se ne è andato in luoghi più sicuri, ma se è dovunque, soffre.
Su un fianco. Non credo faccia bene al bambino. Provare a rigirarla un po’.
Tra l’altro: non si vedono stelle.
S’affaccia la “Padrona” (vuole essere chiamata così). Dice che è poco all’alba. Dovremo andarcene: il fitto scade.
Allargo le braccia.
E sale il primo disco: luce appena. Io non ho più pensieri.
Poco dopo. Sveglia. Il suo disagio è enorme. Grida.
Quella torna “Allora…!?”
S’accalcavano in molti.
Qualcuno porta doni; altri, curiosi, chiedono se abbia un nome. Poi, congratulazioni, auguri, risatine. La “Padrona” è seccata; ci deve far restare ancora un po’.
Più tardi: rade gocce dal cielo.
Dunque piove. Da queste parti quasi un miracolo.
Ed ora sono a Roma, in forma d’uomo morto.
Sono a Roma e sono morto, anche se a Roma resta il tempo intero.
Nasce domani.
Id: 5886 Data: 16/04/2025 10:03:58
*
Monica o della sera lunga
Mentre sera si piega: detergersi alla fonte.
Quindi spandere smalto. Virginale e composta, cose che certamente non è.
Ritrarla, anche (senza che si sappia). Appena sfumature di colori. Lievi, indecifrabili, indecenti.
“Meriggio”, direi: il nome del ritratto. Si, mi sembra appropriato.
La mia depressione? Procede benissimo.
Più tardi.
Notte, come forma di notte. Occhi a soqquadro persi nelle stelle. Amarla? Dovrei essere pazzo.
Al campo.
Codazzo di ufficiali. Lei: irreprensibile. Gentile, tiene tutti a distanza.
Fila di smalti avorio = sorridente. Leggera la sua voce. Scivola nell’aria, mentre quelli schiamazzano.
Breve la sosta. Domani riprenderemo il viaggio verso Susa. Quando saremo là:, strade diverse.
Perché pensarci ora?
A cena.
Quelli farneticano di un mondo ai loro piedi. Lei presta ascolto. (Detto per inciso: non gliene frega niente!)
Olive e frutta. Pane spalmato d’olio = tenersi leggeri. Domani si cammina.
Uno di loro azzarda. Lei lo fulmina col gelo che ha negli occhi.
Quelli continuano. Vino, risate, a volte oscenità. (Truppa, come sempre la truppa). Osservare con condiscendenza (non sanno che sono il nipote di Alessandro).
Rivolta verso me. Cos’hai Lampone?
(Con appena un sorriso): Mio zio mi ucciderà.
S’intrufolava a tratti: luna azzurra. Più in basso, vento fruga betulle.
Si apparta con due generali.
Ritrarla. In pose sconosciute (tratti, più che altro). Titolo: “Frammenti”.
Depressione a spasmi altalenanti.
Accostato da capocomico assonnato. Dove te ne andrai, Lampone? Qualcuno che ti aspetta?
Già!
Quindi perplesso. Domani ci muoveremo verso Susa; Babilonia non è poi distante.
Strade pericolose; il rischio di predoni è sempre alto. Non ti conviene viaggiare da solo.
(Fingere un interesse che mi manca).
Quindi continua. Qui si rischia di sciogliere la compagnia; sono tempi difficili. Susa è occupata (come la maggior parte di tutte le città – dico io). La gente ha paura; la sera non esce; si barricano in casa. Stupri di notte (e di giorno – dico io) e l’incertezza è enorme: nessuno vuole spendere.
Non ti conviene andare da solo; potresti restare con noi.
Sarebbe un diversivo (continua). Ad esempio, declamare poesie mentre ragazze danzano velate (e senza – dico io). Suono di flauti, cetre, voci lievi. Pagano bene se li fai languire (gli uomini di Alessandro). A farli ridere ci pensiamo noi.
Ci penserò, Ipponatte. (Ho già pensato).
Oltre sera (= quasi notte). Ritorna.
Si chiude nella tenda.
Ritrarla. Titolo = “Velarure”.
La mia depressione è cielo. Sfiora la luna. Torna.
In cammino.
Bestie cariche di tendaggi (servono per le scene) e otri (servono per le sere). Procediamo lentamente. I militari sono già più avanti.
Ipponatte (di nuovo). Dicono che forse si potrebbe avere un teatro coperto. Sarebbe più sicuro… Verrebbe gente. Allora, che hai deciso?
Tirare su col naso. Intanto speriamo di arrivare.
Lei si accosta. Ha piedi bianchi con calzari rossi attorcigliati intorno alle caviglie.
Più in alto cosce avorio. Immaginare.
Voce roca di sole, accenna appena. Dunque, Lampone, che farai?
E tu?
Id: 5885 Data: 14/04/2025 16:23:03
*
Lettera alla Pizia
Ah Signora,
le tue tabelle di divinazione danno un responso esatto se è vero che non sanno cosa dire e spetta a me rivestire d'assurdo e di spavento l'insopportabile pianificato stare del sole e della luna, quando il vento si ferma e la sua voce suona come il vuoto.
S'affaccia il giorno e la montagna è piatta, senza neve d'inverno o primavera, alba tramonto sussurrata quiete. Tempesta quando occorre o la ganascia sordida del sole brucia covoni e donne, quando è estate. L'uva langue ed io non ho più vino.
Dunque come potrò ignorare il mio disagio se gli ulivi dimenticano il mare e l'olio sa di acqua - ah Signora - tu non capisci la disperazione quando il bicchiere è colmo di mancanza, perché dormi nei tuoi fumi d'oppio di cui non dai notizia a noi mortali altro che nelle notti che dispensi e bevo per interposta droga un po' di te quando ti aspiro e frano nel mio corpo e nei raggiri dove è obbligo stare.
Diversamente inutile tra noi, tu navighi l'oltraggio della mente, versi inermi, assoggettata folla al tuo delirio. Propaghi; ed ogni dispersione sa di latte - come le vacche invitano - tra l'invidia di capre e dei formaggi al monte - io dilaniavo lupi - e l'universo ride di questo nostro affanno, cui ci consegni e fondi - mia Signora - senza dare risposta.
Ti ripensavo l'altra notte: una impossibilità. Sarà che nel tuo dire che è silenzio la risposta è l'assenza? Dunque perché cercare? Fattivamente il popolo non cerca e si inebria di bicchierini e pasticchette, dalla minore età all'oltretomba. Solo noi dispensati abbiamo il vizio di porre le domande per difetto, ma ho capito che il tuo non dire è dire: non c'è nulla da dire.
Ci avviciniamo al carico d'autunno dove la primavera dorme il suolo e l'inverno s'appresta a congelare. Mi sveglierò domani?
(Tratto da "L'appuntamento", libro libero La Recherche)
Id: 5848 Data: 04/01/2025 15:20:02
*
Roma-Nazaret-Roma
Ho perso tutte le guerre. Ne avessi vinta una sarebbe stato un disastro.
Nei vicoli la sera: pieno d’anime.
Le guida la Madonna ma non può mai condurle in Paradiso. Restano sulla terra. La sera. Nei vicoli.
Quando s’accende qualche finestrella ne intravedi qualcuna. Tremula, come il giallo sui vetri.
Il selciato non dà molti problemi: scivolano.
Ferite? Molteplici, ma non è quello: non esiste alcuna guarigione.
Roma una volta stava alla Madonna come il mio andare sempre alla stazione senza partire mai.
Ci vado per vedere qualcosa che si muove. I treni si muovono quando partono; quando arrivano si fermano.
Roma è un arrivo: non si muove mai.
La musica se ha quattro movimenti mi fa perdere il fiato. Se ne ha tre mi sofferma. Due generalmente cado. Se uno respiro.
Roma è un silenzio tragico. La notte suona ma non suona mai.
Alla stazione sbuffo. Lo faccio al posto dei treni.
Poi, da S. Angelo al sonnifero bastano pochi passi.
Le anime vengono dalla guerra: sono gli sconfitti.
La sera ci sediamo a tavolino e raccontiamo storie mai successe. Se fossero vere sarebbero solo fatti.
Le inventiamo, le selezioniamo, le consideriamo.
Lei non siede con noi.
Le anime non stanno mai nei fatti. Vivono condizioni alternative; per questo non le vede nessuno.
La ritroviamo quando torna sera.
A volte soggiorno nel dissesto. Quattro sedie, una notte.
Il dissesto è un elemento instabile: ruota dentro la terra. S’insedia, spesso.
Quando s’insedia la rotazione sposta l’asse della coscienza. Questo succede a tutti gli spostati: la follia non è un caso eventuale. Ha ragioni profonde; ti sprofonda.
Nel dissesto gli orologi perdono forma e stabilità. Che ore sono? Che razza di domande fai!
Ovviamente le sedie sono sghembe e il tavolino scivola un pavimento roso dalla morte. Che tuttavia conferma qualsiasi rotazione della stanza. Essa è un dissesto stabile.
Roma è morta?
.
Da Roma a Nazaret sono quattro passi: è sufficiente un cambio della strada.
Questo vuol dire sporgersi. Non è difficile: basta lo sconcerto.
Lo sconcerto è sorpresa: ti trovi dentro quel che già sapevi senza sapere già.
Dunque ti guardi. Nazaret sta nell’osservazione.
La Madonna stava sopra i muri.
Stava sui muri, stava sotto i muri. E le grazie, ricevute e sperate. Roma è una grazia sperata, come Nazaret. Come Nazaret spera.
Ci sono speranze e speranze. Io vivo insieme a quelle disperate.
Le speranze non muoiono mai. Per questo sperano; per questo sono disperate.
Poi uno diventa vecchio e comincia a pensare certe cose. O certe cose cominciano a pensare te.
Ci sono e ci rimangono: nella testa. A furia di pensarle, ti viene il mal di stomaco. Esempio di pensieri (nello stomaco): magari ho un cancro?
Poi pensi che ti resta ancora un po’ di tempo. Tempo che non vorresti. Quando tu c’eri, non mi sarebbe bastato l’infinito.
E allora cerchi di trovare vie di scampo, sapendo perfettamente che non ne esistono. Però cerchi.
Forse una combinazione. Si tratta di aprire le porte del cielo: la casa della Madonna.
Nazaret era sporca.
Si fermò ai margini. Succede sempre così. Lasciato ciò che andava abbandonato, si addentrò nei vicoli contorti. Era un luogo o una mente?
Lei sapeva come. Sapeva anche quando, ma non poteva dirlo. Non si può cambiare ciò che siamo, anche se siamo noi che lo facciamo.
Si nasce nel corpo; si muore nello spirito. Lui era nato nello Spirito; sarebbe morto nel corpo.
L’acqua non si trovava spesso; bisognava prenderla quando capitava. Lei era lì. La seguì fino a casa.
Dentro c’erano sette figli.
Lei mi guardava sconsolatamente. Poggiò l’acqua su un banco. Poi accese il fuoco. Si mise ad impastare non so cosa.
Poi mi fà: non esiste una grotta.
Più tardi. Comincia a venir sera.
Nel senso di un racchiuso impedimento
Mia cara,
è in arrivo qualcosa, probabilmente l’ultima, e noi siamo sguarniti di parole.
Il tempo che non lascia alternative guida la terra verso un altro addio. Molti ne ha già vissuti ma noi non eravamo e forse non ancora.
Si sussurrano avvisi: dai piani più profondi.
Ma la linea è estremamente disturbata. Cade. Spesso mi cade il senso.
La notte è una creatura senza volto, ed io che non ho avuto lineamenti, scorro pagine vecchie ma non trovo che notizie già note, mentre il futuro sta negli animali nelle cui viscere si raddensa il nulla del vuoto che ci aspetta.
Ultimamente ho caldo ed i ruscelli scorrono gocce che non hanno suono ma non cadrà la neve.
A volte stanno ferme sulla terra nuvole e vento, diffuse in un clamore che confonde e per quanto mi sforzi non trovo senso di composizione.
Mi rifugio nel tempo, sto negli anni, ma il tempo indietro è un animale esausto, sperduto nella sua malinconia di un malinteso senso del non stare.
Come tu sai, la mia mai ripudiata propensione ad essere e il contrario s’accumula nel grumo di ogni peggio. Oggi io.
Non mi chiedo di noi: lascio cadere.
E tuttavia ti penso, nel senso di un racchiuso impedimento.
Id: 5843 Data: 25/12/2024 14:42:00
*
Dei pesciolini rossi al luna park
Sapevo che si sarebbero presentati (tutto quello che ho fatto e che ho mancato di fare) non invitati, al mio tavolo stasera, ma è come se lo fossero da sempre.
Ceniamo insieme, come vecchi nemici sconosciuti, che hanno l’occasione di conoscersi, pur avendolo fatto un’infinità di volte. L’inutilità frequente delle cene – mi sembrava di pensare – ricordando le occasioni sprecate o, forse, lo spreco delle occasioni. Forse una di più, ma avevo la facoltà di cancellare.
Non intendevo – voglio dire avere l’intenzione di farlo - mentre sarebbe stato facile non farlo, nel senso di una totale negazione.
Si poteva ad esempio sostenere, da qualsiasi parte, che non c’era senso che noi fossimo lì (sarebbe stato identico non esserci) e se proprio avessimo voluto trovarne uno, sarebbe stato più semplice cancellare tutto e presentarsi come fosse la prima volta: magari non avremmo neppure cenato insieme.
Ci si poteva infatti limitare a uno sguardo fugace, forse un accenno, un saluto distratto, chiedendosi poi “chi era quello”, o quelli, a seconda delle circostanze, o non chiedersi nulla.
Tuttavia ci trovavamo lì, seduti allo stesso tavolo, moltissimi, come il conto degli anni.
Qualcuno aveva i capelli grigi, qualcuno li aveva scuri, qualcuno non li aveva affatto, mentre vagiva fastidiosamente da lontano. I miei erano bianchi. Qualcuno aveva una pistola in tasca, o l’ipotesi di una pistola.
La casa poteva essere una qualsiasi, o diversa. Un locale, anche: indeterminato. Sapevamo perfettamente quello che avremmo ordinato. Riconoscersi, però, era difficile. Forse bisognava procedere a qualche eliminazione, ma sarebbe servito?
Da tempo non si vedevano idee e la conversazione era laconica. Facevo la spola tra la cucina e il tavolo, prendevo le ordinazioni, le servivo. Sedevo a mangiare anch’io. Il fatto è che ognuno faceva quello che faceva l’altro e questo non ci aiutava affatto.
Non era neppure facile stabilire se quella finestra doveva essere aperta o chiusa. Quel tagliacarte doveva stare nel cassetto o sulla custodia di pelle appoggiata sulla scrivania? Poteva essere comunque: bastava controllare il tempo e le cose sarebbero andate al loro posto, a seconda del posto e dell’angolazione temporale comunque diversa.
Neppure si sapeva la stagione, ma questo, visto i tempi che corrono, non aveva importanza. Quanto alla data, bastava scriverne un’altra sopra una qualunque intestazione, cosa che tutti si affrettavano a fare.
Restavano lacune. Per avere una certa coerenza del discorso ciascuno doveva ricorrere all’altro, ma nessuno aveva voglia di farlo. Dunque, interruzioni: dei pensieri, dei ricordi, delle figure, dei pesciolini rossi al Luna Park, della vita.
Non era facile stabilire neppure quando andavano dette certe cose, finendo col non risolvere nulla. Forse quella era la parola giusta, ma non veniva pronunciata, affermandola implicitamente. Afferrarla no.
Sapevamo che qualcuno di noi era malato - era inevitabile che lo fosse - ma nessuno poteva prendere la malattia. Era lì, senza nemmeno che ci fosse.
Neppure questo ci ha permesso di distinguerci, ma forse era proprio quella mancanza di distinzione che ci distingueva, almeno in apparenza. Alla fine ci si somiglia tutti; è il tempo che divarica.
Id: 5838 Data: 19/12/2024 09:35:50
*
La signorina Fuzio. Ovvero, piccole menzogne letterarie
La signorina Fuzio è morta e sepolta.
Quando ci ho pensato mi è venuto un momento di sconforto. Detto così non rende giustizia al mio sentire. Sconforto è cosa seria; ti pesa addosso, ti spiaccica, ti rinserra in un angolo piccolo estremamente buio, ma detto così perde pregnanza, si assottiglia, minimizza, evapora e finisce con l'essere ridotto a semplice fatto di cronaca, come se si dicesse: "c'era uno che stava un po' giù"; "uno chi?" "uno" "e perché?" "stava giù". In pratica: tutto finisce lì (vaghezza di vago vagore: vagamente).
Sembra allora che la questione stia non tanto nel dire che sei sconfortato, ma nel come lo dici.
Occorrerebbe non tanto limitarsi all'espressione, ma trovare un modo di esprimere. Uno che se ne intendeva (Céline) sosteneva, forse esagerando un po', che la trama è roba da fruttivendole e che la letteratura riguarda la lingua, capace di rendere i fatti qualcosa di più ampio, diciamo significativo, magari simbolicamente allusivo, metaforicamente adombrato, al di là dell'apparenza di parola che si riduce a pura letteralità.
La lingua che rimanda senza dire, pur dicendo di più, libera la categoria strettissima e fine a se stessa del fatto aprendola alle infinite possibilità del simbolo significante, cosa di cui parrebbe fosse convinto Brodskij che sosteneva che è la lingua che fa la letteratura. E anche l'uomo: "Il poeta, ripeto, è il mezzo di cui la lingua si serve per esistere" (I. Brodskij, Dall'esilio". O forse viceversa.
Sia come sia, secondo Brodskij scrivere rimanda a una dimensione altra, forse un po' metafisichetta, ma non c'è dubbio che, in base a tale idea, l'espressione del mio sconforto si sentirebbe per lo meno sollevata al di sopra della pura materialità del dire e forse si interrogherebbe su qualcosa di diverso dal semplice affermare.
Tuttavia, anche tale rimando significativo non incide sulla questione pura e semplice che la signorina Fuzio è morta e pure sepolta e che tale fatto non è noto a nessuno, dato che chi ne era informato è ormai personalmente defunto a sua volta. Dunque, stiamo parlando di un fatto che non esiste. E neppure il mio sconforto.
Questo mi secca non poco. Che un sentimento così scomodo e coinvolgente, denso di gravidissime conseguenze letterarie esista al massimo a livello di semplice cronaca (giornalismo?), mi secca: non poco! Occorrerà allora dichiarare quel sentimento in altra forma, diciamo "letterariamente", in modo da dar soddisfazione per lo meno alla lingua e dunque operare un passaggio fondamentale capace di trasformare lo sconforto/fatto/(cronaca) nell'oltre uomo della letteratura.
Esempio di trasformazione letteraria.
Sconforto: un sentire cadente. Come cadere da un pensiero.
Ecco, forse avrei dovuto dirlo più o meno così. Se però fossi riuscito a passare sul "piano letterario", avrei corso un rischio fortissimo di spersonalizzazione, finendo col fare un torto a me stesso sul piano personale. Sarebbe allora stato contento Blanchot, che afferma che un autore appartiene al rischio, perché: "L'opera esige dallo scrittore che egli perda ogni "natura", ogni carattere, e che, cessando di riferirsi agli altri e a se stesso con la decisione che lo fa io, diventi il luogo vuoto dove si formula l'affermazione impersonale" (M. Blanchot, Lo spazio letterario, Einaudi, Torino, 1967, p. 41). Quanto alla morte e alla sepoltura della signorina Fuzio, dichiararle in un modo o in un altro non cambia la sostanza delle cose.
Proviamo. Potrei, ad esempio, dire: ella morì e fu sepolta. O ancora: morta e sepolta. O: morse (forse, morette?) O anche sbrigarmela sinteticamente con un “amen” (in questo caso, però, farei poesia: essa è, per dirlo sinteticamente, sintesi! Ahimè raramente sintetica: avete mai letto quelle poesie interminabili tipo io mammeta e tu - oh sant'iddio!). Potrei persino non parlarne per niente, travasando tutto nella categoria del trascendente cui il fatto della morte senz’altro ci consegna. Non cambia. Potrei affrontare la cosa da un punto di vista critico, ma vi sconsiglio dal fare i critici letterari, anche se vi invitano a discutere un testo. La cosa migliore che può capitarvi è che dopo vi si rivoltano contro per giustificare in ogni modo il loro fatto e, francamente, senza un lauto compenso, non vedo proprio perché dovrei sottopormi alla seccatura (leggere, cioè, il loro fatto per sentir poi smentire la mia lettura).
Resta però incontestabile che, come affermava Manganelli, la letteratura è menzogna. Come intendere tale dichiarazione? Decifrare una menzogna rischia di precipitare l'incauto che vi si provi in mondi paralleli di universi improbabili. Mantenendomi più al sicuro, posso soltanto azzardare un dubbio: siamo sicuri che i romanzi che leggiamo raccontino proprio di quello che ci sembra di leggere e che i personaggi che li rappresentano siano proprio le figure che appaiono e che fanno e dicono quel che fanno e dicono? Non sarà magari che essi parlano d'altro, come lo stesso romanzo e che, come sosteneva Blanchot, ciò che ci appare su un piano inequivocabilmente personale non lo è affatto? Non sarà che il dire dell'autore è un dire apparente, mentre è un non dire che rimanda a un altrove che non percepiamo ma che inspiegabilmente dovrebbe riguardarci? Forse la cosa migliore sarebbe lasciar perdere. Resta però che la signorina Fuzio è morta e sepolta e resta il mio sconforto.
Mi è venuto per caso, che come tutti sanno domina casualmente i fatti di un universo casuale (significa che casualmente fa letteratura).
Mi trovavo in auto, diretto verso un luogo di rifornimento. Non per l'automobile: per me, cioè un bar. Venni a trovarmi (trovaimi - è più letterario? -) nel quartiere della mia infanzia (ci sono andato apposta: mi piace) e anche perché so che lì troverò un bar aperto. E lì la signorina Fuzio mi folgora con la sua scomparsa. Intendiamoci: non è scomparsa al bar; casomai è ri-comparsa.
Abitava nel mio stesso stabile, al quinto piano (fa molto romantico) di un palazzo d'epoca umbertina (mai rimpianto abbastanza). Era signorina perché era irrevocabilmente zitella, promessa ad un fidanzato fantasma che nessuno ha mai visto, ed era zitella perché era irrimediabilmente ordinaria. Piccola e grassottella, si affacciava alla porta di casa nella sua vestaglietta a fiori d’ordinanza, con un sorriso stemperato sulle labbra accennate di rossetto e gli occhi stretti (per vedere meglio), velati appena di blu. Ciglia a battente. Dietro di lei, immancabile: la madre. Risparmio descrizione.
Ci si affacciava reciprocamente alle porte per chiedere qualche favore (quelli soliti da inquilini): un pochetto di zucchero, una scorzina di limone, e giù di lì giù di lì, con la promessa di una pronta restituzione che non avveniva mai. Eravamo tutti perennemente in debito. Lei lo era con la vita, cui non concedeva nulla. Anche in credito, però: non riceveva. Era come fluttuasse in un mondo confinato tra il pianerottolo e la soglia. Per questo mi faceva un po’ pena e un po’ tenerezza, nonostante avessi solo dieci anni. La signorina Fuzio mi ispirava sentimenti cadenti: incontrarla si traduceva in un inevitabile cadere.
Anche gli altri inquilini mi ispiravano sentimenti stile precipizio. I signori Aliquò, infinitamente fuori moda e fuori tempo, se non proprio fuori dalla vita. Morirono in un incidente d'auto appena lui prese la patente. Il dr. Strollo, che mi cavò un dente, con la figlia Pucci, più grande di me di qualche anno ed infinitamente inguardabile. I signori Polidori - tristissimi - perennemente chiusi in un silenzio atavico come il loro impenetrabile appartamento, alla cui porta sostavo a volte in attesa di un qualche suono, preda di fantasie irriferibili. L'ing. Berlingeri, tralasciato allora come adesso: meglio tralasciare.
Sostavo, quando non mi lanciavo per i gradini a balzi di cinque, chiaro segno del primo manifestarsi di un DNA di fuga, evidente anche nel rifiuto di recarmi ai giardinetti, dove avrei potuto fare incontri serrati, mentre preferivo passare interi pomeriggi a giocare al teatro con le mie marionette, dove il mondo lo inventavo io e, nell'invenzione, non ero più me stesso. E neppure il mondo.
A scuola però andavo. E lì c’era la signora Borrelli, più piccola del mazzo di fiori col quale si inerpicava per le scale il primo giorno di lezioni, mentre io mi sentivo abbandonato da mia madre alla mercé di quella che allora mi appariva come la summa della streghità. Ovviamente non era così; la letteratura è menzogna, ricordate?
Dunque, nessuna verità né luogo certo. "Questo esilio che è proprio del poema fa del poeta l'errante, il sempre smarrito, colui che è privo della presenza stabile e della vera sosta. E ciò deve essere inteso nel senso più grave: l'artista non appartiene alla verità, perché l'opera è ciò che sfugge al movimento del vero, perché sempre, da qualche parte, essa lo revoca, si sottrae alla significazione, designando la regione dove niente resta, dove ciò che è avvenuto non è tuttavia avvenuto, dove ciò che ricomincia non è ancora mai cominciato, luogo della più pericolosa indecisione, della confusione da cui niente sorge. Questo di fuori eterno è evocato efficacemente dalle tenebre esterne, in cui l'uomo è messo alla prova di ciò che il vero deve negare per divenire la possibilità e la via" M. Blanchot, op. cit., p. 207).
Dunque, un non dire che dice: qui ci ha condotto la morte della signorina Fuzio. Mi convinco allora sempre di più che non se ne sarebbe dovuto parlare. Ma se il luogo è il non luogo, parlare dove?
Questa alterità radicale è un luogo vuoto, come lo definisce Lacan nel Seminario VII, irriducibile alla significazione, che tuttavia proprio perché vuoto può far scaturire da sé ogni rappresentazione e dunque aprire al godimento del significare. Questo non vuol dire che la Cosa sia capace di parola, ma come l’Apollineo Nietzschiano si ridurrebbe a sterile forma organizzativa senza il Dionisiaco, lo stesso Dionisiaco non sarebbe altro che caos senza il sistema formale rappresentato dall’Apollineo. La sintesi non è un fatto; e neppure la lingua.
Santo cielo, questo dire il non dire per dire l'indicibile da dire rischia di trascinarmi nel silenzio; ma forse è da lì che si scrive: il silenzio del mondo.
E la signorina Fuzio?
La Pucci abita ancora lì: ho visto il suo nome sul citofono. Tale visione mi ha causato un sentimento talmente cadente da farmi precipitare in uno sconforto di cui non parlo, altrimenti ricominciamo da capo, col rischio di sprofondare in una saga familiare o, peggio, in un romanzo storico, di quelli infiniti celeberrimi che hanno avvilito la mia infanzia e indebolito il cervello di chi li ha letti e che non si dovrebbero scrivere mai, a meno di essere deboli di cervello e aver bisogno di indebolire quello degli altri per rassicurarsi. O a meno di essere Roth, che ti narra i fatti del signor Trotta ma in realtà parla della fine del mondo; o Marquez che ti racconta cent'anni senza che te ne accorgi; o Bernhard, che mentre ti fa fare una camminata ti conduce tranquillamente in manicomio. E neppure che la signorina Fuzio è morta. Ed è stata sepolta. Dove non so. O se sia vero.
Id: 5794 Data: 27/09/2024 12:29:44
*
Di scatolette e fiori
Ora, davvero ci si stanca di questa ovvietà del camminare, che a rimanere fermi ci fa freddo e la neve ti sferza.
Muoversi: verso dove? Più che altro un pensiero, unica forma di astrazione lieve che senza fare un passo muove il mondo. Ma anche questo è ovvio.
Come lo è il potere: ignora, se non osteggia.
Occorre allora inventarsi qualche cosa, magari un processo al mal di testa, come a Gerusalemme, ma non mi sembra sia servito a molto.
Forse esiliandosi, se non fosse che l’esilio va nel nulla, come dimostrano i fatti di ogni giorno, ammesso che gli esiliati vengano raccolti per lo meno – dico una scatola – almeno.
Riconoscere, quindi, si diceva, un cammino diverso. Costellato in ogni caso di ovvietà. Ad esempio: cos’è la letteratura? E la poesia? Ma perché questo bisogno di definire, declinare, incasellare? Ah, l’ignoto trasformato in consueto. La rassicurazione chiude il mondo; ma non sembra fare la paura che dovrebbe.
Dunque parlarne senza preoccuparsi di dover dire ancora, ma il silenzio è un’indagine sospetta: non ne parla nessuno.
Ma perché quando incontriamo qualcosa che appare come un tempio che ci sembra una parentesi sospesa tra l’esperienza e il non pensato; o un quadro, dove il mondo si aggira radunandosi in empietà più simili al sublime dell’empietà dei giorni, perché poi ne dobbiamo parlare, riducendo l’istante a un campo vecchio, mentre dovremmo soltanto limitarci, almeno qualche volta, a viverne?
La dinamica dell’ovvio stronca il senso, ma anche il più sensato dei pensieri alla fine si invecchia. Bisognerebbe allora ripensare e delle cose farne sempre altre. Quando le hai fatte, farne diverse ancora, fino a quando avrai finito l’infinito. Che si chiude, ma ricomincia altrove.
Ad esempio a Pietroburgo, dove non si mangiava carne in scatola: nelle lattine si mettevano fiori. Ma nei cortili si lavorava sodo perché il Partito non consentiva odori. Dunque una vita al minimo: quel poco che si riusciva a leggere.
Muoversi, allora: dove?
Anche la sera, sul Baltico, quando le isole si prendono per mano, si muove solamente la deriva.
Id: 5606 Data: 22/04/2024 10:47:07