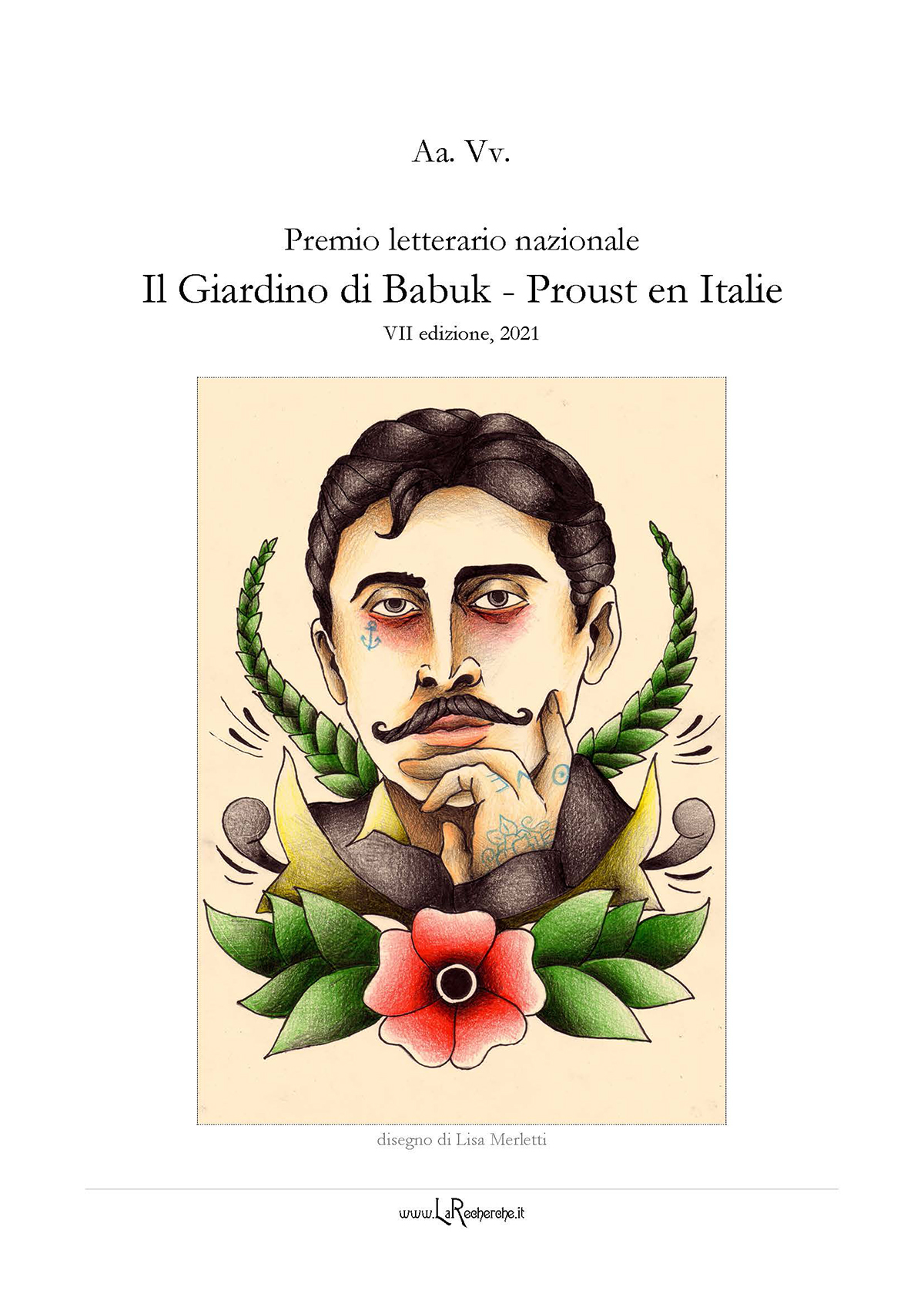chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Saverio Maccagnani
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
*
Strani effetti di un plenilunio nella notte di san Giovanni
Ancora quel segnale! Era il secondo dall’inizio della serata!
Il brivido mi scese rapido dalle spalle alle caviglie. Subito faticai a controllarmi, poi le fibre del mio corpo si rilassarono. Era sopraggiunta un’altra stasi. Mi ricomposi. Impegnati a divorare tartine e stuzzichini ai buffet, gli invitati non si erano accorti del mio disagio. Fu una fortuna, perché né il momento né il luogo erano appropriati per un simile imbarazzo.
Anche questa volta tutto durò pochissimo. Avevo provato un incontenibile bisogno di danzare, tip-tap-tip-tap, tanto che dovetti premere le mani sulle cosce per controllarmi. Trascorsero non più di dieci minuti e, come un’onda che cresceva dentro di me, sentii che il fenomeno si ripresentava. Eccolo! Ancora quel brivido!
Dovetti faticare molto a reprimere uno strano impulso che adesso mi suggeriva di sollevare di scatto le braccia verso il soffitto rococò e di liberare un urlo capace di zittire il brusio del salone. Per fortuna ancora una volta tutto passò presto.
Spaventato per il timore di avere fatto trapelare qualcosa di sconveniente, girai lo sguardo intorno, ma mi tranquillizzai. Nessuno dei presenti appariva particolarmente sconcertato. In realtà ognuno era occupatissimo a rastrellare gli antipasti schierati sui generosi vassoi di portata. Neppure un minimo imbarazzo impediva agli invitati di pressare i vicini per riempirsi i piatti con i diversi assaggi nel timore che altri approfittassero di quel ben di dio. Eppure sussiegosi valletti sostituivano in continuazione le guantiere ormai ripulite con altrettanti cabarè sempre ben equipaggiati di appetitose leccornie.
Poi conquistato un copioso bottino di antipasti, gli ospiti si accomodarono al posto contrassegnato da una targhetta. Nelle pause della masticazione tutti dondolavano come metronomi le posate, ora sovraccariche ora spolpate, condividendo i mugolii di piacere di chi stava degustando le medesime prelibatezze.
Adesso i presenti si aprivano alla conversazione. Si scambiavano arguzie e fatuità, lazzi e parole d’ordine che si meritavano da anni le medesime risposte, ormai gergo per iniziati, linguaggio esoterico per adepti. Ma ai commensali sembrava naturale che succedesse sempre così.
Intanto i camerieri scodellavano i primi potages Parmentier. Era l’avviso che iniziava la cena vera e propria. Adesso molti si concedevano un bicchiere in più. Proprio per offrire un tale conforto agli ospiti, i sommelier piroettavano tra i tavoli rabboccando in continuazione i calici appena prosciugati.
Così tra una chiacchiera e l’altra finivano spruzzate oltre gli incisivi le vocali e le consonanti, soprattutto le sibilanti, insieme a schizzi di saliva e a briciole di crackers dietetici. Intere allusioni maligne venivano rimangiate pudicamente già sul ciglio delle labbra con un esperto colpo di lingua e risucchiate come linguine al pesto.
«…e non mi faccia dire altro!».
I motti più mordaci incastrati tra i denti erano rimossi con l’aiuto di uno stecchino nascosto dietro una mano a far da paravento. Poi la deglutizione di quel bolo greve di cibo e irto di lettere bodoniane era accompagnata da un altro generoso sorso di un vino d’annata.
«Cin, cin!», tintinnava il cristallo delle coppe.
Il rigurgito atteso era abilmente domato a labbra serrate e a guance rigonfie, anche se un leggero sobbalzo delle spalle palesava la trattenuta eruzione di un importante riflusso gastroesofageo. Ma gli ospiti erano persone di qualità e sapevano come comportarsi in ogni situazione.
Non mancava l’augurio corale di una buona peristalsi al rettore emerito (in un clergyman sobrio anche se di ottima sartoria) il cui viso congestionato era ormai intonato alla tinta della poltroncina cremisi sulla quale era insediato e ormai eguagliava il colore di quella porpora a cui tanto aspirava.
«Prosit!»
«Deo gratias vobis quoque!» ringraziava ogni volta costui con unzione, premendo il tovagliolo sulle fauci inumidite dal Brunello.
Finivano sotto alle mense mucchietti di idee immangiabili, complimenti sbrodolati, insipidi corteggiamenti, affari bruciacchiati. E riassunti di best sellers riscaldati e di fiction mal cucinate; storie di mogli, mariti e amanti andate a male; moda, sesso, sport e politica ai quattro formaggi rancidi; motti di spirito scotti; allusioni rapprese; esibizioni di patrimoni annacquati, di carriere mal lievitate; ricordi bisunti, amicizie scondite e passioni senza sugo; confidenze rafferme, rigaglie di vanterie, timballi di sorrisi strinati, soufflè sgonfi di «vediamoci, ma non domani che ho già un impegno»; occhiate in agro-dolce, crudités di maldicenze; polpette stantie di chiacchiere, bignè di aria fritta, fricandò di bugie. E parlar grasso a far da condimento.
La spazzatura della corteccia cerebrale, i trucioli e la limatura delle frizioni sociali, i liquami del vivere comune e del comune buon senso, lì, a montagne sotto quelle mense, come le ossa avanzate da un banchetto di nibelunghi. Per me che ne avevo una chiara percezione era la visione disgustosa dei resti di quel menù. Era mai possibile che solo io mi accorgessi di quell’indecenza?
Ma ancora una volta il segnale! Mi drizzai contro lo schienale della sedia, la spina dorsale a piombo. Mi preparai a controllarmi. Non potevo permettere al mio corpo di andare alla deriva.
Di fronte a me sedeva un’implacabile studiosa euroasiatica. Ci stava intrattenendo in uno slang anglo-italiano sugli sforzi umani per sfruttare le risorse naturali a beneficio del progresso della nostra specie. Negava che il clima del pianeta fosse influenzato dalle emissioni incontrollate.
«Sono tutte panzane. Bullshit, miei cari friends!»
A tale proposito citava gli studi di non so quale scienziato che l’astiosa Reale Accademia delle Scienze –diceva- mai avrebbe proposto per il Nobel. Non riuscii a intendere il nome di quel sapiente a causa del brusio incessante della sala che mi impedì di godere di quella rivelazione. Però i miei vicini assentivano convinti delle buone ragioni del suddetto. Così lei continuò a concionare.
«…e i complottisti delle scie chimiche? e i terrapiattisti? e i novax? Tutti in mala fede? Ma davvero spacciano fake news o le loro convinzioni andrebbero vagliate con più attenzione? Parliamone!». E lei parlava, parlava…
«…in verità siamo tutti manipolati dalle lobbies economiche, politiche e militari. Prendiamo il caso degli alieni! E se da sempre fossero tra noi? Il nome Roswell non vi dice nulla?». E con quest’ultima frecciata concluse la sua dissertazione.
Infatti un convitato ad un tavolo vicino aveva attirato la sua attenzione. Lei si alzò per raggiungerlo. Ma prima ci passò il suo biglietto da visita. Per porgerlo anche a me, che non avevo detto una parola, si sporse al di sopra della siepe dell’elegante centro tavola dietro il quale avevo cercato di ripararmi.
«Dr. Mei Li Fo Newman, graduated in ethology and influencer - The Chinese University of Hong Kong», recitava il cartoncino. Lo riposi nel taschino dello smoking. La ringraziai con un mezzo sorriso e un cenno della mano che voleva apparire disinvolto.
La sentii salutare il nuovo interlocutore.
«Oh, Igor! How do you do?»
Ci furono le presentazioni e un giro di baci. Le fecero posto per il dolce.
Più in là mia moglie intratteneva un gruppo delle più promettenti matricole, alcune in piedi dietro la sua seggiola. Naturalmente solo di genere femminile. Vidi che parlava sempre lei. Naturalmente. Anche se per la distanza non potevo distinguere le sue parole, ero certo che si occupasse del suo argomento preferito:
«…la liberazione della donna sarà possibile eliminando la necessità del corpo femminile come agente della riproduzione della specie…». Oppure: «…la subordinazione delle donne precede il capitalismo e continua con il socialismo …». O a piacere: «…il fallo, dice Lacan, è il significante centrale dell’oppressione sessuale. Quindi… abbasso il fallo!». Già.
Forse dissertava proprio su quest’ultimo argomento a giudicare dalle risatine e dagli applausi festosi che ricevette dal suo adorante pubblico.
Dopo i saluti e le allocuzioni, i convenuti al banchetto annuale della Facoltà di Etologia Umana (l’antica e prestigiosa F.E.U.) si erano concessi un meritato ristoro.
Com’era tradizione la F.E.U., oltre che agli insegnanti e ai loro accompagnatori, accordava anche agli alunni che si erano distinti di partecipare a quella tediosissima cena. Nonostante da anni mia moglie mi proponesse di accompagnarla, avevo sempre declinato l’invito per non ridurmi a fare da comparsa muta in quel consesso di insopportabili pedanti. Ma quella volta lei aveva particolarmente insistito. Nell’occasione si festeggiava la sua recente nomina a chairwoman della sezione femminile. Ci teneva ad esibirmi il suo trionfo, anticamera del rettorato. Quindi non potevo mancare. Ovviamente per i signori era gradito l’abito scuro. Avrei anche dovuto mettermi in ghingheri!
I rinnovati «evviva!» e i battimani dopo i brindisi ricomponevano l’attenzione dei convitati. Poi un irritante parlottio a me estraneo si frazionava tra le tavolate. Però a un certo punto della cena non ne potei più.
Quando giunsi ad augurarmi che una calamità naturale ponesse fine al simposio o almeno che un malore avesse il potere di portarmi via da lì; quando con l’angoscia di un naufrago nella tempesta mi resi conto che nessuno sarebbe venuto in mio soccorso, fui attraversato da un brivido più forte degli altri. Una scossa. Benedetto il terremoto, pensai.
Invece levitai.
Dapprima la mia seggiola si sgranchì con un secco scricchiolio. Si spostò in avanti e all’indietro come per sradicarsi meglio dal parquet. Poi si alzò solo di pochi centimetri, ma tornò subito al suolo. Fin qui nessuno se ne accorse. Infine si assestò in equilibrio a due dita dal pavimento, quasi per darmi il tempo di sistemarmi. O di mettermi in salvo, possibilità che, data l’occasione che mi era offerta, naturalmente non volli considerare. Allora riprese a salire con me sopra.
Quando le grida di alcuni commensali attirarono l’attenzione di mia moglie, lei si zittì all’improvviso. Poi non seppe dirmi di meglio che «dove vai?». Lo urlò tra il terrore di tutti mentre mi trovavo già sulla verticale degli arrosti.
«Vieni giù! Non fare il cretino!» mi fulminò.
Un po’ imbarazzato le feci osservare che avrei voluto ubbidirle, ma in quella circostanza proprio…
Allora rivolta all’emerito rettore, noto esorcista, lei gli intimò: «Faccia qualcosa!». E lui, inebetito, trovò solo la forza di borbottare un formale «Vade retro!» e si aggrappò alla sua croce pettorale.
Provai a lanciare alla seggiola un comando mentale. Mi concentrai con impegno. Davvero ci provai! Davvero! Confesso, però, che non le chiesi di scendere. Volli solo controllare se era possibile guidarla con il pensiero. Mi illudevo che la mia volontà potesse tanto. Macché! Non avevo alcun potere su di lei, me ne accorsi subito. Dovevo sottostare ai capricci di quell’ippogrifo acefalo che chissà come avevo evocato.
Infrangendo la legge di gravità sorvolai le lagune dei potages in una lenta ricognizione e dall’alto dei tre o quattro metri che avevo raggiunto ammirai i colori dei giardini delle insalate e i vulcanetti delle terrine traboccanti di fettuccine e le tonde collinette dei timballi di maccheroni e le pendici terrazzate delle forme di parmigiano in quel paese di Bengodi. Ma almeno da quella posizione favorevole potei contemplare anche le generose scollature ingioiellate di alcune signore.
Orbitai attorno ai lampadari di cristallo facendo le mie più deferenti scuse a tutti gli ospiti, sia che scendendo di quota rischiassi di sfiorare spalle nude ed elaborate acconciature o che rasentassi con le suole elegantissimi smoking. Ma capissero, non potevo farci nulla. Era più forte di me. Mi auguravo che comprendessero la situazione, che credessero al mio rincrescimento.
Ad ogni passaggio in picchiata sulle mense osservavo la precauzione di sollevare i piedi, attento a non decapitare quei deliziosi calici o a non rovesciare preziosi cuvées. Invece ad ogni impennata abbassavo il capo con trepidazione per non far precipitare sulle tovaglie i ninnoli tintinnanti dei lampadari.
Veleggiavo a spirali sempre più ampie ben oltre quelle bocche aperte come buche di un bigliardo, quando un cameriere del Circolo che ci ospitava, in piedi su uno sgabello, si esibì nel tentativo di afferrarmi con un ampio gesto del braccio, quasi fossi stato una fastidiosa falena. Allora il mio velivolo salì ancora più in alto in cerca di asilo nell’Olimpo affrescato sul soffitto. Lassù giovinette assai scollacciate e dalla palese natura leggera, sorrette da amorini ruffiani e viziosi che si sbaciucchiavano tra loro, volavano ad offrirsi a padre Giove che, chissà perché corrucciato, le attendeva assiso su nembi temporaleschi. Ma avendo l’occasione di osservarle così da vicino, mi accorsi che una di loro, quella più grassottella rimasta indietro perché impigliata in una nuvola, sembrava ammiccarmi di sottecchi con sfrontata complicità.
E quando comparve una pertica armata di un uncino per impedirmi di profanare un tale empireo, la mia navicella decise di porre termine alle sue evoluzioni e puntò decisamente in direzione della grande vetrata rimasta aperta. Così beccheggiando leggermente la infilò anticipando chi stava correndo a chiuderla, incalzato dalle urla di mia moglie. E fui risucchiato al di là della porta finestra che dava sul giardino all’italiana.
La sera era tiepida. Le spalliere delle rose regalavano una dolce fragranza. I getti d’acqua delle fontane si frantumavano nelle vasche in nebulizzi. I boschetti, generosi di ombreggiate promesse per chi vi si fosse appartato, fremevano a contatto della brezza. Tutto lì fuori era così perfetto! Finalmente!
Era la notte di san Giovanni, tradizionalmente scelta dalla prestigiosa F.E.U. per il simposio annuale a conclusione dell’anno accademico. In più in quell’occasione il cielo era illuminato da una stupefacente luna piena che tendeva al colore rosso e oscurava la luce delle stelle.
Si dice che la notte del solstizio d’estate sia considerata magica dalla tradizione popolare. Se poi capita in coincidenza con uno splendido plenilunio non c’è da meravigliarsi che produca incanti, magie e sortilegi per chi ha bisogno di credere a tutto questo. O strani effetti per quelli come me che soffrono di qualche afflizione nell’animo. Non ne parla anche Shakespeare in una sua commedia?
Mi frugai nelle tasche. Trovai subito la pipa e la piccola borsa del trinciato che portavo sempre con me. Tanto valeva mettermi comodo. E con il vento in poppa me ne andai pipando come un vapore sul Mississippi.
Sulla terrazza mia moglie adesso gemeva: «Perché hai voluto rovinarmi la serata!». E mi lanciò l’ultimo «dove vai?». Dove vai, dove credi di andare, stupido Olandese Volante sul Mar delle Tegole!
Ma mentre affidavo al vento i coriandoli dell’insulso biglietto da visita della dottoressa Fo, il faccione della luna rossa - ah! - come magnetizzava la mia rotta!
[ Opera seconda classificata al Premio Babuk - Proust en Italie, VII edizione 2021, Sezione B ]
*
La Bella Pescatrice
LA BELLA PESCATRICE
Ossia: “L’uovo, la pietra, il sempreverde e il gelso”.
«Aspasia era figlia di Arbate re di Tebe ma naturalmente non lo sapeva perché era stata allevata da un vecchio pescatore che altri non era se non il fedele primo ministro di suo padre che l'aveva salvata disubbidendo per pietà all'ordine regale di esporla ancora in fasce su uno scoglio alla mercé degli elementi non meno crudeli delle fiere e degli esseri umani affinché non si compisse una terribile profezia che riguardava la salvezza del regno e il diritto a regnare del primogenito ma il compassionevole ministro non era più tornato da quel viaggio scellerato preferendo rifugiarsi con l'infanta in una lontana baia per vivere semplicemente e in pace con la coscienza finché un giorno non era passato di lì a cavallo il principe Corene figlio d'Arbate che l'aveva vista mentre riparava le reti del suo vecchio e saggio tutore e se ne era innamorato si era innamorato mentre si dissetava dalla ciotola di legno che lei gli aveva porto si era innamorato perdutamente della cortese bionda Bella Pescatrice…».
«… e poi scopre che la ragazza è sua sorella e se ne dispera, ma un attimo prima di uccidersi per quel colpevole amore viene a sapere da un'ancella che lui non è il figlio del re di Tebe, ma figlio suo, proprio dell'ancella, scambiato neonato nella culla con il principino morto prima che se ne accorgessero i reali genitori… e allora non c'è incesto e l'orrenda profezia non potrà avverarsi…»
L'impresario Saccomanni interruppe la lettura tutta d’un fiato della sinossi del libretto d’opera che il poeta Salimbeni gli aveva consegnato alcuni giorni prima e completò tra sé la storia con parole sue, tanto si trattava sempre di quella minestra riscaldata.
A quel punto giudicò che fosse giunto il momento di concedersi un altro generoso sorso di quel buon vino che monsieur Jossis gli aveva mandato da Pontoise perfino quando in Francia erano cominciati i primi disordini. Da qualche tempo però c’era stato un blocco definitivo di quella fornitura, per cui la sua preziosa riserva personale era proprio agli sgoccioli. E da ciò che si capiva, non c’era più speranza che tutto tornasse come prima, né per il vino né per la concordia in quel paese al di là delle Alpi.
«Ci mancava anche questa delusione», sospirò l’impresario contemplando controluce lo spumante che si era appena versato da una delle ultime bottiglie della sua misera scorta. Aggiunse ai suoi guai di quei giorni anche il pensiero di quella contrarietà e mandò giù il primo sorso.
Dopo che il visconte Raoul Honneurs de la Cour ai primi accenni di sommossa nelle sue terre -e avendo fiutato l’aria che già circolava nella capitale- si era messo al sicuro in Belgio con altri suoi vicini opportunamente “emigrati”, il suo intendente, monsieur Jossis –o meglio, il ‘cittadino’ Baptiste Jossis come lui adesso si faceva chiamare una volta entrato nella Municipalità- aveva scritto a Saccomanni che le riserve di spumante alloggiate nelle secolari cantine della tenuta se le erano bevute un po’ tutti: i sanculotti venuti da Parigi a dare manforte, la Guardia Nazionale e, finalmente, i contadini che, pur essendone gli artefici, mai avevano potuto spillarne una sola goccia a proprio beneficio. Quindi si scusava vivamente, ma la sospensione della fornitura andava attribuita ai disordini che erano scoppiati anche dalle sue parti. Doveva capire: le rivolte… i saccheggi… le devastazioni. Così la produzione era crollata e la qualità delle nuove vendemmie non sempre si era rivelata all’altezza delle annate precedenti. Ovviamente, se avesse voluto, del vino buono era sempre reperibile, ma andava pagato, eh sì!, e molto caro: “…le gabelle… le dogane… gli accaparramenti, mon cher Saccomanni!…”
E che arsura era quella dei combattenti, fossero ‘chouans’ o repubblicani, che per le loro magre scarselle non guardavano tanto per il sottile su chi fosse il proprietario quando cercavano qualcosa per rinfrescarsi l’ugola, a patto che non fosse acqua, ma succo di vite! Così, a scanso di saccheggi, ciò che rimaneva del migliore cuvée di ogni vendemmia, anche dei dintorni, era stato bevuto o i fattori lo avevano occultato e il prezzo del vino di qualità -semmai lo si fosse trovato- era andato alle stelle.
Circa due anni prima il “cittadino” Baptiste Jossis aveva spedito all’impresario l’ultima partita di “crémant”, qualche botticella di bianco d’Alvernia e un po’ di casse di Morillon di un ottimo vitigno austriaco ben ambientato a Pontoise. Però il prezzo si era rivelato esorbitante. Tanto più che il ‘cittadino’ pretendeva in pagamento solo del ‘nobile’ oro -e in anticipo- e non accettava i più rivoluzionari “assegnati”. Però parte del carico si era perso lungo il cammino in corruzione spicciola e in trafugamenti. Poi … “il n’y a plus de vin” gli aveva scritto e non si era più fatto sentire. Quindi era proprio quella l’ultima fornitura a cui l’impresario stava attingendo e sulla quale poteva contare.
Saccomanni a quel triste ricordo si versò un altro calice, ma adesso si accontentò prudentemente di metà bicchiere. Ancora una volta ammirò controluce la tonalità del colore, si compiacque della limpidezza di quel nettare, ne apprezzò la vivacità olfattiva e il perlage, ne assaporò con gusto la morbidezza, elevando un muto brindisi a quella delizia che, come il secolo decimo ottavo, ormai stava per finire. Infine sospirò. Sapeva bene lui quanto gli costava quel sorso che aveva appena degustato! Promise a se stesso di risparmiare le ultime bottiglie per le occasioni speciali, cercando nel frattempo altri fornitori. Una sbronza solitaria adesso non gli avrebbe fatto dimenticare i suoi ultimi guai.
Esaurito quell’attimo di beatitudine che si era appena concesso, l’impresario ritornò alla sinossi di Salimbeni. La rigirò ancora tra le mani, lesse qualche riga oltre il segno che aveva lasciato sulla sintesi della trama, si rese conto che il seguito della storia era proprio come lui aveva immaginato. Allora sfogliò i fogli con rabbia, li stropicciò furiosamente e li scagliò lontano da sé con un’imprecazione colorita. Le pagine volarono via come gabbiani nella bufera verso l’angolo estremo del salotto e li, oltraggiate per il trattamento subito, si nascosero alla rinfusa tra la consolle e il comò en bois de violette.
«Altro che 'La Bella Pescatrice'! Questo è ancora 'Il Figlio della Serva'!… » ruggì.
Allora non c'era nemmeno bisogno di cominciare la lettura della partitura tanto salvo i nomi e i luoghi le soluzioni proposte dal librettista e dal compositore sarebbero state quasi identiche a quelle delle due opere precedenti: tradimenti coniugali, complicazioni dinastiche, agnizioni sul letto di morte. E poi romanze, cabalette, arie a due voci, recitativi, cori. Sempre in quell’ordine, sempre quella solfa! Se pensava poi che la nuova opera era stata musicata ancora da quella bestia di Fontana che non distingueva un sol maggiore da un mi bemolle!...
Aprì a caso la partitura. Eccola lì la prova: le solite romanze per soddisfare i facili gusti del pubblico, gli ‘assolo ad libitum’ per assecondare i virtuosismi vocali dei cantanti, una decina di duetti scontati tra i vari personaggi, i tediosi recitativi per ricucire la trama, il coro lagnoso che riassume e invano ammonisce. Tutta qua la novità della stagione teatrale! Bella roba!
Intinse allora il naso spugnoso nel bicchiere, portò il capo all'indietro e, invece di centellinare con parsimonia come si era ripromesso, per calmare l’agitazione bevve l'ultimo sorso tutto di un fiato. Così lo spumante gli andò di traverso. E lui si strozzò, rigurgitò e si macchiò la camicia, in verità già non troppo pulita. Allora bestemmiò talmente rumorosamente che perfino lo scrivano sordo dovette alzare lo sguardo dal libro mastro.
*
A quel punto il valletto bussò alla porta. La richiuse subito dietro di sé dopo che Saccomanni con malagrazia lo ebbe invitato ad entrare. Il servitore annunciò a bassa voce la presenza in anticamera di due persone che chiedevano di conferire con lui. Sostenevano di essere attese. Nel contempo gli allungò una busta celestina.
«Chi sono?» sbraitò senza prudenza Saccomanni tra un colpo di tosse e l’altro. Quel giorno non aspettava nessuno e quindi temeva l’arrivo di qualche sorpresa spiacevole.
«Si tratta della signorina Fioravanti, il nuovo soprano. È appena arrivata insieme al suo accompagnatore, il cavalier Cinquecerri», annunciò il valletto in un sussurro e gli fece segno di calmarsi perché chi stava dietro la porta poteva sentire le intemperanze dell’impresario.
A Saccomanni ritornò in un lampo la memoria. Si era completamente scordato di lei. Quattro giorni di ritardo, pensò. Cominciamo bene!
«Finalmente si è presentata, la Musa della lirica!», ironizzò a beneficio dello scrivano che parve non accorgersene. Anche il valletto rimase impassibile in attesa di ordini.
«Fai entrare questa Fioravanti, allora, prima che si vada a lamentare che le abbiamo fatto fare anticamera!», urlò Saccomanni al valletto che invano, a gesti, gli raccomandava ancora di tenere bassa la voce.
Tutti avevano dei diritti! Tutti avevano i loro santi protettori! Bel modo di mandare avanti un teatro!
Ghermì la busta che portava in evidenza lo stemma del conte Roncadelli e lesse il biglietto: «Caro Saccomanni, come ho già avuto l’onore di informarLa, Le raccomando la bella e brava signorina Fioravanti, già soprano dell'Opera di Rivarolo. Avrà modo di apprezzarne le doti vocali e le riconosciute capacità artistiche, ideali per il nuovo lavoro della prossima stagione…». Tanti ringraziamenti e riguardosi saluti, ecc, ecc.
*
In Francia sì che stavano facendo piazza pulita! Dopo aver tagliato le teste ai nobili e alla coppia reale, adesso continuavano ad accopparsi tra di loro, pensò Saccomanni. Ma poi all’ultimo tutta quella loro Rivoluzione a che cosa era servita se non a privare un disgraziato di un po’ di vino buono? L’ultima volta quel furfante di Jossis gli aveva scritto: «Vinum non habemus!». Come nel Vangelo! Se l’era cavata così, quel briccone. Aveva distribuito gratis a tutti il vino della tenuta per evitare la ghigliottina. E ‘bravo’, monsieur Jossis! Adesso per riceverne dell’altro da Pontoise ci sarebbe voluto un miracolo, proprio come alle nozze di Cana, e la borsa di re Creso.
E in più, con tutto quello che stava succedendo in Francia, qui lo avevano obbligato a mettere in scena una "Bella Pescatrice"! E non quella “Lucrezia e Tarquinio” di Alcide Parrinelli che lui aveva caldeggiato e che gli era sembrata più consona ai tempi.
Ma chi lo sa, forse era meglio così: che le tragedie umane insanguinassero solo le tavole di un palcoscenico.
«E le doti vocali! … e le capacità artistiche! …» si interrogò scettico rileggendo l’azzurra missiva del conte. «‘Bella e brava’, lui dice!Staremo a vedere.»
Si alzò dal tavolo, indossò la giacca almeno per nascondere le numerose macchie sulla camicia e andò incontro alla “bella e brava signorina Fioravanti” che già si affacciava sulla soglia, preceduta dal valletto che le faceva strada.
«Ma chérie, finalmente! Che piacere fare la vostra conoscenza! L'attendevamo con impazienza!» e le baciò la punta delle dita grassottelle benignamente elargite.
Il cavalier Cinquecerri che l’accompagnava si fermò sulla soglia, levandosi rispettosamente il tricorno.
*
Allora eccola qua, la ‘bella e brava’ Isabella Fioravanti, già soprano all'Opera di Rivarolo, sulle cui doti vocali e le capacità artistiche -nonché sul nome a lui perfettamente sconosciuto- l'impresario Saccomanni invano si era interrogato. Giovanissima, però, e molto graziosa, questo sì. Non alta ma ben proporzionata. Scurissimi i capelli, spalle morbide, non troppo magra. Proprio una bella figurina, si addolcì l'impresario. Avrebbe fatto una buona impressione sulla scena. Ah, adesso capiva, capiva tutto, naturalmente!
«Bel vecchio porco!» pensò del conte Roncadelli.
La cantante si sedette con consumata civetteria, sistemandosi la generosa scollatura dell'abito e sorrise prima all’impresario e poi al ciambellano, l’anziano cavalier Cinquecerri, ritto dietro la sua poltroncina come l’angelo custode. Questi allora a quel segnale di certo concordato capì che toccava a lui la battuta e porse all'impresario ben altra busta. Inconfondibile la provenienza per formato e blasone. Perentorio l'ordine. D'altronde già la presenza del gentiluomo di Corte non lasciava adito ad alcun dubbio: il Duca aveva nominato la signorina Isabella Fioravanti prima donna al teatro dell'Opera per quegli indiscutibili meriti che solo i potenti sono in grado di riconoscere. Ma nella sua solita magnanimità il Duca desiderava elargire anche ai suoi amati sudditi uno scampolo di tanta beatitudine, in cambio s'intende di un’ulteriore, robusta quota del sofferto prelievo fiscale. E sarebbe stato quindi delitto di lesa maestà sollevare obiezioni a tanta munificenza, in particolare proprio durante le feste di primavera!
L’impresario che, prima di leggerlo, aveva compreso il senso del messaggio dovette rivedere il suo giudizio: dunque non era il conte Roncadelli ad essere interessato in prima persona alla cantante. Si era esposto invece per l’ennesima volta come “uomo di paglia” del Duca, probabilmente per vedersi condonare qualche debituccio di gioco.
«Bel vecchio ruffiano», riformulò allora il giudizio sul conte.
Così anche Saccomanni dovette atteggiare la sua espressione al ruolo teatrale del ‘Perfetto Felice’, cioè del ‘Gioioso Imbecille’. Offrì alla signorina uno dei suoi dolcetti di cui era gelosissimo: «un petit bon-bon?». Lei, dopo averne staccato solo una briciola con un grazioso piccolo morso, disse «merci!» con le ciglia e con una vocetta sottile sottile, come la punta delle sue scarpine.
Saccomanni, fuori di sentimento, si slanciò sulla sua bottiglia e, questa volta senza risparmio, si riempì con tale precipitazione il bicchiere che parte del contenuto traboccò, macchiando un pacco di partiture. Con lo sguardo cercò un paio di bicchieri puliti per fare un po’ di onore alla visitatrice e al ciambellano. Si rivolse invano allo scrivano perché gli trovasse due coppe. Naturalmente non ottenne risposta. Dovette rassegnarsi a semplificare il cerimoniale di benvenuto. Allora si scusò con entrambi gli ospiti, ma quello, disse, era solo il suo salotto di lavoro e nell’imminenza della stagione teatrale non si poteva permettere troppe distrazioni, né alcuna comodità.
Cercò almeno di offrire alla cantante qualche espressione galante per farsi perdonare il comportamento poco ospitale. Si alzò dalla sua poltrona e portò una sedia proprio accanto alla Fioravanti. Dopo che il cavaliere ebbe rifiutato l’invito, si accomodò lui stesso di fianco alla giovane, così poté valutarne meglio il viso, di fronte e di profilo. L’esame lo lasciò abbastanza soddisfatto: bell’ovale, sguardo malizioso, due graziose fossette sulle guance che fiorivano ad ogni sorriso, labbra e naso ben disegnati, dentatura perfetta. Nessun difetto, nonostante il trucco e l’acconciatura non avessero potuto nascondere del tutto qualche traccia di vaiolo sulla fronte. In compenso poté respirare il suo profumo. Era un’essenza delicata, adorabile, probabilmente un’acqua di Colonia che aveva già saturato la stanza e che per alcuni giorni rimase nell’aria a ricordo di quell’incontro.
«Allora sareste proprio voi la Bella Pescatrice?». L’impresario provò a celiare, ma non se la sentì di complimentarla al di là di quella frase di circostanza.
«Mais oui!» pigolò lei, ergendosi con orgoglio sulla poltroncina e protendendo i seni generosi. E gli rivolse uno sguardo meravigliato per tanta ovvietà. Poi in attesa di qualche altro complimento, a cui probabilmente era abituata, spalancò gli occhi, manifestò un esagerato interesse e sorrise fiduciosa. Saccomanni, però, non era granché come conversatore né come uomo di spirito. Si sentiva che non era troppo avvezzo all’etichetta di una Corte. Eppure come compenso per il suo unico sforzo ricevette ugualmente il più amabile dei sorrisi e l'eccessiva considerazione di bellissimi occhi grigi.
«Siete francese, mademoiselle?» chiese l’impresario. Sperava almeno di fare una bella impressione nella conversazione. In effetti il francese si parlava abitualmente sia a teatro che a Corte ed era un idioma che lui padroneggiava benissimo.
«Un peu» fu la risposta sibillina della cantante, che non si sbilanciò oltre. E non disse neppure che in realtà era nata da genitori italianissimi in una locanda della Repubblica di San Marco, -il padre oste, la madre serva- luogo che aveva abbandonato presto per rispondere al prurito dell’arte al seguito di una compagnia di giro. Nei primi tempi la ragazza, ancora un po’ acerba ma con una grande vocazione ad apprendere di tutto, era stata istruita da un giovane e incoraggiante maestro di canto con il quale aveva spartito desco e giaciglio. Ma in seguito fu da lui presentata a molti altri protettori più munifici e altolocati, magari un po’ in là con gli anni, che avendone apprezzato le multiformi inclinazioni, le fornirono adeguati soccorsi e lusinghiere referenze.
*
Nella stanza accanto Fontana e Salimbeni, che da giorni passavano in teatro per conoscere il nuovo soprano, erano impegnati in una delle loro interminabili partite a zecchinetta. Anche il fortepiano attendeva, seppure trasformato in tavolino da gioco.
Saccomanni troncò le cerimonie e andò ad annunciare l’arrivo della Prima Donna. La presentò nei termini più accattivanti e si scusò di non poter partecipare alla prima prova a causa di certi impegni.
Alla vista dell’artista tanto attesa Fontana inforcò le lenti perché quello che vedeva meritava la migliore attenzione. Abbandonò perfino il buon gioco delle carte, si alzò in piedi e sollecitamente le andò incontro. Si inchinò, le rivolse un compito baciamano e incominciò a intavolare una conversazione fitta di schermaglie e di complimenti, di scherzose allusioni e di motti di spirito nel più perfetto stile mondano. La Fioravanti replicava con indulgenti risolini simili a singulti.
Invece Salimbeni, sempre più impacciato del suo collega, scordò di presentarsi e rimase come paralizzato davanti a quella giovane così bella, non sapendo né che cosa dirle né che cosa fare delle sue mani che allora nascose tra i pizzi della camicia. Solo la sua leggera balbuzie poteva spiegare questo atteggiamento insolito in un uomo di lettere. A quel punto Saccomanni lasciò che i tre se la sbrigassero da soli e fu ben felice di prendere congedo.
*
Ritrovò il ciambellano adesso seduto sulla poltroncina che già aveva ospitato la cantante. Ancora calda.
«Allora è proprio come pensavo: il conte Roncadelli non si stanca mai di fare il suo solito mestiere…» e Saccomanni agitò il biglietto di presentazione.
«Eh, già! E per conto terzi, direi. E di quali terzi, poi!», sospirò il nobiluomo, segnando contemporaneamente con l'indice verso l'alto, non si sa bene se per additare il putto dipinto sul soffitto o qualche altra suprema potestà.
«D'altronde, alla nostra età, caro Saccomanni, che cosa ci resta da fare? Adattarsi, compiacere e arrivare a sera, no?»
L'impresario, usando un vecchio spartito come fosse uno strofinaccio, provò ad asciugare il tavolo bagnato per il vino rovesciato e poi sbottò:
«E anche per questa stagione un'opera di Fontana e Salimbeni! E passino pure, pazienza! Hanno firmato un contratto per tre opere e se questa, grazie a dio, è veramente l'ultima!… Ma adesso, una prima donna sconosciuta! E mi si impone un allestimento 'moderno' con architetture mobili, giochi d’acqua e costumi ‘babilonesi’ anche per il coro, anche per l’orchestra… Mi costano una fortuna! Sarò costretto a chiedere ancora quattrini. E tanti! E a sentirmi dire che sono incapace di amministrare i fondi del teatro… che magari me li metto in tasca io o che me li bevo. Ah, mi si vuole fare ammattire! Vedete, eccellenza, con quali panni mi devo vestire? È mia alla fine ogni responsabilità! È come se tutti gli anni mi toccasse passare tra le schioppettate! E poi la voce! Ma non l'avete sentita?»
«…e quando canta è peggio ancora, mi sembra», osservò rassegnato il cavaliere.
Rabbrividirono sull'acuto della prima aria, 'Del cor dolce penare': l'asfissia di un cigno -ad essere gentili- o un perfetto nitrito.
Eppure al termine dell’esecuzione dalla stanza vicina giunse il suono di un compiacente battimani. E seguirono le voci complimentose del musicista e dell’autore del libretto che si congratulavano con la graziosa Fioravanti per quella lettura perfetta della partitura, addirittura a prima vista! E che timbro vocale! che dizione! Per la loro opera non avrebbero potuto desiderare un’interprete migliore.
Chissà se quegli elogi erano dovuti al fatto che i due conoscevano già l’identità dell’alto patrono dell’artista. Di certo qualche sussurro della Corte doveva aver raggiunto tempestivamente i due autori, ma non il burbero impresario che era stato bellamente scavalcato.
«Però…», concluse il gentiluomo e continuò ad alludere con l'indice all'alto regno dell'onnipotente suo protettore. Allargò le braccia e si produsse in una smorfia di rassegnazione. Riprese dal tavolo la lettera del Duca e se la mise in saccoccia.
«Capirete…», ma non ebbe bisogno di giustificarsi.
«Invece per lo scritto del conte Roncadelli… fate voi. A scarico di responsabilità potreste conservarlo nei vostri registri ed esibirlo in alto loco se… se la faccenda dovesse mettersi male. No? Di certo “Lui” capirebbe l’allusione…», ridacchiò. E indirizzò un altro sguardo beffardo in direzione del soffitto e poi della sala prove.
Si alzò puntellandosi sul pomo d'argento del bastone da passeggio e salutò con compita ironia, da quel perfetto cortigiano qual era. Si fermò sulla soglia, scuotendo il capo sul secondo acuto.
«La signorina Fioravanti è alloggiata con la domestica presso l'Albergo della Posta: fate che una carrozza con equipaggio sia sempre a sua disposizione…» raccomandò.
« e… bonne chance!»
Si rimise il tricorno e uscì a passi lenti dalla comune.
*
Al termine di una settimana di prove, arrivò puntuale alla cancelleria ducale la prima lettera anonima, volutamente in debito con l'ortografia e scritta con la mano mancina, ma la cui carta fine, la busta leggermente profumata e la calligrafia femminile rivelavano quale fermento agitasse ormai un certo salotto in cui si passava disinvoltamente dalla passione per il melodramma alla più fantasiose cospirazioni politiche. Il breve testo recitava così:
«Mandate via ‘quela baldraca’ e ‘vadino’ via pure il ‘tirano’ e tutti i suoi ‘schierani’. La voce del popolo.»
Inutile dire chi fosse la ‘baldraca’.
Il ‘tirano’ e gli ‘schierani’ erano naturalmente il Duca e gli elementi del partito 'codino', e la sgrammaticata 'voce del popolo' che aveva sottoscritto il testo, più che al popolo, apparteneva ai velenosissimi ospiti del salotto della contessa Bertani. Qui si leggevano con palese riservatezza le gazzette d'oltralpe, naturalmente sotto il controllo dell'informatissima polizia ducale che, in casi come questi, sapeva chiudere saggiamente entrambe le palpebre.
L'episodio non avrebbe destato ulteriore risonanza, oltre a quello di ingrossare un già ponderoso faldone negli archivi di polizia, se la lettera non fosse stata riprodotta anche su alcuni manifesti, parimenti sgrammaticati, appiccicati nottetempo nei principali luoghi d'incontro e di passeggio, tra cui la cattedrale e, per sommo sfregio, il caffè Franceschi, covo riconosciuto del partito ducale.
O che la minaccia fosse stata presa sul serio questa volta, o che si volessero solo ammonire i soliti cospiratori da caffè, fu rinforzata la guarnigione di cittadella con alcuni reparti richiamati dal contado. Una mattina, ad ammonizione di borghesi e popolani, quelle truppe furono fatte sfilare inquadrate nel corso principale, addirittura due volte, in andata e ritorno, precedute da pifferi e tamburi, con i vessilli spiegati al vento e gli ufficiali a cavallo, per il divertimento dei fanciulli e tra i commenti sprezzanti degli sfaccendati.
A rendere gli onori alle truppe novelle fu schierata una compagnia di granatieri della Guardia, quei mercenari tedeschi ben più alti, più marziali e meglio abbigliati che erano di stanza in città e che la popolazione non poteva soffrire. Il governatore prese stabile dimora nell’appartamento riservatogli nella fortezza e il comandante, generale Strodt, rispolverò un piano di addestramento per fanti e dragoni che risaliva alla guerra dei sette anni. Antiche bocche da fuoco ricomparvero sugli spalti. Si diceva che le colubrine fossero sempre cariche, pronte a sparpagliare la mitraglia. Di giorno numerose ronde pattugliavano la città e ancora più di notte. Non si arrivò a istituire il coprifuoco, ma chiunque era sorpreso in strada a tarda ora veniva fermato, identificato e ammonito: un po' bruscamente, se popolano, o con più deferenza, anche se con pari fermezza, se ospite di qualche importante carrozza.
Naturalmente non ci volle altro. Da quel momento, e in spregio a tutta la sorveglianza, fu un fiorire di libelli. E quando le botteghe dei tipografi furono perquisite e ai titolari vennero annunciate pene pecuniarie e corporali se avessero osato..., si diffusero anche sonetti e canzoni le cui allusioni sulla bocca del popolo delle strade e dei mercati si trasformarono ben presto da sottili parodie in sboccati madrigali e in sconci fescennini sintetizzati su muri e muraglie in espliciti graffiti osceni, dedicati alle esuberanti grazie della Fioravanti e ai ramificati ornamenti sul capo dell’incolpevole consorte del suo illustre patrono.
E pur non avendo il popolo, ovviamente, né tempo né quattrini da buttare nel teatro, rischiando poco e sfruttando la favorevole occasione, poté così mescolare il suo malcontento a quello dei “signori” per il cattivo uso del pubblico denaro, oltretutto in gran parte suo, denaro sudato e carpito dalle odiatissime gabelle.
In più alcuni “benpensanti” si misero ad accarezzare tutti coloro che erano disponibili a riscaldarsi contro tale andazzo. Si videro allora i sudditi più bighelloni, riuniti per strada in crocchi, aizzati da bellimbusti a discutere a favore di interpreti canori del buon tempo antico e contro moderni recitativi e cabalette, quasi che facchini ed erbivendole fossero stati debitori in passato di inviti a cena nei palchi dei nobili e dei borghesi e così avessero maturato l’esperienza e il diritto di manifestare le più libere opinioni. Tra l’altro costoro mai si erano impegnati in pubblici dileggi o in promiscue gazzarre dopo esibizioni canore non proprio eccelse.
A questo punto le lagnanze concordi dei ricchi e dei poveretti contro il malgoverno vennero allo scoperto, coalizzandosi intorno a un pretesto all’apparenza banale: i destini della nuova Opera.
*
Perfino sulla timoratissima "Gazzetta", con prudenti punti di domanda e parecchi verbi al condizionale, ci si arrivò ad interrogare se, vista la spesa, non fosse stato più appropriato permettersi repertorio e interpreti più consoni alla consolidata tradizione del bel teatro dell'Opera, orgoglio dei cittadini e invidia delle Corti finitime. Forse qualcuno si era riempito le tasche?
Non si fece attendere la risposta di Saccomanni, turbato nella sua onorabilità e debitamente ammaestrato dalla contessa Bertani. In una lunga lettera -che non fu mai pubblicata dalla ‘Gazzetta’ ma che allora venne opportunamente diffusa in certi salotti- pur con tante sfumature e allusioni, l’impresario volle precisare alcune ragioni a difesa del suo probo comportamento. Intanto quelle scelte artistiche che gli venivano attribuite non gli appartenevano. Inoltre, insinuò non troppo velatamente, erano state le altrui responsabilità a condizionare il suo operato e i costi. Era chiaro che il problema non era solo quello di avere speso tanti quattrini, ma di averli spesi male solo per «soddisfare i capricci altrui». E per ribadire il concetto, Saccomanni concluse la sua missiva con il dantesco: «…ma se ‘vuolsi così colà!’...», in modo che tutti capissero l’antifona.
Allora la “timorata” Gazzetta, di certo influenzata da ben altri poteri e da essi resa arrogante, improvvisamente cambiò rotta per evitare -come scrisse- “una pericolosa collisione tra reggitori e libera stampa” (che tanto “libera” poi non doveva essere). In ‘certi ambienti’ -scrisse il giornale- da tempo si stava aspettando un pretesto per mettere in difficoltà il Governo ducale e magari “per fare come in Francia”, Dio non volesse! Quindi il foglio, con poca delicatezza, rese pubblica l’esigenza di “sollevare al più presto l’impresario dai suoi gravami”, cioè di licenziarlo in tronco. E quando questo provvedimento venne notificato davvero al Saccomanni, ne fu data perfidamente notizia senza gli usuali ringraziamenti. La direzione del Teatro, si rese noto, era stata assunta ad interim dal conte Pier Luigi Roncadelli a cui, invece, andavano congratulazioni e felici voti di buona riuscita. Facendo propria l’ampia soddisfazione dei suoi lettori, il giornale produsse infine una rispettosa istanza al Duca perché non prestasse orecchio alle indebite pressioni di chi minacciava di stravolgere “il più bel cartellone delle ultime stagioni operistiche”. E nell’incipit dell’articolo si proclamò “Avanti tutta!”, quasi si vivesse in una città di mare.
Così fu sollecitata la rappresentazione de ‘La Bella Pescatrice’ che naturalmente comportava l’esibizione della sua graziosa, anche se stridula, interprete.
Sul retro dello stesso foglio si pubblicavano notizie dagli stati vicini. Sembrava che gli straccioni dell'armata francese comandati da quel Buonaparte - o Bonaparte - si trovassero in brutti arnesi e, nonostante altre corrispondenze parlassero di una loro incontrastata avanzata, li si davano ormai per spacciati, affamati e impantanati, più orda di rubagalline che esercito. L'altalena delle notizie contribuiva ancora di più a tenere desti gli animi, come sempre piuttosto surriscaldati. “Codini” e “patriotti” a turno alzavano la cresta e, localmente, la materia di tanto contendere si coagulò naturalmente attorno ai destini de ‘La Bella Pescatrice’.
Quando all'esercito francese fu attribuita una squillante vittoria, toccò a quelli che già venivano chiamati “giacobini” di esultare. Su un loro foglio, fresco di recente fondazione, ‘L’Araldo della Libertà’, costoro ammonirono che si sarebbe fatto di tutto per rimandare a casa loro, e scornati, tutti quelli che avessero favorito un simile insulto a Talìa, in una strana difesa della conservazione, seppure teatrale, contrari com'erano allo sperpero del pubblico denaro e alle discutibili scelte artistiche locali. L'ammonizione che era solo minaccia di fischi teatrali, venne invece interpretata alla luce dei cosiddetti 'tempi nuovi' come prodromo di sommossa e di un lavacro di sangue.
Ma quando la notizia della vittoria dell'armata francese fu smentita, o almeno alquanto ridimensionata, i partigiani del Duca -adesso stravaganti e improbabili fautori delle novità, seppure teatrali- oltre a far cantare un Te Deum nella cattedrale, minacciarono di regolare i conti una volta per tutte con i "ben conosciuti fomentatori di civili discordie", auspicio interpretato a sua volta come minaccia di carcere o di esilio, se non di solidissimo capestro, per “coloro di cui ben sappiamo i nomi” e per i loro “sodali”. E imposero il rispetto del calendario operistico voluto dal loro Signore.
Così gli Anziani, convocati in tutta fretta, in uno zelante stato di esaltazione patriottica, con una ‘grida’ affissa a tutti gli angoli, proclamarono “imprescindibile” l'esecuzione de ‘La Bella Pescatrice’ e ne affidarono la protezione alla ben addestrata truppa del generale Strodt.
*
La sera del primo maggio una doppia siepe di soldati disposti su due file, armati di fiaccole, con il fucile a spall'arm e la baionetta inastata facevano gli insoliti onori di casa davanti al teatro. Nel viale illuminato dalla luce resinosa, quasi dovessero passare militarmente tra le verghe, avanzavano circospetti in corteo i primi spettatori, cioè il Governatore e gli Anziani che, avvolti nelle loro toghe rosse, offrivano il necessario esempio di coraggio. Stranamente silenzioso, il popolo premeva alle spalle dei soldati allineati.
In mattinata, durante un litigio provocato in piazza da una banale contrattazione tra un granatiere teutonico e una fruttivendola, dagli insulti si era passati alle spinte e poi alle sberle e nel parapiglia generale avevano preso aria anche alcuni coltelli. Altri mercenari erano comparsi a dare manforte al commilitone e solo le sciabole roteate e le piattonate distribuite avevano persuaso la folla. Comunque due soldati erano rimasti feriti, uno leggermente per una coltellata a un fianco e l'altro un po' più seriamente colpito alla schiena da una seggiolata. Molti di più i feriti tra la gente, soprattutto per i colpi di sciabola, tanto per far capire che l'esercizio della violenza non è mai cosa da ignoranti.
Di un ragazzo rimasto sul selciato nel suo sangue e poi portato via, non si era saputo più nulla.
Il generale Strodt, più nervoso del suo morello, salutò i membri del governo cittadino sollevando in alto la sciabola. Partirono alcuni fischi dal buio e si udì distintamente una volgarità urlata in dialetto da una voce femminile. Ma fu come se nessuno avesse parlato. A stento trattenuto dal morso, il cavallo del generale cominciò a schiumare dalla bocca e a scalciare pericolosamente all'indietro.
Alla spicciolata arrivarono anche altri spettatori, tutti rigorosamente 'codini'. Ci furono fischi e invettive. Si chiedeva a gran voce il lutto cittadino per i fatti della mattinata, quindi la sospensione della rappresentazione. Qualcuno confermò che il ragazzo era morto nel pomeriggio e ne fece il nome tra il compianto.
Premuta dalla folla la seconda fila dei soldati, al comando, girò su se stessa e fronteggiò le persone. Erano i militari recentemente arrivati in città. Indossavano le divise verdi del Primo Reggimento, arruolato soprattutto nelle campagne del ducato. Spiegandosi in dialetto, i militari cercavano di calmare gli animi di quelli più a portata di voce. Così si instaurò tra quei soldati e alcuni spettatori una specie di conversazione che gli ufficiali stentavano a zittire. Invece ai mercenari, responsabili dello scontro al mercato, era stato riservato il compito di tenere sgombro il passaggio per le carrozze. E proprio al loro indirizzo erano rivolte le grida di "schifosi!" e di "assassini!".
*
Tutti sono in grado di rendersi conto della differenza che passa tra un uovo e una pietra e non solo per quanto riguarda le proprietà alimentari. Un uovo, meglio se non proprio di giornata, non richiede molta forza nel lanciatore e neppure eccezionale precisione di mira. Se lo si indirizza contro un gruppo di persone eleganti non è impossibile mandarlo a segno su più di un soggetto, grazie alla sua fragile struttura che ha proprietà di dispersione illimitata. Nella vittima produce una sensazione di disgusto, se colta nel viso o negli abiti da sera, che le inibisce da quel momento ogni contatto sociale. È meno onorevole di una ferita in duello e meno pernicioso di una bastonata: per questo è più umiliante. Negli astanti, invece, suscita mirabile e irrefrenabile voglia di ridere.
La pietra, di contro, è efficace solo se si desidera colpire più nel fisico che nel morale. Un buon lanciatore di pietre, infatti, sa cogliere il suo bersaglio anche a trenta passi, superando con calcolata parabola perfino un allineamento militare, restando anonimo in virtù del buio. La persona predestinata, da colpire possibilmente nel capo, non se la cava con meno di un robusto bernoccolo, se non peggio. Non è impossibile che una pioggia di selci lanciate anche a caso da più persone, se non la testa di qualcuno, arrivi a centrare ugualmente qualche bersaglio sensibile. E anche se magari il colpo arriva di striscio in ogni caso fa piuttosto male.
Quale soluzione intermedia potrebbero essere adottate le uova sode, però più adatte all'alimentazione già carente della plebe e quindi da non sprecarsi inutilmente come proiettili, oltretutto di dubbio effetto.
*
Gli spettatori furono fuori bersaglio dal lancio di uova marce e pietre solo quando riuscirono a varcare, e di corsa, l'ingresso del teatro. Le truppe schierate a loro protezione non si erano mosse di un pollice su esplicito ordine del generale Strodt che non ci teneva a suscitare peggiori disordini.
La platea e i palchi mostravano ampi vuoti, vuoi che la prudenza avesse suggerito a molti più domestici intrattenimenti, sia che una parte degli spettatori, vista da lontano la mala parata, avesse ordinato al cocchiere una precipitosa ritirata finché si era in tempo.
Il Duca era assente.
Il sipario si aprì alle nove precise. La prevista ouverture non fu suonata. Il tenore, evidentemente in preda al panico, steccò, e più volte, così vistosamente da far ben figurare perfino i raccapriccianti acuti della bella Fioravanti.
Nessuna reazione tra i pochi spettatori, adesso tutti raggruppati in platea; nessun mormorio, spenta ogni conversazione, inutile qualsiasi mondanità. Ognuno malediceva tra sé il momento in cui si era cacciato in quella trappola -soprattutto per manifestare intatta fedeltà al Duca- e si preoccupava di ciò che avrebbe trovato ad aspettarlo al termine dello spettacolo.
Tale era il nervosismo anche degli autori e degli interpreti che la rappresentazione si avviava verso un poco decoroso finale dopo appena due ore, a causa dei numerosi tagli improvvisati, quando proprio sull'ultima aria a più voci, 'Doman, a un fausto imene…', -il lieto fine, almeno sulla scena-, si spalancarono le porte del teatro e irruppe in platea una piccola folla guidata a grandi passi dalla contessa Bertani e dall'ex impresario Saccomanni che urlava: "Libertà! Il tiranno è fuggito! Viva la libertà!". Tutti gli invasori portavano in evidenza sugli abiti un serto verde. Come una coccarda.
Saccomanni balzò sul palcoscenico e qui, davvero molto teatralmente, ripeté il suo annuncio, agitando una fronda di sempreverde che generosamente, immemore delle passate sofferenze, appuntò sull’elaborata acconciatura della prima donna che poi presentò all’applauso della folla tenendola per mano. E, come colto da un pensiero improvviso, trinciò da quella fronda un rametto che, ebbro ma questa volta di gloria, depose di sua mano tra i seni tuttora frementi della bella interprete. Che lasciò fare.
Nella confusione che seguì si intese a malapena la contessa Bertani che, assieme al 'cittadino' Saccomanni, proclamava non si capì bene quale Repubblica e requisiva il Teatro che da quel momento in poi avrebbe ospitato ben più degne rappresentazioni patriottiche.
«Metteremo in scena per prima cosa “Lucrezia e Tarquinio” di Alcide Parrinelli» promisero e, sentita l'ovazione degli astanti, fu gioco arguire che doveva trattarsi di portentosa recita.
Mentre gli altri 'cittadini' della scorta inneggiavano ai futuri successi, i malcapitati 'codini', riavutisi dalla sorpresa e meravigliandosi di essere stati dimenticati, ne approfittarono per buttarsi come un sol uomo in direzione dell'uscita. E qui apparve a loro uno spettacolo incredibile.
Alla luce delle fiaccole tenute a braccia ben levate dai mercenari, opportunamente pungolati dalle baionette dei soldati del primo reggimento -ora ‘Guardia Nazionale di Campagna’- il generale Strodt consegnava la sua spada e la resa della città nelle mani del disorientato conte Bertani che farfugliò di accettare e l'una e l'altra «in nome della Repubblica e del popolo in armi».
Tutto questo senza lo spargimento di una sola goccia di sangue.
Quando la mattina dopo le truppe francesi entrarono in città non trovarono nessuno, né a contrastarle ma neppure a riceverle. Per le strade solo i segni manifesti di una notte di repubblicani festeggiamenti e di patriottiche bevute.
Ma contro il muro della torre dell'orologio era appoggiato un alberello sradicato dal parco ducale, un gelso già rinsecchito, non alto come un pioppo né robusto come una quercia, ma ugualmente acconcio simbolo dei tempi nuovi, orfano testimone di quella prima alba di tanto sospirata libertà.