chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Antonio Piscitelli
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
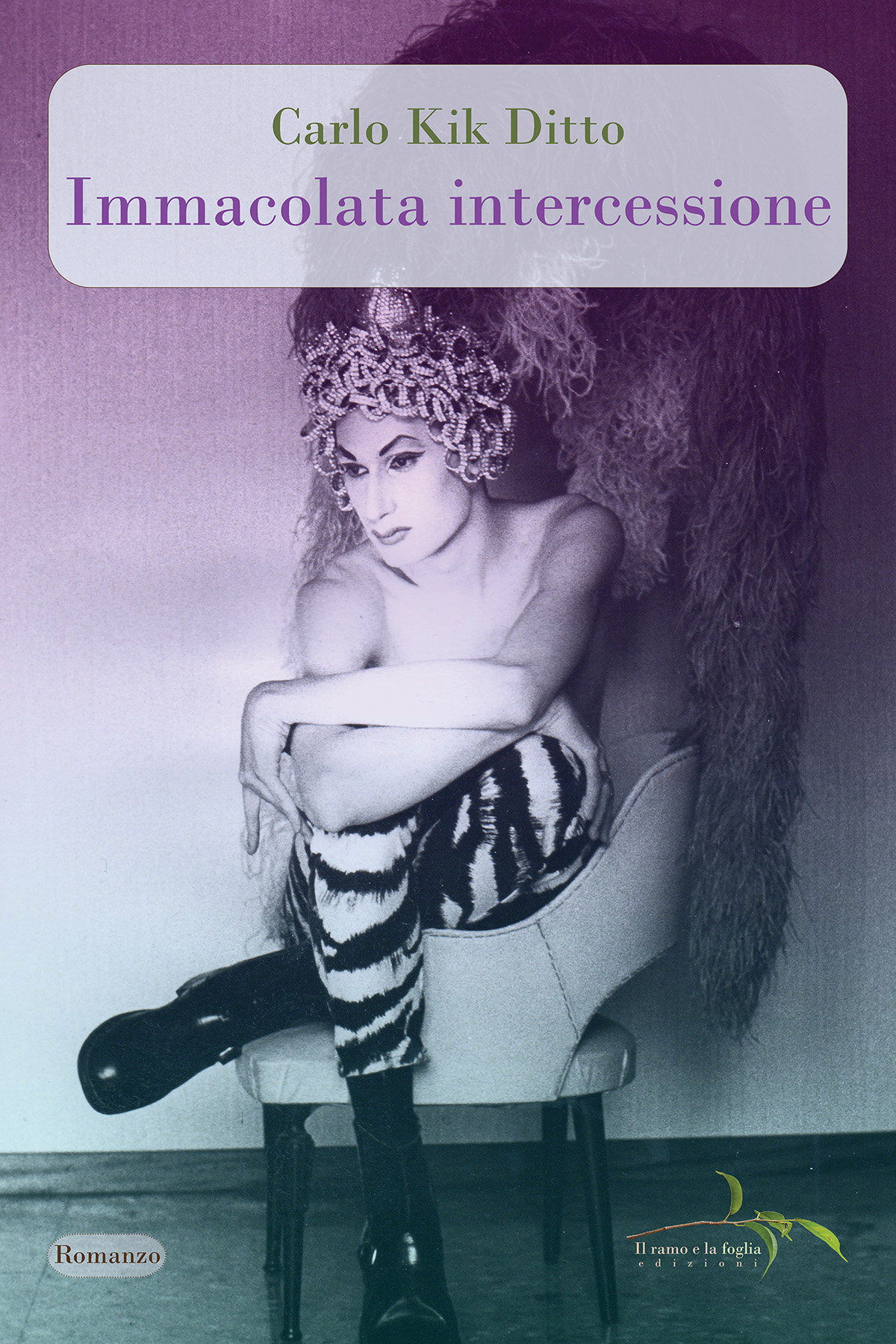 Carlo Kik Ditto - Romanzo - Il ramo e la foglia edizioni
Carlo Kik Ditto - Romanzo - Il ramo e la foglia edizioni
Immacolata intercessione
«LA FIGLIATA»
«Ma io credo ca pe’ sta’ bbuono a stu munno
o tutte ll’uommene avarriano ‘a essere femmene
o tutt’’e ffemmene avarriano ‘a essere uommene
o nun ce avarriano ‘a essere
né uommene né femmene
pe’ ffa’ tutta na vita cuieta…
… e haggio ritto bbuono!»
[Roberto De Simone, La gatta cenerentola]
La rappresentazione più recente del rito propiziatorio partenopeo ce la offre il film di Ferzan Ozpetek, Napoli velata (2017). La recita emula un fenomeno noto agli psicologi come “sindrome della couvade”, una vera e propria sintomatologia psicosomatica presente nei maschi alla prima gestazione della consorte. Percepiscono i disturbi della gravidanza o addirittura le doglie del parto. In termini antropologici si sa che, presso alcune popolazioni primitive, gli uomini fingono il travaglio dello sgravio per prepararsi alla paternità.
A Napoli il cerimoniale, oggi ripetuto come spettacolo per turisti, ha radici antichissime, probabilmente greco-romane, e potrebbe essere legato al culto di Ermafrodito e alle sue lontane origini asiatiche (Shiva e Parvati fusi in una forma androgina, Ardhanarishvara). L’intreccio di credenze e liturgie della fertilità ha sempre una spiccata simbologia erotica e spesso prelude alla confusione dei ruoli sessuali. Potrebbe trattarsi di inconsapevole anamnesi dello stadio embrionale nel quale femminilità e mascolinità erano confuse e indistinte. Quale che sia la spiegazione razionale delle odierne tradizioni, c’è probabilmente in ciascuno di noi come un senso di incompiutezza, per ciò che non siamo o non siamo potuti diventare. Le donne che vorrebbero essere uomini e gli uomini che vorrebbero essere donne sono l’apice di un’aspirazione più o meno consapevole all’intersessualità. Come spiegare, altrimenti, che consuetudini di antichissima fonte stentino ad estinguersi e che, anzi, trovino nuova linfa nelle rivisitazioni della contemporaneità? Immacolata intercessione di Carlo Kik Ditto è probabilmente l’aggiornamento di usanze necessarie alla sopravvivenza, in termini antropologico-culturali, di una comunità. Le ritualità sociali, piaccia o meno, sono il collante di una collettività che non vuole essere soffocata da innovazioni esogene. A dispetto della risibile ambientazione americana, il romanzo di Ditto racconta Napoli e le sue dissacranti manifestazioni pubbliche, che non al folclore alludono, ma a una primigenia identità. Così “la figliata” è qualcosa di più e di diverso dalla rappresentazione del pittoresco. È espressione di un atto di fede nel novero infinito delle possibilità. Che un uomo partorisca è surreale; ma la somma divinità nella quale crede Unicorn, se può infrangere le leggi di natura e rendere gravida una vergine attraverso una mistica fecondazione, può ben concedere, per grazia, a un maschio di partorire. Poco importa che gravida resti una transessuale, sta di fatto che la femminilità artatamente acquisita diventi autentica nella dimensione onirica e irrazionale del racconto.
L’eventualità che il fatto si verifichi è un atto di fede possibile nel tipo di religiosità praticata a Napoli, credibilmente non a Chicago. La devozione napoletana è intrisa di usanze pagane, nei confronti delle quali non c’è stata gerarchia ecclesiastica che non abbia abbozzato. Fin dai primi secoli la Chiesa ufficiale ha dovuto venire a patti con le ritualità comastiche radicate nelle tradizioni greco-latine, trasformandole come poteva in riti cristiani. Le romerie e alcuni tipi di pellegrinaggi sono eredità di antichi baccanali, feste orgiastiche nelle quali crapula e copula si presentano come surrettizie pratiche in felice connubio. Si informi, il lettore di queste note, cosa sono, in Campania, i pellegrinaggi al santuario di Montevergine o a quello della Madonna dell’Arco.
Qualcuno saprà che il Carnevale è un tempo liturgico di tipo penitenziale. Ma quanti, nella percezione comune, ne intendono il significato? Per i più si tratta di un periodo di trasgressioni durante il quale il vietato è autorizzato e l’indicibile è dicibile. Sospensione condizionale della pena! Pena di vivere, intendo. I vari Carnevale celebrati nel mondo sono, più o meno, feste pagane durante le quali ogni disubbidienza è concessa (ogni scherzo vale). I paludamenti dietro i quali celiamo le nostre identità ci consentono, verosimilmente, di essere, almeno una volta all’anno, ciò che non siamo. Il mascheramento potrebbe bene intendersi come bisogno di un’identità diversa, inclusa quella di genere.
Pochissimi ricorderanno com’era un tempo il Carnevale a Napoli. Parlo di un’epoca non lontanissima, ma sufficientemente distante per supporre l’assenza di una vera e propria consapevolezza delle frustranti e repressive norme sociali. Bene, i napoletani festeggiavano il Carnevale in questo modo: i maschi si vestivano da donna e le donne da maschio, andando poi in giro per le strade ad esibire, suppongo, più che un’omosessualità latente, un bisogno inconsapevole di provare l’ebbrezza di una differente identità sessuale, un’ancestrale memoria delle potenzialità dell’embrione dal quale ciascuno, per mera casualità, ha poi derivato il sesso anatomico, non senza nutrire nostalgia per l’anatomia sacrificata all’altare della necessità. Ciascuno di noi poteva essere di sesso diverso e non lo è stato. Ma per alcuni dei partecipanti alla mascherata era davvero la realizzazione di un sogno segreto. La transessualità era una chimera, per le metodologie mediche ancora rudimentali in buona sostanza e pericolose per quelli che vi si sottoponevano, come dimostra il bel film di Tom Hooper, The Danish girl (2015). Fino a tutti gli anni Cinquanta del secolo scorso il cambio di sesso si fermava al travestitismo e non andava oltre. Tuttavia, tale pratica come liturgia collettiva ci dice molto più della mera crisi di identità. Ci suggerisce che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato o immaginato di avere un sesso diverso, per curiosità forse, ma anche perché vorremmo sapere cosa prova il nostro, abituale o meno, partner sessuale. Un maschio potrebbe chiedersi: cosa avverte una donna, in cosa consiste il suo piacere rispetto al nostro? Cosa vuol dire essere penetrati?
Sembra che anche il maschio abbia un’area di elevato potenziale erogeno radiante situata in corrispondenza della prostata. Un surrogato della cervice uterina? Ne conoscono l’esistenza solo i gay o anche gli eterosessuali? Il celebre film di Bernardo Bertolucci, Ultimo tango a Parigi, risponde in qualche misura alla domanda. Pare, tuttavia, che molti etero temano che la cosiddetta stimolazione prostatica comprometta la loro virilità e dunque si astengano dal praticarla. Un pregiudizio come un altro, sembrerebbe, soprattutto se la sollecitazione è di tipo endoscopico. In altri termini, un dito, un oggetto apposito o anche un pene dovrebbe penetrare l’orifizio anale fino a circa cinque-sette centimetri per raggiungere la prostata e stimolarne l’area erogena. Per alcuni maschi inclini alla castigatezza una pratica del genere è considerata non virile. Ma altri sedicenti eterosessuali non si sottraggono all’esercizio della penetrazione di altri maschi, supponendo in tal modo di aver fatta salva la loro mascolinità, senza considerare che il partner è dotato di pene come loro e che dunque il rapporto è certamente omosessuale. Per altro verso il preteso passivo talvolta si compiace del ruolo femminile che il partner supposto etero gli attribuisce perché immaginare di essere amato da un vero stallone amplifica la percezione del piacere. Sono tutti piccoli escamotage che la psiche elabora per gratificare l’identità negletta, ignara della circostanza che l’individualità, comunque si manifesti, è un diritto sacrosanto che nessuno dovrebbe mettere in discussione. Malauguratamente i pregiudizi sono difficili da combattere quando sono conseguenza di culture ataviche fortemente radicate nelle comunità.
Il protagonista del romanzo di Ditto è un maschio omosessuale di aspetto virile. È un gettonato pornodivo, di carattere volitivo, fortemente sicuro di sé, non privo di un pizzico di narcisismo legato alla fisionomia e alle dimensioni del suo pene. Il lavoro che svolge è per pochi privilegiati. Coniugare gradevolezza fisica e misure falliche non è proprio da tutti. Per lui è una specie di missione finalizzata a dare piacere ai fan. Si atteggia anche a benefattore dell’umanità. Troppe qualità per un sol uomo. Intanto mi sento di affermare che le dimensioni spropositate del sesso non sono sinonimo di potenza o appagamento sessuale. I tessuti cavernosi necessitano di un adeguato afflusso di sangue. Un fallo smisurato non ne riceve a sufficienza e dunque regge l’erezione a fatica o non la regge affatto. Uno svantaggio piuttosto che un vantaggio per una stella del porno. È per questo che penso che rappresentare l’enormità dei peni sia piuttosto retaggio di religioni primordiali veneranti divinità itifalliche, le più celebri delle quali furono Priapo e Dioniso. I grandi peni che spesso vediamo comparire sui muri delle nostre città sono simulacri che non rinviano a nessuna realtà sottogiacente. Hanno un valore apotropaico o propiziatorio, per chi ci crede. Manifestano una fede o rivelano un’angoscia, quando non un complesso di inferiorità. Il cornetto della superstizione napoletana (il nome d’arte Unicorn lo evoca) è un simbolo derivante dalla forma del fallo.
Queste osservazioni mi consentono di interpretare una delle sequenze più raccapriccianti del libro di Dotti nel suo valore simbolico di rito propiziatorio della fertilità. Compaiono ben cento attori maschi, più il protagonista, in un unico film porno. Cento amplessi anali subiti nell’arco di poche ore e un mare di liquido seminale. Non credo esista nulla del genere nella pur nutrita produzione pornografica. Devo pensare a una liturgia della fertilità concomitante del miracoloso stato di gravidanza di Shebop, la trans coprotagonista del romanzo.
Intendo dire che la vicenda è così paradossale che dev’essere per forza riconducibile alla tradizionale simbologia della figliata napoletana e ascrivibile alla letteratura antropologica che vanta non pochi precursori, non ultimo dei quali quel Roberto De Simone citato in esergo che, esattamente tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, attraverso opere di grande successo, diede dignità artistica e autentica drammaticità al personaggio del femminello tipico della cultura popolare campana. Intorno alla sua drammaturgia in musica ruotarono giovani autori che diedero lustro al teatro napoletano e variamente trattarono la commistione tra sessualità e religione nella sensibilità del volgo: Annibale Ruccello, Enzo Moscato, Manlio Santanelli, Franco Autiero, Francesco Silvestri, Ruggero Cappuccio, Fortunato Calvino.
In “Festa al celeste e nubile santuario” di Enzo Moscato puoi rinvenire il connubio sesso-religione che caratterizza Unicorn. La figura iconica del femminello è celebrata nel noto documentario di Fortunato Calvino su Carmelo Cosma (La Tarantina).
Dalla nutrita letteratura sui temi dell’altra sessualità potrebbe avere attinto Dotti nel progettare il suo racconto. Potrebbe essersi mosso sulla scia di Curzio Malaparte (La pelle), Giuseppe Patroni Griffi (Scende giù per Toledo). Penso anche al film Splendori e miserie di Madame Royale, opera notevole del compianto Vittorio Caprioli, oppure a Mater Natura di Massimo Andrei e, ovviamente, alla vasta produzione hollywoodiana più convenzionale, in relazione all’ambientazione e alla caratterizzazione (per la verità poco credibile) dei personaggi, che appaiono come una parodia degli americani. La figura di Shebop somiglia ad alcune omologhe della recente serie Netflix intitolata Pose, puta caso ambientata negli stessi anni del romanzo nel contesto dell’house system newyorkese. L’esotismo è il peccato di tanti che si affacciano alla letteratura, ahimè! Per molti giovani scrittori sprovveduti un nome straniero è sufficiente a dare spessore e anima al personaggio e pensano che ambientare una storia in un posto lontano dalla patria renda più accattivante l’opera. Sindrome di Alberto Sordi la chiamerei, se non fosse che l’americanismo di Sordi avesse un carattere smaccatamente parodico. Elena Ferrante scrive di Napoli e i suoi numerosi lettori americani l’apprezzano per questo.
Ecco, se il lettore immagina Napoli come scenario, tutto diviene meno improbabile e l’intera vicenda potrebbe postillare la riedizione di Sud e magia. Intendo dire che una lettura in chiave etnologica si rende necessaria, se si vuole escludere la gratuità dell’operazione. In altre parole, il libro di marcatamente letterario ha poco, mentre sul fronte dell’investigazione psico-etno-antropologica ha più cose da dire di quanto, a priva vista, appaia.
Peregrina, almeno per me, è l’esplorazione di un universo che non conosco o conosco marginalmente. Non sono mai stato sul set di un film pornografico e meno che mai mi sono imbattuto in una pornostar. Invece Dotti ci prende per mano e ci porta nel bel mezzo di riprese hard, ce le descrive, ci lascia immaginare l’apparato scenico e il canovaccio. Ne ha esperienza? Sa di che parla? Non ne ho idea. So che la postfazione è firmata da Ettore Tosi. Carneade! Chi era costui? Cerco il nome sul web e scopro trattarsi di un attore pornografico, regista e produttore cinematografico italiano, che lavora esclusivamente nel campo della pornografia gay. Fin qui Wikipedia. Dunque, uno del mestiere che potrebbe bene essere stato il consulente dello scrittore. Il suo commento al romanzo ne certifica la verosimiglianza, almeno relativamente alla rappresentazione degli ambienti della pornografia. Ci dice che, dietro i Big Jim dello schermo, si celano anime che palpitano e cuori che ardono. Mai messo in dubbio l’assunto! E tuttavia vorrei saperne di più. Non esprimo giudizi di valore, ma di realtà. Non sono un moralista e mai lo sarò, nondimeno pretendo di sapere in quale contesto di legalità si muove la pornografia, come sta messa col fisco, chi investe nelle lucrose produzioni, quali garanzie di sicurezza ricevono gli attori e soprattutto che fine faranno quando dovranno per necessità ritirarsi dalle scene. Mi preoccupo degli esseri umani e nessuno può negare che i pornodivi lo siano. Non mi importa come si guadagna da vivere la gente, fatta salva la sua dignità. Apodittica, in qualche misura, è l’umanità del pornodivo che trovo nel penultimo romanzo di Massimo Carlotto, La signora del martedì. Leggere per credere.
La scopofilia è sempre esistita, persino in epoche in cui la pornografia era di là da venire. Recentemente ho letto un saggio sui nudi artistici come mezzo di turbamento carnale o incentivo all’onanismo. Un corpo ben fatto può suscitare “cattivi pensieri” e non me ne preoccuperei più di tanto. Se potessimo leggere nella mente della gente, troveremmo un bel po’ di oscenità. Oggi i bei corpi non sono solo immagini, appartengono a uomini e donne viventi. Rispettarne diritti e sicurezza è sacrosanto, come per chiunque. Niente raggiri, niente costrizioni, niente sfruttamento, sia ben chiaro!
Per il mestiere che faccio non posso esimermi da marginali notazioni di carattere critico e valutare la forma del romanzo sul quale ho fin qui sproloquiato.
Mentre sul fronte del narrato mi pare che lo scrittore poco curi prosodia e ritmo del discorso, sul versante drammaturgico l’eccesso di dialogato sovraccarica il testo sacrificandone la fruibilità. Vedete, in un romanzo, i dialoghi sono la cosa più difficile da scrivere. Si corre il rischio di farne un pastrocchio e di compromettere l’attenzione del lettore. Per farmi intendere cito la sceneggiatura di un film-commedia americano ben costruito. Il film, nelle sue due versioni, è tratto da un testo teatrale, dunque girato tutto in interni. Gioco di macchina e dialoghi efficaci sono fondamentali, servono a tener desta l’attenzione dello spettatore e ad acuire la drammaticità dello spettacolo. The Boys in the Band di Mart Crowley (versione teatrale e duplice versione filmica) è un buon esempio per due comprensibili ragioni: i personaggi sono tutti omosessuali di sesso maschile; i loro dialoghi sono serrati e fortemente caratterizzanti non della categoria, che è una semplice e banale invenzione ghettizzante, ma degli individui. Le categorie sono astrazioni, gli individui sono personalità. Le parole che pronunciano sono espressioni di sé, non so se mi spiego. Se l’autore non gliele mette in bocca in maniera fortemente caratterizzante, nell’annullare la personalità, ne sopprime la raffigurazione e la funzione. Sparisce il dramma di cui ciascuno di loro è portatore e banalizza la vicenda. Insomma, i personaggi diventano maschere della Commedia dell’Arte. Bisogna tradire le attese del lettore/spettatore, evitare i cliché se non si vogliono alimentare pericolosi pregiudizi. Non sono certo che l’autore di Immacolata intercessione voglia questo. Spero che qualcuno mi capisca.
Ho finito? Sì, ho proprio finito!
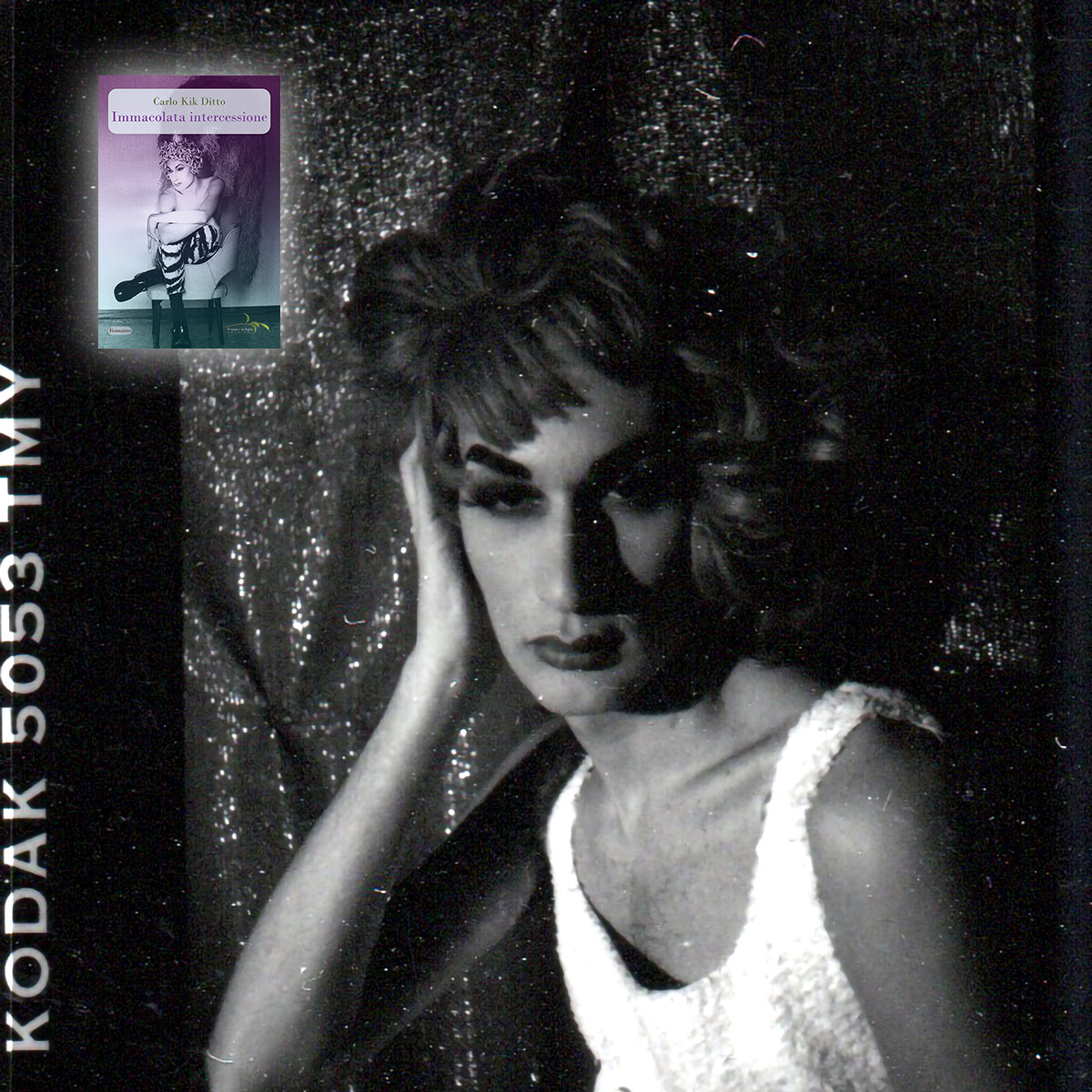
📸 The Real Lady Stretch
in uno scatto di Garth Meyer https://garthmeyer.com/
Id: 1321 Data: 19/11/2021 12:00:00
*
 Miki Bencnaan - Romanzo - Giuntina
Miki Bencnaan - Romanzo - Giuntina
Il grande circo delle idee
Foschia. L’anzianità di una persona riduce il valore della sua morte, esordisce Miki Bencnaan, l’autrice dell’eccellente libro pubblicato da Giuntina nella traduzione di Anna Linda Callow. E se non è l’autrice in prima persona a darci la notizia della scomparsa di due anziane donne tra le mura della casa di riposo “Yadlitza Norbert” di Gerusalemme, lo fa per lei una voce esterna ai fatti, neutra, distaccata, forse indifferente. Foschia. Una fuga di gas, e rilevo gas, ha causato la morte delle due signore. Un incidente, questa volta si è trattato di un incidente, ma il gas non è fortuito. Apprendiamo che è il 19 novembre del 2009. Ancora da una terza persona, ancora dalla meticolosa neutralità del cronista: sulla scena dell’incidente irrompono i congiunti di una delle donne, Binyamin Hopsa, suo figlio, e Pinki, suo nipote. Dell’altro cadavere non si sa nulla, almeno finché il lettore non riesce ad afferrare il bandolo della matassa, il che avviene molto tardi nello sviluppo della vicenda.
Un flashback ci riporta a quindici anni prima, più o meno all’epoca in cui quattro arzilli nonnetti si incontrano casualmente nel comune gerontocomio. Si chiamano Leon Vaydenfeld, Futerko Hopsa, Emanuel Elbalak e Pesca Principali. Ho scritto “casualmente”. Sbagliato. Il caso ha un sofisticato regista e un cantore bizzarro, entrambi già messi in scena senza che il lettore badi a loro più di tanto. Foschia.
Questo l’inizio. Ora dovrei proseguire e cercare di riferire per sommi capi i temi del romanzo. Non lo so fare. Foschia. Per poterlo fare dovrei conoscere la lingua degli elefanti, ma ho appena cominciato a studiarla, proprio partendo da questo libro e vi confesso che, tardo come sono, mi ci vorrà un po’ di tempo per padroneggiarla. Provo a riportare ciò che ho capito. Il libro è un’anti-enciclopedia o un’enciclopedia alla rovescia. Non diffonde informazioni utili, anzi! Le direi piuttosto perniciose per gli automatismi più o meno consci che governano il nostro agire. Foschia: se la vita che conducete vi piace, il libro non è adatto a voi; ma, se voleste prefigurarvene un’altra, magari solo un pochino più bella, che so un modello che preveda la felicità, pregiudizio per pregiudizio, tanto vale che lo leggiate. Il libro. Troverete istruzioni giovevoli al vostro progetto. Imparerete come accumulare denaro in gran quantità in un tempo relativamente breve e quanta fatica comporti sperperarlo. Ancora, vediamo: imparerete a “coltivare” i mobili di casa, praticamente a costi limitatissimi e senza distruggere l’ambiente, grazie all’invenzione del professor Emanuel Elbalak, un autentico genio. Costui è anche il creatore di un pasticcio di fagioli dal gusto impareggiabile. Potrebbe piacere soprattutto ai giovani, giacché è in versi ed è servito al ritmo di un vero e proprio rap. I fan della cultura hip hop hanno di che gongolare.
Imparerete anche come essere vivi anche quando la morte è un fatto incontrovertibile. Immortalità? Una specie. Forse qualcosa di meglio.
Non ci sono controindicazioni alla lettura del romanzo, ma qualche attitudine è necessaria, oltre, ovviamente, a una buona conoscenza della lingua degli elefanti. Per esempio, dovreste essere affetti da sinestesia, una malattia ormai rara che l’antidoto dell’anestesia ha quasi cancellato dalla faccia della terra. Ne resta qualche traccia in isolati portatori sani, credo innocua a giudicare dallo scarso rilievo che le dà la World Health Organization. L’estensore di questa nota ritiene di essere parte di questa minoranza, anche se non dovete credergli perché sa mentire come pochi altri. Può capitare che di sinestesia siano affetti gli artisti e qualche sparuto fruitore delle loro opere, ma il numero di entrambe le categorie è così esiguo che non c’è un vero rischio di epidemia. Foschia. Come? Che dite? Ce ne sono molti? Di sinestetici? Raccontatela a un altro, non la darete certo a bere a me! La globalizzazione è narcotizzante per definizione e i mutanti in circolazione sono maggioritari. C’è forse qualcuno che piange la morte dei nonni, le ultime creature dotate di memoria? Chi prova dolore per la morte della Storia? D’altronde il fatto che pronunciamo una parola, non implica che esista il corrispondente referente. Prendete la parola “ebrei”. Voi sapreste indicarne l’oggetto designato? Non esiste. Come disse Jean-Paul Sartre, è un’invenzione dei loro avversari. Cioè è un parto della nostra mente, il mostro sul quale sfogare le nostre frustrazioni. La nostra facoltà di pensiero è così abile a rappresentarsi l’inesistente che non c’è cosa al mondo che non sia pregiudizio, inclusi noi stessi. L’attività cognitiva è mera ricognizione.
Io sono un’allucinazione nel mio cervello.
Un pregiudizio e niente più.
Così recita l’esergo del libro. Non posso contestare quest’assunto di lapalissiana evidenza, anche se so che la storia intera dell’umanità si regge sul pregiudizio. È la rappresentazione parziale e partigiana del Fatto, non è il Fatto. Vedete, ogni rappresentazione è rappresentante di un rappresentato. È solo la sua immagine o, se volete, la sua immaginazione. Il disegno di una casa, non è la casa, ma solo la sua immagine parziale. Noi non sappiamo nulla della casa, a parte il fatto che il disegno ci evoca la sua immagine. Il Fatto ciascuno se lo cala addosso a seconda dei bisogni del momento, della particolare sensibilità e intelligenza, del livello di conoscenza, del tornaconto. Quest’ultimo, direi, è quasi il principale generatore della nostra rappresentazione del Fatto. Si capisce allora come un semplice costume da elefante possa modificare radicalmente la nostra identità, almeno nell’immagine mentale che ne abbiamo. Siamo “ariani” o “ebrei”? Beninteso, le parole virgolettate non hanno alcun referente, benché abbiano generato la più grande tragedia della storia. Evocata nel romanzo, certamente e necessariamente evocata, anche se, a me sembra, non ne costituisca il motivo conduttore. Il quale è annunciato proprio dall’esergo.
Nelle vicende che s’intrecciano come l’ordito e la trama di un tessuto dal complesso disegno v’è il desiderio di infrangere le regole della tessitura. Il gioco vale la candela se la prospettiva è il disvelamento di una possibile alternativa alla pania nella quale siamo invischiati. Basta non affidarsi alla forma che gli accadimenti assumono nella nostra mente.
«Per questo, secondo me, dovreste mettere in dubbio tutto ciò che vi raccontano. Incluso perfino ciò che vi sto raccontando io adesso». Sono le parole di Pinki Hopsa, il trentenne bizzarro che soffre di sinestesia, che ama disegnare specie volatili estinte e che da personaggio si fa narratore, anzi poeta di un’opera che assume sempre più l’aspetto di un cantico.
Questo Pinki mi piace, somiglia tanto ad altre figure letterarie di grande suggestione. Candido, Myskin, il Pazzariello della Morante? Sì certo, ma anche il Puck pasticcione del “Sogno di una notte di mezza estate”, commedia della quale si dice nel libro e che forse è l’archetipo letterario del “grande circo” che chiude come una sarabanda luminescente l’opera. Assennatamente pazza, come “Il maestro e Margherita” di Bulgakov. L’antitesi non è casuale perché non c’è nulla di più assennato della follia per diradare la foschia che ci avvolge.
Il complesso intreccio, i cambi di prospettiva, una “rettorica discreta” nella quale domina sovrana la figura provocatoria dell’ironia, il riferimento a prototipi letterari di una classicità trasgressiva e irriverente (penso all’Ovidio delle Metamorfosi o all’Apuleio de L’asino d’oro) ascrivono il romanzo della Bencnaan al grande circo della letteratura di tutti i tempi.
Brava anche la traduttrice che ha saputo trasferire nel nostro idioma atmosfere sfuggenti e i ritmi di una prosa che suona come le celebri musiche di scena che Felix Mendelssohn compose per il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Non a caso, vi assicuro non a caso.
Il libro è un raggio di sole nella densa tenebra che offusca la nostra coscienza, fende come una lama affilata la fitta foschia che avvolge la terra. E noi siamo i vapori del gran mare dell’Essere, tra le cui braccia ricadremo come pioggia che torni alle scaturigini.
Id: 843 Data: 24/04/2015 12:00:00
*
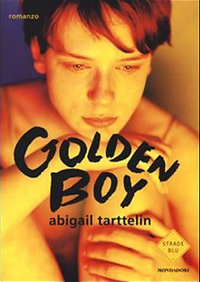 Abigail Tarttelin - Romanzo - Mondadori
Abigail Tarttelin - Romanzo - Mondadori
Golden Boy
Siamo fenomeni
Guardo la copertina. Colpisce, sicuramente colpisce. Non riesco ancora a interpretarne le intenzioni. Non conosco nulla di questo libro, se non il titolo. Non leggo neppure il nome dell'autrice, né le note editoriali sulla quarta, nei risvolti. Mi irrita che di un libro mi colpisca la copertina. Mi sa di marketing. Lo so da sempre che l'imperativo del guardare è la trappola in cui cadiamo tutti, narcotizzati dal trasferimento metonimico che ci fa privilegiare il vuoto piuttosto che il pieno, il contenitore anziché il contenuto, per l'innocente automatismo con il quale di una scatola di cioccolatini ammiriamo la confezione e l'acquistiamo perché si presenta bene, magari ignari che stiamo comprando un pessimo prodotto, fors'anche un surrogato. Il buon Vance Packard ci ha insegnato ben poco.
Diffido della copertina, non del titolo. Dev'essere un libro che tratta del mondo giovanile. Un mio vecchio pallino, quello di andare a cercare pubblicazioni recenti adatte ai miei allievi. Un modo come una altro per avvicinarli alla lettura e per indurli a discutere con me qualche tema di loro interesse. Dai libri sull'adolescenza ho imparato anch'io ovviamente o quanto meno mi sono aggiornato. I ragazzi cambiano, apparentemente cambiano col mutare dei tempi, velocemente, nelle abitudini, nei comportamenti. Senza considerare che la pubertà ha il fascino dell'indeterminatezza, della pupa che presto evolverà in farfalla. Insomma li leggo volentieri i libri che narrano i ragazzi; non dico che mi fanno sentire ancor giovane, ma certamente vivo, questo sì.
Decido di comprarlo ma, poiché ne diffido, lo lascio riposare per un bel po', quasi me ne dimentico. Poi, un pomeriggio tedioso, comincio a leggerlo. Le prime battute mi evocano una commediola hollywoodiana. Sono tentato di riporlo e passare a qualcosa di più interessante. Fuori piove a dirotto, le strade sono deserte, il grigiore entra anche nel living nel quale mi sono messo a leggere, sono costretto ad accendere la luce. No, non mi va di affrontare libri troppo importanti; meglio qualcosa di lieve; nulla vieta che questo "Golden Boy" mi strappi un sorriso. Difatti il temino di apertura, supposto scritto da Daniel Alexander Walker, un bambino di "nove anni e quattro quinti", il sorriso me lo strappa davvero. Procediamo, mi dico. Leggo i pensieri di Karen, la madre, e poi quelli di Max, il sedicenne primogenito dei Walker, con qualche problema di troppo per la sua età.
Max si racconta in diretta, al presente indicativo, rompe l'equilibrio, mette in moto la vicenda. Ciò che viene dopo è l'inevitabile conseguenza di questa scena quasi iniziale: Hunter, il suo migliore amico lo stupra, in casa sua, in camera sua, nel suo letto, mentre i loro genitori, amici da sempre, fanno baldoria al piano di sotto e Daniel, il fratellino, gioca alla play station nella stanza accanto. Il resoconto è minuzioso, mi sembra che indulga troppo sui particolari. Penso che l'autrice non sappia come uscire da una materia che non controlla. È assurdo che Max non trovi il modo di sottrarsi alla violenza. Basterebbe urlare, fingere un alterco con l'amico, non dovrebbe necessariamente riferire la verità. Accorrerebbero tutti. Invece subisce quasi con rassegnazione. Perché? Il quesito mi induce a proseguire, sia pure ancora pieno di sospetti. E scopro, scopro che questo romanzo di Abigail Tarttelin, edito in Italia da Mondadori nella traduzione di Gioia Guerzoni, è un buon libro, un libro che appassiona e fa riflettere. Non poco, direi, dati i tempi che corrono e prescindendo dalla buone o cattive intenzioni della casa editrice. Ciò che conta è che Mondadori lo abbia fatto tradurre e l'abbia pubblicato, anche se continuo a essere molestato dalla copertina, diversa da quelle delle edizioni inglese e americana. Il soggetto ritratto è una ragazzina con un che di virago (anche se penso che un po' tutti gli adolescenti di famiglie benestanti rechino nell'aspetto una certa ambiguità di genere, efebici la più parte), molto diversa dall'adolescente del book trailer della versione originale, questo forse più vicino alle intenzioni dell'autrice. La foto di Luka Knezevic ammicca o allude a chi e a che cosa? No, la copertina italiana continua a non convincermi, mi sembra tradire lo spirito del libro. Che è quello di sviscerare un tema dal quale sembriamo fuggire, forse temendo che ci costringa a guardarci dentro, a mettere in gioco le nostre certezze, le nostre consolidate identità. Di genere nella fattispecie, ma, in termini più generali, umane e culturali, in senso antropologico intendo. Io la domanda me la sono posta: che consapevolezza ho della mia immagine e in che misura essa coincide con la mia identità?
La personalità non cresce sugli alberi. È la risultante di dinamiche educative le cui coordinate sono state elaborate da altri e molto prima che venissimo al mondo. In buona sostanza non abbiamo mai scelto, ci hanno solo detto chi e che cosa dovevamo essere. Abbiamo eseguito gli ordini, per soddisfare aspettative altrui, quasi mai bisogni e istanze nostre. Allora non desta più meraviglia la "passività" di Max, il bell'adolescente protagonista del romanzo della Tarttelin. Non si ribella perché vuole essere accettato, amato se volete: l'unico modo per ottenere consenso, plauso e amore è tradire la sua natura. Sono "Come tu mi vuoi", giusto per richiamare il dramma di Pirandello al quale questo libro mi ha fatto pensare. Con una differenza di carattere sociologico: per la scrittrice inglese il "tu" di Pirandello diventa il "voi" della convenzione sociale alla quale dobbiamo tutti aderire, per non correre il rischio della marginalità.
Pirandelliana è la stessa struttura del racconto, la cui voce narrante si traduce nella proliferazione dei monologhi dei personaggi principali. La variazione di prospettiva dà dinamicità allo spartito e fa sì che il coro approdi a una ben calcolata dissonanza. Le singole voci, pur echeggiando lo stesso motivo, spesso se ne allontanano per rappresentarsi soliste, solitarie, sole. La tecnica non è nuova, ma non per questo meno efficace. Ricordate il bellissimo "Rashomon" di Akira Kurosawa? Bene, il relativismo prospettico lì mirabilmente rappresentato, in "Golden boy" non ha alcuna implicazione filosofica: diventerebbe un dramma collettivo, prossimo alla tragedia, se "esigenze di copione" e spirito di adattamento a tempi meno eroici non inducessero la scrittrice a più miti pretese. La tragedia si stempera nel mellifero finale, questo sì hollywoodiano, che, volendo benevolmente interpretarlo, vuole forse essere un messaggio di speranza per quanti, come il giovane Max Walker, o come molti di noi, disperano che il cammino della storia possa portare a una società inclusiva, meno cieca, meno ignorante, meno persecutoria.
Il tema dell'intersessualità, osservato da svariati punti di vista, psicologico e sociale, umano e culturale, antropologico e scientifico, non è mai stato sviscerato con tanta maniacale oculatezza. Un argomento del genere avrà richiesto studio e documentazione, benché questa, come si evince dal libro stesso, sia alquanto scarsa e scarsamente attendibile. Già, ogni volta che si tratta di sesso, scattano i cavalli di Frisia dell'omertà. Quanta disarmante ipocrisia e ignorante arroganza si nascondono dietro i pregiudizi! Teologie di diverso segno hanno l'assurda pretesa di correggere la natura, benché questa ci insegni che nella biodiversità è la sopravvivenza delle specie. Le alterazioni, biologiche in prima istanza, morfologiche poi, sono la realizzazione di un intelligente progetto evolutivo, nulla di più. Ma l'ordinatore cosmico, qui rappresentato dal dottor Flint di una clinica londinese, certamente allievo di De Gobineau e di Hitler, ha stabilito a priori la norma, segnatamente giuridica, dell'out out, secondo la quale non esistono che le aree terminali dello spettro sessuale. Le anagrafi di tutto il mondo obbediscono ciecamente al comandamento cosmico, sorde alla molteplici variazioni cromatiche dell'arcobaleno, che ne avrà pure sette di colori identificabili (un pochino in più dei due imposti dalla legge), tuttavia sono come le note, sette anch'esse, la cui bizzarra combinazione produce concenti di inaudita bellezza.
Brava questa giovanissima scrittrice a creare attenzione e attesa, mirabile nel rappresentare la complessità dei problemi affrontati in un crescendo finemente drammatico che raggiunge le vette nella seconda parte del romanzo. Le perdoniamo qualche leziosaggine di troppo, qualche innocuo cliché. Il climax con cui ascende alla conflittualità tra e dentro i personaggi mi fa pensare piuttosto all'opera di un drammaturgo o di uno sceneggiatore cinematografico piuttosto che a quello di un narratore in senso stretto. Il suo curricolo personale convaliderebbe questa mia ipotesi. Comunque stiano le cose, questo è un libro che invita alla riflessione e al dibattito, due sollecitazioni che ne valgono la lettura. Ne discutano tra loro i venticinque lettori di questa nota e, se credono, illuminino un pochino il loro ignorante imbonitore. A conti fatti, siamo ventisei, un numero certo piccolo, ma pur sempre una quantità. Chissà che non riusciamo a dirlo ad altri che ci sta a cuore la serenità e la felicità dei nostri simili. Dovrebbe occuparsene al politica, lo so, ma ormai è ridotta a mero esercizio contabile. Che volete che sappia, un contabile, di umanità, di sofferenza, di cromie? Non vede altro che la partita doppia. Nero su bianco. Dal suo punto di vista, occorre incrementare le entrate, apparendogli le uscite come anomalie da recidere, con l'identica sicumera con cui il dottor Flint di questo libro amputa, mutila, rimodella. Il selezionatore nazista non avrebbe saputo fare di meglio.
Magari voi pensate che i sistemi e le leggi dovrebbero rendere l'uomo possibilmente e passabilmente felice, non modellato da un ipotetico noumeno. Non ditelo a me, so bene che siamo fenomeni, tutti indistintamente, qualche volta anche prodigi. Siamo fatti, non idee. Le scienze, almeno loro, dovrebbero attenervisi. Macché! Anche le scienze hanno i loro bravi pregiudizi, e i loro padroni! Come la politica, no?
Id: 830 Data: 10/10/2014 12:00:00
*
 Thomas Harding - Saggio - Newton Compton
Thomas Harding - Saggio - Newton Compton
Il comandante di Auschwitz
LA PROCEDURA!
Il buon giorno si vede dal mattino. Evidentemente anche il cattivo. Così queste due vite che corrono parallele nel libro di Thomas Harding si spiegano col loro mattino, con l'alba delle rispettive esistenze.
I personaggi dei quali il libro ricostruisce le vicende sono di quelli che, provenienti da ambienti assai distanti, in termini sociali e culturali ad un tempo, non si sarebbero mai incontrati se il veleno dell'antisemitismo non avesse attossicato i tedeschi assai prima che l'aggressività del loro capo scatenasse il più cruento e feroce dei conflitti di cui serbiamo memoria.
Tedeschi entrambi, Rudolf Höss e Hanns Alexander sono educati ad amare il loro paese. Entrambi lo ameranno negli anni delle rispettive adolescenze, il primo arruolandosi (prematuramente e in barba alla Costituzione del 1871) nell'esercito, il secondo assorbendo dal padre il culto della fedeltà a una nazione e a una cultura delle quali l'uomo si sente parte integrante e necessaria. Si leggano le pagine dedicate agli anni di formazione dei protagonisti dell'inchiesta condotta da Harding con dovizia di documentazione e si capirà il perché dell'incipit di questa nota: l'imprinting giustifica i comportamenti futuri o li rende quanto meno possibili prima che essi si manifestino.
Rudolf Höss, nato a Baden-Baden nel 1901, come dimostra l'autore a fronte di biografie poco documentate che anticipano di un anno la sua data di nascita, riceve una rigida educazione cattolica, di stampo tradizionalista a quanto sembra, certamente estranea alla prima timida apertura alla modernità della Chiesa (La Rerum Novarum risale al 1891). Severe punizioni e forte induzione al senso di colpa ne sono caratteristiche dominanti. Destinato alla vita ecclesiastica, in parte per volontà paterna, in parte per la fascinazione del credo religioso, il futuro comandante di Auschwitz rinnegherà la primitiva fede quando si sentirà ingannato dal suo confessore («... sono convinto - scriverà nella futura autobiografia - che il mio confessore abbia tradito il segreto della confessione. Dopo quell'episodio persi la fede...»). Per abbracciarne un'altra, di fede, ben più perniciosa del fondamentalismo cattolico. Questo però riguarderà il suo futuro. Per ora, a sedici anni, la scelta è la guerra e la prematura militanza nell'esercito, una deliberazione che lo porterà a combattere in Mesopotamia. Lo spettacolo cruento della battaglia e la violenza guerrigliera rafforzeranno in lui una sorta di malsano attaccamento alla vita militare, al sentimento dell'obbedienza, al bisogno di disciplina, al culto irrazionale del leader carismatico del momento, nella fattispecie del comandante che ne esalta e loda le qualità segnatamente militari.
Più volte ferito, al termine del conflitto organizza, con altri commilitoni, una rocambolesca fuga attraverso i Balcani. Dalla Siria raggiunge la Germania con mezzi di fortuna, affrontando i pericoli e le avversità di una lunga marcia da lui stesso guidata.
Dopo due anni di lontananza, ogni cosa è cambiata a Mannheim, sua città di residenza: sua madre è morta, le sue sorelle sono finite in convento, il suo tutore ha venduto la casa di famiglia. Solitario e un po' misantropo com'è sempre stato, si arruola nei Freikorps, un'organizzazione paramilitare nota per le violenze compiute, forse anche subite, nella lotta al bolscevismo e nella rivendicazione dei territori a minoranza tedesca sottratti alla Germania dal conflitto appena concluso. Combatte, con metodi da guerriglia, prima in Lettonia, poi in Polonia e nella stessa Germania, contro qualsiasi gruppo sia in odore di socialismo. Inizialmente tollerati dal governo, in relazione agli umori politici del momento, i Freikorps sono dichiarati fuorilegge nel 1921. I militanti, Höss compreso, finiranno nell'orbita delle milizie hitleriane, le SA prima, le SS poi. Intanto si rende complice di un efferato delitto. Ne è vittima Walter Kadow, un ex militante dei Freikorps sospettato di tradimento. È condannato a dieci anni di carcere, ma la buona condotta e una fortunata amnistia gli ridaranno la libertà dopo soli quattro anni. Dal 14 luglio del 1928 Rudolf sarà libero di coltivare i suoi miti: Blut und Bloden (il fondamento ideologico della lega Artamanen alla quale aderisce e tra i cui adepti incontrerà la futura moglie, Hedwig Hensel), nazionalismo guerrafondaio, militarismo, slavofobia, antisemitismo.
Fu ispettore agricolo in una fattoria prima di arruolarsi nelle Schutzstaffel, le famigerate SS. A sostenerne la carriera fu un antico commilitone dei Freikorps, il tristemente noto Heinrich Himmler, nientemeno che il Reichsführer. L'apprendistato ha come scenario il primo campo di concentramento, quello fondato da Himmler in persona nei pressi di Monaco: Dachau. Vi impara l'«Attitudine all'odio» cara al Kommandant Theodor Eicke, il cinismo, la cieca lealtà al regime, il rispetto delle procedure e delle gerarchie. È presto pronto per una nuova promozione e al trasferimento al nuovo campo di Sachsenhausen, più prossimo a Berlino e ai palazzi del potere. Allo scoppio della guerra è Himmler stesso a volerlo a Oświęcim, la cittadina della Slesia superiore più nota come Auschwitz. In parole povere, il futuro campo di sterminio fu organizzato e gestito da lui. È qui che la "soluzione finale" avrà il suo centro operativo più efficiente e la produzione industriale di sofferenza, agonia e morte la dimora privilegiata.
Nel libro di Harding Rudolf Höss è dipinto come una personalità sfuggente, duplice se si mette a confronto il premuroso padre di famiglia col kommandant del campo di sterminio. Al processo di Norimberga dichiarerà di aver eseguito semplicemente gli ordini, di aver attuato una regolare procedura. Procedura! Qualcosa di analogo affermerà Eickmann molti anni dopo. Procedura!
Mi sembra mirabile il capitolo 5 del saggio, quello nel quale è dato conto delle fulminea carriera del gerarca. Vi trovi tutte le sfaccettature della poliedrica anima di Höss. L'episodio che chiude il capitolo è illuminante. Non ha nulla da invidiare alla versione letteraria che di fatti analoghi dà David Grossman («Vedi alla voce: amore», Mondadori 2008), anzi aggiunge all'immaginazione la forza delle nuda cronaca. Nulla vieta che il personaggio di Niegel del bel libro dello scrittore israeliano sia ispirato proprio al comandante di Auschwitz.
La formazione di Hanns Hermann Alexander (1917-2006) ha, invece, la connotazione della liberalità. È, col gemello Paul, un "figlio della guerra", concepito da Henny Picard e Alfred nel momento in cui quest'ultimo gode di un congedo dall'ospedale militare che dirige in Alsazia, a pochi chilometri dal fronte franco-tedesco. Il dottor Alexander guadagnerà non pochi meriti per il servizio prestato, mettendo precipitosamente in salvo i feriti e il personale sanitario quando gli Alleati avranno la meglio. La "croce di ferro prima classe" farà di lui una specie di eroe. L'onorificenza, gelosamente custodita, sarà uno dei vanti di questa famiglia ebrea completamente assimilata. L'altro prezioso cimelio è un'antica Torah ricevuta in eredità, ancor oggi usata dalla comunità giudaica di Londra.
I Picard e gli Alexander sono tedeschi di diritto e di fatto; vantano meriti e prestigio nella buona società. Superando le angustie del dopoguerra, Alfred diventa un personaggio ben noto nella Berlino degli anni Venti. Fonda e gestisce una clinica, ricopre la carica di presidente dell'Ordine dei Medici, vive in una casa lussuosa frequentata dal fior fiore dell'intellettualità tedesca. Frequentano il suo salotto e/o siedono alla sua tavola personaggi del calibro di James Franck, Albert Einstein, Max Reinhardt, Richard Strauss, Max Pallenberg, Marlene Dietrich.
Capite in che ambiente e in quale clima culturale vivono la loro infanzia i gemelli Paul e Hanns Alexander? Berlino, in quegli anni, è il cuore pulsante della cultura europea, se non mondiale. Hanno genitori nient'affatto autoritari e una tata, l'amata Anna, che "credeva che i bambini dovessero poter sviluppare una propria personalità" senza costrizioni di sorta.
I due gemelli fruiscono, talvolta abusano, della libertà loro concessa dagli adulti. Discoli, com'è nella natura dei bimbi, ne combinano di cotte e di crude, maturando un carattere gioviale e propenso alla celia, la più scontata delle quali è lo scambio di persona: persino a scuola l'uno è interrogato al posto dell'altro. Sono per temperamento, ancor prima che per identità etnica (un'identità che, peraltro, sentono e vivono assai poco, se non per il minimo di consuetudini familiari), la negazione vivente del Nazismo.
Vittima, come centinaia di migliaia di altri tedeschi, delle leggi razziali, la famiglia Alexander, alla spicciolata, è costretta a lasciare Berlino tra il 1934 e il 1936, quando ancora il giovane regime concede agli Ebrei di migrare, sia pure dietro pagamento di una tassa da capogiro. La loro patria li scaccia come cani: non è solo un crimine, è la stupidità eretta a metodo. Nessun governo lungimirante si priverebbe dei suoi cervelli migliori per le fisime del folle che lo presiede. I tedeschi, narcotizzati dalla frustrazione della crisi economica susseguente al crollo di Wall Street, dalla propaganda di Goebbels e dalla retorica urlante di Hitler, non sanno quanto gli costerà il conformismo da pecoroni e la guerra imminente da esso scatenata. Pagheranno anche loro, a caro prezzo, l'insipienza di una scelta sconsiderata.
Da rifugiati, gli Alexander maturano sempre più un sentimento di affezione verso il paese che li ha accolti e protetti, l'Inghilterra. Si ricostruiscono a fatica una vita, ripartendo da zero, adulti o giovani che siano. Allo scoppio della guerra, Hanns e Paul si offrono volontari nel "corpo dei pionieri militari ausiliari" dell'esercito britannico. Sia pure separatamente, daranno il loro contributo alla vittoria alleata. Poi la svolta che porterà Hanns sulle tracce dei criminali nazisti in fuga. Inizialmente ingaggiato come interprete, gli sarà affidato il delicato compito di rintracciare e affidare alla giustizia inglese Rudolf Höss, il ben noto comandante di Auschwitz. Fattosi esperto segugio, riuscirà a trovare e ad arrestare il gerarca. I processi ai quali costui sarà sottoposto sono oggi storia.
Ecco, in sintesi, i momenti salienti di questa bell'opera di Thomas Harding che la Newton Compton offre ai lettori italiani nella traduzione di Lucio Carbonelli. Il titolo originale (Hanns and Rudolf) mi pare più neutro di quello italiano che, invece, quasi riproduce l'einaudiano "Comandante ad Auschwitz", l'autobiografia che lo stesso Höss compose in un carcere polacco in attesa che la sentenza di morte fosse eseguita proprio nel campo da lui diretto.
Difatti la scelta di porre a confronto, a capitoli alterni, le due biografie mi pare giustifichi la mia ipotesi interpretativa: dare ragione del comportamento dell'adulto attraverso il processo che lo ha condotto alla maturità e alla consapevolezza delle scelte. Di qui anche un necessario corollario: sia Höss che Alexander sono restituiti alla loro nuda umanità. Né superuomini né demoni, i due hanno pregi e difetti, dignità e grettezza, arguzia e stupidità. Questo vuol dire una sola cosa: del bene come del male sono responsabili gli uomini e solo essi. È pretestuoso invocare ingiustificabili forze sovrumane quali determinanti delle nostre scelte e delle nostre azioni. Vittime e carnefici, allora come ora, muovono parallele nell'impervio cammino della vita. La parte dalla quale schierarsi è una libera opzione.
Vi siete mai imbattuti in qualche complessa pratica burocratica della quale ignorate la ratio? Vi sentite stupidi e frustrati, quasi vittime del meccanismo perverso che vi fa girare come trottole da un ufficio all'altro, magari per un timbro o una firma. Se provate a chiedere il perché di tanta farraginosità, vi sentirete rispondere dal burocrate di turno che quella è la procedura. La Procedura!
Bene, ogni volta che mi trovo in una situazione del genere (e vi assicuro che mi ci sono spesso trovato), m'insorge il medesimo pensiero: costui è un mio nemico, un potenziale nazista. Se il caso mi volesse sua vittima (e in parte già lo sono), affermerebbe di tormentarmi (e in parte già mi tormenta) perché segue una procedura della quale non è responsabile. Tutti così i burocrati. Eppure sono uomini come me. Come me? Non del tutto, direi non del tutto. Loro si guadagnano la pagnotta applicando procedure; io me la guadagno sforzandomi di pensare.
Antonio Piscitelli
Id: 822 Data: 15/08/2014 12:00:00
*
 Antonella Cilento - Romanzo - Mondadori
Antonella Cilento - Romanzo - Mondadori
Lisario o il piacere infinito delle donne
ORFEO È FEMMINA
Fin dalle prime pagine mi sono reso conto di avere tra le mani un ordigno esplosivo. Era quasi mezzanotte. Il buonsenso mi avrebbe suggerito di chiudere il libro e di riprenderne la lettura il giorno seguente. Invece no, non riuscivo a smettere e sono andato avanti fino all’alba. La deflagrazione c’è stata, e potente, nel cuore della notte. Ha mandato in frantumi il libro e me. Mille pezzi schizzati ovunque nella mia povera casa. Dio mio, che disastro!
Come faccio a rimettere al loro posto migliaia di parole, se non altro per chiuderlo, il libro? Mi armo di pazienza. Comincio dai nomi propri. Stacco dagli occhiali sui quali si è impressa la parola Ribera e, dalla stanghetta laterale sinistra, Caravaggio. A terra trovo l’errabondo Cervantes (de Zerbantes), nell’incavo dell’ascella il povero poeta albionico messer Guglielmo e mi domando come abbia fatto a finirci. E questo chi è? Jacques Colmar. Guarda un po’ dov’è andato a ficcarsi: giusto nella fenditura tra i due cuscini del divano. E quell’altra parola, Pitigliano? Perbacco, tra le costole di due saggi storici di Anna Foa che trattano di diaspora. Quando si dice le coincidenze! Mi domando dove sia andato a ficcarsi Michael de Sweerts.
Basta, ci rinuncio, è troppo complicato. Per quanto mi ci provi, non riuscirò a venirne a capo. Ormai le pareti di casa sono tutte imbrattate e anche il mobilio, accidenti! Non sarò mai in grado di ricomporre il volume. Se ci tenete a leggerlo, dovrete comprarne un’altra copia, la mia non ve la posso prestare. Per quanto consti di sole 283 pagine, eserghi, dediche e ringraziamenti compresi, in realtà esso s’innerva in una tale quantità di altri testi da far pensare a una vasta enciclopedia. Nello specifico, del XVII secolo, con non poche fughe in altri riposti della Storia europea, della cultura in ispecie. Ce n’è per tutti i tipi di interesse.
Scusate, devo aprire le finestre, c’è un fetore qui dentro da far voltar lo stomaco. Capirete, a distanza di quasi quattro secoli, con l’abitudine della doccia mattutina e delle abluzioni serali, non si riesce facilmente a convivere con gli effluvi di allora. Sapete bene che il Seicento è stato uno dei secoli più puzzolenti della storia. La Cilento è incredibile: non solo vi fa scorrere davanti agli occhi il quadro vivente dell’età barocca, tanto che voi la vedete, quest’epoca, sia pure attraverso la speciale prospettiva della pittura del tempo che, negli spagnoli e nei fiamminghi, ha trovato la sua più potente espressione, inclusiva dell’ammiccante lezione caravaggesca; non solo questo, ma anche la suggestione di odori e percezioni tattili e uditive tali da poter parlare, e a ragione, di una scrittura che ha fatto della sinestesia il suo elemento caratterizzante.
Vi sto dicendo che è un libro molto denso? Certo. Altrimenti non sarebbe scoppiato. Ma questo non deve affatto spaventarvi. Il romanzo è fruibile da chiunque e in qualsiasi modo lo si voglia leggere. Potete anche prenderlo per un bel racconto, un po’ romanzo storico-picaresco, un po’ novella licenziosa (Boccaccio, Aretino, Straparola), un po’ favola alla Basile, un po’ commedia dell’arte; io vi riscontro persino, per il ritmo della prosa e la vividezza dei dialoghi, l’opera buffa. Voglio dire che si ride, si piange e si ascoltano vivaci concertati senza soluzione di continuità. Scrittura visiva e, in parte, visionaria quella della Cilento: tanto i primi piani dei personaggi quanto le scene di massa rinviano a celebri tele secentesche, tra le quali emergono, oltre a quelle dei noti pittori già citati, le produzioni di Micco Spadaro. Vedo anche, nei volti dell’epoca, il naturalismo grottesco dell’arte presepiale, con la massiccia presenza, su una scenografia tutta partenopea, del variegato popolo dei vicoli e dei mercati: la nana, la vecchia scrofolosa, l’oste, l’avvinazzato rubizzo, il bazzariota, il soldato spaccone, il gradasso, il lenone, il ruffiano, il truffatore, la prostituta discinta e tutta la variegata plebe che, da epoca immemorabile e fino ai nostri giorni, rende la città refrattaria a qualsiasi istanza di modernità. Non manca il mondo dei bottegai e dei professionisti, cioè di quel ceto presunto medio, mediocre in realtà, sempre prono al potente che gli rimpingui la borsa, ancorché il potere implichi solo rapina e saccheggio. Si leggano le drammatiche pagine dedicate alla rivolta di Masaniello e si capirà cosa intendo. I voltagabbana e i profittatori di allora sono i medesimi che segneranno la storia di Napoli nei secoli venturi, tanto che si è voluto vedere nel romanzo la rappresentazione d’una contemporaneità camuffata più che una ricostruzione storica in chiave letteraria. Legittima, per carità, un’interpretazione del genere, ma solo se si ammette che il presente è l’esatta riproposizione di ciò che la città fu ieri e l’altro ieri e secoli or sono. A Napoli non si fa storia, non si è mai fatto storia, solo cronaca, la stessa di cui è infarcita la povera e provinciale stampa cittadina. Chi vi arriva da fuori (e di stranieri ne sono arrivati tanti nel corso dei secoli, dominatori e mercanti, artisti e rifugiati, soldati e viaggiatori, migranti d’ogni nazione), dopo alcun tempo, è perfettamente assimilato, non ne distingui più la provenienza. Napoletanizzato! Osservate il personaggio centrale di Avicente Iguelmano, un mediconzolo fallito di origini catalane che, puta caso, nella capitale del vicereame va incontro a fama onori e ricchezza, protetto dai potenti di allora, inclusa la corte, nonostante sia solo un ciarlatano, un somministratore di panacee. Come si spiega tanto successo? Gode fama di aver compiuto un miracolo, per aver risvegliato da un sonno inspiegabile quanto misterioso un’adolescente, Belisaria Morales (Lisario: si noti il diminutivo che fa pensare a un maschio, a parer mio per nulla casuale), la quale, ben femmina, è il vero motore della vicenda. Parte da qui la fama di Avicente, paragonabile alla stessa di cui godono i numerosi santi venerati dai napoletani, inclusi quelli famosissimi che popolano i suoi sogni. La guarigione è un miracolo. La speranza non è alimentata dal senno, ma dalla fede, beninteso una credenza superstiziosa, scaramantica, blasfema, ingiuriosa d’ogni seria spiritualità. La subcultura del cornetto, dell’ex voto, dell’amuleto, della reliquia o del cero votivo è tutt’altro che scenografia per turisti, è stile di vita nella forma e nella sostanza. L’intellettuale, l’uomo e la donna di studio e di ricerca in questa città non hanno ricetto, oggi emarginati, un tempo scannati o decapitati, in ogni caso posti alla gogna e al pubblico ludibrio.
È questo che Antonella Cilento intende dirci? Penso di sì, per quanto il suo libro si presti a ogni azzardo dell’immaginazione, tale è la ricchezza di stimoli che offre al lettore.
Vedete, io credo che il romanzo sia il grido di dolore di un’erede delle grandi figure femminili che l’altra vicenda cittadina, quella negata e ignorata dai più, vanta: da Artemisia Gentileschi a Eleonora Pimentel, da Luisa Sanfelice ad Anna Maria Ortese. Mi direte che queste famose donne sono solo in parte o occasionalmente napoletane. È vero, ma è anche vero che altre donne meno note hanno provato a fare udire la loro voce, purtroppo e assai spesso sovrastate dalle urla isteriche delle parenti di San Gennaro o dai baccanali di fujénti e vattienti (flagellanti) che, al ritmo assordante di grancasse e “tammorre”, inquinano l’etere e soffocano il lamento affannoso delle partorienti. Non udrete mai la voce di Lisario se non leggete il romanzo di Antonella Cilento. La scrittrice è napoletana, completamente napoletana e dà voce a chi la voce non l’ha mai avuta, perché gliel’hanno estirpata, appena si sono accorti che produceva verità.
La poveretta che fa? Impara a scrivere e s’inventa un’interlocutrice, una Madonna “femmina” feconda, alla quale confida le sue pene. Chi altri potrà udirle se non una femmina come lei, per immaginaria che sia? Quando tu per il mondo non esisti, sei una cosa, un animale o un giocattolo, non ti resta che affidare a un diario le tue confidenze. A rifletterci bene, l’epistola è il genere più praticato dalle donne. La scrittura clandestina e privata la loro unica consolazione.
Ecco il significato di questa sofisticata operazione letteraria: farci udire l’espressione autentica del femmineo, persino di quello che la protervia della convenzione cela nei maschi e che risiede nel sistema limbico di ciascuno.
Iguelmano, sposo padrone della sventurata Lisario, vorrebbe carpirle il segreto del piacere infinito, ma non trova che deliquio e umori, cioè lo schermo e il linguaggio di una creatura alla quale è negata la vita ancor prima che essa si realizzi. Il segreto è solo la cecità dell’osservatore, un maschio ovviamente, perché il punto di vista delle donne è inammissibile per statuto.
Antonella Cilento non ci incita alla guerra tra i sessi, ma alla corretta compenetrazione, tale che ognuno sappia riconoscere la metà negata di sé. In termini di storia delle culture e delle civiltà, il misconoscimento è sempre stato di un solo segno, al silenzio sono state ridotte le donne, alle quali questo libro dà voce, almeno nei voti dell’autrice. Il canto di Teodora, che deve fingersi uomo per esibirsi nel teatro della vita, seduce perfino il vecchio Iguelmano, che pure, in passato, ne ha auspicato la morte, magari presago dei sovvertimenti futuri.
Teodora oggi c’è e seduce parimenti tutti gli uomini che hanno buon udito. Gli altri, miserabili, si sono fatti sordi, non potendo estirparle le corde vocali, come un tempo fecero con la madre.
Sapete che penso? Che una civiltà sorda è giunta al traguardo. Ormai Teodora non ha più bisogno di fingersi maschio per farsi udire, a dispetto di tante donne che ancora lo credono, per opportunismo o vigliaccheria, fate voi. Se è vero che la storia volta pagina a ogni trauma che le occorre, bene, questo è l’evento traumatico del momento: il canto melodioso di Teodora. Potete pure turarvi le orecchie, esso sta già edificando la futura dimora per tutti, sontuosa, accogliente, inclusiva.
Fuor di metafora, la melodia è tutta nello stile della Cilento, che si estrinseca in una prosa ironica e mordace, lirica all’occorrenza, certamente pittorica. Limbica, se non si vuol fortuita la bella immagine di copertina, opera di Dino Valls, artista spagnolo contemporaneo che ha fatto del “Siglo de Oro” lo sfondo ideale per la proiezione d’un’energia psichica le cui scaturigini sono nella sede fisiologica di quella cosa che chiamiamo anima. Femmina l’anima, innegabilmente femmina, non solo in senso grammaticale! I maschi non la possiedono. Se ne sono privati da se medesimi, votandosi da sé alla mera ferinità, al mostruoso alibi della lotta per la sopravvivenza.
Orfeo è femmina, credetemi! Si chiama Lisario-Teodora-Cilento.
Id: 807 Data: 09/05/2014 12:00:00
*
 Edith Bruck - Romanzo - Garzanti
Edith Bruck - Romanzo - Garzanti
Quanta stella c’è nel cielo
UN MONDO DECLINATO AL FEMMINILE PLURALE
Si può leggere in molteplici modi questo splendido libro. È certamente testimonianza del dramma dei sopravvissuti ai campi di sterminio, ma anche travaglio collettivo di un’Europa ancora tramortita dagli eventi bellici, il cui emblema è una delle regioni più tormentate d’Europa, la vasta area geografica dagli incerti e contesi confini a cavallo tra Austria, Ungheria, Boemia, Slovacchia, Polonia, Germania, Ucraina. La babele di lingue nel treno sul quale viaggia Anita, la protagonista del romanzo, non ci riferisce solo gli stati d’animo degli Ebrei superstiti, contrastanti e contraddittori, ma rivela lo sguardo pietoso che Edith Bruck rivolge ai profughi di ogni nazione, perfino ai carnefici di un tempo, ora ridotti a larve umane, anch’essi senza un posto in cui andare, clandestini tra clandestini: «Chissà come stavano i tedeschi? Me lo chiedevo spesso. Doveva essere duro vivere con tutti quei morti sulla coscienza, compresi un milione di bambini uguali ai loro figli».
Non puoi non correre con la mente al mondo di oggi, a quel coacervo di culture e storie nel quale viviamo esattamente come i viaggiatori del treno per Zvìkovec. Ne percepiamo umori o malumori, ne udiamo le lagnanze, ne osserviamo i medesimi comportamenti. Viaggiamo tutti come sardine in scatola, ignari dei luoghi in cui siamo, incapaci di recuperare la memoria, incerti del nostro futuro. Dove saremo tra un’ora, domani, tra un anno? Ci sarà un posto in cui far crescere i nostri figli senza l’assillo del bisogno, senza la minaccia dell’odio che nega il loro diritto a esistere? «Il mio prossimo figlio nascerà in Terra Promessa», afferma una viaggiatrice e ne riceve, come risposta, il feroce commento di un uomo, «E lo ammazzeranno gli arabi!», a mo’ di presa d’atto d’un ineludibile destino. Ma la sortita è anche la latente ideologia nazista che nega la vita ancora prima che essa si manifesti, quasi uno sterminio preventivo. Una volta ho chiesto a Udi, un mio amico ebreo, a che servisse mettere al mondo dei figli destinati al dolore e alla morte violenta. Mi riferivo alle giovani vittime della guerra arabo-israeliana. Mi rispose con le stesse parole che adopera la Bruck: risparmieremmo il lavoro sporco ai nostri persecutori, ci annienteremmo da soli. Aveva ragione Udi, ha ragione la scrittrice. Tuttavia, alla luce della storia e della cronaca, non posso non riflettere sulla circostanza che la mattanza non finisce, che continuiamo a produrre carne da macello a vantaggio di un nazismo di fatto che, apparentemente sconfitto, resta la caratteristica di fondo della cultura inumana che ancora ci ostiniamo a chiamare civiltà. È un veleno che intossica la coscienza collettiva da tempo immemorabile, prodotto di un’ideologia che ci pretende tutti bestie in lotta per la sopravvivenza: mors tua vita mea! Guerra a oltranza! Vogliamo contare insieme le vittime innocenti dello stato permanente di belligeranza sul quale si regge il mondo del quale tutti siamo ostaggio? I vincitori, sempre gli stessi, non ci badano. È normale, sono i padroni di casa, cosa volete che gliene importi che la loro casa sia stata costruita col sudore, il sangue e la vita stessa dei loro schiavi, anche in questo caso sempre gli stessi? Le ascoltate o le leggete le cose che si dicono sui loro organi di pretesa informazione? Economia, parlano solo di economia, cioè della scienza dell’utile, laddove l’utilità è misurata in numero di vittime alle quali è possibile succhiare il sangue. E quando queste sono diventate esangui, le si elimina. Non ci manca ovviamente la fantasia per trucidare intere comunità. Siamo diventati bravi, espertissimi, efficientissimi. La cosa singolare è che gli esecutori dello sterminio sono gli stessi schiavi, ai quali è fatto credere che è normale uccidere il proprio simile, benché non si tratti che di un bambino, di una donna incinta, di un infelice disabile, o di un innocuo vecchietto. La “religione universale” pretende che la nostra sopravvivenza dipenda unicamente dal numero di esseri umani che riusciamo a soggiogare e, al momento opportuno, eliminare, anche preventivamente, magari costringendo all’aborto una giovane donna che nel figlio concepito vede la rigenerazione e la “possibilità”, forse l’unica che le rimane. In tal caso, per questa donna, nata in schiavitù perché non c’è femmina al mondo che non sia nata schiava, portare avanti la gravidanza è un coraggioso atto di ribellione. Mi piace per questo Anita, l’adoro, ne sono innamorato: solleva finalmente la testa e regala a me la speranza. Perché per ogni femmina d’uomo che sollevi il capo, si accende un lumicino di speranza nel mio cuore.
È così che ho sofferto la tormentata riflessione di Anita, mirabilmente riferita e investigata dalla Bruck. Eli, il ragazzo che l’aggioga ai suoi desideri di maschio padrone, indifferente ai nobili sentimenti di lei, le impone lo strazio dell’aborto, quando ormai lo stato di gravidanza metterebbe a repentaglio la sua stessa vita. Doppiamente nazista quest’ebreo dal bel volto e dall’arido cuore: nel negare la nuova vita, non si perita di sacrificarne la procreatrice. Una cosa da gettar via, come l’acqua sporca che buttiamo col bambino.
Ora accade che, nella fattispecie, il maschio padrone si sia fatto il conto senza l’oste, il quale non è altro che una ragazzina di neppure sedici anni che mostra di avere il coraggio leonino della sua progenitrice, di quell’Eva che si pretende prima femmina d’uomo. Quanto denigrato è stato il suo gesto di ribellione a una soggezione umiliante! A diffamarla è stato lui, quell’imbelle di Adamo che, egli stesso schiavo, anziché seguirne l’esempio, l’ha denunciata, innescando per millenni l’abitudine alla delazione e all’omertà, al tradimento e alla proditorietà, schermendosi dietro la volontà di un preteso padre tiranno sanguinario che, inventato da lui, ha chiamato Dio, senza neppure vergognarsi d’essersi inventato una divinità umana, troppo umana, troppo simile alle sue ambizioni fallocratiche di dominatore assoluto del gineceo nel quale ha relegato la metà di sé.
«Da padrone di me e di nostro figlio aveva pronunciato la parola “aborto” subito, alla maniera del selezionatore, che con la parola “sinistra” aveva mandato ai forni mia madre. “È un nazista”… », rimugina Anita a proposito di Eli che, ironia della sorte, si chiama “mio Dio”. La ragazzina, un tempo, aveva chiesto a sua madre se nascere donna fosse una disgrazia; «È una disgrazia nascere, figlia mia», le aveva risposto lei. Battute nelle quali sono il fatalismo e la rassegnazione di una sapienza al maschile singolare che predica nei fatti la sottomissione, il giogo, benché la cavezza sia spesso chiamata destino o volontà divina.
Per questo il gesto di Anita cessa di essere mera risposta individuale alla protervia maschile e diventa il segnale della rivolta collettiva contro un’ideologia che ti vuole schiavo ancor prima che tu sia nato, che aggioga i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi discendenti per infinite generazioni. Che Anita sia ebrea, di quel particolare universo “concentrazionario” dei ghetti e degli shtetl, rende la sua disobbedienza ancora più eversiva perché proveniente da un mondo doppiamente negato, dall’antisemitismo, ma anche da se medesimo. Vivere non è più una disgrazia, se nasci libero e nella “Terra promessa” della dignità. Eva, calunniata da Adamo e dai suoi discendenti, ha un’erede esemplare e costei si chiama Anita, la sedicenne protagonista del romanzo di Edith Bruck. Ci sono state altre femmine d’uomo come lei? Certamente, parecchie, purtroppo sole con la loro disubbidienza. Finite per lo più male, chi su una pira, chi in manicomio, chi nel ghetto claustrofobico di un harem per pedofili, chi nella sentina del silenzio.
Se la storia avesse prodotto più Anite-Eve, probabilmente non staremmo qui a piangere i nostri morti, compresi i sei milioni di ebrei finiti nei campi di sterminio. Questo libro, oltre ad attanagliare il lettore nell’andamento ascensionale di un dramma assai ben rappresentato, è un monumento alla speranza. È l’unica reale prospettiva di un cambiamento epocale, la concreta possibilità che si possa finalmente cessare di declinare la nostra “civiltà” al maschile singolare. La Bruck ci propone un mondo al femminile plurale, l’unico che può liberare tutti dalla subalternità, predatori e prede, kapò e internati.
Il libro è stato ripubblicato quest’anno, in concomitanza con l’uscita del bel film che Roberto Faenza vi ha tratto. Da vedere anche il film, benché sia altra cosa, come sempre quando i mezzi espressivi mutano.
Id: 805 Data: 13/06/2014 12:00:00
*
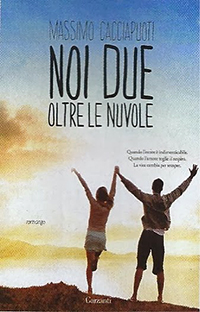 Massimo Cacciapuoti - Romanzo - Garzanti
Massimo Cacciapuoti - Romanzo - Garzanti
Noi due oltre le nuvole
L’ATTIMO CHE VALE L’ETERNITÀ
Non è facile, forse non è mai facile quando un libro ti cattura. Usualmente, però, che ne parli o ne scriva, organizzo agevolmente il discorso e la parola mi pare che fluisca. Ora mi trovo dinanzi a un romanzo che ha nel suo arco molteplici frecce e non so stabilire quale sia la più ferale. Credo quella che mira direttamente al cuore e lo fa sanguinare. In senso metaforico ovviamente. Non produce morte, ma palingenesi, qualcosa di simile a ciò che accade ai due "eroi" di questa storia, Nica e Sandro, quando si trovano entrambi dinanzi al precipizio della vita e s’azzardano a lanciarvisi, senza cautela alcuna.
Il vizio del raffronto m’induce a pensare ad altri due noti autori delle patrie lettere. Il primo è Paolo Giordano de “La solitudine dei numeri primi”; il secondo è Niccolò Ammaniti, autore di diverse opere che hanno come protagonisti degli adolescenti, in testa alle quali porrei “Io non ho paura”, se non altro per la maniera ossessiva in cui Nica, la voce narrante del romanzo di Cacciapuoti, ne riecheggia il titolo per scongiurare la sua, di paura. C’è poi da tener presente un altro libro, “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon, un successo editoriale di una diecina d’anni fa, che mi pare possa chiudere il cerchio. Potrei ovviamente fare riferimento all’intera tradizione letteraria del romanzo di formazione, ma scantonerei troppo, correndo il rischio di non mettere a fuoco le specificità del bel libro di Cacciapuoti.
È chiaro che, in tutti i casi menzionati, lo spartiacque tra i due mondi, l’infanzia e la maturità, è la sfuggente e scontorta linea di demarcazione che si chiama adolescenza. Guadare questo torrente in piena è l‘impresa più angosciante e tormentosa della vita. Sotto i nostri piedi c’è una riva solida dalla quale intravediamo la dirimpettaia che probabilmente delimita un territorio impervio, forse ostile, ma al quale dobbiamo giungere per forza. Siamo su un percorso che non prevede soste, neppure se vi s’inframmezzano ostacoli superiori alle nostre attese o, almeno, percepiti insormontabili dall’osservatore. Per quanto il mondo degli adulti possa offrirsi di sorreggerci, l’impresa è nostra e soltanto nostra. Siamo soli, unici e singolari, siamo “diversi”, benché contigui, come vogliono i “numeri primi gemelli” di Giordano. Nica, la quindicenne del romanzo di Cacciapuoti, ne ha una lucida consapevolezza, a dispetto delle pretese materne di volerla “uguale” agli altri, integrata.
L’integrazione ci sarà senza dubbio per la maggior parte di noi: essa coinciderà con la “normalizzazione”, che in effetti vuol dire semplicemente conformismo, adeguamento a un modello comportamentale pensato da altri, probabilmente in tempi storici molto distanti dal presente, e imposto come divisa da indossare, benché ad alcuni quest’abito possa andare stretto. Chi questa divisa rifiuta è considerato “anormale”, “asociale”, “diverso”, “insano” e quant’altro implichi esclusione e marginalità.
“Felice chi è diverso / essendo egli diverso. / Ma guai a chi è diverso / essendo egli comune”: così Sandro Penna risponderebbe all’obbligo di fingerci uguali. L’artificio del camuffamento è esibizione di un abito, non alterità. Questa è assai più pudica di quanto si creda. Nica percepisce il belletto come un orpello svilente ed io ne comprendo il complesso sentimento, anche se quasi nessuno rifiuta la maschera che indossa o gli è fatta da altri calzare. Non è mai agevole essere fedeli a se stessi, benché l’identità sia unica. Non esiste nessuno al mondo uguale a noi, nello spazio come nel tempo. Siamo inimitabili. Per clonati che fossimo, il clone non potrebbe avere la nostra stessa storia, le nostre stesse esperienze. C'è di mezzo lo iato del tempo. Dall’unicità dovrebbe derivare la preziosità. L’unico è anche prezioso. Macché! Vallo a spiegare questo concetto apparentemente elementare! Siamo tutti indotti a svilirci nel mare magnum del convenzionalismo. Tutto ciò che è fuori dal magma omologante diventa peccato, dannazione. Così anche l’adolescenza, che della diversità ha addirittura le stimmate, ben visibili nei due ragazzi della delicata storia raccontata da Cacciapuoti. Vera, ci riferisce l’autore, per avere essa una fonte orale a lui ben nota. Ma a me viene da aggiungere che essa lo è tanto più perché ora la vicenda ha una veste letteraria, anzi poetica, e approda a quella verità insondabile che è il mistero. Il numero primo di Giordano, che ho voluto assumere come metafora di questa povera argomentazione, ha questo di speciale: è rapportabile solo a se stesso e all’unità, quasi che identità e unità siano l’una la forma speculare dell’altra. Alludono entrambe a un oscuro oggetto di conoscenza, a qualcosa d’inafferrabile che possiamo ben chiamare mistero. Secondo voi, qual è il numero più grande, affascinante e misterioso che ci sia? Il numero uno. Esso ha un sinonimo, che è “tutto”. A meno che la fantasia non vi faccia prefigurare più universi, il che è una contraddizione in termini, l’Universo è necessariamente tutto, ma anche unico, sicché ha insieme le attribuzioni dell’unicità e della totalità. Tutto l’esistente è dentro una totalità. Sono troppo scemo per concepire altro e vi risparmio, anche perché non ne sarei capace, disquisizioni teologiche. Non è di Dio che intendo parlarvi, solo dell’Universo che, sarà pure nato dall’insondabile casino prodotto dal botto iniziale, si è poi reso limitatamente e parzialmente comprensibile, da noi che forse ne siamo l’immagine speculare. Chi può dirlo con certezza? Cacciapuoti e la poesia. Se non dircelo esplicitamente, farcelo prefigurare con lo strumento della parola ben scritta, della storia ben narrata. Storia d’amore, intendiamoci. Tra una quindicenne e un sedicenne, in qualche modo e per differenti motivi “diversi”, esclusi dall’umano consesso, forse dalla vita. Anche tra loro medesimi la frattura pare insanabile: non c’è ponte che unisca gli esseri umani, neppure l’incoscienza degli adolescenti. Sennonché, che sia l’estate, che sia il mare, che sia la luce, che sia il cielo stellato, il ponte sembra costruirsi da sé, probabilmente progettato da quell’invisibile architetto che si chiama amore. Coniuga due esseri che le avversità e le circostanze vorrebbero distanti, precipitandoli, congiunti, entro l’ebbrezza del vuoto, nella voragine di una caduta libera che le montagne russe o il tuffo da una scogliera o l’immediatezza di un bacio umido traducono nel caos primordiale. L’identità si fa bina e multipla, tende a smarrirsi nella festa della ritrovata compatibilità. Io sono te, tu sei me, siamo uno, siamo tutto e tutti. Noi siamo compatibili, sembra urlare Nica al mondo che non vuole e forse non può intendere il senso delle sue pretese, un senso riposto e misconosciuto, oltre i limiti del male che scinde e scompone, oltre la morte che incombe, oltre i vincoli della legge, oltre le nuvole.
Per intendere ciò che affermo occorre salire sull’aereo per noi fabbricato da Massimo Cacciapuoti. Siamo sulla pista, quasi increduli che il mastodonte nel quale siamo rinchiusi possa sollevarsi in volo. Non ci crediamo neppure quando corre veloce verso l’orizzonte. Poi il miracolo del distacco brusco dal suolo e il senso di smagamento che ci assale via via che il velivolo prende quota. Il mondo si perde sotto i nostri piedi, sempre più piccolo, sempre più distante. Una massa grigia e densa ci avvolge. Siamo persi, non c’è appiglio al quale possiamo aggrapparci, il panico è segnalato dall’ottundimento dell’udito, per la pressione che cambia, certo, per la pressione. Poi il miracolo dell’emersione sopra un candido manto di bambagia. Non ne percepiamo la caducità, solo la calma che ci trasmettono le strinature d’ori e violetti che la luce del sole dissemina sul soffice illusorio piancito. Siamo oltre, siamo altrove, forse siamo ovunque.
È così che levita il racconto di Cacciaputi: dalla gravezza del fatto all’imponderabilità della poesia. L’unico indizio di grossolanità è una lacrima che riga il nostro volto. Inevitabile. La vicenda ha risvolti amari. Eppure ti resta nell’animo quel senso di sospensione che l’amore disincrostato dalle convenzioni verbali riesce a trasmetterti. Una suggestione come un’altra, tanto più gradita quanto più accompagnata dalla buona prosa. L’epilogo rivela la tenacia dell’unicità, dell’irripetibilità. La fedeltà di Nica è totale, va ben oltre la promessa fatta a Sandro. Ti fa star bene, sospeso in una dimensione nella quale l’attimo e l’eternità si equivalgono, forse coincidono. Ben oltre le nuvole!
Id: 803 Data: 12/09/2014 12:00:00
*
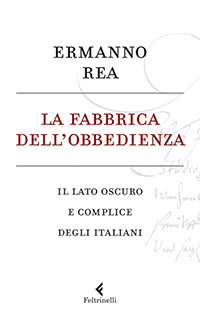 Ermanno Rea - Saggio - Feltrinelli
Ermanno Rea - Saggio - Feltrinelli
La fabbrica dell’obbedienza
Il dignitoso “no!” di Giordano Bruno
Disambiguo subito il titolo orwelliano[1]. Fabbrica dell’obbedienza è quel complesso e raffinato metodo di persuasione-sottomissione elaborato nel secolo XVI dal Sant’Uffizio ed eretto a efficace sistema di consenso più o meno generalizzato. Secondo Rea, questo sistema vige ancora nel nostro paese, anzi è così introiettato dalla coscienza collettiva da diventarne l’elemento caratterizzante. Menzogna, ipocrisia, servilismo, corruzione, raggiro, imbroglio sono gli inevitabili corollari di un plurisecolare esercizio di sottomissione a un “principio”, astratto quanto indimostrabile, secondo il quale l’ordine dell’Universo sarebbe stato stabilito ab origine, a prescindere da ogni successiva elaborazione umana, anzi, da questa prospettiva, sarebbe grave peccato-reato pretendere di sovvertire tale ordine nelle istituzioni che l’umanità si è data o intende darsi. Il loro assetto è piramidale e gerarchico. Al vertice c’è sempre e comunque un uomo che la “Provvidenza” ha preposto agli altri perché si faccia garante e tutore dell’indiscutibile “principio di autorità” sul quale ogni umano consesso deve fondarsi. La Storia non esiste, il divenire è mera illusione, il cambiamento è sovversione.
Sennonché, prima che questa concezione si attestasse, rinverdendosi e sclerotizzandosi nei paesi rimasti cattolici dopo lo scossone della Riforma, c’erano stati alcuni uomini di limpida e libera coscienza, italiani per lo più, che, anziché far derivare la conoscenza da un principio astratto, preferivano brancolare negli affascinanti meandri di una perenne ricerca che mai persegue verità assolute e trascendenti, ma le più “limitate” e transeunte che le circostanze di luogo e di tempo consentono. In altre parole, negli affari umani e occasionali, alla mistica si antepone la ricerca, alla teologia la scienza. Gli uomini che ebbero tale concezione sovversiva si dissero umanisti e, con i loro studi e le loro opere, contagiarono il resto d’Europa.
Da questa falla scaturisce la contestazione di Calvino Lutero e affini che spacca in due il mondo cristiano. La Chiesa di Roma corre ai ripari. Indice quel Concilio tridentino dal quale deriverà la dottrina ufficiale del Cattolicesimo, la più pesante delle ipoteche poste sull’impervio cammino della promozione umana. Cade su di essa, come un macigno, il Tribunale dell’Inquisizione, in tutta Europa ardono i suoi lugubri roghi. A bruciare è il più incredibile patrimonio di cultura che l’umanità abbia mai prodotto e con esso chiunque ne sia considerato il produttore. Emblematiche, in tal senso, le vicende di Giordano Bruno e di Michelangelo Merisi da Caravaggio, diverse certamente per interessi biografie e esiti, ma accomunate dall’orgogliosa contestazione di quel principio di autorità che ha ridotto alla completa soggezione il nostro paese, più che altri di pari credo religioso. Mirabili le pagine dedicate a queste due grandi figure, valgono da sole l’intero libro. Il quale non è soltanto questo, ma molto di più. È, per dirlo con le parole dell’autore, lo sfogo di un cittadino con i nervi a fior di pelle. Intanto mi permetterei di dire che, per essere uno sfogo, è tutt’altro che rabbioso. Appassionato certamente, discorsivo e coinvolgente come solo sa esserlo una delle penne più straordinarie delle nostre lettere, tale da apparentare il libro alla grande pubblicistica laica, l’unica che ha fatto crescere e maturare intere generazioni di giovani, dando all’Italia quel poco di pensiero critico che le rimane. La passione civile, l’amore e il rispetto per la comune umanità vanno ascritte a un vasto repertorio di opere che, benché bistrattate e studiate da pochissimi cultori, vanta nel nostro paese nomi illustrissimi, alcuni dei quali ricordati, in nota, dallo stesso Rea. Valga per tutti il libro di Bertrando Spaventa, Rinascimento Riforma Controriforma e altri saggi critici, qui proposto alla nostra attenzione nell’edizione de La Nuova Italia del 1928. La prospettiva di Rea è però duplice: da un lato si richiama ad alcuni nostri intellettuali di grande spessore, dall’altro a studi e riflessioni provenienti d’oltralpe. Ne scaturisce una visione dell’Italia a tutto tondo, tanto più meritevole d’attenzione quanto più prossima alla verità. Chiunque abbia girato un po’ l’Europa e abbia posto la necessaria attenzione all’immagine che gli altri hanno di noi, non può non sottoscrivere le perorazioni di questo libro, benché possa non condividerne la complessiva argomentazione. Rea non scrive né per persuaderci né per denigrarci. Il suo intento è quello di farci riflettere, tant’è che pare mettersi costantemente da parte per dare spazio alle possibili repliche dei lettori. È davvero difficile che uno scrittore sia capace di dare tanto spazio ai suoi interlocutori. Il libro è bello per questo, sembra invocare il nostro contributo alla chiarezza, pare sollecitarci alla contestazione, al dibattito, secondo quel raffinato metodo dialettico che egli stesso, l’autore, celebra quale patrimonio irrinunciabile della cultura laica. L’antitesi, negando la tesi, permette di giungere a una sintesi che è premessa per una più avanzata forma di conoscenza. In altri termini, la verità non è data una volta per tutte, ma va cercata, costantemente cercata. Noi viviamo dentro un processo del quale siamo attori, ciascuno con la sua fetta di responsabilità. La consapevolezza di essere dentro un divenire, se da un lato piega la nostra protervia, dall’altro ci spinge all’azione e al cambiamento. In termini politici la democrazia è nemica giurata di ogni governo esterno alla volontà e alla responsabilità del “cittadino”. È un regime instabile e provvisorio, destinato a essere, di volta in volta, empito dallo stesso divenire di cui è parte. Questa precarietà nega di necessità il principio di autorità su cui la Chiesa e le sue dirette emanazioni fondano la loro legittimità. L’ordine gerarchico di cui si avvale per governare e orientare le coscienze è visto come promanante dalla divinità, quindi immutabile nello spazio e nel tempo. Si tratta di un’istituzione che si pretende estranea alla Storia. Le si deve assoluta obbedienza perché essa si origina direttamente da Dio, dinanzi al quale non puoi che chinare con umiltà il capo. Questo “Dio” della Chiesa cattolica ha tutte le caratteristiche del sovrano orientale d’epoca ellenistica, dinanzi al quale ogni suddito si prosterna. La credenza e la connessa liturgia finiscono di pari passo nel cerimoniale della Roma imperiale, con la divinizzazione in vita dell’Imperatore. È in questo contesto e riferendosi a questo modello che nasce l’organizzazione della Chiesa. Al vescovo di Roma vengono attribuite, sia pure attraverso un acceso e talvolta cruento dibattito interno al cristianesimo dell’epoca, tutte le prerogative del sovrano orientale. Ne scaturisce un inevitabile conflitto con l’autorità politica alla quale la Chiesa delle origini usurpa sempre più le prerogative, anche per l’obiettiva latitanza del potere civile. Da Costantino a Teodosio è un lungo braccio di ferro tra Chiesa e Impero. La spunta la prima, come dimostrano gli editti teodosiani emanati col beneplacito, se non col ricatto, del vescovo di Milano di allora, quel tal Ambrogio oggi considerato il patrono della città. Storia! Il conflitto non termina qui. Esso si protrae per circa un millennio, benché l’autorità pubblica di riferimento cambi di volta in volta. Storia! La continuità istituzionale è garantita dalla granitica organizzazione della Chiesa più che dall’ondivago alternarsi delle dinastie imperiali. In questo marasma, mi si perdoni la sintesi eccessiva, ha modo di affacciarsi alla storia quel barlume di modernità che va sotto il nome di Umanesimo prima e Rinascimento poi. Si riscopre Atene e la Roma repubblicana, se ne rivangano i pensatori più illustri, si riconosce la centralità dell’uomo quale motore della Storia e artefice del proprio destino. L’individualità e la responsabilità diventano i cardini di una concezione fortemente eversiva dell’ordine costituito. Ne deriva quel movimento riformatore all’interno del Cristianesimo che approderà al Protestantesimo nelle sue varie formulazioni. Si tratta, in effetti, del rifiuto del principio di autorità. È come se i protestanti rinfacciassero alla Chiesa di Roma il suo carattere mondano e storico e ne denunciassero apertamente i limiti e la transitorietà. Lutero non contesta Dio, ma i suoi pretesi portavoce e interpreti, cioè la superbia umana fatta istituzione. Apriti cielo! La reazione è immediata e spietata. Si rimarca, rincarando la dose, il principio di autorità attraverso una dottrina che nega ogni autonomia al libero pensiero, alla libera ricerca. La Controriforma è regime di terrore come dimostrano l’Inquisizione e l’Indice. Mai, nella storia dell’umanità, è esistita tanta accanita e cruenta persecuzione della cultura e del dissenso. I regimi totalitari del XX secolo, afferma Rea, traggono gli auspici proprio dai metodi polizieschi generati dal Concilio di Trento. La milizia fascista e la Gestapo hanno un illustre precursore e un’autorevole legittimazione. Nel nostro paese la similarità di Fascismo e Controriforma è sancita da quei Patti Lateranensi che ancora oggi sono il più pesante vincolo posto alla democrazia. Mentre nelle altre nazioni europee, quelle protestanti in testa, l’autonomia dello Stato dal potere religioso è garantita, da noi non si muove foglia che non abbia l’avallo delle gerarchie ecclesiastiche. Il diritto di sovranità va a farsi friggere, con la consenziente complicità dei suoi stessi titolari. I quali non sono cittadini. La cittadinanza è assunzione di responsabilità; la sudditanza è passiva obbedienza all’ordine costituito. Gli italiani non hanno il senso della cosa pubblica, non chiedono diritti ma prebende, elargizioni, protezione. Storia!
La Controriforma non fu solo repressione e terrore, fu anche blandizie. La sua espressione artistica è e resta il barocco, la lussuria architettonica che lusinga gli occhi e desta la stessa meraviglia del portento, del miracolo. Storia! Gli eventi miracolosi e strabilianti esistono solo nel mondo cattolico. Ve ne spiegate il motivo? Nessun altro che la radicata paganità di popoli che s’ostinano a rimanere plebe. La Chiesa non ha avuto difficoltà ad avallare il politeismo e il paganesimo delle plebi, pur di governarne le coscienze. Lo dimostrano le ritualità più frequentate della religiosità popolare, nella quale romerie, pellegrinaggi e pubbliche flagellazioni adombrano e preservano antichi riti pagani. La superstizione alimenta la rappresentazione animistica e prescientifica del mondo fenomenico, la cultura è guardata con sospetto e demonizzata ovunque. Qui dove io vivo i chiassosi eserciti sanfedisti ancora s’aggirano minacciosi per le strade, a dispetto della luce promanante dal poco dibattito che qualche spirito generoso, al pari di Rea, prova ad alimentare. Non si respira, non c’è aria, si soffoca. Il potere è solo spettacolo e forma, è autoreferenziale, alimenta l’immaginario collettivo con la volgarità e l’oscenità di una liturgia che accarezza i più bassi istinti del branco.
Vuole, il lettore di queste povere note, un’immagine precisa della Controriforma e dei modelli politici che vi si ispirano, in testa ai quali è senz’altro l’Italia oclocratica odierna? Bene, legga o rilegga con estrema attenzione, come suggerisce lo stesso Rea, il capitolo del dostoevskiano “I fratelli Karamazov” dedicato alla leggenda del Grande Inquisitore. È illuminante, oltre ad essere una delle pagine più alte della letteratura mondiale. Il Grande Inquisitore di Dostoevskij dimostra a Cristo il modo “diabolico” in cui ottiene il consenso del popolo. Lo stesso dei nostri governanti. Basta soddisfare i bisogni ferini di crapula e copula e il gioco è fatto. «Il Grande Imbonitore – cito dal libro di Rea – trova il modo di narcotizzare gli italiani (più esattamente, una considerevole parte degli italiani) mettendo in piedi una complessa macchina del consenso di massa, fondata sulla legittimazione – sullo sdoganamento, come con parola sgraziata si usa dire oggi – di tutto ciò che di sporco esiste nella nostra società e dentro molti di noi: individualismo, invidia, edonismo. Una macchina della persuasione fondata sulla “tecnica dello specchio”, capace di riflettere, drammatizzandoli al massimo, i peggiori difetti nazionali trasformati in spettacolo».
Ho un’esperienza personale che mi fa propendere per gli argomenti con cui Rea sostiene le sue tesi. C’è stato un tempo in cui sono stato insegnante e lo sono stato con lo spirito con cui alcuni nobiluomini e nobildonne (beninteso, solo alcuni) furono miei professori. Appresi da loro la dignità e l’impareggiabile abitudine a pensare con la mia testa. Testa non eccelsa, per carità, ma indubitabilmente mia. A me pareva, nel corso della mia attività, che molti dei giovani di cui mi occupavo stessero bene in mia compagnia. Ero felice di vederli crescere con la carezza di una cultura che era mia, benché costruita in anni di intense letture e riflessioni. Anche ai miei ragazzi volevo dare la dignità e la libertà di cui avevo l’illusione di godere. Spesso, quando lasciavano la scuola, mi dicevo che il paese avrebbe beneficiato di loro, del loro entusiasmo, dei loro ideali. Ci credevo. Non ho mai perso di vista alcuni di loro, altri li ho ritrovati dopo lungo tempo. Uomini, ammogliati, con figli. Fatte salve le promesse che molti hanno mantenuto, in altrettanti casi oggi mi trovo davanti a degli autentici imbecilli. Perfettamente omologati al sistema dominante, corrotti fin nel midollo, senza avere la consapevolezza di esserlo. Mai smacco è stato per me più cocente. Io ho prodotto un simile disastro. Chissà quanti padri diranno dei figli la medesima cosa. No, cari papà di un tempo, se questo può esservi di conforto, sappiate che a deformare le nostre giovani promettenti piante non siamo stati noi, ma il sistema dal quale sono state inevitabilmente fagocitate e piegate. È già successo, accadrà ancora. Cosa insegneranno questi giovani genitori ai loro figli? «...l’antico, vergognoso segreto/ d’accontentarsi dei resti della festa. … come il servo può essere felice/odiando chi è, come lui, legato,/come può essere, tradendo, beato,/e sicuro, facendo ciò che non dice». [Pasolini]. Mi fermo qui, ma potrei raccontarvi di altre e ben più amare esperienze, tutte suffraganti il pregnante ragionamento di Rea. La demenza precoce e l’incoscienza sono assai più diffuse di quanto si creda.
Su un argomento del libro ho qualche perplessità, anche se, a onor del vero, l’autore fa la sua proposta-provocazione col garbo che gli è congeniale. Nel capitolo dodicesimo Rea invita a prendere in considerazione la prospettiva politica contenuta nel saggio di Giorgio Ruffolo, Un paese troppo lungo, Einaudi, 2009: la costituzione di due ampie autonomie nell’ambito dello stato unitario. Intanto mi chiedo quali sarebbero i confini geografici di queste autonomie? Dove finisce il Sud e dove comincia il Nord? Le grandi isole, poi, con chi andrebbero? Da quel che ne so, tra la Sicilia e il resto del Meridione non sempre è corso buon sangue. Per altro verso, a giudicare da quello che leggo nella cronaca dei giornali e nei testi di molti autorevoli analisti settentrionali, pare che l’intero paese sia ormai preda della piovra meridionale, il braccio secolare di una Controriforma culturale riveduta e corretta. La totale omologazione cancellerebbe in tal senso la frattura storica tra Nord industriale ricco e opulento e Sud feudale e depresso. Siamo tutti figli dello stesso padre!
L’autonomia del Mezzogiorno mi fa paura. Attualmente è ben difficile trovare un’amministrazione locale che non sia controllata dall’unanime cricca neo-sanfedista. Che accadrà a me e ai pochi miei sodali, tra i quali annovero alcuni nomi illustri ricordati da Rea, avvocato Marotta in testa, quando l’area del paese in cui vivo sarà definitivamente nelle mani dei Gattopardi? Oggi l’Italia e l’Europa mi danno qualche garanzia, mi fanno intravedere contrade in cui possa recarmi in volontario esilio, magari chiedendo l’elemosina e vivendo sotto i ponti, ma mantenendo integra la mia dignità. In futuro, quando la cosa pubblica sarà irrimediabilmente perduta, che ne sarà di me, ammesso che io sopravviva allo scempio? Per quanti secoli ancora il portone di palazzo Serra di Cassano dovrà restare chiuso? Quanti altri Gennaro Serra, Eleonora Pimentel, Carlo Pisacane, Giacomo Matteotti, Piero Gobetti, fratelli Rosselli e Antonio Gramsci dovremo piangere? Quanti altri Ebrei dovremo inviare ai campi di sterminio? Quanti zingari, omosessuali e disabili? Ripeto, il braccio secolare dell’attuale Sant’Uffizio non è lo Stato, ma la belva mafiosa, che non conosce legge, non sa di pietà, uccide e basta. Sono nazisti di fatto. L’Umanesimo, per questa gente, è una parolaccia.
Caro Rea, abbia pietà di me! Lei ha spesso denunciato il culto della personalità, a partire da quello tributato a Stalin. Ebbene, tale culto è endemico nel nostro paese. Il popolo italiano da sempre invoca l’uomo inviato da “Dio”. 'O Re!' Chi sarà quello futuro? Ce lo risparmi, la prego, se ciò è possibile, se i miei concittadini hanno ancora un minimo di discernimento. Ha visto in che cosa si è trasformato il famigerato KGB? Era nei suoi metodi, nelle sue premesse che diventasse mafia, la terribile mafia russa. Non ci consegni all’Inquisizione!
Quanto a me, non so se son capace del grandioso, dignitoso, coraggioso “no!” di Giordano Bruno. Morire con dignità mentre le tue carni bruciano tra atroci sofferenze non è cosa da tutti.
Id: 797 Data: 25/04/2014 12:00:00
*
 Eva Schloss - Biografia - Newton Compton
Eva Schloss - Biografia - Newton Compton
Sopravvissuta ad Auschwitz
L’INNO DI BATTAGLIA DI EVA SCHLOSS
“E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male!”
[Giovanni Pascoli]
Desideravo leggerlo, ma quando l’ho visto esposto in libreria ho provato una certa irritazione. Già il titolo italiano, Sopravvissuta ad Auschwitz, è meno neutro dell’originale inglese, After Auschwitz. Ma il sottotitolo che la casa editrice vi ha aggiunto è addirittura mendace. Recita: La vera e drammatica storia della sorella di Anne Frank. È noto ai più che Margot, l’unica vera sorella di Anna, morì anch’ella a Bergen-Belsen nel 1945. Non è mai esistita altra sorella che Margot. Perché dunque questa informazione falsa? Evidentemente per stuzzicare la curiosità del lettore più sprovveduto, il quale magari si chiederà chi sia mai questa sorella misteriosamente e improvvisamente evocata. Posso ipotizzare un’operazione di marketing finalizzata a rendere più attraente un libro che non ha bisogno di altra promozione che la lettera del testo che propone, eccellente per sé e dunque degno di essere letto da qualsiasi lettore sensibile non solo al tema della Shoah, ma ai drammi e alle contraddizioni del nostro presente? Speculazione a parte, l’autobiografia di Eva Schloss non è solo un libro di drammatiche memorie, ma anche un’approfondita indagine dell’atroce condizione psicologica di chi è sopravvissuto ai crimini nazisti e ha dovuto riappropriarsi della vita tra mille difficoltà, tanto più in vecchiaia, quando il peso dei ricordi corre il rischio di schiacciarti irrimediabilmente, com’è accaduto ad alcuni, tra i quali non possiamo dimenticare il nostro Primo Levi. È pertanto ammirevole la tenacia, la forza e il modo con cui Eva è andata e va avanti, certamente testimone diretta degli anni più bui della storia europea, ma anche portatrice di un raggio di luce nelle tenebre della contemporaneità. Consiste in questo il valore del libro che ha scritto in collaborazione con Karen Bartlett e che la Newton Compton propone ai lettori italiani nella traduzione di Lucilla Rodinò e Rosa Prencipe: nell’ampia panoramica su uno spaccato di storia europea, dagli anni dieci del secolo scorso fino ai nostri giorni, nella prospettiva che coinvolge nel diritto di commemorazione non solo gli Ebrei, ma tutte le vittime dell’olocausto, nella compassione per i martiri delle numerose guerre che funestano la cronaca mondiale dei nostri giorni, nella solidarietà per i capri espiatori di tutti i pregiudizi presenti, nella pietà per le sorti degli umiliati e degli emarginati, ignari e involontari esclusi da un sistema economico e sociale che discrimina nei fatti e nella legge. Riconosce in questo sistema di valori il significato dell’opera intrapresa da Otto Frank, il padre di Anna, prima nel dare alle stampe il celebre Diario di sua figlia, poi nel promuovere una capillare opera di sensibilizzazione intorno al motivo della memoria.
Molti conosceranno le numerose polemiche che hanno investito la figura di Otto, una delle quali è l’accusa di lucrare sul suo stesso dramma familiare. Eva Schloss smentisce senza mezzi termini questa calunnia, ce ne restituisce un’immagine più consona ai fatti, più vicina alla sensibilità e al carattere dell’uomo, per averlo conosciuto assai bene dopo la guerra e per essere egli divenuto parte integrante della sua famiglia. Il 10 novembre 1953 Fritzi Markovits, la madre di Eva, sposa in seconde nozze Otto Frank. Entrambi vedovi per aver perso i coniugi nei campi di sterminio, trovano sostegno l’una nell’altra per lunghi anni. Sarà Fritzi a sostenere il nuovo marito nell’annosa ed estenuante vicenda editoriale del Diario di Anna Frank, gli sarà accanto in tutte le iniziative intraprese, lo seguirà nei numerosi viaggi intorno al mondo per la promozione del celebre libro, con lui risponderà alle migliaia di lettere che riceveranno da lettori di tutto il mondo, molti dei quali, è comprensibile, adolescenti in cerca di conforto e sicurezza. Otto diventa per Eva una specie di padre adottivo e sarà considerato il nonno dalle sue figlie. Non è suo padre e lei ha scarsamente frequentato Anna quando questa era in vita, benché fossero dirimpettaie e usassero giocare entrambe nella Merwedeplein di Amsterdam, la stessa piazza in cui trovarono alloggio dopo la fuga precipitosa l’una da Francoforte, l’altra da Vienna. I Frank vi emigrarono nel 1933, subito dopo l’avvento di Hitler al potere, i Geiringer (tale il cognome da nubile di Eva) nel 1938, dopo l’Anschluss.
È per questo che abbiamo rigettato il depistante sottotitolo dell’edizione italiana del libro, per neutralizzare l’analoga accusa che potrebbe essere rivolta all’autrice, un rischio di cui ella stessa sembra consapevole. L’autobiografia di Eva nega la logica di mercato, ma non la esclude certamente il suo editore italiano, il quale ragiona da imprenditore ed è mosso dal criterio d’impresa. Se lo dimentichi, il lettore di queste note, il vecchio editore che leggeva i libri, scopriva i talenti, li promuoveva per la dignità e i meriti che vi rinveniva. Un libro è una merce come un’altra e come tale è trattato. È difficile per un autore sfuggire alla mera legge del profitto, a dispetto delle sue buone intenzioni.
Tuttavia, fatta questa doverosa precisazione, occorre riconoscere che il libro merita la lettura. La prosa asciutta e incisiva, la fluidità del racconto, l’organizzazione della materia inducono alla riflessione più di quanto la scorrevolezza del testo lasci intendere, senza contare che non mancano qua e là brevi ed efficaci commenti dell’autrice che denunciano una mirabile lucidità di pensiero. Ecco cosa scrive a conclusione del capitolo dedicato ai processi ai collaborazionisti olandesi che denunciarono numerosi Ebrei: «Vorrei poter dire di credere che questa gente, e Miep Braams [l’infermiera che consegnò ai tedeschi il papà e il fratello di Eva, ndr] in particolare, si sarebbe trovata davanti alla vera giustizia dopo la morte, ma la mia esperienza ad Auschwitz mi aveva privato della fede nella potenza divina di “Dio” o nell’aldilà. La giustizia deve esistere in questo mondo, altrimenti non esiste affatto». Il contesto, poi, suggerisce l’idea che, in questo mondo, esistono norme convenzionali più o meno pattuite, non certo il diritto. I regimi, democrazie comprese, si reggono sulla legge, non sulla giustizia. Non è scritto da nessuna parte che le leggi siano buone per essere volute o accettate dalle maggioranze, qualunque sia il modo in cui queste si esprimono. Se così fosse, dovremmo legittimare il nazismo medesimo. Lungi da me e dall’autrice del libro il volerlo fare!
Nel 1995, in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz a opera delle truppe sovietiche, Eva assiste alle cerimonie e ai discorsi retorici dei capi di stato ivi convenuti. Costoro stigmatizzano le deportazioni e il razzismo e ne auspicano la sconfitta ovunque e per sempre. «Ma è successo ancora – commenta Zvi, suo marito – … Sta succedendo in diverse parti del mondo proprio in questo momento». Come dargli torto? Ne è consapevole la narratrice stessa se rivela di non voler demordere, nonostante la stanchezza e il peso degli anni. Spetta a noi seguirne l’esempio. Penso che al dovere di vigilanza andrebbero educati i giovani, nelle scuole, come la stessa autrice non manca di fare da molti lustri, a prescindere e prima che la presente opera vedesse la luce.
La Schloss rivela un temperamento volitivo, fiero, forte, battagliero, quasi negando nei fatti la timidezza e l’impaccio coi quali si presenta al pubblico delle conferenze a cui partecipa in ogni parte del mondo. Non fa sconti a nessuno, neppure a se stessa, rappresentandosi nell’immediatezza delle asperità del suo carattere, nella severità con cui giudica sua madre in diverse circostanze, nella valutazione non proprio benevola dei Giudei in odore di collaborazionismo. Eppure dietro la schermo dell’intrepidezza si nasconde una dolcezza d’animo e una finezza di sentimento che spingono il lettore alle lacrime. Tenera l’immagine che offre dell’amato fratello Heinz, un ragazzo di diciannove anni morto, poco dopo suo padre, nel campo di Mauthausen presso il quale era stato forzosamente trasferito nel gennaio del 1945. Ne evoca in più punti la mitezza dei modi, la nobiltà dei sentimenti. Amava i libri e le pittura, così che ce lo rappresenta negli anni dell’adolescenza come un solerte lettore e un pittore dilettante di promettenti attitudini.
Heinz, nei giorni della coatta clandestinità, nasconde alcune sue tele sotto le assi del pavimento della casa in cui s’è rifugiato. Lo fa poco prima che, per la denuncia di Miep Braams, sia catturato dalla Gestapo. Eva riuscirà a recuperare le tele dopo la guerra e a custodirle per lunghi anni. Commovente la descrizione di un autoritratto. Il ragazzo vi è rappresentato seduto alla scrivania; sullo sfondo è ben visibile un calendario che reca la data dell’11 maggio, quella di nascita di Eva. Una maniera, interpreta lei, per manifestarle il suo grande affetto, il sentimento che li lega oltre l’oltraggio del tempo che scorre. Le tele saranno esposte cinquant’anni dopo la morte del ragazzo. In occasione di una mostra americana, l’ormai anziana signora non può fare a meno di rivolgersi a lui, quasi fosse presente all’evento: “Visto, Heinz, non mi sono dimenticata di te. Avevi paura di non lasciare il tuo segno nel mondo, ma sei ancora con noi. Hai fatto il tuo debutto”. Ancora con noi! La tenacia della memoria è l’unico possibile risarcimento a chi ci è stato sottratto da una mano assassina, impassibile dinanzi al bocciolo che cade prima che abbia potuto effondere il suo profumo.
Nella piccola galleria fotografica che correda il volume, Heinz compare tre volte. È prima un grazioso bambino, poi un adolescente dall’aria romantica. In una foto è ritratto con un libro in mano, lo sguardo intento alla lettura. Non riesco a distogliere gli occhi da lui, mi sembra di conoscerlo, mi pare di potergli parlare, me l’ha reso vivo l’affettuosa testimonianza di sua sorella. Ha l’età dei miei studenti e, come loro, sogna di cambiare il mondo. Come i miei giovani allievi, lui l’avrebbe fatto davvero un mondo migliore, avrebbe reso lieti i miei anni maturi. Negando a lui la vita, hanno negato a me la gioia. Il loro delitto è anche contro la mia persona, contro la vostra, contro coloro che verranno. Ecco perché i suoi nemici sono anche i miei, e i vostri, e dell’umanità.
«Un’altra sera, una giovane tedesca si alzò in piedi e iniziò a piangere. Disse che suo nonno era stato nazista, mentre suo fratello aveva fatto parte della Resistenza. Il nonno aveva sparato e ucciso il fratello, e la famiglia non aveva mai accettato la cosa. Lei aveva lasciato la Germania per allontanarsi dal passato della sua famiglia e fino a quella sera non ne aveva mai parlato con nessuno».
L’episodio è gettato lì quasi per caso, ma colpisce per la particolare drammaticità. Né l’autrice del libro né noi possiamo verificarlo, ma, da altre fonti, abbiamo testimonianza di casi analoghi. Il fatto che la Schloss lo riferisca dimostra l’ampiezza di prospettiva con la quale affronta il tema del nazismo. Punta il dito contro il veleno di un’ideologia, non contro un popolo, per il quale non nutre astio, ma pietà, per essere stato esso per primo ostaggio di un manipolo di criminali.
«Qualche mese fa, ho concluso il mio discorso e ho guardato la scolaresca che avevo davanti. Una ragazza somala dagli occhi scuri ha alzato esitante la mano e mi ha chiesto: “Pensa che succederà di nuovo?”».
L’autrice afferma di non essere riuscita a rispondere. Rispondo io per lei, parafrasando le parole di suo marito. Succederà, certo che succederà, anzi succede tutti i giorni sotto i nostri occhi indifferenti, annegati nel brodo di giuggiole d’un effimero benessere. La storia mondiale del secondo dopoguerra è storia di genocidi. La cronaca del presente è il resoconto d’una sanguinaria battuta di caccia all’uomo. Il numero delle vittime del dopoguerra è di gran lunga superiore a quelle dei campi di sterminio. Pare che i nazisti abbiano fatto scuola. I criminali dei nostri giorni, dietro qualsiasi maschera si celino, hanno appreso la lezione. A noi non resta altro che erigere gelidi monumenti ai caduti.
Confesso che mi ripugna questo genere di risarcimento. Vorrei non risarcire nessuno e vorrei che i giovani vivessero in pace e armonia e che la parola “discriminazione” sparisse da tutti i dizionari del mondo.
Forse è per questo che mi è piaciuto il libro di Eva Schloss: non è un gelido monumento, è un inno di battaglia.
Id: 786 Data: 07/02/2014 12:00:00
*
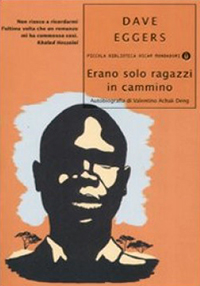 Dave Eggers - Romanzo - Mondadori
Dave Eggers - Romanzo - Mondadori
Erano solo ragazzi in cammino
Autobiografia di Valentino Achak Deng
Homo homini lupus
«In ognuno di noi vive una bestia
frenata solo da ciò in cui ci hanno insegnato a credere,
il bene e il male.
Quando dimentichiamo quegli insegnamenti,
la bestia che è in noi
si scatena in tutta la sua furia»
[Émile Zola]
La fondazione Valentino Achak Deng (http://www.valentinoachakdeng.com) è un’associazione no-profit fondata dal protagonista-narratore del libro e dal suo autore. Essa è nata dopo la pubblicazione del romanzo di Dave Eggers, What is the What, 2006 (nel nostro paese: Erano solo ragazzi in cammino – Autobiografia di Valentino Achak Deng, Mondadori 2007, traduzione di Giuseppe Strazzeri).
È una storia romanzata, ma la vicenda alla quale fa riferimento è tristemente vera e nota: la seconda guerra civile sudanese, dalle sue premesse fino al ricollocamento dei Ragazzi Perduti negli Stati Uniti. Oltre alla cronologia del libro, sono da ricordare l’accordo di Naivasha del 2005 e il referendum separatista del 2011 che dovrebbero garantire un minimo di serenità ai giovani sudanesi che oggi vivono a Marial Bai, il luogo natale di Achak. I ragazzi di questo villaggio, sopravvissuti alle razzie dei Baggara, grazie alla fondazione, hanno finalmente una scuola vera, con dei veri insegnanti e materiale didattico degno di tal nome. L’istruzione è uno dei progetti dell’associazione umanitaria, il cui scopo è dare dignità a una popolazione decimata dal più atroce conflitto del secondo dopoguerra, con ben due milioni di morti e quattro milioni di profughi. Il protagonista del romanzo non solo rievoca la sua personale odissea, ma testimonia il martirio di una terra e di un popolo le cui sole colpe sono quelle di vivere lontani dal mondo dello sviluppo e di essere ignari delle sue perfidie, tanto più che le vittime della maratona di sangue del racconto sono bambini, orfani o crudelmente strappati ai genitori naturali.
Il pretesto del conflitto è il tentativo del governo di Khartoum, nel 1983 guidato da Jaafar Nimeiry, di imporre la Shari’ah su tutto il territorio nazionale, a dispetto degli accordi di Addis Abeba del 1972 per i quali il Sudan meridionale, a maggioranza cristiana e animista, non vi era vincolato. Dietro la svolta fondamentalista, però, si nasconde una differente realtà di natura economica: i pozzi petroliferi per lo più situati nel Sud del paese. Sono una risorsa della quale il Nord non intende perdere il controllo. Nel romanzo la vera causa del conflitto è ricordata nella breve e intensa storia di Lino (pp. 239 e sgg): nel 1974, due anni dopo gli accordi di pace per i quali le risorse tra Nord e Sud andavano equamente divise, Gerge Bush padre, all’epoca ambasciatore presso le Nazioni Unite, trova il più grosso giacimento di petrolio sudanese, puta caso nei territori del Sud. Sono interessati al business i petrolieri americani legati al futuro presidente, la potente Chevron in testa. Il petrolio fa gola a parecchi, tanto più se capita a ridosso della crisi che ha messo in ginocchio i paesi industrializzati. Il governo centrale sudanese, a maggioranza islamica, è foraggiato dagli stessi americani i quali, poveretti, finiranno col darsi la zappa sui piedi. Khartoum, negli anni cruciali della guerra civile, darà ospitalità nientemeno che a Osama bin Laden e al gruppo di Al Qaida, vale a dire all’ideatore e agli esecutori dell’attentato terroristico al World Trade Center (11 settembe 2001). Al medesimo petrolio sono interessate Cina e Malesia, la prima tra le maggiori fornitrici di armi all’aggressore. Viene da chiedersi, a questo punto, se la seconda guerra civile sudanese sia un conflitto locale o una guerra di rapina voluta da alcune grandi potenze. Lo scenario è tale per cui la risposta non può essere che scontata. La seconda guerra mondiale non è mai finita, è solo diventata più subdola. Ha cambiato regia e teatro: la nuova direzione è fondata, in linea generale, sul consenso popolare, benché il popolo, nel caso presente, sia ridotto a una massa di imbecilli drogati dal benessere economico; il teatro sono gli angoli appartati di mondo dei quali si ignora per lo più l’esistenza, noti solo ai predatori che ne sanno individuare le risorse. Il Sudan è uno di questi numerosi casi. La storia recente ce lo insegna. Sparito il vecchio colonialismo, se ne presenta un altro rinnovato nei metodi e nelle vesti. Basta soffiare sul fuoco di conflitti politici, culturali, religiosi, è sufficiente armare la parte che si ritiene possa fare i nostri interessi e il gioco è fatto. Qualche milione di morti da una parte, un genocidio dall’altra, una strage di immane dimensione altrove ben valgono il buon affare. Infine arrivano i buoni, mediano tra le parti in lotta, s’impossessano d’una fetta consistente dell’ambito trofeo di guerra e tutto finisce. È incredibile come a vincere siano sempre gli stessi: i soliti ignoti. Sì, non sappiamo chi siano. Sapreste voi identificare il leone che azzanna un bimbetto di pochi anni, ne maciulla le carni e sparisce nel nulla? Potreste voi accusarlo di infanticidio? È un predatore, fa il suo mestiere. Individua nel branco l’esemplare meno protetto, il più debole di tutti, e questo diventa la preda. Vigliacco il leone, come tutti i predatori! Non si confronta mica con una bestia di pari forza. No! Azzanna i deboli e di quelli di pasce, più o meno come la bestia umana, predatrice per natura, a dispetto del millantato blasone che si è data. Osservate attentamente le dinamiche di una rapina. Il rapinatore, benché possa andare incontro a qualche imprevisto, individua il soggetto da rapinare tra chi percepisce più debole di lui, se non altro per essere la vittima disarmata. Vigliacco il rapinatore! Non si confronta mai con chi potrebbe fronteggiarlo e difendersene. La vittima non deve avere opportunità. È vittima, per legge convenuta.
Così nella recente carneficina del Sudan, le prime vittime sono i bambini. Fuggono dai loro villaggi in fiamme, vedono trucidati genitori e conoscenti, scampano per un pelo alla stessa drammatica fine. Soli, spauriti, affamati, vagano per la campagna desolata fino a quando si imbattono in qualcuno che promette di metterli in salvo, in un luogo lontano dal conflitto, in una Etiopia, terra mitica nell’immaginazione dei piccoli profughi. I Ragazzi Perduti percorrono a piedi centinaia di chilometri, attraversano deserti e foreste, guadano a nuoto fiumi insidiosi, abbandonano lungo il percorso decine di compagni, morti, tutti morti, chi per essere preda di fiere, chi per annegamento, chi per inedia, chi per dissenteria o febbri malariche. È una strage di innocenti ancor prima che la meta sia raggiunta. Questa è Pinyudo, un campo profughi in territorio etiopico, un luogo desolato dove acqua e cibo scarseggiano e dove la sicurezza è tutt’atro che garantita. Gli Etiopi vedono questa massa di straccioni come intrusi, non mancano di fargli sentire la loro ostilità, non esitano a spargere sangue. Pinyudo è una trappola per i piccoli profughi, le cui fila s’ingrossano ogni giorno di più. Sono considerati i semi della guerra partigiana: è tra loro che l’Esercito di Liberazione recluta le nuove leve. Malamente addestrati, vengono rispediti in Sudan a combattere l’esercito governativo. Molti vi lasceranno le vita o qualche arto.
Quando nel 1991 il regime di Mènghistu viene rovesciato, anche la vita dei piccoli profughi sudanesi diventa un inferno. I soldati del Fronte Rivoluzionario Democratico del Popolo Etiopico attaccano Pinyudo, costringendone i rifugiati alla fuga. L’eccidio che ne deriva sembra una battuta di caccia. I cecchini etiopi tendono ogni sorta di insidie ai fuggitivi. I superstiti sono di nuovo in marcia; tra loro c’è Achak Deng, ma è stremato e vinto dall’orrore del sangue e dei cadaveri che lo circondano. Si lascia andare lungo il ciglio di una strada polverosa, vuole abbandonarsi alla morte come ha fatto il suo amico d’infanzia William K. «Allora… camminavo domandandomi a ogni passo se volessi davvero continuare a vivere». Un bambina più piccola di lui, Maria, lo incita a muoversi, a sperare. Un neonato piange e cerca il seno della madre morta. Valentino lo raccoglie e lo mette in salvo. Negli anni avvenire si chiederà sempre quale sorte sia toccata a quel bimbo.
La marcia forzata verso la salvezza approda finalmente a Kakuma, in Kenya. Ancora un campo profughi, ma questa volta supervisionato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e da una pletora di associazioni di volontariato. È una landa desolata che le associazioni umanitarie e gli stessi profughi renderanno vivibile. Diventa la città dei rifugiati per eccellenza: sudanesi a parte, ospita eritrei, etiopi, somali, bantu, ugandesi, congolesi, burundesi, ruandesi. Non vi mancano i dissidi, non mancano episodi di microcriminalità, ma il tempo rende soddisfacenti la vita e le relazioni del campo. Le abitazioni cominciano a diventare in muratura, i giovani hanno la possibilità di ricevere un’istruzione e di praticare qualche sport, qualcuno trova addirittura lavoro e guadagna in proprio. Achak collabora a un progetto umanitario finanziato dal Giappone. Diventa stretto collaboratore e amico di Norigaki, il ventisettenne che lo gestisce al campo. Se lo vedrà morire davanti agli occhi in seguito a un incidente stradale. L’ennesima prova alla quale è sottoposto poco prima di essere ammesso al ricollocamento negli Stati Uniti. Impatta sull’universo luccicante dello sviluppo e lo scopre non meno insidioso delle foreste e dei deserti percorsi da bambino. Anche il nostro mondo è sede di predatori e prede. Ovviamente le prede sono i più deboli. Tra questi i rifugiati, ingenui, inesperti, incapaci di manovrare i complessi congegni delle nostre tecnologie. Alcuni di loro pagheranno con l’alienazione, qualcuno col suicidio, qualche altro finirà irretito dal vizio e dal piccolo crimine. Come da copione. Achak ce la fa. È tenace, pacificamente combattivo. Aspira alla laurea, incontra mille difficoltà. Sogna di ricostruire il proprio paese. Opera concretamente per realizzare questo sogno.
Questa, per sommi capi, la vicenda di un libro che non fa sconti a nessuno. Se i murahaleen sono animali rapaci assetati di sangue, non meno bestiali sono gli afroamericani che rapinano Achak nella sua casa di Atlanta, lo massacrano di botte e lo tramortiscono. In mezzo si trova l’indifferenza o la diffidenza dei più. C’e da riflettere e da riflettere anche parecchio su questo bel romanzo di Dave Eggers. Drammatico, tenero, poetico, avvince il lettore e lo lega ai suoi personaggi col sentimento della sofferta solidarietà.
La prosa scorrevole, il tono colloquiale, la scarna essenzialità della cronaca drammatica fanno perdonare qualche accorgimento retorico di troppo finalizzato a strapparci la lacrimuccia. La retorica è uno dei ferri del mestiere della letteratura. Ben venga se spesa per una giusta causa!
Id: 773 Data: 17/01/2014 12:00:00
*
 Theodor Herzl - Romanzo - Bibliotheca Aretina
Theodor Herzl - Romanzo - Bibliotheca Aretina
Vecchia Terra Nuova
IL SIONISMO ASSIMILAZIONISTA DI THEODOR HERZL
Non è di quei libri di cui la stampa discuta. Non sapremmo neppure dire se ne ha dato notizia. Eppure è interessante, non solo per il mondo ebraico al quale era prevalentemente rivolto quando fu scritto, ma per gli studiosi del Sionismo, per gli storici in generale, per noi comuni lettori ai quali – siamo all’attualità – sta a cuore la questione ebraica che non cessa di scuotere le coscienze, ponendo quesiti assillanti ai quali è difficile, forse impossibile, dare risposte. Il libro s’intitola Altneuland, ne è autore quel Theodor Herzl a torto considerato quasi l’unico padre del Sionismo, è la sua traduttrice una delle personalità più illustri della comunità ebraica italiana, Roberta Ascarelli, titolare della cattedra di lingua e letteratura tedesche presso l’Università di Siena e Lucca. Il romanzo, il cui titolo italiano suona “Vecchia Terra Nuova”, è stato edito nel 2012 da Bibliotheca Aretina coi contributi del MIUR e del Dipartimento di Letterature Moderne e Scienze dei Linguaggi dell’Università di Siena, col patrocinio del Forum Austriaco di Cultura di Roma: un bel po’ di prestigio intorno a una pubblicazione che ha il valore di una chicca nello stagnante dibattito culturale del nostro paese.
Sì, perché di questo si tratta, di un’operazione autenticamente culturale che consente a noi italiani di rileggere il Sionismo, di approfondirlo, di constatarne le discrepanze e le contraddizioni, alla luce di quanto ha prodotto non solo in seno all’ebraismo mondiale, ma nella storia del secolo scorso, i cui epigoni sono vivi e attuali sotto i nostri occhi, drammaticamente vincolanti le odierne relazioni tra i popoli. C’è Israele, ci sono i paesi arabi confinanti, ci sono i Palestinesi, cova sotto la cenere di una quiete apparente la “guerra che non si può vincere” (Grossman), c’è il terrorismo di matrice islamica, c’è l’antisemitismo strisciante dei gruppi neonazisti, c’è l’ipocrisia di chi finge che il problema non esista, c’è un sessanta per cento di Ebrei che ancora vive nella diaspora, che per lo più vi si trova bene, che non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Palestina; c’è infine un controesodo per il quale gruppi consistenti di Ebrei israeliani abbandonano la loro terra natale per trasferirsi nella capitale di quel paese che, quasi settant’anni fa, voleva annientarli.
Così risulta utile il confronto tra ciò che Herzl pensava dovesse essere l’antica nuova terra degli Ebrei e ciò che in effetti è stata in virtù di un percorso tortuoso e non sempre comprensibile, almeno agli occhi di chi Ebreo non è ma che sente propria l’intera loro vicenda, diasporica e non, quale ascendenza del comune drammatico presente. La storia degli Ebrei è storia di tutti, così come le loro attuali vicissitudini riguardano l’umanità non meno di un’altra umanità meno nota e meno atavica, ma pur sempre antica, nei termini in cui non c’è uomo sulla terra che non sia antico, che lo si voglia derivante da un comune antenato o lo si pensi evoluto da specie preesistenti. In altri termini, come la si volti o la si giri, deriviamo tutti da un ceppo comune, se è vero che ora siamo miliardi e che non più di ventimila anni fa eravamo pochi milioni di individui disseminati su una superficie vastissima, tutti migranti, tutti diasporici, per via di un’economia primitiva di mero sfruttamento delle risorse disponibili, un’economia di rapina, di semplice rapina, talché se la praticassimo oggi avremmo distrutto ogni forma di vita sulla Terra, compresi noi stessi. Volenti o nolenti, da questi discendiamo. Tutti! Ne deriva che siamo tutti parenti più o meno prossimi, anche se alcuni gruppi si distinguono per la memoria lunga. Ma la memoria è la risultante di circostanze favorevoli che hanno consentito ad alcuni di registrare il loro passato, in molti casi solo mitico, su un supporto meno effimero e contingente dei neuroni postsinaptici, i rudimentali hard disk della Storia: la pietra, la pergamena, il papiro, la carta.
Il libro di Herzl è ascrivibile alla narrativa utopistica, anch’essa atavica nelle lettere, tanto da far pensare addirittura alla Πολιτεία di Platone, non foss’altro che per lo spazio che vi hanno i dialoghi. La narrazione in senso stretto vi occupa una minima parte e la trama è piuttosto esile. E’ l’anno 1902. Un giovane ebreo disilluso, Friedrich Löwenberg, medita il suicidio, dal quale viene sottratto dalla proposta di un misantropo, un ricco aristocratico tedesco noto come signor Kingscourt, anglicizzazione del vero cognome Königshoff. Andarsene a vivere su un isola deserta dei mari del Sud, lontani dalle umane perfidie, è una valida alternativa al suicidio per entrambi gli eroi di questa storia, l’uno giovane, l’altro abbastanza avanti negli anni. Ci troviamo dinanzi alla versione riveduta e corretta del Robinson Crusoe, con questa differenza sostanziale: i due non sono naufraghi, ma migranti volontari adusi alla vita comoda del mondo civile. Viaggiano su un confortevole e lussuoso yacht, sull’isola condurranno un’esistenza tutt’altro che disagevole. Prima di partire Friedrich salva dall’indigenza e dall’inedia una famiglia ebrea, i Littwak, costituta da padre, madre e due figli, un maschio adolescente, David, e una femmina ancora in tenerissima età, Mirjam. Il ragazzo è sveglio, intelligente, di sani principi, sogna un futuro di felicità per i tanti ebrei indigenti e perseguitati sparsi per il mondo. Non c’è dubbio che questo personaggio sia il portavoce dell’autore.
Durante il viaggio d’andata verso l’isola, Löwenberg e Kingscourt sostano per alcun tempo in Palestina, le cui note caratterizzanti sono la povertà e l’estrema arretratezza. Ne fuggono inorriditi, ma vi fanno ritorno venti anni dopo, per quella che vorrebbe essere una sosta tecnica, in rotta a ritroso verso l’Europa. Siamo nel 1923. Sbarcano ad Haifa, dove si imbattono nientemeno che in David Littwak, divenuto nel frattempo uno degli esponenti più in vista di quella che viene definita la Nuova Società, un’entità non statale che accoglie Ebrei da tutto il mondo, in pacifica convivenza sia con gli Arabi che con le altre minoranze presenti in Palestina, meta di turismo internazionale e asilo di intellettuali e imprenditori ammirati per l’intraprendenza dei coloni. Ha inizio da questo momento una lunga serie di dialoghi nei quali David o altri suoi sodali rispondono alle domande di Kingscurt, con questi che riveste un po’ il ruolo del Simplicio galileiano o, se si vuole e in taluni passaggi, del Candido voltairiano, e gli altri che rispondono, con accenti didascalici, alla lunga sequela di domande dell’anziano gentiluomo. Le risposte, articolate quanto ingenuamente riduttive, servono a illustrare il progetto politico di Herzl e del suo Sionismo, una delle varianti dei Sionismi che prima e dopo di lui furono elaborati da altri promulgatori, tra i quali meritano d’essere ricordati i Kulturzionisten, il cui leader carismatico, Asher Ginzberg, proponeva la rinascita spirituale dell’Ebraismo, in termini religiosi, culturali, linguistici, riproducendo, secondo i suoi avversari, tra i quali un agguerrito Max Simon Nordau, la mera mentalità del ghetto, un apartheid alla rovescia - diremmo noi. Alcuni tratti del Sionismo culturale ritroveremo nel personaggio del dottor Geyer, il capo dell’opposizione politica nella Vecchia Nuova Terra, «… un maledetto religioso, un sobillatore, un aizzatore…» al quale, nell’immaginazione di Herzl, si oppone il gruppo maggioritario degli integrazionisti per i quali tutti hanno diritto di vivere in Palestina con pari dignità, Arabi inclusi, immigrati non Ebrei compresi.
La Nuova Società è dunque una comunità multietnica, plurilinguistica, multiculturale, interreligiosa priva di conflitti, se non quelli della battaglia politica: «Non siamo qui per eleggere un capo di Stato, – afferma il vecchio dottor Marcus, uno dei candidati alla massima carica della comunità – poiché noi non siamo uno Stato. Noi siamo una cooperativa con forme nuove…». Per farla breve, la Palestina immaginata da Herzl non è altro che una fetta d’Europa trapiantata nel Vicino Oriente, quasi ospite di una compagine statale molto più ampia qual era l’Impero Turco del tempo. Le terre colonizzate dagli Ebrei, nella finzione del romanzo, sono state acquistate e messe proficuamente a cultura, le industrie sono state impiantate con capitale internazionale, questo finalmente sedotto dall’operosità e dalle capacità imprenditoriali di un popolo eterogeneo che confida sulle proprie risorse e le valorizza, che crede fermamente e “positivisticamente” nel progresso, con l’ingenua convinzione che esso derivi dallo sviluppo.
Herzl con i suoi argomenti dimostra non solo il suo passato assimilazionista, ma anche la sua derivazione culturale europea. È un degno figlio dell’Europa occidentale e delle sue propaggini americane, come ben dimostra l’ottima Roberta Ascarelli nel breve saggio che pospone alla presente pubblicazione. Le ascendenze culturali e letterarie, le influenze e le fascinazioni sono tutte ben evidenziate dalla traduttrice. Non mancano, nella sua dissertazione, raffronti con autori affini, così come non omette di evidenziare le debolezze dell’opera insieme agli argomenti dei suoi critici. È forse la parte più interessante e più utile del volume.
Sul piano letterario Altneuland è probabilmente un mezzo fallimento, mancandole il mordente del vero Bildungsroman al quale viene assimilato per qualche somiglianza, neppure tanto implicita, al Wilhelm Meister di Goethe. Passi per la trama scarna e povera di sorprese; gli è che quello che dovrebbe essere il protagonista, il giovane Friedrich Löwenberg, che ritroviamo presto quarantenne nella seconda parte dell’opera, è figura scialba e scarsamente caratterizzata, non meno degli altri personaggi del libro. Sembrano proposizioni di un enunciato che si intende dimostrare, benché li si dichiari esprimere sentimenti e emozioni. Le donne sono stereotipi freddi e distanti, tanto da far sospettare un pizzico di misoginia nell’autore del libro, se non fosse che un certo puritanesimo misogino era caratterizzante, presso la piccola e media borghesia, l’epoca in cui il romanzo fu concepito e redatto, a dispetto dello spessore umano e psicologico delle grandi eroine della narrativa ottocentesca. Con un’espressione un po’ stantia si direbbe che le figure femminili di questo libro sono tutte casa e chiesa, benché le si pretenda emancipate e capaci di ricoprire incarichi di responsabilità nella società civile, in subordine, beninteso, al loro ruolo di madri e spose fedeli. Emma Bovary e Anna Karenina non troverebbero ricetto nella Vecchia Terra Nuova, una patria che, se non è perfetta, poco manca che lo diventi per tutto l’efficientismo del quale la si magnifica a ogni piè sospinto. Ci si prefigura un’umanità ideale che non è mai esistita, neppure in seno alla comunità ebraica, restando fermo il fatto che, proprio perché gli Ebrei non hanno nulla di più e nulla di meno degli altri, possono essere autentici gentiluomini o gentildonne, ma possono ugualmente essere dei farabutti.
Che l’opera fallisca il suo scopo primario lo riconosce lo stesso Herzl in una lettera del 10 marzo 1903 (la citazione è della Ascarelli): «Dal punto di vista artistico il libro non ha un grande valore, anche se mi è costato un grande impegno. Ma serve ottimamente a spiegare il tutto». Questo “tutto” altro non è che l’esposizione ad usum delphini delle argomentazioni contenute nel saggio del medesimo autore dal titolo fin troppo celebre, Der Judenstaat (Lo stato ebraico), pubblicato nel 1896 sull’onda del clamore suscitato dall’affaire Dreyfus. Mettendo da parte, ma non cancellando, le sue tradizionali posizioni assimilazioniste, Herzl vi propugna la migrazione programmata verso una terra in cui gli Ebrei possano vivere in pace senza dover subire persecuzioni e senza dover rinunciare alla loro identità. È questo il busillis, il tema scottante e per nulla risolto dell’identità: chi sono gli Ebrei e come li si identifica? Qual è il loro segno distintivo? A noi viene da rispondere che non esiste alcun segno distintivo, una circostanza che fa degli Ebrei uomini affini alla restante umanità. Hanno e avevano caratteristiche psicologiche, sociali, morali, culturali non dissimili dagli altri uomini, se si esclude che le coordinate storico-geografiche rendono difatti l’umanità articolata in gruppi più o meno omogenei con qualche differenza somatica di secondaria importanza che nulla toglie e nulla aggiunge alla sostanza. Herzl lo sa bene e lo dichiara senza esitazione fin dal saggio che dà vita al suo Sionismo: occorre prefigurarsi una società multietnica, multiculturale, interreligiosa perché i medesimi Ebrei vengono da luoghi assai distanti, parlano lingue diverse, hanno spesso acquisito la forma mentale della terra di provenienza, possono o meno seguire la religione dei padri. Sono dentro la Storia, cioè dentro un processo che crea differenze, ma queste differenze sono accidentali, non sostanziali. Ecco allora che la Vecchia Terra Nuova è abitata da un pot-pourri di esperienze storiche diverse, ciascuna delle quali rispetta l’altra e ne riconosce la legittimità. È un fortunato esperimento di integrazione tra culture diverse. È una favola, se volete, ma una favola lungimirante ben oltre la questione ebraica che intende affrontare. A cosa sono ridotti oggi i concetti ottocenteschi di patria, nazione, popolo, territorialità? Chi può affermare di avere una patria, se essa spesso rifiuta i propri cittadini e li costringe alla diaspora? Chi può dire di vivere nel posto in cui è nato? Cos’è un popolo quando le persone fisiche che lo costituiscono non godono degli stessi diritti e delle medesime opportunità? E, infine, di quale territorialità parliamo quando i confini geografici e politici sono agevolmente aggirati da Boeing supersonici che spostano milioni di persone al giorno in ogni parte del globo e se la globalizzazione, nel bene come nel male, crea interdipendenze tra popoli e nazioni prima inimmaginabili?
“Una d’arme, di lingua, d’altare/di memorie, di sangue e di cor”? A quale delle compagini della terra possiamo applicare il celebre distico manzoniano, frutto peraltro di una contingenza storica che aveva un senso in età romantica, ma che avrebbe avuto epigoni tutt’altro che confortanti nella seconda metà del XIX secolo? Guerre civili, babele linguistica, pluralità di credi, memorie scarse o addirittura assenti per via di un processo generalizzato di omologazione-alienazione, patrimoni genetici necessariamente confusi, sentimenti a dir poco contrastanti sono caratteristiche costanti del mondo di oggi. E non se se viene fuori se non si accetta l’ineludibilità del processo in atto. Tolleranza, convivenza pacifica tra diversi, integrazione tra culture non sono solo il sogno di Herzl, sono la necessità storica di oggi. Qualcuno ha una proposta diversa? Si faccia avanti!
Sembrerebbe che questo qualcuno sia l’attuale Israele, un paese affascinante indubitabilmente, ma anche pieno di stridenti contraddizioni. La modernità e la trasgressione convivono con un fondamentalismo intransigente che alimenta se stesso e la tremenda “guerra che non si può vincere”. È contraddittorio persino che un personaggio come Theodor Herzl sia, da un lato considerato una specie di nume tutelare di questo stato, dall’altro puntualmente tradito nelle intenzioni e nella attese. Sì, è vero, in Israele con la maggioranza giudaica convivono molte altre minorane. Ma in che condizioni? Quella di derelitti marginali e emarginati. Non contano, conta l’appartenenza alla stirpe eletta che detta le sue regole, anche quando queste regole sono le medesime degli avversari che si intendono combattere, derivano da una tradizione antica per la quale lo Shabbat deve per forza bloccare mezzo paese nella fornitura di servizi essenziali come i trasporti, il matrimonio civile non esiste e lo Yom Kippur costringe tutti, Ebrei e non, all’espiazione di colpe non commesse, con un intero paese che si trasforma in un deserto: nessuna macchina in giro, nessun mezzo di trasporto, nessun luogo di ristoro aperto, neppure per un bicchiere d’acqua. Altro che stato laico! Questa si chiama teocrazia, né più né meno di quella che vige in alcuni stati arabi fondamentalisti, che è stata, in Europa, il triste regime del Medioevo e della Controriforma, un sistema le cui prime vittime furono gli Ebrei stessi.
E che dire della politica demografica? Non ricorda quella dei persecutori di settant’anni fa? Pur di mantenere inalterate le proporzioni tra maggioranza ebrea e minoranza araba non si esita a inneggiare alla prolificità come panacea per la sicurezza nazionale: facciamo tanti figli, trasformiamoli in bei soldatini, mandiamoli al massacro della “guerra che non si può vincere”. Se non fosse che qui anche le donne (prodigi dell’emancipazione femminile!) fanno i soldati, sembrerebbe la rifioritura dell’antica Sparta, per non evocare ben più tristi e recenti militarismi. Per altri versi si favorisce l’immigrazione da ogni dove, spesso senza neppure verificare che vi sia la possibilità di accogliere i nuovi arrivati. Il più recente flusso migratorio è quello dai paesi della ex Unione Sovietica dopo il crollo del Comunismo. I Russi poi sono talmente tanti che sembra di trovarsi a Mosca o a San Pietroburgo. Sono gli eredi delle vittime dei tristemente noti pogrom, gli antesignani dei campi di sterminio sotto un’altra bandiera. Ma sono solo gli eredi, non le vittime vere. Non sono mica tutti brava gente. Israele ha importato la mafia russa, anzi ne è diventata l’ufficio di rappresentanza sul Mediterraneo. Con un punto d’appoggio così prestigioso e così “sicuro” il traffico mondiale di armi, droga, prostituzione e quant’altro è diventato molto più agevole per i veri nemici, non degli Ebrei soltanto, ma del genere umano. Sapete perché è così sicuro per il crimine? Perché Israele non si tocca, non si può toccare, altrimenti si è accusati di antisemitismo. Ma come ti permetti – dicono – di contestare la politica di un paese che accoglie i discendenti delle vittime della Shoah? Girate per Tel Aviv il sabato notte e vedrete coi vostri occhi chi sono questi rampolli. Come in tutte le grandi metropoli del mondo, la febbre del sabato sera contagia anche i giovani Israeliani di oggi e attira il turismo trasgressivo da ogni dove perché non mancano, non più, le possibilità di abbandonarsi alla sregolatezza e agli eccessi. Sembra di trovarsi a Las Vegas o ad Amsterdam, col vantaggio di godere di un clima più clemente.
Gli stessi ragazzini Israeliani li ritroverete, allineati e coperti, infagottati nelle divise militari, mitra in spalla, nei treni affollatissimi che li riportano a casa dopo il servizio o che vi si recano per prestarvelo, ai posti di blocco, all’aeroporto, alle frontiere, al fronte, presso le nuove colonie, dovunque, tanti, tanti diciottenni, maschi e femmine. Sono bellissimi! Chi scrive non ha mai visto tanta bellezza concentrata. Altro che le immagini oleografiche e caricaturali del nazismo! Corpi mozzafiato, nasini all’in su, biondi con gli occhi azzurri, mori con gli sguardi intensi, neri statuari, languidi volti orientali. C’è di tutto: sembra davvero la Vecchia Terra Nuova di Herzl. Ma ti viene tristezza a guardarli perché sai che tra di loro ci sono le future vittime del terrorismo e della “guerra che non si può vincere”. Quanti! Israele è un cimitero di morti giovani, giovanissimi o di mutilati già a vent’anni. Lì non c’è famiglia che non vanti una vittima o una tragedia di immane proporzione.
Intanto i prezzi lievitano e l’imposizione fiscale si inasprisce. Il grosso dei costi? La difesa, ovviamente, le armi. La gente si lamenta, è normale, quando può va a fare la spesa altrove, per risparmiare e far quadrare il bilancio familiare. Un tassista ci ha raccontato che, quando si reca a far visita a sua figlia in America, fa incetta di prodotti che possono tornargli utili: costano molto meno.
Quelli che hanno qualcosina da parte cominciano a tornare nei paesi di provenienza. Un buon numero di giovani se ne va a Berlino, dove gli è consentito il diritto di essere ebreo e, se vuole, può consentirsi le analoghe trasgressioni di Tel Aviv, ma con minor rischio di saltare in aria mentre sta ballando in discoteca.
Allora, abbiamo davvero trovato una patria ai perseguitati di un tempo? Si può dir patria la casa dei lutti, dello stato permanente di belligeranza e della qualità della vita ai limiti del sopportabile? Il turista che va solo sul lungomare di Tel Aviv e lì si ferma, non se ne accorge, non ci pensa, ma questo genere di turista è di solito superficiale e distratto. Gli bastano i locali alla moda, le discoteche eccentriche, gli alberghi lussuosi, gli stessi che troverebbe in qualsiasi altra grande città del mondo. Quello che gira, invece, per sapere e per capire, vede i villaggi abbandonati dai Palestinesi, vede il degrado dei quartieri poveri, vede la speculazione edilizia selvaggia che ha distrutto meravigliosi tratti di costa, vede l’inquinamento che ha reso i marciapiedi bituminosi, vede il labirinto claustrofobico dei nuovi insediamenti, vede il fondamentalismo che la fa da padrone e detta le regole per tutti; costui si rende conto che forse abbiamo reso un pessimo servigio agli Ebrei che vivono là. Israele è un grande ghetto in parte, ma solo in parte, dorato. Vi si vive una vita da reclusi, condizionati dalla farneticante ideologia del “sangue e del suolo” elaborato da quel romanticismo degenere contro il quale un ebreo “illuminato” come Victor Klemperer si scaglia con disgusto.
Le stirpi non esistono, sono l’invenzione allucinata dei frustrati. Hanno tutte in comune un passato mitico, vengono fatte derivare da dèi, eroi o superuomini di dubbia autenticità. Se di stirpe vogliamo parlare, ne esiste una sola ed è quella che ci fa derivare tutti dalla scarica elettrica che produsse i primi amminoacidi. La filogenesi dà qualche certezza, l’ontogenesi sciorina ipotesi indimostrabili.
Ecco quanto diceva già Dante a proposito delle stirpi:
«Sì che non dica quelli delli Uberti di Fiorenza, né quelli delli Visconti da Melano: ‘Perch'io sono di cotale schiatta, io sono nobile'; ché 'l divino seme non cade in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone; e, sì come di sotto si proverà, la stirpe non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe». (Dante, Convivio, trattato IV, paragrafo XX, capoverso 5).
Il cespite è unico e si diparte dallo stesso tronco. I paleontologi prima, gli storici poi provano a raccontarcelo.
Nella favola di Herzl è raccontata la campagna elettorale tra il partito di David Littwak, probabilmente un lettore del Convivio, e quello del dottor Geyer, che supponiamo lettore di Arthur de Gobineau. L’autore riferisce che a vincere la contesa sia il primo. Nella realtà storica è stato il secondo, almeno a giudicare da quanto un illustre Ebreo di cittadinanza italiana riferisce in una recente intervista rilasciata a Silvia Truzzi de “Il fatto quotidiano”. Di questa intervista, risalente al 5 novembre 2013, ci azzardiamo a riportare un passo. Quando la giornalista chiede a Moni Ovadia perché sia stato estromesso dalla comunità ebraica milanese, l’attore risponde:
«Per le mie posizioni critiche nei confronti del governo Netanyahu. Le violazioni del diritto internazionale, mi riferisco all’occupazione e alla colonizzazione dei territori palestinesi, durano da oltre cinquant’anni. Ho imparato dai profeti d’Israele che bisogna essere al fianco dell’oppresso. Io esprimo opinioni, non sono depositario di nessuna verità. Penso però che questa situazione sia tossica. Per i palestinesi, che sono le vittime, ma anche per gli israeliani: non c’è niente di più degradante che fare lo sbirro a un altro popolo. Aggiungo però che io m’informo esclusivamente da fonti israeliane. Non palestinesi: gli ultrà palestinesi sono i peggiori nemici della loro causa. Apprezzo molto due giornalisti israeliani di Haaretz, Gideon Levy e Amira Hass. Quello che dico io, rispetto a quello che scrivono loro, è moderato. Bene: vivono in Israele, scrivono su un quotidiano israeliano, sono letti da cittadini israeliani e pubblicati da un editore israeliano».
Sarà anche Ovadia un antisemita? Non sarebbe molto più sensato considerarlo un intellettuale che osserva, riflette e esprime “liberamente” le sue opinioni? Com’è giusto che sia, in qualsiasi paese libero!
Id: 761 Data: 06/12/2013 12:00:00
*
 Khaled Hosseini - Romanzo - Piemme
Khaled Hosseini - Romanzo - Piemme
E l’eco rispose
CHI SONO GLI ORCHI?
Somiglia all’orco delle nostre fiabe, quello più o meno topico di Gianbattista Basile o, ancor meglio, di Charles Perrault, probabilmente memoria ancestrale del tempo in cui i nostri antenati vivevano ancora sugli alberi e una delle loro maggiori preoccupazioni era difendere i cuccioli dai predatori. Il div di Hosseini sembra la sua versione afghana. Gli orchi sono mostruosi e mangiano i bambini, più o meno come la morte, che porta via le giovani vite quando la dissenteria imperversa, di solito con la canicola estiva. Un tempo, anche qui da noi, la mortalità infantile, nei periodi caldi dell’anno, raggiungeva livelli pandemici. Perdere un figlio era, ed è tuttavia in tante aree del globo, un danno economico di immane proporzione. Sono braccia da lavoro che si perdono, è l’assicurazione per la vecchiaia che è minacciata. Così si fanno quanti più figli possibile, certi che un buon numero di loro morirà prima ancora di conoscere le traversie della vita. I legami parentali e clanici sono fortissimi: garantiscono la sopravvivenza del gruppo, se non della specie in determinate aree geografiche. Quando muore un giovane, la sua famiglia viene ricompensata con i doni della comunità: cibo in prevalenza, una specie di risarcimento a quello che in prospettiva verrà a mancare per la scomparsa prematura di un suo potenziale produttore.
Le economie primitive generano ruoli e funzioni, stabili tra le generazioni, che agli occhi degli Occidentali di oggi, ormai abituati al proteismo sociale ed economico, sembrano catene. Sennonché essi stessi, gli Occidentali, hanno conosciuto tempi in cui il vincolo, il legame con la comunità di appartenenza era indiscutibile, quasi che un dio l’avesse imposto come norma universale. Le leggi che regolavano i rapporti sociali erano funzionali all’economia dei tempi in cui furono formulate e fatte passare come promananti da una divinità. La Shari’ah questo è: una maniera di intendere il diritto, fatta sì propria dai fondamentalismi islamici di oggi, ma storicamente ben nota, sia pure con altri nomi, all’Occidente civile, libero, ricco e tecnologico.
Per noi contemporanei, a partire dal Codice Napoleonico, è scontata l’idea che il diritto lo generino gli uomini in relazione alle necessità del momento storico. È nostro l’assunto che il diritto nasca vecchio, quasi a sottolineare la provvisorietà di una codificazione che sembra sempre in ritardo rispetto alle dinamiche storiche e sociali. Le nostre società hanno come nota caratterizzante un dinamismo che è addirittura frenetico rispetto alla capacità dei legislatori di prendere atto delle novità.
Ma il mondo non è omogeneo. La discrepanza tra ricchezza e povertà è tale per cui la frenesia appartiene a una minima parte della popolazione mondiale, se è vero che il due per cento degli adulti ne possiede il cinquanta per cento e che solo il dieci per cento dell’umanità usa e consuma l’ottantacinque per cento dei beni, il restante quindici per cento essendo appannaggio di tutti gli altri. Più le economie sono povere più generano forme organizzative statiche e, ai nostri occhi, claustrofobiche. Più le economie sono primitive più generano ignoranza e superstizione. I poveri non hanno né tempo né mezzi per istruirsi.
Noi Occidentali abbiamo una storia plurimillenaria i cui cultori sono uomini di scienza. I poveri hanno la memoria pre-scientifica del loro passato, tramandata per lo più oralmente di generazione in generazione, narrata la più parte da santoni e capi religiosi con una visione statica e teleologica della vicenda umana.
La contraddizione, per non dire il conflitto, scoppia di necessità. L’Afghanistan ne è diventato l’emblema per i fatti recenti della storia e della cronaca. Khaled Hosseini ce lo fa intendere a chiare lettere in questo splendilo libro, E l’eco rispose, pubblicato in Italia da Piemme nella traduzione di Isabella Vaj. Rivisitando d’acchito la rappresentazione mentale che noi abbiamo dell’orco, il div, e mettendone in discussione la presunta perfidia. Qui il male cela o potrebbe celare il bene, mentre ciò che sembra bene (si legga con attenzione il settimo capitolo e si rifletta molto) nasconde bellamente il volto orribile della schiavitù.
Le carte sono rimescolate, com’è giusto che sia, e le nostre tradizionali categorie mentali vanno in frantumi. Ecco, se dovessi dire cos’è questo libro, direi che è la nostra immagine riflessa in uno specchio andato in pezzi. Ce lo dimostra non solo la vicenda, ma anche la tecnica narrativa che, mutando ben nove volte di prospettiva, se non rappresenta a tutto tondo la nostra condizione presente, ce ne dà una raffigurazione plurima soddisfacente, almeno per quanti vogliono capire e che in un testo narrativo non colgono la mera fabula.
Dell’autore avevamo letto i due previi romanzi, Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli. Pare che quattro milioni di lettori italiani si siano commossi al racconto delle storie di Amir e Hassan, di Miriam e di Nana, con quel tanto di razzismo inconsapevole che interviene ogniqualvolta ci ergiamo a giudici di comportamenti e culture che ci paiono o sono ferini e primitivi, ignari talvolta di quanta ferinità e primitività sia insita nella nostra ignoranza, a dispetto delle tecnologie che ci fanno sentire sicuri e padroni del mondo. Ci siamo commossi anche noi e forse abbiamo commiserato le vittime di tanta miseria culturale e morale. Un po’ razzisti anche noi, dunque, per colti e informati che pretendiamo di essere. Ci consolava l’idea di essere tra i buoni del mondo.
Ora Hosseini ci smentisce e ci sputa in faccia la verità. Gli orchi siamo noi, benché non sia detto che siamo necessariamente cattivi. Un po’ ci assolve lo scrittore, se è vero che si è pienamente occidentalizzato e dell’Occidente va sempre più condividendo gli stili di vita e la mentalità. Fa parte di quel gruppo non esiguo di intellettuali che non ha dimenticato la propria origine e che vive un po’ ovunque nel mondo, concentrato per lo più tra Europa e Stati Uniti. La terribile frattura che apre il romanzo appartiene a tanti, ma appartiene anche a noi che, se non siamo migranti per necessità, lo siamo per scelta quando la patria che ci ha dato i natali ci sta stretta, come accade a quel Markos, di origini greche, che, nel libro, è il Deus ex machina dell’intera vicenda, ma anche il simbolo di una condizione che dissolve il dramma dell’Afghanistan nella farsa collettiva.
Mai, come col presente libro, abbiamo sentito tanto vicino questo paese. Ci appartiene esattamente come la nostra storia di popoli pretesi civili e progrediti. L’Afghanistan è lo specchio di tutto ciò che siamo stati e che siamo. In questo romanzo c’è la sintesi efficace della nostra Storia.
Hosseini giunge a un’opera davvero matura, nello stile, nella struttura, nella trama. Ci sentiamo di annoverarlo tra gli scrittori viventi più degni di attenzione e plauso.
Un’ultima notazione: i div hanno i connotati della diversità, perciò appaiono strani e sfuggenti, perciò vivono lontani dall’umano consesso. Non riescono ad accettare il conformismo rassicurante delle regole di convivenza, contingenti certamente, ma dai più percepite (Ah, la feroce indolenza dello spirito umano!) perenni. In tal senso, ciascuno di noi è un div, quando si pone senza veli dinanzi allo specchio della propria coscienza: diverso da tutti gli altri, solo dinanzi alle sue responsabilità. Siamo unici e questo ci spaventa. Così ci riconosciamo negli accidenti che ci accomunano. Finiamo con l’essere l’eco di una voce che non è la nostra.
Id: 760 Data: 12/11/2013 12:00:00
*
 Yoram Kaniuk - Narrativa - Giuntina
Yoram Kaniuk - Narrativa - Giuntina
1948
Il caso e la necessità
Ho appena finito di rileggerlo. Sono commosso e intriso da una paratassi mnesica, ai limiti del farfugliamento, che mi risuona nell’animo come una nenia malinconica. Le memorie dell’ottuagenario ex-combattente del Palmach sono un puzzle scomposto e allucinato, nei cui vuoti si insinua, feroce, una verità che pare menzogna. Mi sento triste, lo confesso. Reprimo un accenno di lacrime perché la razionalità, più che il pudore, mi dice che non bisogna piangere. Anche se certe cose le sento vive nel mio animo e la voglia di piangere è tanta, come quando avevo anch’io diciassette anni e il dolore degli altri mi stracciava il sorriso sulle labbra. Non ho pianto. Piangere non serve ad altro che a consolare il cuore affranto, non risolve i problemi. E poi io non ne ho colpa. Io, in quanto individuo, intendo, non in quanto cellula malata di una civiltà cinica e indifferente. No, non ho colpa, ma non ho mai saputo che fare per riscattare le colpe della mia genia. L’unica risposta che ho saputo dare è stata quella di sostenere qualcuno che ritenevo più bravo di me a sbrogliare l’intricata matassa. Nel mio paese, s’intende. L’ho votato. Mi ha puntualmente tradito. Ho puntato su qualche altro cavallo che reputavo vincente. Ho perso di nuovo. Che fare? È così, come vuole la laconica chiusura del bel romanzo di Yoram Kaniuk edito dalla Giuntina nella traduzione italiana di Elena Loewenthal.
Ora mi domando se 1948 avrà successo qui da noi e se i lettori premieranno questo specchio spregiudicato della nostra coscienza imbellettata, apposta imbellettata per sfuggire alla cognizione di sé. È tale il libro di Kaniuk, una spregiudicata analisi di coscienza, senza maquillage e senza fronzoli retorici. Una lingua asciutta, affilata, penetrante quanto quel proiettile che vaga nell’autoblindo a Bab el Wad, sulla strada che da Tel Aviv porta a Gerusalemme, e uccide due partigiani del Palmach, sotto gli occhi neppure tanto esterrefatti di Yoram che, non ancora diciottenne, ha già imparato della guerra molto più dei capi militari, lui soldato semplice, volontario di un conflitto il cui fine è fondare uno Stato per dei morti, come lo stesso autore afferma. Yoram non lo sa che sta fondando uno Stato, non sa neppure che cosa sia uno Stato, sa che vuole dare un posto in cui stare ai sopravvissuti alla Shoah, morti viventi raminghi per i mari, stipati su bagnarole che non trovano approdo da nessuna parte, dopo che la Gran Bretagna mandataria ha posto un veto armato alla massiccia immigrazione degli Ebrei perseguitati in terra di Palestina, dove non c’è uno Stato e dove gli Arabi sono maggioritari. Così gli Ebrei sono respinti da tutti, anche da quelli ai quali spetterebbe il compito di trarli in salvo dall’orrore, dando così ragione a Herr Goebbels il quale aveva detto che se gli ebrei erano così intelligenti e così dotati e suonavano così bene, come mai nessun paese li voleva.
L’autore non sapeva di fondare lo Stato di Ben Gurion, aveva militato in uno dei movimenti giovanili che sognavano un assetto binazionale per la terra di Palestina e in questo sogno di convivenza pacifica si crogiolava come ogni adolescente che si rispetti e che abbia maturato per tempo la coscienza dei tempi in cui gli è dato di vivere. Era un sabra e poco sapeva di Sionismo, anche se optando per la militanza nell’Hashomer Hatzair, dopo essere passato per l’Hamachanot Haolim, s’era convinto della possibilità di coabitazione tra Arabi ed Ebrei, a dispetto d’una guerra subdola che, fin dagli anni venti, aveva visto cadere, vittime di attentati, uomini e donne di entrambe le parti. Per lo più capri espiatori, come sono sempre gli innocenti obiettivi del terrorismo e delle guerriglie, i due modi più sporchi di condurre un conflitto di per sé sporco, perché guerre pulite non ne esistono da che mondo è mondo.
Me ne sono anch’io andato in giro per Tel Aviv, percorrendola in lungo e in largo. La città, oggi, non è più quella di cui narra Kaniuk; no, non lo è, forse perché, come dichiara egli stesso, i giovani non sanno o preferiscono non sapere, mentre gli adulti fondano la loro memoria sulla retorica nazionalista dei nuovi libri di storia con l’imprimatur. Via Ben Yehudah, la strada centralissima in cui abitava la famiglia Kaniuk, è ancora lì: ad ogni crocevia puoi vedere il mare, lo stesso in cui si smarriva lo sguardo del narratore sedicenne, con la testa confusa e l’eco altrettanto confusa di voci d’una Shoah i cui reticenti superstiti, i volti segnati dall’orrore, soli e spauriti, cominciavano ad aggirarsi sempre più numerosi in quest’appendice architettonica dell’Europa prebellica, mentre i nativi, i sabra, che non sapevano o sapevano poco o sapevano per sentito dire, avevano la vaga sensazione che qualcosa bisognasse fare, a dispetto della chiusura delle frontiere voluta dagli Inglesi fin dal Trentanove. Mi son sentito come lui, come Yoram a sedici anni, e mi sono detto che io, io medesimo, avrei agito allo stesso modo in cui agì lui: avrei tentato di difendere l’arabo innocente linciato da una folla inferocita e morto sotto i suoi occhi, la prima orribile morte in diretta alla quale lo scrittore abbia assistito; avrei ballato la hora vicino a un compagno senza nome diviso in due pezzi; avrei difeso la roccaforte di Quastel e avrei sparato a Abdel Khader al-Husseini, il mitico capo della Jihad di allora morto proprio in quell’occasione, per vincere, con un manipolo di ragazzini, una battaglia data per persa contro un esercito apparentemente bene armato e bene addestrato; avrei assistito, con malcerta freddezza, al dissanguamento di decine di ragazzi miei coetanei, zotici e incolti per lo più, contadini dei kibbutz, scaricanti di porto, simpatiche canaglie come Ari-Pseudonimo; avrei… qui ho tremato, ho tremato davvero dinanzi a una scena agghiacciante, l’acme crudele di una narrazione drammatica, che me ne ha evocate altre delle quali ho letto, delle quali ho visto foto e documenti d’epoca, delle quali il cinema mi ha restituito la copia in sedicesimo. Lo scenario era ovviamente diverso e poteva essere il campo di Auschwitz, di Sobibór o la via fangosa lungo la quale Eichmann sospingeva i suoi cinquantamila Ebrei ungheresi verso la soluzione finale, lasciandone per strada oltre la metà, ovviamente morti, ovviamente massacrati perché infermi o deboli come i bambini denutriti. Ma siamo in Palestina, nel villaggio arabo di Beit Yuba e qui il boia è un Ebreo. Kaniuk non ne rivela il nome, per buon gusto e per affetto, afferma, e lo chiama semplicemente N. Costui vede un compagno orrendamente mutilato, legato a un albero, con i genitali suoi propri in bocca. Il villaggio è quasi deserto, ma in una casa il cadavere di un arabo reca indosso la camicia verde del partigiano ebreo orrendamente mutilato. In casa vi sono anche due donne e un bambino. N. è accecato dall’ira. Uccide le due donne, inveisce con un pugnale sulla più giovane, la possibile genitrice della progenie assassina degli Arabi, intima a Yoram di sparare al bambino, sbeffeggia i suoi ideali di fratellanza; questi gli punta l’arma contro per indurlo a desistere dal folle proposito. Parte un colpo. Non si sa chi ha sparato. Colpisce a morte il bambino. Mi spiace dirlo, ma il Nazismo non avrebbe saputo fare di meglio. Si legga con attenzione il capitolo 12 e si capirà perché. Vi si trovano tutti gli ingredienti dell’umana barbarie: il fanatismo e l’intolleranza, la frustrazione e il nazionalismo ottuso, l’odio e il pregiudizio, il razzismo e la ferocia belluina d’un’umanità accecata dall’ancestrale legge del taglione nella versione aggiornata della rappresaglia. Funziona così, ha sempre funzionato così, ancor prima del Nazismo e della guerra arabo-israeliana del 1948. Scene analoghe sono in «Guerra e pace» di Tolstoj, benché vi si tratti d’altra vicenda bellica, d’altri tempi, d’altri campi di battaglia. Ho pensato che il giovane Yoram ben potrebb’essere il Pëtr Kirilovič Bezuchov dell’epopea tolstojana. In fondo i due libri, a parte la differente mole, si somigliano nella struttura, con scene di guerra che s’alternano a scene d’ordinaria quotidianità, non senza la postuma, densa e pregnante riflessione dell’autore.
Il Nazismo! Se lo si sfronda dei connotati storici, diventa una possibile dimensione dell’umano agire, un movente come un altro, quasi una necessità. I metodi del terrorismo dei due opposti fronti, ebreo e arabo, prima durante e dopo la guerra del Quarantotto, coincidono, con tutta la loro carica di ferocia indifferente al sangue delle vittime innocenti. La brutalità non s’arresta neppure davanti ai cadaveri, sui quali si continua a inveire con efferata cinica crudeltà. Così come la compiaciuta occupazione dei villaggi palestinesi, molti dei quali abitati da innocue famiglie arabe, con la massiccia nakba che ne consegue, ha poco o nulla da invidiare agli esodi forzati ai quali gli Ebrei medesimi sono stati costretti dalle SS hitleriane. È così! Le frange estreme del Sionismo e della sua ala militare, l’Irgun, sono state naziste e magari lo sono, nei sentimenti, i loro epigoni politici. Non si dimentichi che il famigerato gruppo Lehi (banda Stern) vide in Hitler un possibile interlocutore e ne auspicò l’alleanza nello stesso momento in cui questi faceva deportare e massacrare milioni di Ebrei.
Ha ragione Viktor Klemperer[1] quando, in un contestato capitolo del suo Taccuino, attribuisce al Nazismo influssi sionisti e sottolinea l’identica matrice culturale delle due ideologie[2]. Ora, tuttavia, mi viene voglia di infirmare anche questa ipotesi e d’essere assai più radicale. Nazista potenziale è ciascuno di noi per gli istinti belluini che si porta dentro. Certo, ce ne siamo spesso allontanati, elevandoci ad altezze vertiginose rispetto alle bestie che siamo stati. Ma bastano una serie di circostanze favorevoli, beninteso generate da noi medesimi come una ragna che ci imprigiona e che la stoltezza chiama destino o fato, per scivolare nella ferinità ancestrale. Disconosceteci il diritto d’essere quello che siamo, cancellate la nostra dignità, conduceteci alla disperazione della miseria materiale, negateci la possibilità d’aver cura dei nostri figli e dei nostri vecchi, massacrate la nostra famiglia, toglieteci la facoltà d’amare e vedrete che, prima o poi, tirerete fuori il Nazista che è in noi. Vi odieremo e la nostra sete di vendetta non sarà appagata fino a quanto non vi vedremo annegare nel vostro stesso sangue. L’odio genera se stesso e il sangue chiama altro sangue. È così! Si dice che l’occasione faccia l’uomo ladro, per necessità. Se non si presenta l’occasione, non vi sarà necessità alcuna. Se è vero che tutti siamo bestie, è altrettanto vero che ciascuno può diventare uomo. Una questione di scelta, non di destino.
È bello di verità questo libro di Yoram Kaniuk.
[1] Viktor Klemperer, LTI. La lingua del Terzo Reich – Taccuino di un filologo, pref. di Michele Ranchetti, 4a ed. riveduta e annotata a cura di Elke Fröhlich, Giuntina, 2011.
[2] Cfr. Antonio Piscitelli, La lingua del Terzo Reich… ecc., in Meridione, anno XII, numero 2-3, aprile-settembre 2012, Edizioni Scientifiche Italianee, pp. 393-405.
Id: 646 Data: 16/11/2012 12:00:00
*
 Carmela Cammarata - Romanzo - Del Vecchio Editore
Carmela Cammarata - Romanzo - Del Vecchio Editore
Quelle mani
Più che di romanzo si tratta di mitografia, non solo perché la protagonista sproloquiante, Zlata, ha una statura tragica che oscilla tra Giocasta e Medea, vale a dire tra incesto e infanticidio, ma anche e soprattutto perché è figura simbolica che conduce, senza indulgenza per chi legge o, nella finzione narrativa, per chi ascolta, all’archetipo del Male. È dunque opera esegetica questo bel libro di Carmela Cammarata, se è vero che denuncia le possibili modalità con cui la coscienza forgia se stessa e si giustifica. Non c’è azione o pensiero nella storia di Zlata che non trovi giustificazione nelle convenzioni di una nomologia appositamente elaborata per legittimare il crimine. Non è vero che non ci sia morale nell’agire di questa donna. C’è, è studiatamente formulata per coonestare il dato di fatto, teleologicamente utilitaristica e conservativa. Fondamentalista, in parole povere. Zlata è tutti noi. Rappresenta il cinismo stomachevole con cui, a salvaguardia della nostra integrità da predatori, poniamo le ragioni del bene comune di cui ci facciamo interpreti e propalatori, univocamente, senza neppure ascoltare le ragioni degli altri che, oggi, malauguratamente per fondamentalisti e integralisti, sono i più e che, prima o poi, sommergeranno in un bagno di sangue le nostre malefatte.
Non so se il bagno di sangue ci sarà davvero, ma temo che la pagheremo cara, se non noi, le future generazioni. Il personaggio di Farisa, la negra, s’allontana dalla scena dei crimini, migra altrove e partorisce altri figli, così come la Francese (alluderà all’Illuminismo?) porta in grembo il frutto della felicità. Non la nostra, tanto per essere franchi, quella degli “altri” che ci sostituiranno, con altre leggi, con diversa Storia.
Siamo alla frutta, sembra dire la Cammarata, con buona pace di chi resta ostinatamente legato a una Civiltà che non ha più nulla da esprimere. Troppe le falsità che abbiamo raccontato ai nostri figli, fino a rincitrullirli del tutto. Non abbiamo mai messo al mondo tanti scemi come nell’epoca presente. Una mano pietosa li seppellisce in giardino, pace all’anima loro!
Ciò che mi lascia perplesso della tesi di fondo, o almeno della interpretazione che no ho data, è l’indulgenza per il passato, rappresentato da quel padre Erminio che si rifiuta di assolvere Zlata, mentre il più giovane don Carlo lo fa, sia pure senza convinzione. Cosa vuol dire questo, che abbiamo avuto un passato “morale”, capace di distinguere il Bene dal Male? Lo studio della Storia sembra dirmi il contrario, se devo porre su uno dei piatti della bilancia la quantità di sangue e dolore delle vittime e sull’altro la levità con cui i carnefici hanno sempre vissuto nella maschera protettiva delle ipocrisie istituzionali. La morale è sempre stata giustificativa dei rapporti di potere, l’hanno imposta i vincitori.
Fatte salve le possibili deduzioni in senso contrario dei potenziali lettori della Cammarata, resta la qualità di un’opera nella quale, più che il testo, conta la struttura. Le voci narranti sono più d’una, in prima persona, anche se a spiccare è la lunga, estenuante e balzana logorrea della protagonista che, per molti versi, richiama alla memoria figure letterarie come la Tzia Bonaria di Michela Murgia o certe donne lucane della Mariolina Venezia di Mille anni che sto qui, tanto per citare produzioni recenti del panorama letterario italiano. Ma ancor più somigliante è questa Zlata alla Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio, della storia criminale del nostro paese, una donna dalla quale tanta ispirazione ha tratto il teatro e il cinema. È espressione, anche linguistica, della lucida follia con la quale si rivela un animo distorto dal pregiudizio, dalla superstizione, da una fede pre-confessionale e tuttora animistica che perdura nel paludamento della liturgia sacralizzante. Sembra Bene e invece è Male. Si santifica addirittura nel martirio, quale testimonianza di una verità che trascende il contingente e si propone come assoluta e immutabile. Va investigata con gli strumenti dell’antropologia e della psicanalisi, con progressivo divezzamento dalla natura diabolica dei moventi. Non c’è un diavolo che induca al Male, c’è la nostra sete di dominio, il nostro egoismo, il nostro essere vincitori. Il “diverso” è la negazione vivente della nostra verità, perciò va combattuto e, se possibile, eliminato dalla scena del mondo. Ecco spiegata la furia omicida di Zlata, sanguinaria non meno di tutti noi che operiamo il male, convinti, più che convinti, di essere nel giusto.
Mi piacciono le voci delle donne, sempre che non si commiserino troppo, mi piace la loro spregiudicatezza nell’eviscerare questioni che sono alla base della nostra autolegittimazione. Carmela Cammarata lo fa mirabilmente e per questo mi piace. Vi rendete conto che continuiamo a ripeterci, con maniacale insistenza, di essere i buoni, a dispetto e contro ogni evidenza che dimostra esattamente il contrario? Vi sorge mai il dubbio che il nostro filantropismo, che si dà l’alibi di aspirare alla felicità dei diseredati della terra, non sia altro che un modo di camuffare nuove forme di sfruttamento e colonialismo, per operare veri e propri genocidi culturali? No, non mi assolvo! Inclino alla speranza, come forse tenta di fare l’autrice di “Quelle mani” nelle ultime battute della Francese, ma non mi assolvo. E denuncio tutte le Zlata del mondo per crimini contro l’umanità.
Id: 578 Data: 12/06/2012 12:00:00
*
 Giuseppe Pititto - Romanzo - Fazi Editore
Giuseppe Pititto - Romanzo - Fazi Editore
Il grande corruttore
IN UN PAESE ORRIBILMENTE SPORCO
Agli amanti del genere dico subito che vale la pena leggerlo. Ma lo suggerisco anche a coloro che poco o nulla curano i thriller tutt’azione e poca letteratura. Sono veloci, riferiscono fatti, intessono dialoghi cinematografici, tengono desta l’attenzione del lettore dalla prima all’ultima battuta. Fanno il loro mestiere, insomma. Nascono per il mercato e al mercato sono rivolti, conoscendone la suscettività. Compaiono sovente ai vertici dei libri più venduti. Non sempre lo meritano, ma vi compaiono.
Non so se anche quest’opera prima di Giuseppe Pititto troverà estimatori, ma per certi versi lo auspicherei, non tanto perché le caratteristiche del buon thriller le ha quasi tutte, ma perché pone seri quesiti alla nostra coscienza. È un romanzo, come rivela d’acchito l’ammiccante copertina, ma è opera di un magistrato ancora in servizio, spesso titolare di inchieste scottanti che, per sua stessa ammissione, gli sono state sottratte con motivazioni pretestuose. Sembra di capire che le indagini gli sono state tolte perché, magari, lui, il Pititto inquirente, era assai prossimo ad accertare precise responsabilità, avocate o affidate a personaggi di mezza tacca più proni alle verità di Stato, che non coincidono esattamente con le nostre attese, di noi comuni cittadini che la giustizia la vorremmo, perché siamo brava gente, un po’ distratta forse, ma brava gente. Lui si è occupato delle indagini sul delitto di Ilaria Alpi e, puta caso, il suo racconto muove proprio dall’omicidio di una giornalista che sta per scoprire, ma in effetti non scopre un bel nulla, un colossale traffico d’armi dietro al quale c’è un ministro degli Interni, tal Ugo Miraglia, aspirante alla carica di Presidente della Repubblica. Nella finzione narrativa, è lui il grande corruttore di cui riferisce il titolo del libro.
Non vi sto rivelando il nome del colpevole perché questo compare a chiare lettere fin dalle prime battute. Tutta la narrazione ha intendimenti diversi. Non vuole farci scoprire la verità, ma mostrarci le losche manovre adoprate per occultarla. Un giallo alla rovescia, insomma, un resoconto spietato e senza sconti su come presumibilmente funziona la giustizia in Italia, se non addirittura il sistema paese in quanto tale, una roba, credetemi, da sentirvi contorcere le budella, da farvi desiderare di migrare altrove, come molti giovani già hanno fatto o stanno meditando di fare.
Come dite? Mi sto facendo prendere troppo la mano da un’opera di fantasia? Guardate che io in questo paese ci sono nato e ci vivo. È da che ho l’età della ragione che leggo sui giornali di trame e corruzione, di servizi segreti deviati, di tentativi golpisti, di attentati e omicidi impuniti, di strani giri di denaro, di P2 e P4, di magistrati e giornalisti spietatamente ammazzati, di inchieste affossate e chi più ne ha più ne metta. Non me le sono mica sognate queste cose! Non è forse di queste settimane la notizia che la corruzione ci costa 60 miliardi di euro l’anno e che, all’interno di paesi dell’Unione Europea, siamo ai primi posti in classifica? Non vi scoraggiate, amici cari, vedrete che prima o poi conquisteremo la palma del primato assoluto, almeno a livello europeo. Per i campionati mondiali dovrete attendere un poco, non siamo ancora bene addestrati. Forza Italia!
Ironia della sorte, ho letto il libro di Pititto subito dopo aver completato quello, di ben diverso genere e consistenza, che Pietro Grasso, il procuratore nazionale antimafia, in collaborazione con Enrico Bellavia, ha dato alle stampe per i tipi dell’editore Baldini Castoldi Dalai. S’intitola “Soldi sporchi”, fa esplicito riferimento a note inchieste giudiziarie, ci spiega papale papale come funziona il riciclaggio. È addirittura più semplice della pur disarmante semplicità con cui avviene la corruzione nella rappresentazione che ce ne dà Pititto. Armi a guerriglieri e terroristi in cambio di droga. Il ricavato della droga finisce su conti cifrati all’estero e, una volta ripulito, viene immesso sul mercato per altre losche manovre finanziarie e speculative, col beneplacito di banchieri, finanzieri, politici e magistrati. Persino del Vaticano, a quanto pare. Le armi, ovviamente, vengono utilizzate per ammazzare i nostri soldati in servizio all’estero. Il tutto con la splendida coreografia dei funerali di Stato ai quali le facce di bronzo dei nostri politici si presentano contrite e innocenti, chiaramente mantenendo il più stretto riserbo su chi produce le armi, a chi vengono vendute e con quali guadagni, visto che quelli che le usano contro di noi, mafiosi compresi, non le producono.
Allora mi vien da pensare che la vicenda che ci riferisce l’autore de “Il grande corruttore”, per inventata che sia, viene pur sempre da uno che di giustizia se ne intende, così lo scenario che ci rappresenta somiglia parecchio alla cronaca reale. La lingua adoperata è semplice e immediata, priva degli artifizi retorici propri di un testo letterario, addirittura scabra nella sintassi poco articolata, nell’eccesso di scene dialogate che certo non possono indulgere a funambolismi stilistici. Voluta tutta questa immediatezza, per colpirci e farci indignare? Lo penso, anche se non posso esserne certo. Ciò che leggerete, se ne avrete voglia, è agghiacciante: sete di potere, avidità, crudeltà e cinismo stomachevoli. Non sembra di essere nel bel paese dall’idioma gentil sonante e puro caro ad Alfieri, ma nell’aura sanza tempo tinta di dantesca memoria. C’è da soffocare. L’atmosfera è quasi sempre plumbea, fredda, piovosa, impregnata del puzzo di fumo di sigarette, pipe e sigari, una cosa da fare un baffo alle famigerate camere a gas.
Poche le pause rilassanti. Un capitolo ci mostra una bella Parigi autunnale, scenografia ideale d’una coppia “pulita” che si concede la fuga momentanea dalla melma patria. Si amano teneramente il giudice Davide Nucci e sua moglie Cinzia, ma faranno entrambi un brutta fine.
Poi c’è un corale commovente, quello della manifestazione studentesca di Roma, davanti a Palazzo dei Marescialli, sebbene anche in questa occasione Pititto non manchi di ricordarci chi siamo, ponendo sulla bocca di uno degli studenti la frase: «L’unica è farsi gli affari propri. Mio padre me lo dice sempre».
Probabilmente questo studente è nostro figlio, quello al quale ciascuno di noi insegna a chinare senza amore la testa, a non offendere anime privilegiate. Questo nostro figlio un giorno diventerà giornalista, ubbidirà ciecamente al suo direttore, che ubbidirà alla proprietà del giornale, che si piegherà al referente politico del momento. Così scriveva Pasolini:
Se fossero lì [le madri], mentre voi scrivete
Il vostro pezzo, conformisti e barocchi,
o lo passate a redattori rotti
a ogni compromesso, capirebbero chi siete?
Sembra il ritratto dei giornalisti di Pititto, eppure la lirica è vecchia di parecchi lustri. Così penso che il mio paese è malato da sempre, è nato malato d‘ignavia e cieca avidità. E sogno di andarmene, di lasciarlo marcire e morire nella sua stessa melma. Potrei chiedere asilo politico a qualche altra nazione. Non so perché, mi viene in mente la Finlandia. Non l’ho mai visitata, ma mi hanno detto che vi si respira un’aria così fine da dare le vertigini. Se è così, ci vado. Ho tanto bisogno di una boccata d’ossigeno!
Id: 562 Data: 10/04/2012 12:00:00
*
 Francesco Prisco - Romanzo - Guida Editori
Francesco Prisco - Romanzo - Guida Editori
Bomba Carta
IL LIBRO “BOMBA”
SUL MERCATO DELL’EDITORIA NOSTRANA
Vien subito in mente don Ciccio Ingravallo, il commissario del “Pasticciaccio” di Gadda, tanto per trovare il prototipo di questo Gaetano Santaniello, epigono, ma anche un po’ emulo del ben più noto predecessore. È lui, il Santaniello, a condurre le indagini su una serie di atti terroristici che l’Accolita Scrittori Anonimi (in acronimo LASA) mette a punto contro i personaggi simbolo del mondo dell’editoria, del giornalismo, della televisione, in pratica contro i padroni dell’informazione. Tutti assimilabili a reali personaggi pubblici, ben riconoscibili dietro la maschera di cognomi artatamente ammiccanti a qualche caratteristica degli originali.
Si tratta della versione romanzata de “La casta”, ma con la marcia in più d’una scrittura che, nel contaminare stili, si fa stile in proprio, allo stesso modo in cui un musicista nella combinazione di toni e semitoni, di tempi e pause afferenti crea l’originalità dello stile personale.
Bello, dunque, questo «Bomba carta» che Francesco Prisco ha pubblicato per l’editore Guida. La quarta di copertina lo definisce un noir, ma gli fa torto perché il colore nero poco si addice a un’opera che, per molti versi, è policroma, nell’intreccio, nelle variazioni tonali, nella felice contaminazione dei registri, nella caratterizzazione dei personaggi. Questi, coi loro tic, i loro vezzi, le loro parlate regionali, alludono all’illustre tradizione italica degli Zanni, tranne poi deludere le aspettative del lettore, perché da comici si fanno grotteschi, tragici nell’epilogo della vicenda narrata. Sì, perché l’umorismo iniziale evolve in satira feroce, poi in sdegnosa denuncia di un male che corrode dal di dentro il sistema democratico e ne narcotizza le coscienze critiche: lo sciocchezzaio banalizzante dei mezzi di comunicazione diventa la nostra coscienza, ci mette in testa i pensieri, in bocca le parole. Mai omologazione è stata più consona al Potere. È una sindrome di Stoccolma casereccia, con noi tutti beceri complici delle sentinelle della libertà di pensiero e espressione, beninteso una libertà condizionata, assai condizionata. Così l’industria della carta stampata, alla quale il titolo del libro allude, in combutta strategica con le reti televisive consociate, produce pennivendoli piuttosto che scrittori, imbonitori da strapazzo invece di giornalisti, opinionisti scemi quale degenerazione triviale delle menti pensanti. E rissa, null’altro che rissa infeconda.
Questo il senso di un’operazione letteraria che, per altri versi, mantiene l’autonomia del fatto in sé, vale a dire del romanzo fantapolitico ben scritto a vantaggio dei buongustai. Di questo si tratta soprattutto, di un’operazione d’alta cucina che, dosando opportunamente ingredienti vari, serve una pietanza affatto nuova e originale. Prisco è un sapiente alchimista della parola, costruisce pagine di intensa bellezza con materiale estrapolato dal bombardamento quotidiano del chiacchiericcio televisivo e dell’eloquio giornalistico, intinti, spesso senza soluzione di continuità, nel motto plebeo, nell’icasticità della parlata regionale, nel turpiloquio ben dosato e per nulla disturbante. L’allusione a Gadda è dunque un obbligo, benché occorra dire che il richiamo allo scrittore milanese è solo nell’identica capacità di coniare il mezzo linguistico e di calarlo nella materia, quasi a volerle inalare l’alito vitale. Così la vicenda narrata acquista dinamicità e colore nell’esplosività di una lingua creata di sana pianta e plasmata ad arte sulla psicologia dei personaggi. A volte basta una semplice battuta a darti intero il ritratto di un poliziotto, di un uomo di cultura, di uno studente universitario o a restituirti un’atmosfera, un ambiente, una forma mentis. Si vedano gli assolo dei personaggi o la splendida concertazione dei duetti, dei quartetti e persino di quel coro polifonico che è la mimesi di un talkshow televisivo e si capirà cosa intendo.
«Bomba carta» fa ridere, sicuramente, benché talvolta la risata si faccia amara e preluda al corruccio, a tratti commuove persino, quando questo o quel personaggio si accorge di non essere altro che un’impotente marionetta stritolata dai poteri occulti, quelli veri, quelli che conducono il gioco. Così Cristiano e Marta, che non hanno neppure il diritto di amarsi, così l’intellettuale Palanca e il mitomane Fabbri, così persino i tutori dell’ordine Gaetano Santaniello e Alberto Stefanelli, patetici questi nella loro pretesa di salvaguardare l’ordine democratico a discapito del garantismo giuridico. Allora il quadro ti si completa davanti agli occhi quando capisci che il cinismo dei grandi decisori, nonché manovratori del complesso marchingegno, non esita a sacrificare i suoi uomini se sono in gioco gli interessi della casta.
Lo scenario sembra quello dei turbolenti anni di piombo, con la differenza che il dissenso, questa volta, pare assai funzionale al Sistema, se non ne è la legittimazione pseudo-tautologica del genere L'état, c'est moi. Qui l’opposizione sembra provenire da infervorati intellettuali militanti, ai quali rispondono per le rime quelli organici, in un botta e risposta del quale è difficile prevedere gli esiti. Provate a indovinare chi vincerà e con quale vantaggio. Sono aperte le scommesse.
Quanto a me, punto su Francesco Prisco e sul suo bel libro. Se i grandi media avessero l’umiltà e il coraggio di dedicargli un poco d’attenzione, forse griderebbero al caso letterario. Ma dovrebbero essere masochisti e dubito seriamente che lo siano.
Id: 523 Data: 09/03/2012 12:00:00
*
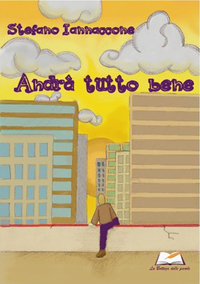 Stefano Iannaccone - Romanzo - La Bottega delle parole
Stefano Iannaccone - Romanzo - La Bottega delle parole
Andrà tutto bene
AVVERTENZA PER I LETTORI DI QUESTE NOTE
La casa editrice “La bottega delle parole” è al suo primo titolo. Un titolo, ritengo, di tutto rispetto. Sono tutti giovani quelli che stanno tentando l’avventura editoriale. Occorre fare due cose: sostenerli e farli conoscere. È il solo modo che abbiamo, noi comuni lettori, per incoraggiare i nostri ragazzi, al di fuori e a dispetto delle false mediazioni del mondo politico. Consiglio di non demordere dinanzi alla difficoltà di reperire il libro che suggerisco. La distribuzione è scarsa, se non inesistente. Insistete e sarete ben ricompensati da una buona lettura.
«Conoscersi è riconoscersi»
Avete mai visto le lastre di una tomografia computerizzata? Se la direttrice di investigazione è il piano assiale, il nostro corpo vi è ridotto in tante fette, né più né meno che un salame. La direttrice coronale, invece, ci riduce a piatte lamine fronto-dorsali il cui piano mediano disegna perfettamente la sagoma del nostro corpo, più o meno alla maniera dell’uomo vitruviano. La terza direttrice è quella detta sagittale, da destra a sinistra. Se il tutto viene affidato a un apposito software, questo ti ricompatta in 3D e tu ti ritrovi integro, ma violato nei più intimi recessi. Ci guardano dentro, dalle tre possibili dimensioni, beninteso per scopi diagnostici. E tuttavia, prima che scienza e tecnologia arrivassero a tutto questo, vi è arrivata l’arte figurativa, nella fattispecie di quel cubismo analitico che, scomponendo la prospettiva, ha rivelato la faccia nascosta delle cose.
Ecco, se dovessi trovare il prototipo del bel romanzo che Stefano Iannaccone pubblica per “La bottega delle parole”, direi che ci troviamo dinanzi alla versione letteraria della pittura cubista, rivisitata alla luce dell’intenso dibattito letterario del XX secolo. Solo che, nel nostro caso, non si scompone la realtà fenomenica, ma si scandagliano sentimenti e emozioni, segnatamente quella cosa complessa che chiamiamo amore. L’opera, tecnicamente, si presenta come un’enunciazione a più voci e dunque una scomposizione della prospettiva. C’è, ovviamente, il punto di vista dell’autore insito in una sensibilità estetica che negli intercalari, nelle iterazioni, nella sintassi scarna sa farsi stile funzionale all’universo giovanile che intende rappresentare, tranne poi affluire a pagine di elevata grazia e raffinatezza via via la narrazione procede. Costruisce immagini e atmosfere, direi, brillantemente, tanto da darti l’impressione che l’universo dei trentenni ti si componga davanti agli occhi, benché non sia mai veramente descritto o introdotto. C’è poi una voce narrante, quella del protagonista Marco, che in realtà è duplice perché, mentre si racconta, dà dritte al lettore nella forma della “excusatio non petita”, retorica perché, a legger bene, sembra più una perorazione finalizzata a intenerire il lettore preteso fuggitivo dagli “stralci di vita” dello sfigato locutore. Dice questo, in buona sostanza: «Caro lettore, ti consiglio di non leggermi, se non vuoi essere trasformato in una statua di sale». Fin dai tempi biblici, quando voi ponete un divieto del genere, invitate a nozze. Non otterreste lo stesso risultato se, invece di vietare, costringeste. È chiaro che noi ce ne freghiamo dei suggerimenti del narratore e proseguiamo, ben consapevoli delle conseguenze. Sono millenni che diventiamo di sale e non sarà certo un artifizio retorico a farci demordere. Per fortuna, visto che vale proprio la pena andare fino in fondo.
A imbrogliare la matassa si mette la seconda voce narrante, quella di Fabiana, la quale si racconta e intanto dice di Marco. Si tratta prevalentemente di flash back ad avvicinamento progressivo. Sul finale i due co-protagonisti si specchiano a distanza, in contemporanea: siamo all’oggi narrativo, che ovviamente chiude il libro, non la vicenda. A queste due voci dovete aggiungere quelle di altri personaggi minori, i quali s’esprimono con lettere, biglietti, sms o con l’immediatezza del dialogato. Infine ci siamo noi, col nostro bagaglio di conoscenze e esperienze, che dobbiamo godere del racconto e della sua resa letteraria. Iannaccone è molto preciso, ci lancia segnali inequivocabili. I font cambiano col mutare della prospettiva.
Fin qui la tecnica. Ma qual è la materia? Uno sguardo di superficie ci farebbe dire che il tema di fondo è la condizione variamente instabile dei trentenni di oggi. Così ci inducono a credere le poche note editoriali. Non è così. A dispetto delle apparenze, il tema non è d’attualità, ma di condizione. È pur vero che le coordinate spazio-temporali rendono la vicenda prossima a noi e all’esperienza dei nostri giovani universitari e post-universitari, disoccupati, sottoccupati o precari che siano. Il tema, direi, è ricorrente, nel cinema, nelle inchieste giornalistiche, nelle opere letterarie di recente produzione. Il che farebbe del romanzo di Iannaccone la pedissequa riproposizione di una solfa noiosa. Ma il libro non annoia, non solo perché lo stile dell’autore è fascinoso, ma perché attinge a motivazioni che vanno ben oltre il fatto storico contingente. Qui è in gioco il tema dell’identità, un tema che attanaglia le menti pensanti da quando l’uomo si è ricavato un po’ di tempo per riflettere. Chi sono io?
Fa tenerezza la figura di Marco che si sente come qualcun altro. Che so, come Robin Williams, Brad Pitt, Edward Norton, Kevin Spacey in tale o talaltro film che vede protagonisti questi attori. Sottolineerei che il meccanismo di identificazione, di tipo proiettivo, fa riferimento non al personaggio di una vicenda, ma all’attore che l’interpreta. Significa che Marco più che vivere la vita, la mima, ne recita il copione. Lo dimostra la continua previsione delle battute che vengono puntualmente ripetute nelle scene dialogate, esattamente nei toni e con le parole della prefigurazione. Il meccanismo psicologico della proiezione (Sono Batman. Sono Superman. Sono Spiderman) è tipico di una fase della vita in cui si è fortemente in cerca della propria identità. Di solito questa fase coincide con l’adolescenza, ma non è detto che finisca con essa. Così Marco, nella percezione di noi lettori, di Fabiana, di qualche suo amico e fors’anche di sua madre, pare un adolescente. L’anomalia d’ordine congiunturale sta proprio in questo, nel protrarsi dell’adolescenza fino alla soglia dei trent’anni. Per il resto, Marco ci rappresenta tutti, a prescindere dalla condizione o dall’età anagrafica. Non è un romanzo rivolto ai giovani, ma a tutti, per motivi che vanno ben oltre queste brevi note. Chi siamo?
Iannaccone la risposta ce la dà, proprio nell’ultima pagina. Parrà pure scontata, visto che probabilmente ce la diamo noi medesimi prima che il libro si chiuda. E tuttavia è densa di significato e di conseguenze. È l’unica possibilità che abbiamo per poter dire che “andrà tutto bene”, benché le circostanze paiano avverse.
Ne è prova proprio questo bel romanzo, opera prima di un giovane dal promettente futuro, una felice novità delle lettere italiane. Io so, ma non ho lo spazio per dimostrarlo, che le energie, intellettuali, morali, civili, si sprigionano quanto più i tempi sono avversi, quanto più le circostanze le imbrigliano. Abbiamo toccato il fondo? Sì, lo abbiamo toccato. Ora non possiamo che risalire. Scrittori come Iannaccone ce lo dimostrano. Andrà tutto bene!
Id: 518 Data: 17/02/2012 12:00:00
*
 Miriam Rebhun - Narrativa - l’ancora del mediterraneo
Miriam Rebhun - Narrativa - l’ancora del mediterraneo
Ho inciampato e non mi sono fatta male
Stolperstein, in tedesco, è la pietra smossa del selciato, quella in cui si può inciampare. A questa parola fa riferimento il titolo che Miriam Rebhun ha voluto dare al suo libro. Un racconto denso di memorie, alle quali si intreccia la cronaca di un percorso di vita, mutila fino a un certo punto, fino a quando, seguendo l’esile filo di Arianna della frammentaria documentazione in suo possesso, l’autrice ripercorre a ritroso le tappe di un’identità in parte smarrita, in parte volutamente rimossa. Miriam sa poco o nulla del ramo paterno della sua famiglia. Non ha mai conosciuto il padre, ucciso a Haifa nel 1948, mentre in autobus si recava al lavoro, da un cecchino. Si chiamava Heinz. Nato a Berlino nel 1918, col fratello gemello Kurt (Gughy) approda in Palestina nel 1936, per sfuggire alle leggi razziali. Posti al sicuro dalla persecuzione nazista, i gemelli Rebhun troveranno entrambi la morte lì, nella patria che i sopravvissuti alla Shoah stanno cercando di darsi, entrambi vittime della guerra che da oltre sessant’anni oppone Israeliani e Palestinesi. Giovanissimi ambedue, ciascuno con moglie e figli.
Nel 1943 Heinz è volontario della Brigata ebraica che risale la penisola italiana al seguito delle truppe anglo-americane. Di stanza a Napoli, presso la piccola comunità della città conosce Luciana Gallichi, una bella ragazza di antica famiglia sefardita. La sposa nel dopoguerra. Dal matrimonio nasce Miriam. La famigliola così composta si trasferisce a Haifa. Poi la tragedia che costringe Luciana e la sua bambina a far ritorno alla città d’origine. Qui la piccola cresce nel clima di serenità e speranza del secondo dopoguerra, protetta dall’amore di una madre che tenta di risparmiarle la pena che porta nel cuore. In parte vi riesce. Il racconto degli anni dell’adolescenza è dolce, ha toni lirici di inusitata grazia. Vi ritrovi la vitalità chiassosa di una Napoli ingenua dove giovani studenti di liceo si incontrano, discutono, ballano al ritmo yè-yè, vivono le loro prime storie d’amore, tenere storie di ragazzi che guardano speranzosi al futuro. Miriam incontra Marco, il fidanzato che sposerà assai presto e dal quale avrà due figlie. Poi la vita di una famiglia che, a motivo dei numerosi parenti in entrambi i rami, diventa una piccola comunità d’affetti, mista, secondo uno spontaneo sentimento assimilazionista che sembra negare nei fatti la discriminazione.
Negli anni della prima maturità Miriam, testimone di seconda generazione com’ella stessa afferma, sente il bisogno impellente di recuperare la parte mancante di sé, quella che affonda le radici nel ramo berlinese della famiglia e in una delle tante tessere del mosaico d’orrori che ha segnato la vicenda degli Ebrei prima, durante e dopo il Nazismo. I nonni paterni, Frida Josephy e Leopold Rebhun, sono il suo cruccio. Nel 1934 hanno messo in salvo i loro unici due figli, non se stessi. Loro sono rimasti lì, a Berlino, a subire l’oltraggio di un regime che, nel puntare l’indice sugli Ebrei, mostrò di avere in odio l’umanità nella sua interezza, azzerò per qualche tempo la Civiltà, attinse alla furia caotica e selvaggia d’una natura preferina che nulla sa e nulla concede alla pietà.
Frida e Leopold non erano che dei nomi, privi di storia e identità, sconosciuti come la più parte delle vittime della mattanza nazista. Grazie alle amorose e puntigliose investigazioni di Miriam, oggi la loro vicenda è un po’ più nota e può ancora parlare ai nostri cuori di reduci dalla più feroce frattura della Storia.
Il libro di Miriam Rebhun non è solo atto di risarcimento e di giustizia postuma, ma anche lezione di umanità per quanti vi si avvicinano con l’animo di goderne la straordinaria forza di gusto e espressione. Da leggere, assolutamente da leggere, tutto d’un fiato. Sì, perché la prosa dell’autrice non transige: si insinua nella coscienza come una lama sottile e ne penetra i recessi. Ha la dolcezza di una carezza che avvolge e protegge, anche quando si fa sentenziosa, soprattutto quando, quasi con tecnica da romanzo poliziesco, coinvolge nell’intricata matassa che ha il suo bravo bandolo nella città di Napoli, infine cuore pulsante d’un’umanità che la cronaca sanguinaria degli anni recenti fa sembrare irrimediabilmente smarrita. La prosa della Rebhun sa farsi scarna e essenziale quando dice della solidarietà dei tanti che, col pudore dei “giusti”, hanno salvato gli Ebrei dalle grinfie delle leggi razziali e dall’orrore dei campi di sterminio.
Spesso mi sono chiesto, non senza sgomento: da che parte sarei stato se fossi nato quarant’anni prima. Ora lo so, dopo aver letto il libro di Miriam Rebhun lo so, senza remissione.
Id: 492 Data: 20/01/2012 12:00:00