chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Maria Musik
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
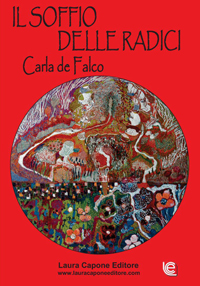 Carla de Falco - Poesia - Laura Capone Editore
Carla de Falco - Poesia - Laura Capone Editore
Il soffio delle radici
Il Soffio delle Radici è la prima silloge poetica di Carla de Falco ed ha, recentemente, vinto l'Alexandria Scriptori Festival, patrocinato, tra gli altri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal salone Internazionale del Libro di Torino.
Prima ancora di iniziare a leggere, troviamo la citazione “Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'.” Charles Bukowski. Storie di ordinaria follia, 1972.
Sembra che l’autrice, prima ancora di “aprirci la porta”, voglia avvertirci su quella che è la sua scelta di campo. Che, poi, il messaggio sia affidato a Buk, è un altro indizio o, forse, indicazione. Non troveremo un versificare aulico, il rigido rispetto della metrica o di questa o quella scuola di “metrica” ma il bisogno di dire molto, forse, di dirsi molto racchiudendolo nei brevi lampi poetici di chi è ossessionato dal bisogno quasi carnale di scrivere, di scriversi.
Così entriamo nell’astrolabio recto di Carla de Falco: quattro partizioni, la sfera celeste “appiattita” sul piano dell’equatore ed il “punto di vista” posto a sud. Le emozioni muovono il regolo che, spostandosi da un quadrante all’altro, permette di misurare le altezze, le ascensioni, le posizioni ed i tempi. Il tutto contenuto nel cerchio.
Nel darci il benvenuto, la poetessa ci avverte che questo non è un punto di arrivo, terra sacra sulla quale erigere un tempio vuoto ma piuttosto un non luogo dove fermarsi per rinfrancare la voglia della ripartenza.
Il primo “quadrante” (che dà il nome al libro), ospita le origini, il loro incessante alitare sul fuoco divampante dell’emozione che si fa parola. Ma di soffio si tratta: sacro e vivificante ma, al contempo, sussurro. Il ricordo della terra natia, del latte che stilla dalle mandorle della terra calabra, dell’insegnamento che viene dal mare che paternamente ammonisce, insegna l’orgoglio del “non appartenere”, la forza dell’indignazione, l’incantesimo della poesia che risiede nel “lasciarsi solcare” custodendo, però, il segreto dell’abisso. Ma le radici sono conficcate anche nella lavica terra campana che ha disegnata, con tinte forti, la tela di Carla de Falco. Ci sono i profumi, il vulcano, il mediterraneo, Secondegliano ma tutto sfuma nel soffio che impedisce alla parola di farsi cartolina o manifesto. A questa sezione appartiene anche la poesia ksar ghilane che conduce il lettore ancora più a sud, nella notte di un’area desertica in Tunisia. Il tema del viaggio ed il ricordo della notte e dell’alba africane sono, forse, simboli del “nomadismo interiore” di chi riconosce le proprie radici ma non appartiene alla terra. Questo testo è denso di immagini che, grazie a rapide pennellate di nero (serpenti/radici ai piedi), arancione, oro, viola e rosa, ci rappresentano il luogo, il trascorrere delle ore (di nuovo, quadranti solari che ci lasciano scivolare dalla notte sino all’aurora), i rapidi passaggi climatici. Ma la conclusione è affidata al suono, quello dei tamburi che, cardiacamente battendo, accompagnano l’ingresso di un nuovo mattino.
Il secondo cadran solaire, emozioni al confine, ci lascia esplorare con la poetessa il profondo sentire la vita, soffrirla senza mai, però, mai smettere di scrutare l’orizzonte e “nuovi volti al confine”. Questo è il luogo dei sentimenti più profondi, delle “persone cardine”, degli incontri che segnano. L’amore, la passione, il legame con la madre, la maternità, l’amicizia sono temi “comuni” ai poeti perché i poeti raccontano il sé e l’altro e Carla non si sottrae ma li affronta a modo suo, senza maiuscole, inseriti in un quotidiano che, da solo, basta a rendere grandi le emozioni. Ma è anche luogo dell’autocoscienza.
“è tempo per me di riscrivere miti
di prendere a sorsi dal thermos la vita
incrociare con grazia braccia argento alla luce
scrutare non vista nuovi volti al confine.
e questo arditissimo viaggio in salita
percorrere a passo leggero di marcia
senza mappe né esatte speranze
accettando fiatone e chili di troppo
affidando alla sorte non georeferenziata
ogni sogno raggiunto o vetta scalata.”
Ed in questo percorso di risveglio e di veglia, colpisce il dialogo/monologo con la madre, alla quale la poetessa affida, come fosse la sua luna, le domande che già si fanno risposta. L’invettiva non è rivolta alla natura ma alla storia, ad una società barbara e bruta. E tutta la rabbia si scioglie nell’amore che scaturisce dal presagio del distacco che non dovrebbe abbandonare il figlio ad un cielo capovolto, che s’esprime nella violenza del verso che accusa pur contenendo il desiderio, trattenuto dalla necessità della denuncia, di offrire il tenero conforto cha accarezza.
La chiusa di questa seconda sezione è straziante e coraggiosa, affidata al commiato per un’amica. L’autrice non usa eufemismi e verga, senza temere, la parola cancro. E l’omaggio, il più bello che rende all’amica prematuramente scomparsa, è racchiuso negli ultimi versi.
“e nelle radici della mia mente muta
da allora non ho mai più trovato
il senso del futuro senza lotta
o l’idea stessa d’essere arrivata.”
Ed eccoci, con “la fiamma del canto”, al passaggio nel terzo quadrante. Qui, senza se e senza ma, ci si confronta con la poesia, quella di Carla de Falco.
Impossibile non citare nessuno pseudonimo ammesso e aveva ragione ciarlz bucoschi: in prima persona, quasi con orgoglio e senza pudore, dichiarano la necessità del verso, descrivono la poesia come un istinto animale al quale è impossibile sottrarsi, un’ossessione che rende insensibili alla sete, al bisogno di sonno, alle “sane abitudini”.
Ma questa “malattia” dello scrivere, peggio, del versificare che pone il Poeta come portatore di una parola che mette in connessione le umane sfere e le celesti, non trova riconoscimenti né spazi adeguati al volo. Così, già dal gioco di parole del titolo, “intellectu ali”, parte l’amara riflessione sul disconoscimento.
“prima fu l’albatros ferito e goffo
poi è stato il falco alto levato
mò c’hanno preso per un piccionaccio
sporco, grigio ed indesiderato
dannoso nel produrre quel suo guano
che campa d’aria e bricie di granone
e scampa al dissuasore ed al pestone.
...”
Ed è un altro gioco di parole, abissi per versi, che ci spinge a solcare l’ultima partitura del cerchio. In questa ultima sezione, la poetessa sembra voglia “disubbidire” al salmastro padre e palesare parte del mistero, non più “attenta a non svelar l’abisso”. Ma lo fa in versi e, quindi, esprime/manifesta ma il segreto rimane tale così come il dovere di ciascuno di trovare il suo buio.
Il buio e la notte sono protagonisti di questa sezione.
E’ il Vespero che porta la luce, Lucifero/Venere, che vive nella notte ed è l’ultima a scomparire sul far del giorno. La morte del poeta si compie, anch’essa, “una notte” a causa del dolore altrui. Ed è sempre nel buio che soccorre la sera che si sperimenta la stanca impotenza.
“...
nel paltò sfoderato della notte
un bottone ciondola svogliato.
sono io che non ho ago
né ho fiato
per imbastire orli e piegature
...”
Ed al buio è “dedicata” l’efficace “il ladro silenzioso della vista”, a questo stato di assenza che permette di toccare il tutto tondo, che pur nell’assenza di colore, consente la messa a fuoco perfetta e perfettamente immune dalle “deviazioni” dell’abbaglio di una luce che conduce nel vuoto.
Concludo con la citazione integrale dell’“epilogo in ossimoro”.
“ per tacere memorie
Ho percorso emozioni.
Era esigenza dare solidi argini
Al mio camminare tra impressioni.”
[ Leggi l'intervista a Carla de Falco, a cura di Maria Musik ]
Id: 697 Data: 10/05/2013 12:00:00
*
 Mori - Pellico - Poesia e Prosa - Carocci e Vv. Ee.
Mori - Pellico - Poesia e Prosa - Carocci e Vv. Ee.
Due letture per i 150 anni d’Italia Unita
Per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia proponiamo due libri, uno fresco di stampa, uno già letto sui banchi di scuola.
*
Figlie d'Italia. Poetesse patriote nel Risorgimento (1821-1861)
di Mori M. Teresa
Editore Carocci (collanaFrecce) - 2011

L’autrice del libro non ci propone una critica letteraria anche perché le scrittrici che “porta alla luce” non sono famose bensì il tentativo di dare il giusto rilievo alla voce femminile che ha contribuito, e non poco, al processo di liberazione ed unificazione del nostro Paese. Il volume, oltre che proporre dei testi poetici, si arricchisce di stralci di memoriali ed epistolari che aiutano il lettore ad accostarsi, guidato dall’autrice, alla condizione delle donne nei decenni risorgimentali ed a riscoprirne il contributo alla costruzione del filone romantico e patriottico del romanzo popolare in rima.
Credo sia ora di tornare a “leggere al femminile”, specie per riscattare il ruolo delle donne in un periodo storico che ci ha abituate a vederle più nel ruolo, romantico e risorgimentale, della compagna (madre, moglie, figlia) dell’Eroe, del Patriota o dello Statista. Senza nulla togliere a questa funzione, impegnativa e di non scarso rilievo, voglio cercare la loro voce, sentirla “in diretta”, scoprendole protagoniste.
Spero questo libro non deluda le mie aspettative.
*
Le mie prigioni
di Silvio Pellico
Cosa c’è stato prima del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, prima di Garibaldi e di Cavour?
Le mie prigioni sono una lettura appassionante ed, al contempo, difficile.

Pellico aderì alla Carboneria per seguire il proprio ideale anti austriaco ma rimase sempre un uomo di fede, politicamente un moderato che si agitava stretto fra il richiamo insurrezionale in nome della Nazione e la riprovazione per l’ondata rivoluzionaria, il tutto sempre segnato da un fortissimo afflato fideistico.
La storia della sua permanenza presso le carceri dei Piombi di Venezia e poi dello Spielberg di Brno (nell’attuale Repubblica Ceca), si svolge nell’arco di un decennio, fra il 1820 ed il 1830.
Il racconto si dipana attraverso l’alternarsi del mesto ricordo della vita da uomo libero ed il narrare della durezza della detenzione, della disperazione che conduce a pensieri suicidi ai quali solo la fede pone un freno, alla terrificante asprezza dello Spielberg.
La narrazione, benché priva dei capitoli aggiuntivi che l’autore non riuscì mai a portare a definitivo compimento, danneggiò l’impero asburgico quanto se non più di un’insurrezione proprio perché il contrasto fra l’orrore della Fortezza e la profonda quanto controversa e ferita umanità di Pellico, fece sì che il suo scritto trovasse un grande accoglimento nei salotti intellettuali europei, fungendo da pericoloso propellente per la formazione del pensiero che avrebbe alimentato l’avvio dei moti risorgimentali.
Mi rendo conto di quanto riproporre questa lettura, possa apparire una scelta impopolare ma credo essa contenga, in fieri, le grandi forme di pensiero che si sono, poi, sviluppate e concretizzate in tutto il risorgimento, contribuendo con anime diverse ma intenti comuni alla restituzione dell’Unità e della Libertà ad una nazione che, per secoli, era stata divisa e sottomessa.
L’insegnamento da trarne: che non sempre colui che ci mostra le sue debolezze e le sue contraddizioni, che vinto cede alla violenza del potere (Pellico, durante la prigionia, inizialmente fermo nella decisione di non collaborare, provato sino allo stremo, accettò di confessare l’adesione alla Carboneria) sia il meno adatto a suscitare la rivolta. La difesa della libertà ha bisogno di azione ma l’azione ha bisogno di pensiero, anzi, di convergenza di pensieri, purché onesti ed accomunati dal perseguimento dei medesimi valori.
Leggi anche l'eBook Poetica Unità d'Italia
Id: 405 Data: 16/03/2011 12:00:00
*
 Roberto Nobile - Racconti - Coniglio Editore
Roberto Nobile - Racconti - Coniglio Editore
Col cuore in moto
“… Le mie moto, angeli venuti dal cielo in terra a miracol mostrare, le mie moto, illuminate dal mio sguardo, aureolate dal mio desiderio, divinizzate nell’Olimpo della mia mente, lui se le fotteva! Senza amore, senza distinzione fra un’anima e un’altra, ma pescando col suo rozzo desiderio fra culi e serbatoi, e fiche e motori, e sise e manubri, come un cane allegro. / Con quanta inesprimibile tristezza, con quali complici e vili sorrisi nascondevo le fitte al cuore martoriato dalle sue vanterie! / E il dolore pulsava, si espandeva, si moltiplicava proiettando nel futuro il mio transfert moto-donne, quando le più belle le avrebbe prese chi meno le amava, e il silenzioso amante sarebbe rimasto solo con i suoi deliri.”
Ma proprio questa breve narrazione ci prefigura il futuro di un corridore. “Col cuore in moto” è la sua storia “raccontata in racconti”, con un’abilità a metà strada fra l’arte di un cuntastorie popolare col mosaico di “quadri”del suo cartellone e un poeta della scuola siciliana alla corte di Federico II.
Così ci ritroviamo in una Ragusa anni Sessanta, evocata con immagini a volte oniriche come quelle del film “PERDUToAMOR” di Franco Battiato, a volte volutamente popolari e rozze come in una novella verista, ad inseguire, nelle sue corse in moto e nelle sue iniziazioni di vita, a volte un timido ed eroico adolescente, a volte un ironico e dolente adulto che nella Memoria ricostruisce passioni ed inquietudini mai domate. “Si può restituire un’eredità, o farsela cambiare da chi te l’ha lasciata? Qui, nella scrittura, grande officina di riparazioni del passato si può…”.
Roberto Nobile, in quest’officina, ancora accompagnato da una tenera voce che gli ripete “Acciddu, acciddu, ca ti fai male”, non picchia colpi da fabbro ma lavora di “fino” con una fresa e una chiave a brugola. E, mentre ripara, ci racconta la fiaba de “La Bella Addormentata”. “Ma intrecciata coi rami spezzati e contorti, e morti e rinati, coi radiconi che non si sa se partono da sotto o da sopra, coi rampicanti e le liane appesi al grande albero di carrubo, è rimasta, attaccata al suo tronco, la 125 Stornello. / Le macchie di rosso stinto che si intravedono nel verde, sembrano more, e la ruggine pare corteccia. Chi ci crederebbe che faceva scappare i vitelli dalle stalle, quando Lucio arrivava dalla trazzera, seminando polvere e tuoni di scarico libero? /…/ Ora è confusa, ferro, gomma e cromature, integrata nella malinconia dell’abbandono, e non disturba più”. Così, intanto che ascolti la storia, ti prende la voglia di trasformarti nel Principe Azzurro, di tagliare i rovi con i feroci fendenti della tua spada e di baciare la dormiente, restituendogli il suo rombo, restituendo a te stesso il giovane coraggio, goliardico e spavaldo, di portare scompiglio. E poco importa se non sai nemmeno come fosse fatta una 125 Stornello: il tuo bacio avrà ugualmente la passione giusta per un miracolo. Ed ecco, che proprio quando sei arrivato alle ultime pagine del libro arriva il lieto fine: non è come te lo immaginavi ma c’è tutto: la luna nel pozzo sotto mentite spoglie di chiave, un improbabile cavaliere ed un “The End” carico di amore e nostalgia.
La città cresciuta a dismisura - dove “la tribù dei lavoratori ha abbandonato la moto e si è dispersa. / La “due ruote” se la sono presa i “figli di papà”, e non per lavoro, ma per lusso, e il lusso non accetta limiti /…/ Nessun eroe come Vannino il Commissario accarezza e ingravida motociclette, e non si partoriscono più centauri, né semidei / Quel mondo è tramontato” – ha preservato la magica radura che custodiva il sonno della Principessa Stornello ed un Roberto Nobile (di nome e di fatto), con una protesi alla gamba che non gli è valsa l’ingresso nei Campi Elisi dove scorazzano gli antichi popolani/eroi ma che lo ha condannato ad essere un reduce, a “Mettere un punto e basta a un’epoca, girare su di sé una pagina del gran libro e sparire”.
Non pensate a nulla di melodrammatico o retoricamente nostalgico. “Col cuore in moto” è un libro snello, autobiografico, capace di rubarti sorrisi e pensieri, semplice nel raccontare la complessità. Ha il gran pregio di donarti emozioni, di “sentire con”. Se, poi, siete veri motociclisti della vita, avete “una marcia in più” per godervi il rombo, la velocità, le curve, i rettilinei, il dolore della caduta, l’orgoglio del rimettersi in sella e di sapere quando è arrivato il momento di scendere.
Id: 186 Data: 15/05/2009 17:22:54
*
 Alessio Romano - Poesia - Lalli Editore
Alessio Romano - Poesia - Lalli Editore
O Verdone!
Certo è che, neanche si è aperto il libro, e già ci si interroga. Convocati ad una lettura attenta solo da questo eloquente incipit ci si immerge in una marea artistica inquietante, difficile, certo non immediata. Eppure, sebbene affaticati, si continua a leggere affascinati, scivolando fra le pieghe di una vita così breve e già così adulta.
Una giovinezza che preferisce alle serate con gli amici e ai fuggevoli amplessi la compagnia “ingombrante” di Wagner e di Leopardi, di Cesare Pavese col contrappunto del Flauto Magico di Mozart, che irride e adula Tchaikovsky e Cardarelli, Pasolini e Paganini. Tutti geni, tutti artisti, tutti grandi, tutti morti.
Ed il suo scrivere e poetare gode nell’usare un linguaggio aulico, a volte trecentesco a volte romantico, e nello stesso tempo lo dissacra, giocando come un gatto che mai ucciderà il suo topo.
Proprio questo stile è, spesso, di intralcio al lettore. Per chi abbia lasciato sui banchi di scuola o nelle aule universitarie il linguaggio ormai desueto dei grandi, da Dante sino a Leopardi e Pascoli, è difficile non scoraggiarsi davanti a termini sconosciuti o dimenticati che, senza note a piè di pagina, lo costringe a fermarsi per consultare un vocabolario che includa lemmi obsoleti o a tralasciare il verso, abbandonandolo nell’incomprensione. Anche la sintassi di alcuni versi, che esplodono in un contesto più ”moderno”, affaticano il lettore.
“Tant’era bella,/che nessuno avrebbe contemplarla/osato sanza innamorarsi,/o giudicandola”
Il troncamento iniziale, il dividere con l’infinito l’ausiliare dal verbo servile, quell’aulico “sanza” proiettano il lettore ignaro (è alla prima poesia del libro) nel dolce stil novo per, poi, farlo ripiombare nel nostro secolo con un secco gerundio.
E, ancora, termini antichi e ricercati: “Moribondo camminai per mille verste,…”; perché non dire “miglia”? All’omaggio a Prokofiev, l’autore sacrifica il lettore, colpevole di non sapere che la versta è un'antica unità di misura dell'impero russo, ormai in disuso. (Per la cronaca: la lunghezza di una versta è di 500 sazhen, pari a 1066,8 metri).
Ed il lettore, ormai giunto ad un terzo dell’opera, s’indispettisce, viene da pensare: “Chi è questo ragazzo che vuole farmi pesare la mia ignoranza? Cos’è, una sfida? Oppure è solo un imitatore di mille personaggi? Un erudito, forse, ma chi vuole raggirare con tutti questi aggettivi anteposti ai sostantivi e tutto questo citare artisti?”.
Se, poi, il lettore è una lettrice il dispetto è ancora più pungente. Questo innalzarmi come fossi Beatrice per, poi, precipitarmi ingiustamente nell’Inferno, come fece Dante con Taide. Quale misoginia si cela dietro a versi antichi che fra i colori di un dipinto, un violino, un “frisare” che sfiora lisciando, vagheggiano amori sacri e profani, con donne dal sentire adulto, ed a rifiutare disgustato le allettanti cosce sode e superficiali delle coetanee per, poi, di nuovo evocarle? Ma come mi vuoi santa e bajadera?
Ma la realtà è un’altra. L’artista si sperimenta, evocando i grandi, che più non emula, cerca conforto per la sua arte, cerca dolorosamente se stesso trovandosi, diverso dagli altri, deciso a diventare nient’altro che un poeta, sacrificando a volte pulsioni e desideri nel inseguire la “perfezione”. Ed in questo, anche se alcuni suoi scritti parrebbero sostenere il contrario, non c’è dileggio o superiorità ma, forse, ossessione.
“Facilmente concepita l’idea/che un poeta che ancor poeta non è,/per diventarlo dev’essere pure mago,/e non v’è alcun poeta precedente/che mi carichi d’incredibile energia/perché più in alto di loro/mi è parso di vedere l’incantevole/destino conquistato,/e più in basso di come viene uccisa/una formica ho visto/il destino nell’altro suo volto.”
E mentre il poeta cresce, recidendo a morsi il cordone ombelicale, ma senza mai rinnegare l’arte paterna e le materne cure, pur allontanando entrambi come ogni altra distrazione dal suo distinguersi dagli altri, chiuso in un individualismo affamato di senso si droga dei versi e delle sonate dei grandi Maestri del passato. Ora è un giovane/vecchio e la sua poesia riverbera tutta l'angoscia ed il compiacimento ed il tormento di questo guardare il negativo fotografico del ritratto di Dorian Gray.
Alessio Romano è, a mio avviso, una giovane promessa che ha bisogno di “piegare” la volontà e l’istinto ad evolvere verso uno stile più coerente, ad “impoverire”, solo di poco, il lessico a favore di una maggiore efficacia espositiva ma che già ora riesce ad agganciare la mente, il cuore ed il gusto del lettore. Non di tutti i lettori ma di quelli che accettano che si possa contaminare il linguaggio contemporaneo, che dall’asfalto spuntino prepotenti giurassici fiori, che accetti di condividere l’angusto spazio del ghetto dei poeti e dei pazzi “… Perché non è limitato/l’uomo che ha una ristretta consuetudine/ma è pazzo l’uomo/che non si muove come fa l’altro.”.
Che dire di “O Verdone”: un libro "bello e impossibile", difficile da capire ma che non esiterei a consigliare. È perversamente e verginalmente attraente!
Id: 115 Data: 03/10/2008 23:27:31