chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Paolo Mazzocchini
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
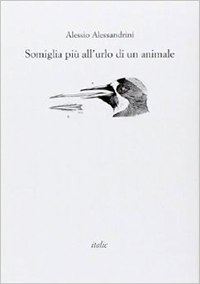 Alessio Alessandrini - Poesia - Italic Pequod
Alessio Alessandrini - Poesia - Italic Pequod
Somiglia più all’urlo di un animale
La lettura di queste raccolte poetiche di Alessandrini (perché di più raccolte si tratta, riunite in un solo volume) coinvolge notevolmente sul piano emotivo ed intellettuale. E questo è già un primo, impressionistico se si vuole, ma importante segnale del valore dell’opera; specie se si tiene conto di quanto tanta poesia moderna e post-moderna si affidi spesso ad un ermetismo algido ed esoterico (o anche ad una allusività molto implicita ed ellittica) che troppo spesso ostacola, anziché favorire, quel coinvolgimento. Certo, anche la poesia di Alessandrini è difficile, poco incline a spendersi sul versante della comunicatività; vi si incontrano callidae iuncturae assai spericolate (ferita gesuita o incensurato rumore) e di ardua decifrazione. Ma nel complesso si tratta di una poesia chiara e intensa, di una scrittura sorvegliata, densa di significati, giocata con maestria su alcuni motivi guida, fantasie simboliche e ricorrenti del vissuto interiore che si sviluppano e si oggettivano in efficaci variazioni sul tema. Notevole la sezione sul mare (La panchina azzurra): il mare come formidabile specchio dell’uomo. Nel caso di Alessandrini il paesaggio marino diventa anche e soprattutto frontiera tra civiltà/in-civiltà e natura, aggressione ottusa e offensiva dell’una e resistenza sacra e implacabile dell’altra; le cicale umane contro la stereofonia delle onde; il luogo dove si esibiscono le oscene dis-fattezze dei nostri corpi/cadaveri; ma dove è possibile una – stupenda e commovente – visione femminile nuda sì, ma quasi disincarnata, santificata dalle onde (c’è una donna nuda che si bagna/ che bagna la sua schiena/ il mare la fa santa/ accarezza impazzito la sua pena).
Altre poesie sono ispirate dalla grande neve del 2012. Qui l’alterità uomo/natura sembra riprodursi in termini di reattività interiore (oraziana – direi quasi) rispetto alla costrizione di inusuali e surreali condizioni esterne. In Neve è particolarmente suggestivo quel rintanarsi nel bozzolo polveroso della casa, nel microcosmo domestico che fomenta memorie, riqualifica abitudini e gesti quotidiani: le calze affebbrate sul termosifone/ il bisbiglio di un libro, le nostre / parole soffuse, la memoria di noi / spaginata nel lento sfarinare delle ore. Notevole in questo caso la pregnanza dell’ultimo verso dove il battito silenzioso del tempo vuoto si percepisce – visivamente – in una col cadere lento, minuto della neve sui vetri.
Diversi altri punti (o passaggi) delle raccolte di Alessandrini meriterebbero un’analisi ravvicinata. Ma forse mette conto soffermarsi di più intorno a certune fantasie simboliche e ricorrenti cui già si accennava. L’una è la tendenza monocromatica di molte descrizioni, dove il bianco predomina sì, ma in quanto colore non colore, o assenza di colore. Assenza di calore e di vita. È un bianco che non ha molto da spartire con il dramma creativo di un Mallarmé né tantomeno si configura come una metafora di purezza o di candore: il bianco di Alessandrini ha talora qualcosa di vagamente spettrale, l’angoscia sottile degli ospedali e degli obitori, della neve che aspetta di essere infangata, della biancheria che attende di essere profanata dagli umori sgradevoli e dagli effimeri amori del corpo. Il corpo: ecco l’altra presenza un po’ ossessiva insieme – cioè in significativa relazione – col bianco. Ma anche questo, come si diceva a proposito dei bagnanti in riva al mare, non sembra sentito gioiosamente, perché anche quando assapora eros avverte la vicinanza di thanatos, la costante percezione della sua imperfezione, la sensazione assillante della sua ‘sotto-struttura’ scheletrica (Pasto totemico, Metereologia), l’inquieto presentimento della corruzione. Il bianco e la corporeità paiono insomma – paradossalmente – i lati più oscuri e meno solari della poesia di Alessandrini. Ma anche, e per ciò stesso, tra i più intriganti e originali.
Id: 853 Data: 06/03/2015 12:00:00
*
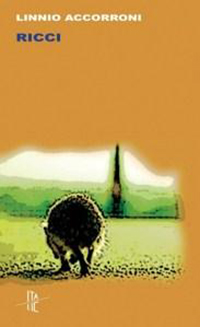 Linnio Accorroni - Narrativa - Italic
Linnio Accorroni - Narrativa - Italic
Ricci
«Dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le lacrime vostre»: questa provocatoria riscrittura che Francesco De Sanctis fece del celebre adagio virgiliano avrebbe potuto forse aggiungere un ulteriore, adeguato esergo alla cruda, straziante e illacrimata cronaca di una morte annunciata che è il romanzo Ricci di Linnio Accorroni. Commentata da due voci, osservata da due angolazioni diverse e complementari, quella di un padre condannato da un cancro al colon e quella del figlio che lo assiste e lo accompagna impotente, passo dopo passo, verso la fine, questa cronaca si dipana in un diario di giornate in apparenza sempre e disperatamente uguali, tra controlli e ricoveri ospedalieri, recrudescenze reali e illusorie remissioni del male, attraverso il filo conduttore, volutamente esibito in tutte le sue più nauseanti e respingenti fenomenologie e varianti linguistiche: la defecazione incontenibile, patologicamente multiforme del vecchio malato, il Leit Motiv coprologico assurto a emblema della dissoluzione della carne e dello spirito (se mai esso esista), ostentato ad esorcizzare qualsiasi tentazione di lettura pietistica o edificante del testo. Eppure, nonostante questo, mai una materia così sgradevole ha catalizzato di più l’espressione della più intima e nuda umanità dei coprotagonisti, le due personae del padre e del figlio che, progressivamente e insensibilmente, sembrano convergere in un solo essere: nel senso che la prima (quella paterna) sembra parlare sempre più attraverso la seconda, trasmigrare in essa offrendosi così l’unica forma possibile di sopravvivenza e consegnandole nel contempo la sua unica, definitiva e autentica eredità. Struggenti ed altrettanto sobri nella loro funzione di simbolico contrappunto all’umanissima crudeltà della storia sono i cosiddetti sinantropismi e i crimini di pace: rubrichette che intermezzano il diario sotto forma di descrizioni di vita e di morte di animali che accompagnano e rispecchiano quelle degli odierni umani patendone, per di più, molto spesso la indifferente, quasi ‘naturale’ violenza: si veda fra tutti quella – eponima del libro - della morte di un riccio investito da un’auto ai bordi di una strada: «Un porcospino enorme, con la testa schiacciata e completamente staccata dal corpo. Peccato: ce l’aveva quasi fatta [...] Gli aculei gialli e neri, tanto fieri e ostili quando li sbandierava sul dorso, adesso sparsi a terra sono poca cosa, inerti e sparpagliati come inutili bacchette dello shangai abbandonate da un bambino distratto.»
Id: 782 Data: 04/03/2014 12:00:00