chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Franca Alaimo
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
 Tommaso Di Dio - Poesia - Interlinea
Tommaso Di Dio - Poesia - Interlinea
Verso le stelle glaciali
Un’architettura complessa, iconica e verbale, poesia e prosa commiste, sorregge l’ultima silloge di Tommaso di Dio: Verso le stelle glaciali, un viaggio dalla terra al cielo come già annuncia il titolo, enigmatico quanto suggestivo, se è vero che non esiste alcuna costellazione che compaia con questo nome sulle mappe celesti.
Bisogna, infatti, fare subito i conti con il carattere simbolico-visionario degli affreschi che l’autore dispone sulle pagine, a cominciare dal primo testo iconico, e dunque a-verbale, in cui, nonostante la slabbratura dei contorni visibili, e la stessa smarginatura dell’immagine verso un fuori solo intuibile, si riconosce un albero, potente e stratificato archetipo che ha attraversato tutte le civiltà e le religioni, caricandosi di innumerevoli sensi.
L’albero radicato nella terra ma volto con i rami al cielo: immagine dell’uomo e del suo duplice anelito desiderante; l’albero asse del mondo attorno a cui si dispone l’universo; legno della Croce salvifica; o, ancora, quello su cui si issano le vele per la navigazione. Infatti, se il viaggio suggerito da Di Dio si svolge attraverso i quattro elementi primordiali della terra, dell’aria, del fuoco e dell’acqua, è quest’ultima a prevalere sugli altri, ché non solo la maggioranza dei testi iconici ha a che fare con la liquidità del mare, ma, come scrive lo stesso poeta nella “Nota ai testi”, “all’interno della sezione 1492 sono variamenti citati scritti dal diario di bordo di Cristoforo Colombo. In particolare quelli relativi al primo viaggio verso l’America”, con la precisa intenzione, deducibile da diversi testi, di universalizzare storicamente l’avventura di ogni individuo.
Del resto la liquidità marina allude anche allo sfrangiamento, alla frammentarietà della conoscenza: se si torna all’immagine di apertura del libro, quell’albero tremolante (fotografato, come sembra, nello specchio di una superficie acquorea), altro non appare che una cosa concreta scossa da se stessa, come dire che non solo è impossibile raggiungerne l’essenza, ma, per di più, null’altro di essa è conoscibile se non la sua caducità (“mare aperto e solare/ cerca se qualcuno ha la chiave/ chiamalo e portalo qui. Perché anch’io infine veda/ e senta/ interamente questa che sento e vedo / canzone della terra”), E, dunque, il viaggio fisico e mentale di ogni uomo sulla terra è un po’ come andare a tentoni, nonostante le molte mappe consultabili.
Perfino la bambola (ci avvertono la seconda e la terza mappa), che pure è un essere inanimato, aveva qualche centinaio di anni fa, una sua maschera leggera e morbida, e la bimba, nel celarne il volto, doveva imparare ad immaginarlo, abituandosi così a cercare anche il proprio ogni volta che lo specchio glielo rimandasse indietro: così l’autore presenta e commenta le immagini (le maschere di stoffa, a cui si allude, sono custodite in un museo londinese e sono databili fra il 1690 e il 1700), che probabilmente hanno la funzione di aggiungere altre indicazioni interpretative a quanto già suggeriscono i testi poetici.
Il motivo della maschera è, del resto, un tòpos che attraversa la letteratura e che, al di là delle sue più semplici significazioni di inganno e nascondimento, investe soprattutto la scrittura in sé come sdoppiamento, una sorta di ombra che cela, così come la maschera della bambola, il vero volto di chi e di cosa scrive.
Il viaggio di Tommaso di Dio, muovendo da questa consapevolezza, mira, però, ad una sorta di catarsi universale. Per questo motivo egli non può e non vuole compierlo in solitudine, sebbene spesso i suoi compagni di viaggio siano indifferenti (Insieme sono/ bradi, fertili e seri come gli animali inutili) o ostili (come i marinai increduli di Cristoforo Colombo: La nave è sabotata.), oppure emarginati (extracomunitari, poveri, solitari, folli); o, ancora, trascinino l’esistenza in stanze d’ospedale, perduto il senno, nudi perfino dei ricordi, o che abitino sul limen fra vita e morte, o abbiano già lasciato il mondo, se è vero che la poesia deve essere la parola che passa dai morti ai vivi, una sorta di mappa sonora che cuce passato e presente in una continuità grazie alla quale “tutta la storia umana torna leggibile”.
Questo senso dell’appartenenza, questa assunzione del “noi”, fa di Tommaso Di Dio un filosofo della sorte comune, un innamorato dell’uomo e dell’amore che lo spinge a dire: “ogni cosa splende/ si perde e dice stai/ fra mondi, confratèrnati”.
Il viaggio, sezione dopo sezione, si configura, a fine lettura, come un percorso iniziatico: nella prima sezione ci sono i vivi che gioscono che soffrono che operano il bene e il male, immersi fra le cose, negli spazi cittadini, schiavi degli istinti e dei bisogni; nella successiva prevale la condizione del disancoramento: qui i protagonisti sono quei malati ormai incapaci di intelligere la realtà, e a cui basta, però “vivere con la luce davanti agli occhi” in uno stato che prefigura la meta finale; segue la terza tappa, quella dell’abbandono del proprio sé per un ritorno ad una terra non più separata dal cielo, una terra in cui le cose rivelano la loro dimensione trascendentale e la conoscenza procede insieme al movimento incessante dell’essere, tra bagliori d’assoluto, e la verità non è che la fiamma di una piccola candela sufficiente, però, a guidare l’umanità verso il sentimento della fratellanza in nome della quale “Sapremo parlare/ Riconoscerci. Fuoriuscire./ Sapremo fare a pezzi questo niente/ e alzeremo le braccia/ canteremo felici.”
Non so quanto possa sembrare azzardato il paragone, ma la lettura di Verso le stelle glaciali di Tommaso mi ha fatto pensare alla Commedia di Dante per diversi motivi: innanzitutto per la struttura meditata e coltissima dell’insieme; per l’idea comune ad entrambi di descrivere un viaggio ascensionale dall’inferno terreno alla beatitudine della luce dopo l’attesa; per la trasformazione graduale del linguaggio che dalle cose e dal buio della dimensione terrena si solleva sempre più verso altezze concettuali man mano che la luce si fa sempre più dilagante, ma soprattutto per il ritorno di entrambi sulla terra, dopo avere esperito l’approdo ad una diversa dimensione.
Non dobbiamo, infatti, dimenticare che Dante compie il suo viaggio da vivo (è la sua “ombra” che lo attesta) e che gli è dato giungere fino alla luce somma di Dio, ma non di fissarla e conoscerla del tutto, ché il suo sguardo d’uomo non potrebbe sostenerla, sicché presto si accorge di essere approdato a ciò che non potrà mai riferire con le parole, all’ineffabile, all’indicibile. E tuttavia, tornando alla dimensione terrena, Dante saprà che la luce esiste e se ne farà testimone presso gli uomini condividendo con loro la sua esperienza.
Allo stesso modo, ma diversamente da Dante, con un approccio del tutto laico, Tommaso Di Dio si assume il ruolo di testimone della dimensione metafisica delle cose, fa della terra e del cielo una Unità inscindibile, cercando di perseguire la luce del vero, a cui è chiamata la scrittura. Kafka, esploratore dell’enigma così scriveva: “Chissà se la meraviglia della vita non sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se spesso rimane nascosta, profonda, inesprimibile, decisamente lontana (…) Questa è l’essenza dell’incantesimo che non crea, ma chiama”:
E quando Tommaso di Dio non dà un numero a quella che dovrebbe essere l’undicesima mappa, è questo che vuole fare comprendere al suo lettore: che, così come la parola non può dire l’enigma, per quanto possa approssimarsi ad esso, anche il numero non può contenere l’infinito, tanto che il simbolo che lo rappresenta è un otto che sembra inginocchiarsi di fronte all’innumerabile. “Nessuna mappa – scrive- fra quelle che sono state finora registrate e raccolte ha potuto indicare cosa ci sia là, nel fuori (...)”. L’unica risposta è, allora, quella di lasciarsi affascinare dalle stelle glaciali (lontane, arcane e purissime) che ci vocano: “Forse, la potenza della mappa è proprio questa: a tal punto ci fa innamorare di sé, che alziamo la testa, guardiamo il cielo”.
Id: 1226 Data: 01/05/2020 12:00:00
*
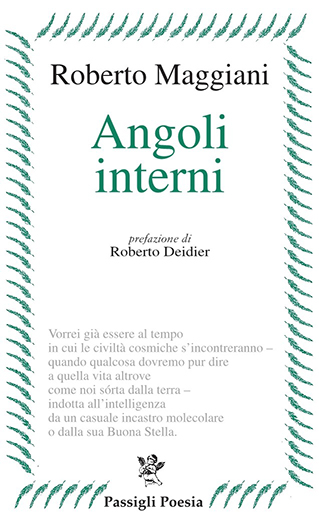 Roberto Maggiani - Poesia - Passigli Editori
Roberto Maggiani - Poesia - Passigli Editori
Angoli interni
Ha il respiro delle antiche cosmogonie l’ultima silloge (Angoli interni) di Roberto Maggiani, che, prendendo le mosse dalla narrazione della nascita del mondo, dilata il materiale poetico in ogni direzione, pur conservando un’efficace unitarietà d’insieme grazie anche alla limpidezza del linguaggio che come una luce meridiana illumina il suo versificare.
E se da quelle lontane narrazioni derivano all’autore la stessa meravigliata curiosità e l’abbondanza di immagini sontuose, al progresso delle scienze si devono l’attualità del registro lessicale, la presenza di formule, la proliferazione delle ipotesi, la mappatura molto più ampia del cosmo visibile e invisibile. Al racconto biblico della Genesi rimandano, invece, l’idea della centralità dell’Uomo (intelligenza, creatività, parola), così come l’ipotesi della presenza (oltremodo dubbiosa e sfaccettata) di un Dio che sembra delinearsi, ogni volta che fa il suo ingresso nei testi, dallo sfrigolio delle due opposte dimensioni della razionalità e della irrazionalità.
Se infatti l’ipotesi di un Dio creatore appare non necessaria alla Scienza, la sua esistenza sembra rispondere ad un bisogno così intimo d’amore e di proiezione oltre la morte, da sconfinare nel grido accorato di Cristo sulla croce: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
L’autore, infatti, pienamente consapevole di questa sfasatura tra pensiero e sentimento, che però non determina mai alcuna oscurità interpretativa grazie all’uso di costruzioni semplici e lineari, scrive di volere raccontare il reale e arrivare al dunque/ tra il come della scienza/ e il perché della fede/ nell’aria di un poema. E molto mi piace che egli parli di struttura poematica della sua silloge, poiché essa, specie nelle prime sezioni, si snoda narrativamente secondo un iter temporale progressivo: dalla nascita dei primi mattoni della vita all’evoluzione delle specie fino alla comparsa dell’Homo sapiens, per giungere alla complessa realtà odierna caratterizzata da questioni spinose, come una nuova forma di razzismo, la strage degli extracomunitari e una egoistica, dilagante indifferenza, alla quale l’autore oppone tutto lo sdegno del suo animo: Impazzisco all’idea di quanto male/ c’è nel mondo e ancora: Niente dovrà starmi vicino/ soffrendo il male della mia presenza.
Eppure, la concezione del tempo, che sorregge la struttura della silloge, non è affatto lineare: il passato, infatti, come accade agli alberi che serrano in cerchi sempre più larghi la memoria della loro esistenza, talvolta millenaria, sembra riscriversi in ogni nato, quasi che l’uomo sia un testo aperto in cui accanto al già detto, ai saperi già accumulati, al tempo dei morti, debba essere scritto tutto il nuovo da tramandare alle generazioni a venire. Così che il passato non solo regge il presente, ma s’infutura; e mi viene in mente, a questo proposito, la silloge di Tiziano Fratus, Poesie creaturali, in cui, fra gli altri, si può leggere questo bellissimo verso: il futuro è più antico del passato.
E anche quando l’obiettivo si restringe all’individuo Maggiani, alla sua vita, ai suoi affetti, solo apparentemente l’architettura poematica di Angoli interni subisce un’involuzione, perché quell’io, nel momento in cui si identifica con il noi (Riconosco questo universo/ dalla canzone d’amore-morte/ che il coro dell’umanità/ canta fin dagli albori), dà voce a tutti i sentimenti universali, come la paura della morte, l’incanto di fronte alla bellezza della Natura, la speranza di un oltre in cui sopravvivere e ritrovare le persone care, il mistero del bene e del male, e soprattutto la fame d’amore.
Certo si potrebbe osservare che la personalità di Maggiani sia più complessa di quella di un uomo comune, in quanto mette insieme (come il poeta latino Lucrezio ed il contemporaneo Bruno Galluccio) la lucida razionalità dello scienziato e l’intuizione lirica del poeta, la non sistematicità della fantasia e la sistematicità della ragione, e però è da questo connubio che deriva quell’oscillazione fertile tra assoluto e reale, tra arcano e quotidiano; è su questa soglia che appare Dio, che crea senza sosta le forme della vita, intanto che gli si affianca il poeta per custodirle e salvarle, lui che raccoglie/ tutto il Cosmo in un solo verso.
Ne consegue che, in quanto creatrice, la parola della Poesia accampa la sua superiorità sulla parola della Scienza, che studia il cosmo, ne svela poco a poco i segreti, ma non saprà mai rispondere ai numerosi perché dell’uomo, né garantire la verità ultima.
Se una parola-chiave va cercata nei tanti testi di Angoli interni è Amore, declinata in ogni sua possibilità, a cominciare dai legami fra gli elementi invisibili del creato a quelli parentali (in questo senso vanno letti i delicati quanto intensi testi dedicati ai genitori e al nipote Pietro), dai rapporti sentimentali di coppia alla gestualità (descritta senza reticenza alcuna) del rapporto sessuale, se è vero che il corpo dell’uomo, come già nel Rinascimento, si colloca per l’autore all’interno dell’energia cosmica, della sacralità del Tutto e perfino della nostalgia di Dio: Ci sarà posto sotto le mani di Dio?/ ho bisogno di essere toccato – sempre.
L’Amore è, infatti, la parola che più di ogni altra si incarica di dare orientamento e senso, e come già Dante nell’ultimo canto del Paradiso (Nel suo profondo vidi che s’interna/ legato con Amore in un volume/ ciò che per l’universo si squaderna) anche Maggiani la usa come il filo rosso che lega insieme tutte le creature, persuaso che da essa muovano il perdono, il rispetto della fragilità, la comunione con gli altri.
Il poeta, anche in questa sua ultima prova, resta coerente con le sue tematiche di fondo e con l’esperimento non nuovo, ma certamente non molto praticato, della commistione del linguaggio scientifico con quello lirico; il tono è pacato e coinvolgente, la sensibilità etica sempre molto viva: tutto questo fa sicuramente di Maggiani uno dei più significativi e riconoscibili autori contemporanei.
Id: 1130 Data: 27/07/2018 12:00:00
*
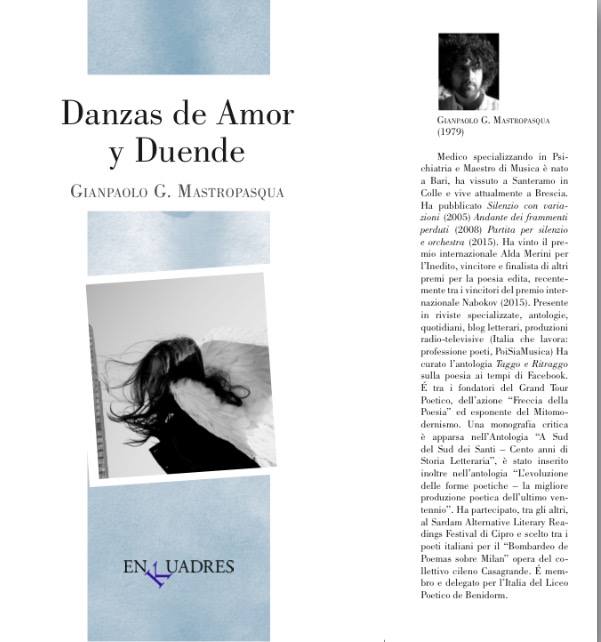 Gianpaolo G. Mastropasqua - Poesia - EnKuadres
Gianpaolo G. Mastropasqua - Poesia - EnKuadres
Danzas de Amor y Duende
Danze d'amore e duende, l'ultima silloge poetica di Mastropasqua si caratterizza come una costruzione complessa e incantatoria, capace di coniugare la stratificata formazione culturale del poeta con un'estrosa, vivida immaginazione e una percezione magica della realtà, proposte quali chiavi d'interpretazione del mistero del mondo.
Per l'autore, infatti, medico psichiatra e maestro di musica, avido lettore di testi esoterici ed essoterici, innamorato del Neoplatonismo ficiniano e dell'Ermetismo, in particolare, (da cui gli deriva l' intensa fioritura di allegorie, simboli, allusioni, immagini inedite), profondo studioso, per formazione personale, della psicologia freudiana e junghiana come di quella contemporanea, diventa necessità primaria, nella scrittura poetica, trasmutare il proprio bagaglio culturale in un'attitudine visionaria che, travolgendo la lingua d'uso, tenti un'approssimazione a quella originaria, a quella preverbale, che solo Dio conosce.
Mastropasqua di se stesso dichiara: “Io non sono io, non scrivo per gli uomini, scrivo per Dio”; e ancora: “Essere in poesia è penetrare l'oltrefemmina per entrare nel suo più intimo abbacinante segreto, amandolo con tutto il corpo fino a perderlo”.
Bisogna partire da queste affermazioni per comprendere pienamente questa originale poetica psico-emozionale, che fa dell'eros l'elemento eretico-rivoluzionario per eccellenza, il collante universale fra regni terreni e i sovraregni celesti, come avverte già l'esergo dantesco: “Nel suo profondo vidi che s'interna/ legato con amore in un volume/ ciò che per l'universo si squaderna”.
L'universo (il volgersi del Tutto all'Uno) viene legato insieme da Mastropasqua attraverso una sapiente rete di corrispondenze le cui chiavi vengono rivelate dalla stessa struttura della silloge ruotante attorno ad uno dei due più importanti numeri sacri delle antiche culture orientali (il sette), e in seguito presente nelle scritture giudaico-cristiane.
L'autore, infatti, divide la silloge in sette sezioni, in ognuna delle quali sono inseriti sette testi e, per ogni sezione, dà a lettore una chiave, grazie alla quale mette insieme l'elemento mitico, il magico, quello mistico e quello musicale alludendo contemporaneamente alle sette vocali gnostiche, ai sette pianeti, alle sette chiavi e alle sette note musicali, ai gradi delle scale musicali, ai sette metalli simboli, alle sette lettere alchemiche, e ai sette chakra, corrispondenti ai sette nomi degli arcangeli.
La silloge, dunque, va letta come un testo squisitamente iniziatico, a tal punto questo insieme di saperi e di simbologie, così come la somma del tempo e dello spazio, vengono messi al servizio della Poesia, celebrata come la Lingua per eccellenza, quella che trasforma il poeta in un essere abitato da un misterioso duende, qualcosa di notturno e insieme luminoso. Come lo è la luna, la vergine di metallo, presente come figura magica, nella maggior parte dei testi.
Il poeta-duende ama cantare e fare musica (da qui il testo Karmica in omaggio alla musicalissima tessitura poetica di Amelia Rosselli) e soprattutto danzare per raggiungere l'estasi, morto fino alla non morte, per provare la vertigine/ dell'ultimo respiro, quel passaggio/ agli anni-luce in cui ritornerò luce.
Ché, in fondo, è la morte l'esperienza mistica per eccellenza, quella che ci proietta nell'oltre, che ci inabissa nell'infinito, che ci restituisce dei così come tutti eravamo prima di incarnarci e reincarnarci nel tempo terreno; per questo motivo Mastropasqua dà inizio al suo canto con una stupefacente cosmogonia e si augura di concludere il suo percorso mortale come suono fra le pagine bianche.
Nel testo conclusivo tutto è evocato e riassunto: la donna, la musica (viole, arpe, tube, chitarre), la terra e i tre regni (vegetali, animali, minerali), il sesso fecondante, l' alto e il basso, e la valenza erotica-eretica della poesia.
Il percorso, per raggiungere la Sapienza, è arduo, così come arduo e sorprendente è quello tracciato da Matropasqua, che talvolta la personifica in figure simboliche, alla maniera degli Arcani maggiori e minori dei Tarocchi: l'Erborista che possiede tutta la segreta sapienza delle piante (angelica, achillea, dionea, linaria, olmaria felce); la Seduttrice che misura la violenza e il genio, il gesto,/ il fallo proteso nel cielo oracolare; il Medico che ammira la compiuta dedizione,/ la scrupolosità dei dettagli, il microbo,/ il suo immeritato amarsi; e tante altre, tutte in qualche modo sacerdotali, sibilline, erinniche, profetiche, angeliche e demoniache.
Bisognerà che il lettore si abbandoni, per apprezzare tutta la traboccante fioritura di questa poesia e per giungere là dove “il suo letto d'inchiostro e biancofoglio è un segno trasponente, un patto metamorfico” alla voce del poeta, a quell'effetto d'insieme, che richiama un'architettura barocca, così diffusa nel Sud, che è poi, come dichiara altrove Mastropasqua, “la metafora di un inconscio perduto e da recuperare”.
Id: 1117 Data: 01/06/2018 12:00:00
*
 Miriam Bruni - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Miriam Bruni - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Coniugata con la vita
Il linguaggio poetico di Miriam Bruni è caratterizzato da una gradevolissima chiarezza da cui sgorga una sorta di luce frontale (luce e sole sono i lemmi più frequenti) che accende ogni dettaglio del paesaggio.
È, infatti, la Natura il centro della ispirazione dell'autrice, che, attraverso un processo di immersione e di fusione con essa (in un testo, a pag. 27, dice di sé: Io sono l'Aria e in quello successivo: La mia pelle è un cielo), attiva quella inclinazione alla conoscenza sensoriale-coloristico della vita.
Non a caso nel testo a pag. 33, viene evocata una magnifica definizione del poeta Salinas “Luce del tatto” per indicare le mani, che “sanno guardare dove l'occhio non vede” e descrivere il movimento dell'esistere nella scrittura poetica.
L'attenzione verso i dati esterni, che rendono così ariosa e brulicante di esseri e forme la poesia della Bruni, non significa, però, che i suoi testi siano soltanto degli affreschi aggraziati ed eleganti, ma privi di tensione e di interiorizzazione, ché, anzi, ogni cosa sembra investita da una ricerca di assolutezza.
Le cose di qui, rimandano, allora, al mistero che brucia in esse, al senso segreto della Vita e dell'esistere individuale, ad una complessità la cui unica risposta certa sembra essere la fede in quel Dio creatore instancabile, che la poeta definisce Madre (pag.32), forse per evidenziarne l'infinita tenerezza, che è uno dei sentimenti più percepibili all'interno dei versi di questa silloge.
Dentro questa luminosa cartografia del territorio della sua esperienza quotidiana, la Bruni, dunque, innesta quello della sua interiorità non meno variegata, mobile e ricca di sentimenti: dal dolore alla gioia, dalla scoratezza alla consolazione, dalla nostalgia alla volontà di affrontare il tempo a venire.
Dal piano metafisico a quello visibile, tuttavia, identico è il flusso che trascorre e lega insieme: l'Amore, sebbene l'amore terreno, nel tentativo di somigliare a quello divino, non riesca ad essere saldo e totale come il secondo, causando, a causa di questo scarto, una febbrile passione attraversata dalla sofferenza e dalla nostalgia della totalità.
La poetessa indaga anche questa volta con chiarezza il suo cuore innamorato, percorre i territori interiori della solitudine, dal dolore, sfiora talvolta l'angoscia, sebbene mai vi precipiti, ancorata com'è alla Bellezza delle cose e alla saldezza della Speranza di matrice cristiana.
Quest'ultima determina la limpidezza del linguaggio con la sua visibile verità come strumento d'empatia con il lettore, che viene chiamato a con-dividerlo, in una sorta di comunione non meno sacra di quella liturgica, se è vero che scrivere poesia è per Miriam una magia, una visione, una ricerca di fratellanza.
Id: 1101 Data: 09/04/2018 12:00:00
*
 Francesca Del Moro - Poesia - Edizionifolli
Francesca Del Moro - Poesia - Edizionifolli
Una piccolissima morte
Con questo libro, stampato su carta pregiata che aggiunge al piacere della lettura quello del tatto, la Del Moro entra nella schiera di quelle donne che cantano, con veridicità descrittiva e una quasi spasmodica irruenza del sentire, il proprio corpo come soggetto desiderante e insieme come oggetto desiderato, in un'alternanza dolorosa fra assenza e pienezza del piacere. L'autrice fa, dunque, suo un lungo percorso di liberazione sessuale ed espressiva, che ebbe, probabilmente, le sue punte più scomode e ardite nelle poetesse americane, fra l'altro legate da un rapporto d'amicizia, Sylvia Plath e Anne Sexton, e a cui tutte le autrici successive, anche quelle europee, hanno fatto riferimento.
Tra le italiane, per esempio, il caso più eclatante, negli anni ottanta del Novecento, fu quello di Patrizia Valduga con la sua commistione di elementi formali tradizionali e impetuosità erotica del linguaggio.
La Del Moro, più che a quest'ultima, sembra ispirarsi alla Sexton, sia perché come la poetessa americana mette in scena un amore adulterino, sia per l'atteggiamento anti-cattolico nei confronti di Dio, rappresentato nel testo di chiusura come una sorta di psicoanalista-guardone, tra fantascienza e blasfemia.
L'unico oggetto sacrale rimane, dunque, il corpo, che si fa, all'interno di una professione di misticismo laico, strumento di comunicazione con l'Altro, l'Amato.
Quest'ultimo è rappresentato come una sorta di ambigua divinità che, dopo le benedizioni e la gioia e l'ardore amoroso, una volta perduto, viene fatto oggetto di ironia dissacrante, nonostante l'assedio del dolore.
Sembra, allora, che la Del Moro costruisca, non so quanto consapevolmente, una relazione fra la figura di Dio e quella dell'Uomo, entrambi feroci e deludenti; una sorta di attacco, insomma, alla mentalità patriarcale: ed è proprio questo a costituire l'elemento di modernità e di scardinamento rispetto alla lirica amorosa femminile del passato.
E' un punto di vista, infatti, che allontana l'autrice dal pericolo di una ridondanza sentimentale, sebbene le poesie dell'amore condiviso siano assolutamente imbevute di romanticismo: il pranzo preparato con raffinata cura dei particolari, la cosmesi del proprio corpo, lo sconvolgimento dei sensi, una certa sudditanza fisica rispetto alla figura maschile, la disperazione dopo l'abbandono.
Ma la differenza sta nel fatto che la poeta conserva, comunque, una ferma consapevolezza di sé, restando una persona non dimidiata, “disamorata a tutto,/ ai miei amici e agli altri indifferente”, e però pronta a difendersi con “la vincente crudeltà”, che è una reazione per antonomasia virile.
In ultima analisi, la Del Moro ci racconta una storia d'amore, forse autobiografica, forse no: una lei ha una relazione con un uomo già sposato, che in un primo momento sembra innamorato e coinvolto, e poi non esita ad abbandonarla, provocandone la delusione, la rabbia e il dolore, Fin qui la situazione, per altro affatto rara, oggi.
Ma la magia della Del Moro sta nel trasformare un'esperienza comune in un evento poetico (ed è questo soltanto che davvero conta), attraverso un linguaggio che, perfino quando resta legato alle cose e ai gesti quotidiani, sa creare un'alta temperatura emotiva e immaginativa, sorprendere con la qualità e la novità di certe immagini, e mettere in scena crudezza e tenerezza di dettagli anatomici e gesti erotici con eguale coraggio.
Ci vuole, infatti, molto coraggio per dirsi in questo modo, per infischiarsene dei giudizi, per sconvolgere certi parametri morali e religiosi.
Ci vuole anche una femminilità prorompente ed una testa capace di pensare in modo autonomo per concepire e scrivere poesie d'amore di questo genere.
In altre parole, questo prezioso libricino di Francesca potrebbe rappresentare un suo amabile, fedele e veritiero ritratto. E di questo tutte noi dobbiamo esserle grate.
Il libro è stampato in tiratura limitata di 100 copie numerate.
Chi volesse procurarselo, può scrivere a Edizionifolli:
Id: 1093 Data: 02/03/2018 12:00:00
*
 Cinzia Della Ciana - Romanzo - Effigi Edizioni
Cinzia Della Ciana - Romanzo - Effigi Edizioni
Acqua piena di acqua
Acqua piena di acqua è il titolo emblematico di un romanzo atipico, che privilegia piuttosto che una trama di accadimenti oggettivi all'interno di un riconoscibile e preciso assetto cronologico, una forma di narrazione “interiore”, che, spostando il suo baricentro all'altezza delle ripercussioni delle vicende nella psiche dei personaggi e delle emozioni memoriali nella sfera privata, introduce quella nota di struggente melanconia della percezione temporale che è una delle note più costitutive di questa prosa.
Già l'elemento dell'acqua rimanda per antonomasia al fuggevole scorrere del tempo, alla sua instabile liquidità, al fluire inarrestabile della vita, e, come evoca il titolo, anche ad una sua funesta eccedenza.
Non a caso l'acqua piena d'acqua è un modo di denominare, in genere, la piena di un fiume, sebbene il riferimento sia, in questo romanzo, storicamente ben definito, alludendo a quella che inondò le strade di Firenze e di Pisa, nel novembre del 2000: un evento drammatico rimasto impresso nella memoria di tante generazioni; ma che, all'interno di questa particolare tessitura di vicende, assume un significato fortemente emblematico di un esondazione liberatoria di ossessioni e nodi psichici che vengono infine scavalcati dall'ultima delle tre donne protagoniste: Letizia (la nonna), Anna (la figlia), Ludovica (la nipote).
Quella storia taciuta nell'oggettività delle sue vicende socio-politico-economiche, e che si dipana, grosso modo, attraverso tre generazioni, dal secondo dopoguerra fino al 2000, diviene, allora, la voce di una donna nuova, finalmente libera, consapevole e responsabile, che ha abbandonato le sponde delimitanti, rischiando coraggiosamente il travolgimento. Una donna che si racconta come soggetto della propria storia, del proprio spazio interiore di sentimenti e desideri, e come soggetto della Storia quale spazio concreto e tempo fertile da abitare con il corpo e la mente, con la volontà e la gioia di essere finalmente se stessa.
Ludovica, la giovane ricercatrice universitaria, che, contravvenendo agli ordini dei vigili, oltrepassa il ponte sul fiume disastrosamente in piena, rappresenta il salto generazionale, il passaggio dal cronico mutismo ossessionato della nonna Letizia alla parola che decide e pretende; dalla costrizione dentro ruoli soffocanti e noiosi confinamenti tra le pareti domestiche alla libertà del fluire insieme all'acqua della Storia, con la possibilità di stabilirne il corso.
In definitiva la storia di questo romanzo è quella del riscatto femminile dal dopoguerra agli anni 2000 (che nel chiudere un ciclo introducono il nuovo); forse è la storia di una sola donna, che, dopo avere ripetuto all'interno della propria biografia, i limiti e i dolori e gli errori delle donne della sua famiglia, riesce a liberarsene e a dare una nuova lettura degli eventi precedenti, riscattando anche le altre, tutte le altre.
Una storia di questo tipo doveva necessariamente spezzare gli stereotipi narrativi per fare respirare il proprio alfabeto spirituale, e procedere, così come fa, attraverso sequenze analogicamente associate, fili misteriosi che cuciono tempi e luoghi, tentare figure e emblemi di spericolata originalità.
Id: 1077 Data: 01/12/2017 12:00:00
*
 Roberto Pazzi - Romanzo - Bompiani Editore
Roberto Pazzi - Romanzo - Bompiani Editore
Lazzaro
Sorprendente, immaginoso, visionario, come la maggior parte dei romanzi di Roberto Pazzi, Lazzaro, l’ultimo in ordine di tempo, è innanzitutto una dichiarazione d’amore per la città di Roma, incantevole teatro a cielo aperto in cui si svolgono le vicende dei tre protagonisti principali: Leo Bonsi, il despota ormai vecchio e malato, impotente, ma dedito al voyerismo; Alberto Cantagalli, il maestro, che si dà la missione di ucciderlo per il ripristino della democrazia; Santa Teresa, che, tornata rediviva, sembra risolvere la millenaria schizofrenia tra erotismo e misticismo in un crescendo di ‘fisicità’ e di lirismo appassionato, divenendo presenza e figura della necessità e della peculiarità della Poesia, a cui pure Pazzi si dedica da sempre.
Questi tre personaggi rappresentano anche tre incarnazioni diverse del topico binomio Amore e Morte: Bonsi che cerca di ingannare la prossimità della morte (fisica e politica) dedicandosi a spiare le prestazioni sessuali delle sue guardie del corpo; Alberto Cantagalli che coltiva il sogno di dare la morte al tiranno per amore dei valori umani della libertà e della dignità; santa Teresa che ritorna dalla morte per sposare con l’amore celeste quello terreno allo stesso modo con cui opera, appunto, la Poesia.
La città di Roma, sede del potere politico e religioso, luminosa d’arte e insieme misteriosamente oscura, sfolgorante di maestosità e però anche decadente, è certamente il luogo ideale per una vicenda come questa che si sorregge sullo scontro tra fede e potere, tra idealità e perversioni. In qualche modo la Roma di Pazzi ricorda quella celebrata da Sorrentino nel suo film “La grande bellezza” che, sia pure orchestrato secondo moduli estetici ed intellettuali differenti, tuttavia si conclude anch’esso con un messaggio o, meglio, con una speranza di redenzione.
Ma quello che di nuovo, forse addirittura di rivoluzionario, c’è in questo romanzo di Pazzi è qualcosa di più sottile, che scavalca la stessa trama, che chiama l’uomo, come Lazzaro che dà il titolo al romanzo, ad una rinascita senza precedenti. Lazzaro indugia di fronte al richiamo di Cristo che vuole riportarlo in vita, anche perché Lui continua a ripetere il suo falso nome, a ribadire il peccato dell’eros, se è vero, come Pazzi ipotizza, che Lazzaro fosse una fanciulla innamorata di Cristo e morta per eccesso d’amore non consumato.
Quello, dunque, che più coinvolge e stupisce di questo romanzo (oltre la spettacolarità di certe soluzioni immaginarie e le metamorfosi e lo svelamento di altre segrete verità) è il suo procedere sulla linea grigia (è il colore della copertina) che si colloca tra bene (il bianco) e male (il nero), quella su cui gli opposti si toccano ed in parte si fondono.
Di fatto non c’è protagonista che incarni l’assolutezza di una virtù o di un vizio e che non abbia in sé ampie porzioni di entrambi: il buon maestro romagnolo finisce con l’essere ossessionato dalla sua volontà di uccidere; il despota Bonsi appare, nella sua vecchiezza e nella deformazione del suo appetito erotico, ridicolo e patetico, sebbene il suo voyerismo sia, freudianamente, fame d’amore e paura della solitudine, e talvolta lo sfiori pure il desiderio di qualcos’altro, fosse pure la dimensione della morte.
E Teresa non è solo una santa che recupera man mano le sue reliquie sparse tra chiese e palazzi reali per diventare di nuovo corpo integro che recupera un passo sicuro e sensuale, dopo la sua iniziale e tenera zoppia, ma anche la fanciulla innamorata che vede nei tratti di Alberto Cantagalli quelli del suo primo amore. È la santa con un corpo teneramente femminile che scolpì Bernini, colei che si abbandona a Dio con quel languore sensuale vigilato da un angelo-cupido che la guarda con un ambiguo sorriso. Teresa è l’eresia dell’amore, così come Lazzaro: sono loro che si sbilanciano di più sul confine tra lecito ed illecito, tra sacralizzazione e desacralizzazione.
Allo stesso modo l’imperfetto e troppo terreno Cantagalli viene paragonato a Cristo e il Signore delle mosche (cioè il Diavolo), che spesso si intrattiene a conversare con lui, non è la creatura mostruosa cui ha dato vita l’immaginario collettivo, ché anzi, appare pietoso nei confronti del maestro, e spesso lo introduce alla comprensione più profonda degli eventi, e, infine, gli impedisce di macchiarsi di omicidio, portando via il vecchio corpo del despota Leo con l’aiuto di Belfagor che è nientemeno che l’Angelo di marmo con la spada che troneggia su Castel Sant’Angelo: altra ‘verità’ svelata dopo secoli di false convinzioni.
Tra le varie metamorfosi introdotte da Pazzi, la più lirica è quella di Santa Teresa che ricorda il metodo descrittivo, qui capovolto, dei racconti ovidiani, ma la più interessante è quella di Cantagalli (prima trasformato in mosca e poi in farfalla). Si tratta, comunque, di una trovata inventiva non nuova in Pazzi (in Cercando L’imperatore i fedelissimi dello zar si trasformano in uccelli per potere comunicare con lui); ma in quest’ultimo caso mi sembra importante la sottolineatura dell’autore tra la perfetta identità della farfalla-Cantagalli e quella posata sul capo di Lazzaro bendato in un dipinto osservato in una chiesa romana; perché, se è vero che i volatili rappresentano per Pazzi – come lui stesso scrive ‒ la leggerezza di cui ha fame il mondo, è questo, dunque, il sogno da perseguire per una rinascita alla vita (Lazzaro) e per una metamorfosi dell’Uomo (Alberto Cantagalli). Del resto la farfalla è anche il simbolo più diffusamente affrescato nelle tombe antiche in quanto “animale spirituale”, come già indica il nome greco psyché . L’umanità, insomma, deve riprendersi le ali e imparare di nuovo a volare, come fa quasi da sciamano il maestro Cantagalli in uno dei passaggi più suggestivi del romanzo, quando, sotto le spoglie di un insetto, sorvola la città eterna e, nel contemplarla, la proietta su un piano ideale di intatta bellezza.
Id: 1061 Data: 25/08/2017 12:00:00
*
 Giovanna Rosadini - Poesia - Einaudi
Giovanna Rosadini - Poesia - Einaudi
Unità di Risveglio
Una serie di coppie di distici compone la prima delle tre sezioni della silloge poetica Unità di risveglio uscita nel 2010 nella collana bianca dell’editore Einaudi. In Sintomi la crepa, che diventerà un abisso nella successiva sezione Terra di nessuno, è già aperta, e la Rosadini cerca di colmarla con i fruscii delle innumerevoli consonanti fricative: allitterazioni ripetute che fanno nell’orecchio quel “ronzio remoto/ come un’arnia affollata in fondo alla palude”.
La parola poetica che vi batte dentro con tale ritmo ostinato è testimone di un progressivo svuotamento interiore percepito anche come un guasto fisico, che investe ogni membro del corpo: strappi, grumi di sangue, ossa scheggiate, pieghe, tagli, cicatrici, “la bocca sdentata dell’inguine” lo ingiuriano, nonostante l’inarrestabile proliferazione (“mi crescono le unghie, ed i capelli”).
Dunque, da subito, viene posto al centro dell’universo poetico della Rosadini il corpo, quale strumento primo dell’experiri, veicolo d’ogni emozione (“la gioia della mente/ sta/ nel corpo”), realtà oggettiva all’interno della dimensione spazio-temporale in stretta correlazione con quella dell’interiorità soggettiva.
Esso è il protagonista assoluto della sezione centrale della silloge: Terra di nessuno, in cui l’autrice racconta l’esperienza del coma in cui piombò per tre settimane nella primavera del 2015. La parola viene chiamata ad affrontare un argomento al limite del dicibile, a inseguire frammenti memoriali ed onirici e a razionalizzare pulsioni e percezioni di difficile decifrabilità; e si fa vibrante, tesa, complessa, talvolta sperduta, confortata soltanto dal medicamento della musica: rime interne, assonanze, consonanze, allitterazioni e altre figure di suono.
Ma più di ogni altra cosa la soccorre (per usare un’espressione di Cristina Campo) l’eletta figura del mare. È un ritorno alla casa della prima infanzia, affacciata sul mar Ligure. Alle acque fetali della propria storia biografica.
In questo senso, può considerarsi centrale il testo a pagina 52 (introdotto dalle parole dell’amica e poeta Mariangela Gualtieri che chiama “mamma” l’acqua), in cui la vampa dei ricordi trova sollievo nella contemplazione del mare: “alito azzurro di luce”, “promessa”, “traccia sedimentata”, che “parla in un modo familiare”.
Di fatto il linguaggio adoperato dalla Rosadini s’intesse di verbi, aggettivi, nomi, tutti ampiamente legati all’elemento acquoreo e che disegnano, all’interno soprattutto di questa sezione (ma, sia pure meno vistosamente, anche nelle altre due), un’omogenea e vasta area semantica. Come se tutto il mondo poetico espresso dall’autrice possa essere rappresentato con una sola metafora, ma così variamente declinata, da produrre un effetto a raggiera di forte impatto emotivo-evocativo.
Già nel testo d’apertura della seconda sezione, il corpo in coma viene definito: “Uno scafandro ottuso/ sul fondo del mare”. E d’ora in avanti tutto ha a che fare con la liquidità tra ripetuti affondamenti, vortici, onde, fondali, “acqua che stringe/ da ogni lato”, “liquido/ che affoga ogni protesta”, derive, risucchi, naufragi. Perfino i familiari in visita sono paragonati ad ormeggi sicuri, ad approdi di speranza. Sanno di luce e sale marino: sono la vita che sta fuori, la luce estiva, l’altro canto.
Del resto l’acqua è uno dei simboli archetipali più complessi e più intensamente usati nell’ambito del linguaggio comune, filosofico e mitologico-poetico: sorgente di vita, elemento di dissoluzione, simbolo degli strati profondi dell’io, fertilità e morte, emblema del flusso del tempo: il “sempremai ricominciato” (come scrive Valery) che istituisce una relazione ciclica tra vita e morte.
Inutile elencare tutti i poeti che lo hanno amato e fatto oggetto del proprio canto, ma certamente, fra tutti, è Omero con la sua Odissea a venire per primo in mente: la storia di Ulisse che compie un lunghissimo viaggio per mare, ostacolato da mostri, fatture, ire celesti, tempeste, prima di raggiungere l’amata patria e la casa e gli affetti più sacri, è soprattutto un percorso di ritorno verso se stesso, verso la propria identità, come quello compiuto dall’autrice. Perché prima di ritrovarsi bisogna perdersi, prima di amarsi bisogna conoscersi, prima di ritrovare la salus, bisogna sapere cosa sia la malattia.
E, dunque, non stupisce che la Rosadini titoli la terza ed ultima sezione del libro Itaca. È il momento dell’approdo alla propria casa, agli oggetti, agli affetti, tra spaesamenti, consolazioni, dubbi e domande. E finalmente in quello conclusivo:Home again (significativamente corredato dell’annotazione Milano-Genova 2007-2008) il paesaggio marino della propria casa d’infanzia colora i versi con le sue belle cromìe: “indaco cielo e azzurro mare”, “linea/ di verde che sfuma piano verso oriente”, il “bianco/ nuvola”, e, lungo il litorale, brilla “il vivido dei fiori spruzzati”. Alla paurosa verticalità dello sprofondamento si sostituisce lo “spartito orizzontale/ di nuvole”, il “pentagramma che inizia dalla costa”.
Il viaggio si è concluso, ma il futuro non sarà come il passato (anche il ritorno di Ulisse è un non-lieto fine con tutto quel bagno di sangue che consacra il ricongiungimento degli sposi), perché la malattia ha provocato dei mutamenti fisici e psicologici a cui bisognerà adattarsi.
Un libro, allora, questo della Rosadini insieme materico e intimo, ché il corpo viene nominato, esplorato, esposto come un oggetto, e i sintomi del male inventariati, le più piccole percezioni registrate come in una sorta di diario medico, il sistema nervoso innestato nei suoni delle parole, i sogni narrati come una realtà parallela a quella sospesa, chiusa, immobilmente rituale, quasi onirica, dell’ Unità di risveglio; ma, allo stesso tempo, un percorso profondo nello spazio interiore, un’indagine sul senso del proprio essere nel mondo, un modo di integrare esperienza, memoria e poetica.
Id: 1041 Data: 28/04/2017 12:00:00
*
 Grazia Fresu - Poesia - Bastogi
Grazia Fresu - Poesia - Bastogi
L’amore addosso
Rimbaud, il poeta fanciullo, l’angelo ribelle della poesia francese, affermava che il giorno in cui le donne avrebbero cantato in poesia l’eros con la stessa libertà degli uomini, senza alcuna censura, allora avrebbero davvero raggiunto la parità con l’altro sesso, se è vero che è l’uso del linguaggio a misurare il potere.
Nella poesia italiana hanno fatto da apripista, nel secolo scorso, operando una rottura all’interno della lingua “muta” delle donne nell’ambito della sessualità, la compianta Maria Grazia Lenisa, di origine friulana, ma ternana d’adozione, che non per nulla si auto-definì “la ragazza di Arthur”; e Patrizia Valduga con Medicamenta. E, tuttavia, la prima ha dato vita ad una poesia segnata da un erotismo di natura simbolico-intellettuale; la seconda ha azzardato lo scandalo della nominazione fino al limite dell’impoeticità e della gratuità. Molto più aperto e libero appare l’eros della Fresu che, con molta sincerità, dice: io canto il mio piacere di donna (pag. 31).
Non so se Grazia Fresu abbia un qualche debito debito nei confronti delle poetesse italiane citate. A me sembra piuttosto che, volendo cercare le fonti ispirative di questa poesia, bisognerà rintracciarle nella tradizione lirica in lingua spagnola, rappresentata da Lorca, Neruda, Alberti, per nominare i più noti, che rappresentano ormai i poeti classici della poesia erotica. Ma esiste anche una notevole consonanza fra la Fresu e una poeta contemporanea (ancora poco conosciuta in Italia), anche lei di lingua spagnola, che è Juana Rosa Pita, di origini cubane. Eppure le due poetesse affermano di non conoscersi e, dunque, con ogni probabilità tale risonanza va attribuita ad un medesimo retroterra culturale, e, appunto, a quella libertà nell’uso del linguaggio erotico finalmente concessa anche alla donna-poeta e che non fa più scandalo (ma non in tutte le nazioni, cosa che non bisogna dimenticare).
Per la Fresu, tuttavia, prendere a maestri i poeti di lingua spagnola è stata una strada obbligata, in quanto l’autrice, pur essendo nata a La Maddalena, in Sardegna, vive da moltissimi anni in Argentina, e, per essere precisi, a partire da 2008, a Mendoza, dove insegna lingua, cultura e letteratura italiana presso l’Università.
Dalla poesia erotica in lingua ispana, ed in particolare dagli autori poco fa nominati derivano a Grazia la vitalità del sentimento, la sovrabbondanza metaforica del linguaggio, la forza delle percezioni sensoriali, il vivido cromatismo.
Ma di questi aspetti si parlerà tra breve, portando a testimonianza i suoi versi. Quello che mi preme sottolineare, adesso, è la presenza quasi ossessiva del mare nei testi di questa silloge. Esso potrebbe essere indicato, prendendo a prestito una celebre definizione di Cristina Campo, come l’ eletta figura del mondo poetico della Fresu.
Infatti, non solo non c’è un solo testo poetico in cui il mare non sia presente (sia che faccia da sfondo reale alla voce della poeta, sia che alimenti un’ invenzione retorica), ma tutto il linguaggio della silloge ne è condizionato, intriso, illuminato.
Ho perfino provato, man mano che avanzavo nella lettura dei testi, a costruire un campo semantico con tutte le parole relative al mare, finché ho dovuto constatare che esso si andava allargando tanto a dismisura da combaciare quasi con l’interezza del vocabolario usato dalla Fresu in questa silloge.
Basterebbe leggere un testo quale I mari che navigammo ( pag.26) per rendersi conto che non c’è verso che non evochi il mare: distese azzurre, creste di spuma, coste, porti, rive, nave, polena, pennoni, venti, bussole, sartie, marinai, sirene, pirati, capitano e così via: un inventario interminabile, probabilmente legato alla lettura di libri d’avventura e diari di viaggio, e, soprattutto alla biografia dell’autrice ed agli ambienti geografici in cui è vissuta e che hanno fatto la loro irruzione nel territorio immaginario e nel vocabolario personale, mai come in questo caso tanto consoni alla volontà di celebrare l’uomo amato, a cui la silloge è dedicata con queste parole: Al mio Capitano.
Dagli stessi versi della Fresu apprendiamo la storia: Nella mia vita segreta sei tornato/ bruciando lontananze…mentre mi invade il tempo che hai trascinato fino a me/ nella tua rete di ricordi; e ancora, in un altro testo: ma nella mia memoria/ ci amiamo appena adolescenti/ sui bordi caldi del mare. Dunque, il libro della Fresu canta un amore sbocciato nel periodo dell’adolescenza, silente per così tanti anni da sembrare perduto, e però di nuovo riaccesosi nell’età matura, tanto inaspettatamente quanto prodigiosamente, così che l’autrice può dire: separarci fu il dramma della vita e trovarci oggi/ l’ultima sfida al destino.
E, da quando di nuovo l’amore è esploso come una fiamma inconsumabile fra i due amanti, la distanza dello spazio non è solo solitudine e attesa talvolta angosciante, ma anche collana preziosa di memorie con cui adornare l’assenza, e, ancora, desiderio, spazio di fantasticherie, ma soprattutto premessa alla gioia dei rinnovati incontri.
L’incontenibilità del trasporto amoroso trova espressione attraverso un linguaggio ardito, che non ha pudore di nominare i luoghi intimi del corpo, di raccontare le notti di passione, di svelare pensieri, desideri, emozioni. “Quell’amore addosso”, così come è definito nel titolo della silloge, vuole sottolineare la forza della passione: l’amore addosso che scardina/ il freddo e l’abbandono…una parola sola suggellata tra le labbra riarse, e il miracolo dell’unione carnale: …l’amore addosso sei tu,/ non altro da me, la stessa pelle lo stesso nome/ la stessa vita che unisce e commuove, come si legge nella poesia che dà titolo alla silloge.
L’impeto dei sentimenti mette le ali all’immaginazione poetica, affidandosi, innanzitutto alle metafore, la cui sovrabbondanza corrisponde all’eccitazione dei sensi vivificati, le cui percezioni delle cose reali si fanno vivide di colori, profumi, sapori, sebbene il dominio appartenga alla vista e al tatto, com’è naturale che sia. Ecco qualche bellissimo esempio: Ho raccolto il tuo amore/ anemone spuntato tra gli scogli (pag.15); la tua lingua petalo di viola mi profuma; la tua lingua è… una canoa ansimante (pag.30); i nostri corpi sono tutti gli Adami/ e le Eve che si scoprono/ nudi e amanti fuori dell’Eden (pag.31); le tue rose sono i nostri respiri (pag. 65); nel tuo petto zattera che porta lontano (pag.18); e mi fermo perché, in sostanza, è il linguaggio stesso di questa silloge a somigliare ad un’interrotta metafora.
La Fresu, ben consapevole del valore letterario della sua scrittura e delle sue caratteristiche tecniche, fa della metafora perfino l’oggetto di un testo (“Metafore”, pag. 25) in cui ripete: “Cerco metafore per raccontarti”, per concludere che “nessuna metafora, mio amato,/ ha la tua bellezza d’amante”, quasi a ricordarci che la realtà di un sentimento supera la finzione della letteratura.
Abbondano anche le similitudini che hanno il compito di guidare l’eccesso del sentire verso l’accostamento di realtà parallele fino al raggiungimento di un’unità cosmica fra gli amanti ed il tutto: una sorta di giustificazione, di benedizione che rende sacro il congiungimento amoroso, svelando gli arcani legami fra le cose del cielo e della terra: ti darò i miei versi/ come uccelli notturni/ per proiettare il volo su nei cieli (pag. 16); ci possediamo come Salomone/ e la Regina di Saba, / regali e potenti come il desiderio/ come l’eternità, come l’amore (pag. 18).
Non mancano i testi del dolore: quelli in cui l’attesa si fa straziante, e la paura di un nuovo allontanamento, se non addirittura, di possibili tradimenti sconvolge l’autrice, che non riesce a colmare il senso di vuoto che l’opprime. La cosa significativa è che, in questo caso, la parola sembra scarnificarsi, rapprendersi in brevi coaguli di sensazioni ed emozioni, quasi che il dolore la spogli d’ogni volontà; quando, invece, quanto più è animata dalla gioia, tanto più si espande e dilata ed esplode.
Mi sembra che proprio questa docilità, questa duttilità della versificazione possa essere considerata la più appropriata testimonianza di un poetare di natura emotivo-sentimentale, ma perfettamente dominato da una tecnica sicura e complessa.
Infatti, un’ultima cosa da dire, ma non per questo meno importante (piuttosto è il contrario) è quella della presenza della meta-poesia nella versificazione della Fresu: se è vero che tutta la silloge è dedicata ad una persona in carne ed ossa, è anche vero che, mentre scrive, l’autrice tira in ballo la poesia stessa (o il libro), facendone la figura per eccellenza all’interno delle figure retoriche di cui si adorna: son l’epopea, la speranza il libro/ che la mia mano ha scritto in stanze segrete/ con penne di pavone, di acquemarine, / la visione del nostro incontro in una coppa di rime (pag. 27); amarti somiglia alla mia mano/ che ti scompiglia il cuore/ e scrive versi per consegnarti/ a un tempo di bellezza (pag. 22); e i traguardi sono solo ricami del dire (pag.56); noi che abbiamo il mare dentro/ eternamente viaggiamo/ al bordo della parola e del silenzio (pag. 60).
A questo punto, dando una seconda occhiata alla copertina del libro, ci si rende conto del fatto che essa riassume tutti gli elementi dei vari testi qui raccolti: il mare (la distanza, il viaggio, il canto), la rosa (l’amore, il sesso), il berretto da capitano (il mestiere dell’uomo amato); i gabbiani (angeli di libertà e nostalgia) e un libro (questo libro) che sta volando verso l’amato, oltre la finestra.
Sentimenti, immagini, sogni, oggetti, luoghi, sono tutti immersi in un ritmo che inizialmente potrebbe non essere avvertito, perché l’autrice si affida raramente alle rime, ma piuttosto a consonanze, assonanze e figure di suono come allitterazioni e reiterazioni.
Talvolta, invece, il ritmo nasce dal potere evocativo determinato dall’originale accostamento delle parole, che dilata lo spazio-tempo della lettura, così come della vicenda raccontata.
Questo della Fresu, che oggi ho avuto il piacere di presentare, è insomma, uno dei più convincenti ed affascinanti libri d’amore che mi sia capitato di leggere recentemente: appassionato e delicato, lavoratissimo dal punto di vista stilistico e però immediato e sincero nell’emozione, trasbordante negli effetti retorici e insieme sorvegliato nella resa comunicativa; è soprattutto il canto dell’amore senza pregiudizi e steccati etici: carne e spirito, cuore e sesso, fusi nel miracolo che è ogni essere umano, quando tutto si consegna, come direbbe Dante, all’ ‘Amor che move il sole e le altre stelle’.
Id: 1037 Data: 07/04/2017 12:00:00
*
 Guido Garufi - Poesia - Nino Aragno Editore
Guido Garufi - Poesia - Nino Aragno Editore
Fratelli
“Non siamo noi che personifichiamo, sono le epifanie che giungono a noi come persone”, scrive Hillmann. A me sembra che nessun’altra affermazione possa meglio esprimere il mondo poetico di Garufi, che, nel rimandare ad una visione sacra del reale, abitata da divinità, angeli e presenze metafisiche, rinverdisce il concetto di ispirazione, ormai così poco condiviso, se non disprezzato, nel mondo delle lettere contemporanee, perlopiù votato ad una laicità che ha svuotato di ogni alone di mistero il gesto amanuense dello scriba (il solo, nel passato, che conoscesse l’arte della scrittura e che fosse in grado di comunicare con gli dei).
Significativamente Giovanni Tesio, che firma una densa e coinvolgente postfazione, parla di “angelismo visitante”: annunci, voci che versano nell’orecchio del poeta sussurri e segreti e formule mistiche; i propri morti, innanzitutto, e tutti i poeti letti ed amati, e le cose che sempre sono altro rispetto a ciò che appaiono: “tra questi fiori che fiori sembrano/ e sono invece anime che nella notte ondeggiano” (Verso il mare, pag.10); e, a pag. 13: “quelle nuvole che sembrano distanti/ ma sono angeli divini”; e si potrebbero offrire altri esempi di questa straordinaria rappresentazione (la cui espressione richiama il linguaggio acceso dei mistici) che tenta di costruire una corale fratellanza fra le cose e fra quest’ultime e l’uomo.
Garufi allude, attraverso uno stile maturo, nutrito di letteratura, armoniosamente costruito, alla felicità visiva e cognitiva dell’infanzia: a questo mirano le irruzioni memoriali nel suo più lontano passato, come anche l’ascolto e l’accoglimento delle voci misteriose della sua terra natia.
Tutto questo potrebbe fare pensare alla poetica del Pascoli; ma in Garufi non c’è alcun balbettamento, nessuna patologia sentimentale (nonostante la dolente qualità di molti ricordi), ma piuttosto una gioia intima, un’affermazione di vitalità più che whitmaniana, perché essa proviene dallo spirito, dalla percezione di una coralità sacra ed affratellante.
È l’amore il fiato più profondo di questo libro, così percorso da termini evocativi, quali “luce” ed “aria”, che si rifrangono in verbi e nomi attinenti al volo, all’esplorazione dell’alto, e trovano i loro concreti emblemi nei molti volatili che percorrono il cielo, mentre si respira nei versi lo spalancamento dei sensi, il flusso palpitante dell’essere.
Un libro, si diceva, di “angelismo visitante”: angeli sono anche tutti i poeti letti ed amati dall’autore, dalla letteratura classica a quella contemporanea. Essi sembrano spargersi come uno stupefacente pulviscolo d’oro nei versi di Garufi: l’uno accanto all’altro, in un mescolio di sintagmi, stilemi, versi, titoli mietuti a piene mani, senza che l’espressione soffra di alcuna pesantezza o superbia esibizionistica, poiché l’autore non cita, anche quando sembra farlo, ma ridice e illumina di ardore empatico ogni parola.
Si ha l’impressione di entrare nell’onirica biblioteca di Borges, dove è possibile trovare Montale e Sereni, Luzi, Pasolini, Leopardi, Dante; e, tra i poeti stranieri, Pound, Eliot, Baudelaire, Coleridge; e tra i classici, Catullo, Isidoro di Siviglia, e, ancora, così tanti altri che, man mano che si va avanti, si comprende che la meta è la dimensione visionaria ed assoluta della lingua, quella che “manca alle persone”, come afferma Garufi in un’intervista: la lingua “altra”, che è conoscenza immediata e intatta, la lingua “una” prima del disastro di Babele, quella fondativa, quella, insomma, della Poesia.
Di fatto, questo libro, con tutti i suoi angeli sussurranti, vuole essere un omaggio alla Poesia, invocata come una musa, alla maniera degli scrittori di poemi (e, di fatto, poematica è l’architettura segreta di questa silloge nonostante le sezioni in cui si divide e la frammentazione in più testi); elogiata come la sua “seconda famiglia” dall’autore; incapace di salvare il mondo, ma efficace “nell’entrare nel cuore delle persone”.
Forse per sottolineare questo fallimento della poesia come evento risolutivo del male che è del mondo reale, forse per allontanare da sé il sospetto di cecità o l’accusa di vigliaccheria nella fuga in una dimensione troppo privata, forse per ricordare agli altri il suo concreto impegno politico-amministrativo, Garufi conclude il suo libro con la sezione intitolata Poesie del disamore, in cui ironia, sarcasmo, dolore e risentimento etico accompagnano l’esplorazione delle relazioni umane nella società contemporanea.
Ma è proprio il termine “disamore” a condurre ancora una volta al suo opposto: il lettore è chiamato, come fa l’autore, a non nascondersi, a non abbandonarsi all’otium quale facile via di fuga, ma ad impegnarsi all’interno della comunità: le voci degli angeli, dei cari morti, gli ideali, la bellezza, la purezza dell’infanzia potranno, casomai, servire da psicopompi nell’arduo cammino della vita terrena. In questo senso va letto il titolo della silloge: quel Fratelli, che richiamando una celebre poesia di Ungaretti, desidera restaurare all’interno del clima d’odio della società attuale, simile a quello che si respirava nei campi di battaglia durante la prima guerra mondiale, i legami affettivi naturali, la religio dell’esistere: compito primo della poesia.
Id: 1035 Data: 03/03/2017 12:00:00
*
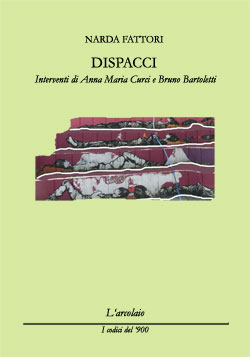 Narda Fattori - Poesia - Editrice L’arcolaio
Narda Fattori - Poesia - Editrice L’arcolaio
Dispacci
Poi leggi le poesie della silloge Dispacci di Narda Fattori e ricominci a sentire l’aria circolare dentro i polmoni e schiarirti il cuore già a cominciare dai versi iniziali, simili a delle finestre spalancate da cui entra la vita, tutta. E, pagina dopo pagina, finisci con l’immergerti nella vita biografica ed intima dell’autrice, e nelle sue relazioni con gli altri, con il mondo esterno, la Natura, gli eventi della storia contemporanea.
Il dolore, la gioia e, tra l’una e l’altro, tutti i diversi sentimenti possibili, sono da lei accolti con la grazia di chi ha appreso come stare in equilibrio, se è vero che la vita “non fu ballo”, ma nemmeno “solo sventura”, ed ogni cosa è stata affrontata con l’umiltà di sapere che “siamo fatti/ di quasi niente”.
Inutile cercare un tema dominante, perché, con quella semplice complessità che appartiene al vero poeta, Narda Fattori abbraccia il tutto e lo racconta con un linguaggio di straordinaria pulizia formale, che, sebbene accolga tanta terminologia contemporanea, travalica il tempo dando voce a sentimenti assoluti, universali, entrando nei territori dell’anima.
Così, sia quando canta la tragedia contemporanea dei tanti annegati nel mare Mediterraneo e quella della guerra e della crudeltà, sia quando dà voce ai ricordi ed ai sentimenti personali, in realtà la sua poesia non fa che mimare il flusso eterno dell’esistere da sempre contraddittorio, il suo coagulo di bene e male, senza acrimonia o pregiudizio , perché l’essenziale è la continuità; perché, a forza di resistere dentro, s’impara ad avere quello “sguardo ridente/ alla vita sì alla vita ai suoi dolori/ agli amori ai troppi errori “ e, perfino, a sperare che “si volesse aprire ancora una porta”.
La malinconia, la solitudine, la macina dei ricordi si aprono strada in questi versi, in cui l’elemento lirico e quello narrativo appaiono così strettamente intrecciati e caratterizzano la personalità di una donna che ha molto sopportato e sofferto, e, tuttavia, sembra avere raggiunto il segreto del vivere, lo stesso che narra un’antica, bellissima leggenda, secondo la quale, dopo la morte, l’anima di ciascuno verrà pesata in una bilancia che avrà sull’altro piatto una piuma.
La Fattori, insomma, non ci comunica solo il dovere etico del vivere nell’innocenza del bene, come i bambini, ma aggiunge un più profondo messaggio estetico-filosofico, come a dire che solo colui il quale sa guardare le cose lievi, quelle senza apparente significato e scopo, raggiunge il segreto dell’essere. Che sono le cose minime a reggere il mondo con la loro grazia. Per questo motivo Narda canta “il ricciolo dei tuoi capelli”, “il cielo lassù azzurro alto col gregge chiaro”, una ragazza che “spalanca lo sguardo sull’azzurro”, “la processione ridente dei bambini”, “una farfalla/ che si appoggia sul fiore senza peso”. E, mentre viene da pensare al celeberrimo passo del Libro dei Re in cui si racconta che Dio fu “nel mormorio di un vento leggero”, d’improvviso sembra illuminarsi il senso di un titolo “Dispacci” che, di primo acchito, sembra così poco consono al tono poematico della silloge.
Il fatto è che la Fattori, “da un avamposto arrischiato, uno dei pochi tuttavia che garantiscono vista acuta ed eloquio chiaro”, come scrive nella prefazione Anna Maria Curci, invia i suoi testi (o i suoi “dispacci”) per richiamare gli uomini al bene ed al bello, ai loro bagliori, sia pure minimi, che, tuttavia, illuminano il buio del mondo contemporaneo come di ogni vita individuale. Se i “dispacci” arriveranno a destinazione, non è detto: potrebbe accadere di no, come al messaggero di Kafka; e, però, essi resterebbero comunque in attesa di una probabile, futura accoglienza. Poiché la poesia è un valore che non ha tempo e, dunque, non fallisce mai.
Narda, intanto, organizza i suoi testi secondo una struttura instancabilmente positiva: il male, rappresentato con verità e forza descrittiva, non occupa mai tutto lo spazio dei versi; c’è sempre in essi, spesso nella strofa conclusiva, un controcanto d’amore, la qualità tersa di un pensiero mai disposto al disfacimento, alla resa.
E, soprattutto, c’è la limpidezza del dire che fa parte di una precisa postura etica: la comunicabilità per Narda è, infatti, un valore aggiunto al gesto di per sé generoso del poetare; quasi che il mettere in comunione con gli altri il proprio mondo interiore, il pensiero, lo sguardo sulle cose sia una forma di religione, un modo, cioè, di tessere legami duraturi e significativi.
Quasi superfluo appare, infine, sottolineare come l’ampio bagaglio culturale e la preparazione filosofica dell’autrice non costituiscano elementi di gravezza e di ostentazione, ma come, invece, elaborati in modo del tutto personale, diventino quasi un pulviscolo d’oro sparso nella tessitura dei versi, che se ne impreziosiscono senza sovraccaricarsene.
Bella e fluida è la musicalità della versificazione -ricercata attraverso catene sonore di significanti, specialmente allitterazioni, consonanze ed assonanze (preferite alle rime)- che fa di questi Dispacci tante preziose epifanie.
Id: 1027 Data: 20/01/2017 12:00:00
*
 Nicola Licciardello - Poesia e Prosa - Mimesis Editore
Nicola Licciardello - Poesia e Prosa - Mimesis Editore
Estasi.com
Prima di entrare nel merito di questo straordinario libro iniziatico di Nicola Licciardello, desidero premettere che forse non sono la persona più adatta a presentarlo. Io sono una donna occidentale che non riesce a rimuovere le radici più profonde di questa civiltà, nonostante i miei personali terremoti e ribellioni e l’attrazione profonda verso l’India e la sua civiltà. E’ vero che ho studiato per qualche tempo Sanscrito, ho letto la traduzione del Bhagavagīta e tanti scrittori iniziatici, sono stata in India un mese intero e, quando sono tornata, sapevo di essere stata rigenerata e trasformata da questo viaggio e non in modo temporaneo. Però, per quanto mi riguarda, mi ritengo una donna e scrittrice occidentale votata, un po’ come tutti gli abitanti del Continente europeo, ma ancora di più in quanto siciliana, alla drammaticità, al fato, alla fascinazione dolorosa del transeunte, sebbene vorrei, al contrario, tenere sempre viva in me la luce pura della Gioia che talvolta danza dentro di me e con me e che considero la vera essenza della Vita.
Nicola Licciardello, viaggiando, leggendo e operando in modo metodico e non superficiale ed approssimativo come il mio, ha saputo raggiungere e conquistare il segreto della Gioia per donarlo successivamente agli altri, scegliendo di diventare a sua volta maestro di yoga, dopo la frequentazione di scuole e maestri originali, perché come lui stesso dichiara (pag. 108), ha sempre avuto “la fissazione di ricevere gli insegnamenti dai Maestri originali”. Anche la scrittura e la pubblicazione di questo libro vanno considerate dei doni attivi in quanto finalizzati a produrre stati d’animo positivi e riflessioni utili alla crescita interiore del proprio sé.
Il fatto che Licciardello abbia speso gran parte del suo tempo a viaggiare in ogni parte del mondo, anche se in questo libro si concentra maggiormente sull’unico viaggio a Tahiti (1995) e su quelli in India, non significa, comunque, che egli abbia perduto le sue radici occidentali: ce lo confermano non solo l’avere fissato una sua dimora in territorio toscano, ma anche l’ampia conoscenza dell’arte italiana ed europea, della sua storia, la lettura così acuta dello sviluppo tecnologico dell’Occidente (ormai dilagante anche in Oriente se pure secondo una combinazione del tutto originale con gli archetipi di quelle civiltà). E ce lo conferma la nostalgia di casa che ogni tanto lo prende a Tahiti, e una confessione all’inizio del soggiorno in Australia (dove la nascita del figlio corona il sogno d’amore descritto in un primo diario indiano): “Certo, nonostante tutte le iniziazioni, ero rimasto un eurocentrico catapultato nella New Age già fatta-data con il fruscio maestoso dell’eucaliptus, il silenzioso apparire dei canguri, il degli australiani, nel loro ritmo soffice, ironico-fatale, lunare” (pag. 118).
Entrando nel merito del libro e della sua struttura, non meraviglia che lo stesso autore abbia sentito la necessità di dedicarlo anche ai genitori “per le radici forti e il sostegno che mi hanno dato” e di concentrare nel primo capitolo (intitolato, appunto, Radici) la storia della sua infanzia e giovinezza e la formazione culturale, cattolica per spirito e valori, ma casualmente (o fatalmente) aperta alla fascinazione del messaggio di Yogananda, invitato addirittura a casa da due inquiline del piano di sopra, l’incontro con il quale rimase sempre avvolto da una serie di resoconti evasivi; la presenza in famiglia del nonno Nicolò, filosofo panpsichista, e l’incanto musicale e mitologico dell’ambiente naturale del territorio catanese, segnato dalla presenza del mare, emblema dell’infinito movimento del divenire e della danza della Natura – con l’Etna, emblema del sacro e del tremendo mitologico. E poi il ’68, gli incontri, le conversazioni, le letture e la frequentazione di ambienti intellettuali a Venezia, Padova, Roma fino alla decisione di partire e incontrare l’India.
Questo primo capitolo, inoltre, fornisce al lettore le due chiavi d’interpretazione dell’intero libro. La prima è la volontà di liberarsi, intanto in prima persona, e successivamente di aiutare gli altri a farlo, dal mito del dolore sacralizzato, che sta al centro del sistema del Cattolicesimo a causa di una distorta interpretazione del messaggio cristico, finendo con l’essere uno strumento di castrazione del proprio io più profondo e determinando le tristi derive mentali della misoginia, della sessuofobia e dei sensi di colpa. La seconda è l’influsso che sulla formazione interiore-intellettuale di ogni creatura umana determina l’ambiente esterno, un insieme di paesaggio e credenze religiose misteriosamente e fatalmente intrecciati.
Dai suoi cenni di comparazione fra le religioni, leggiamo: “Nella cristianità il paradiso in terra è proibito. In questo mondo non vi è un sorriso possibile, dal momento che la , tradita, ci ha abbandonati, lasciandoci la Verginità della Madonna imprendibile” (pag. 217). E a proposito del Cristo: “La tristezza del Salvatore ha inquinato la terra, l’angoscia per come ‘finisce’: inchiodato in croce, modello da duemila anni per la solitudine individualista dell’Occidente” (pag. 285).
Non è, come si potrebbe pensare, un attacco sferrato alla predicazione di Cristo, quanto alla lettura che dei suoi insegnamenti ha fatto la Chiesa Cattolica, e questo mi ricorda un altro grande studioso di religioni, amico e guida spirituale per tanti anni: Silvano Panunzio, il quale, pur procedendo in senso inverso rispetto a Nicola Licciardello (che sostiene come l’esclusività dell’Occidente sia destinata a venire assorbita nell’inclusività dell’Oriente), fa convergere tutte le tradizioni religiose nel Cristianesimo, e lamenta come si trascuri da sempre il messaggio iniziatico di Cristo, la sua gioiosa luminosità più profonda, la pratica della contemplazione a favore della meccanicità dei riti. Una volta che gli confidai quanto mi annoiasse partecipare alla Messa, mi disse di non andare e di continuare ad amare Dio, come facevo, attraverso la contemplazione della bellezza del Creato e la benedizione di ogni creatura vivente.
Un incontro della sapienza orientale tantrica con quella occidentale sembra, tuttavia, avverarsi per Licciardello nella Vita Nova e nel Paradiso dantesco (pag. 316-320): in quest’ultimo “Il suo linguaggio amoroso è quasi sovrapponibile a quello tantrico: la verginità di Matelda (riso e dolce gioco) è gravida della suprema, celeste (Bodhicitta) del (sukhàvati). Nel Letè la (ancora senza nome) letteralmente sommerge ed abbraccia Dante – proprio come un’Avalokitésvara della compassione abbraccia il discepolo nel buddhismo tantrico”. Ho riportato solo un piccolo stralcio di questa mirabile lettura (trenta pagine nella sua originaria versione-saggio) dell’opera dantesca alla luce della sapienza orientale, che però non è nuova nell’ambito della critica letteraria; tanto che mi ricordo di avere letto un saggio bellissimo di un altro illustre amico, il poeta Peter Russell, che interpretava La Vita Nova alla luce della spiritualità dei Sufi.
Ai riti cattolici Licciardello contrappone quelli dell’india per la loro “innocenza infantile”, così come “i pellegrinaggi senza dolore”, la devozione “senza fanatismo”, la “gentilezza e gioco della festa senza tragedia, puro omaggio”, la preghiera “che si fa col corpo intero, una funzione biologica. Non un sacrificio cruento.” (pag.269). Poco prima, l’affermazione densissima di conseguenze etico-estetiche sul “paradosso della trascendenza affidata all’arte, la religione come arte. E l’arte come prosecuzione del gioco della natura”. In effetti, tutto il suo libro Estasi.com trasuda d’amore per l’Arte, e (a parte l’Introduzione) la prima volta che la parola “estasi” viene scritta è a pagina 151, quando l’autore parla della pittura di Gauguin.
Il fatto è che più di un semplice diario, questo libro è un romanzo di trasformazione della coscienza, un’interpretazione di luoghi ed esperienze, una lettura di molti capolavori dell’arte mondiale, una piccola antologia poetica, visto che vi sono inseriti numerosi testi poetici composti dall’autore, ma ci sono anche dei passi descrittivi squisitamente lirici. Infine è anche un saggio politico-economico-filosofico sulle condizioni attuali del mondo e sul suo futuro.
Non susciti meraviglia che io affermi di non avere mai letto un’interpretazione dell’arte di Gauguin tanto acuta come quella avanzata da Licciardello. Il capitolo a lui dedicato è denso d’informazioni, sfolgorante e folgorante. Mi piace riportare questo giudizio: “Le sue opere non sono un mero capitolo di storia dell’arte occidentale, ma anche dell’etnologia, dell’antropologia, della filosofia, dell’esoterismo (…), sono già un’arte planetaria”. “Per un attimo, il paradiso in terra appare, come inabitabile profumo, come semplice aria, verginità prima e dopo l’uomo: campi di colori-forme che diventano visioni di luce interiore (pag.202)”.
Tornando ad uno dei temi-chiave di questo libro, cioè la volontà di liberarsi dal dolore, va premesso che la ricerca alternativa della gioia è un viaggio soprattutto interiore, poiché essa è l’essenza del nostro io profondo; e tuttavia la civiltà sembra averla esiliata in un recinto di falsi e sciocchi limiti che le impediscono di sgorgare con spontaneità e libertà, come invece accade in civiltà come quella tahitiana, balinese e indiana.
Si tratta, dunque, di liberare la gioia attraverso una serie di strumenti: la contemplazione, la necessaria alternanza fra meditazione solitaria e partecipazione alla collettività, quindi fra silenzio e parola, con l’arte e la capacità di abitare il ritmo dell’Essere in quanto forma, numero, suono, profumo, pulsazione dell’eros. “Al di là del tempo musicale, negli organismi viventi e negli atomi, nell’arte e nelle galassie il ritmo è onnipresente, primum assoluto, ‘padre’ di ogni forma” e anche “Il nostro organismo è una sinfonia sempre in esecuzione (pag.235)”.
Ecco perché la danza – gli dei indiani danzano, il sé è un danzatore – vederla, eseguirla, descriverla, fotografarla, diventano una delle magnifiche ossessioni di Licciardello. A nessuna arte egli dedica più spazio nel suo diario, raggiungendo in certe descrizioni un parossistico, ipnotico acme lirico-erotico assolutamente liberatorio, purificatorio, la prossimità alla gioia nel desiderio di Dio, una sorta di “febbrile corsa verso la Meta, il Viaggio come meta, prolungando il piacere all’infinito” – come si legge sulla quarta di copertina. Il capitolo VI “Ritmo e Danza” si apre con un bellissimo testo poetico di Licciardello che comincia così: “Seppi tutta la libertà quando cominciai a danzare/ Seppi il Divenire dell’Essere, l’Essere del Divenire”.
Concludo riportando una considerazione molto interessante sull’attuale destino dell’Europa: “Quanto all’Europa, ferita nella Liberté di bestemmiare le religioni altrui, tutti convengono che dall’Illuminismo non si torna indietro – infatti è la religione inconsapevole europea, l’ipocrita laicità dei Massoni (non erano laici ma cristiani imprenditori) – mentre in Grecia trionfa la democrazia di Tsipras. Ma quanto più l’Europa si arrocca nella sua esclusiva Liberté ideologica (lasciando egalité e fraternité all’etica cristiana), tanto più è destinata a soffrire i contro-fondamentalismi – sionisti, islamisti, razzisti, localisti, terroristi. Solo discutendo alla pari con altre culture, altre energie, altri modelli, potrebbero sciogliersi le corazze identitarie – che non esistevano per i grandi romantici tedeschi e fino a von Humboldt: le lingue che parliamo sono “indoeuropee”, veramente noi non siamo illuministi, siamo indoeuropei. E infine siamo, dovremo essere un’interdipendenza globale, un’umanità post-europea, policentrica.” (gennaio 2015, pag. 360).
Credo che proprio a questa meta stiamo avviandoci: il quando, però, verrà raggiunta dipenderà da troppe cose. In ogni caso è quello a cui l’umanità sembra destinata.
Id: 1021 Data: 13/01/2017 12:00:00
*
 Anna Maria Curci - Poesia - L’arcolaio
Anna Maria Curci - Poesia - L’arcolaio
Nuove Nomenclature e altre poesie
La severa, difficile, spesso ruvida poesia, nonostante la sofisticata trama sonora, di Anna Maria Curci si esprime in questa silloge (il cui titolo Nuove nomenclature ed altre poesie già si fonda, almeno per quanta riguarda il primo sintagma su di un’ambigua o, meglio, ambivalente lettura definitoria e/o ideologica) attraverso un abbondante ricorso alla figura della metafora.
Quest’ultima talvolta cede il passo all’impianto narrativo di una fiaba prossima all’immaginario inventivo dei Grimm, ma riadattata allo scopo, come accade nel testo a pagina 70, in cui la Fata-Musa Talia preconizza il destino letterario, (che somiglia, fra l’altro, ad un sintetico e più che calzante giudizio critico) della Curci, offrendole così il suo singolare dono: “Sia la tua veste fatta di percalle”, e, qualche verso dopo, un altro strano personaggio, Obliquo, ribadisce: “Non cercare tra sete il tuo tessuto”. Il messaggio è chiarissimo: la Curci avverte il lettore della sua poesia che si troverà di fronte ad un textum poetico (textum, appunto, come tessuto) fittissimo fatto di una notevole quantità di fili mescolati insieme, eppure finissimo nel suo esito finale.
In questo modo la Curci oggettiva e “drammatizza” la consapevolezza della sua diversità, più volte orgogliosamente ribadita, e della sua creativa follia, che anch’essa si oggettiva in una figura (Halde, pag. 28) che si aggira in una discarica abusiva, intenzionata a resistere ai miasmi, e a “volteggiare” “sulla lordura”.
La lordura che la poesia della Curci intende sorvolare, librandosi in cieli più netti e confortevoli, si riferisce tanto a quella dell’assetto politico del mondo contemporaneo (è utile a questo proposito leggere il testo Assetto a pag. 21) ed ad ogni sua “sottaciuta, pervicace, scostumatezza possibile, tara d’ideologia e tabe del Potere”, come scrive il prefatore Plinio Perilli (spiegando, così, l’allusivo riferimento della Curci alla nomenklatura sovietica nella scelta del titolo), che a quella della poesia contemporanea: “aria fritta (…)con blatte” o, se si vuole, nonostante o proprio a causa del vacuo eccesso del verseggiare contemporaneo, “muto impasto e sale”.
Già il testo d’apertura Sotto coperta mi sembra possa essere letto in due modi: una prima lettura confermerebbe una risentita stigmatizzazione dell’ipocrisia politico-morale sulla questione dei profughi e dei clandestini (su quest’ultimi l’autrice ricama un bel testo sull’etimo del termine ‘clam- destino’); una seconda lettura, più incline a ravvisare una significazione metaforica, potrebbe alludere alla clam-destinità di un coro di poeti sommersi ai quali chi sta meritatamente o no alla guida del marchingegno culturale appena rivolge una “lieve degnazione”.
Volare alto, librarsi sopra, essere Fuori classe (pag.53) richiede, di fatto, una forte dose di resistenza, un’abnegazione feroce, poiché l’idillio di natura non ristora/ chi sceglie l’auto-inferno. Al lettore Anna Maria ha il coraggio di ammettere (pag.50): Pare facile, dici,/ dispensare bellezza/ da una corda di basso./ Ma il drappeggio è salato, dove il termine ‘drappeggio’ ancora una volta richiama il textum del testo, ed il termine ‘salato’ il verso dantesco ‘quanto sa di sale lo pane altrui’ e, perciò, di fatto, includerebbe quell’atteggiamento di aristocratico e puro auto-esilio della scrittrice all’interno della società letteraria.
Certo ci vuole una grande perizia nel portare avanti con rigorosa eleganza la composizioni di versi insieme aspri e sonanti, una virile disposizione alla lotta che ricorda la forza vitale del Tirso, bastone sacro di Dioniso e delle seguaci del suo culto: le Menadi. In un testo (pag. 68) la Curci scrive: Con Pastior porto le civette ad Atene; gelosamente, al ritmo di Tirso, verso che conferma, fra l’altro, quel profondo spessore culturale, così abbondantemente dispiegato in questa silloge, talvolta nella filigrana nascosta della costruzione verbale; talvolta, e in modo evidente, attraverso precisi riferimenti ad altre culture ed autori ed opere letterarie.
L’immaginario di questa duttile poesia spazia dalla mitologia all’etimologia, dalla storia antica a quella privata (bellissimi i testi che ricordano l’esperienza infantile della seconda guerra mondiale, come a sottolineare una lontana iniziazione al male e al dolore), e da questa alla cronaca contemporanea, dalla geografia privata a quella globale, dalla pittura al cinema fino alle molte letture di un fecondo percorso culturale e molto altro ancora.
Esso, inoltre, trova, una varietà sorprendente di esiti espressivi, quali settenari, distici, endecasillabi, che si avvicendano in testi di varia lunghezza: dalla brevità dei distici (a volte aforistici) alla distesa musicalità dei testi dell’ultima sezione: Canti dal silenzio.
Quanto finora detto potrebbe far supporre al lettore di trovarsi di fronte ad una poesia algida, tutta partorita “di testa”; ed, invece, la laboriosa ricerca della parola, la rifinitura sapiente, il lessico spesso corrosivo, se disciplinano, non comprimono la partecipazione vibrante, la passione civile ed esistenziale, l’empatia con le creature viventi, e, soprattutto, l’incandescenza del sentimento della poesia con la quale la Curci traccia una cartografia della realtà: è con quest’ultima che l’autrice ingaggia una lotta senza quartiere a difesa di una nuova etica che la rinnovi, che la sacralizzi nuovamente a cominciare dall’ascolto del silenzio, dal quale soltanto può di nuovo, come scrive Perilli, rigermogliare la Voce.
Id: 1016 Data: 02/12/2016 12:00:00
*
 Carla de Falco - Poesia - Temperino rosso
Carla de Falco - Poesia - Temperino rosso
Rime d’amore e di frontiera
I testi di Rime d’amore e di frontiera si inseriscono agevolmente all’interno di quella linea poetica mediterranea caratterizzata da una chiarezza espressiva tesa al raggiungimento di un’immediata comunicabilità.
L’autrice sa benissimo di essere una voce pressoché fuori moda, “fuori fuoco, fuori onda, fuori coro/da risuonare praticamente muta”, all’interno di una produzione poetica per lo più votata ad un freddo tecnicismo e ad un cerebralismo criptico che è una delle cause della perdita di consensi che oggi affligge quest’arte fin troppo esercitata e, tuttavia, scarsamente circolante al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori.
Carla intende, invece, recuperare un rapporto d’intesa con il lettore (chiamato più volte in causa a partire dal verso iniziale della prima poesia della silloge: “potrei dirti che tutto è della morte”), spostando l’attenzione della poesia verso soggetti semplici, convinta che “ci sia da fare tanto sui dettagli/ più che sulle cose che dicono importanti”, quelli che fanno parte dell’esperienza di ogni uomo, così che egli sappia finalmente riconoscersi nelle parole del poeta.
Né per questo motivo la poesia della de Falco corre il rischio di cadere nella banalità. L’autrice, infatti, sa come emblematizzare e universalizzare gli oggetti del suo teatro visivo-esperienziale, proiettandoli in una rete di echi e rimandi sonori e di suggestioni emotivo-intellettuali, attraverso cui fare vibrare le domande di una costante ricerca di senso dell’avventura esistenziale.
La mediterraneità della poesia della de Falco trova, inoltre, una seconda via d’espressione grazie all’abbondante tavolozza di colori (blu cobalto, verdi, azzurri, giallo oro) degli elementi naturali: il mare, innanzitutto, e la vegetazione tipica ( fico, cactus, peonie, mandorli, aranci, ulivi) e gli animali della campagna e dei monti e dei cieli del suo Sud. La loro presenza è così numerosa all’interno di questa silloge e così esatta la loro nominazione da farne per il lettore quasi un piccolo manuale sulla flora e la fauna del Mezzogiorno d’Italia: essi, tuttavia, contribuiscono non solo a disegnarne un ritratto vivido e pulsante di vita paesaggistica, ma si impongono quali strumenti alludenti a eventi e rivolgimenti storici del passato, così come ai mali che l’affliggono ancora.
Un testo quale Il percorso di un’origine, apparentemente descrittivo, grazie all’uso di una forte connotazione aggettivale, fra l’altro simmetrica, (ogni albero è caratterizzato da due aggettivi) di un baobab, di un cedro, di un ulivo (portati tutti in Italia dai popoli conquistatori), si arricchisce di significanze più profonde e può essere letto come un invito alla condivisione del dolore di un popolo sempre in lotta con una “idra nera/aizzata da lividi caronti” (il sistema malavitoso e la corrotta amministrazione del potere); e gli aggettivi, di cui precedentemente si parlava: magico , sapiente, regale, stanco, torto, duro, raccontano un percorso di fatica, di bellezza, di sacrificio, di luminosità ed insieme di oscurità, di vita e morte.
Così, attraverso un linguaggio che nella sua postfazione Giuseppe Vetromile definisce “morbido”, passa la forza di un impegno morale e civile, che soltanto in un testo trova parole durissime e taglienti: “lo scrittore non è veliero da bottiglia / la sua parola è acido che brucia / il suo cuore è tamburo che risveglia”. Dunque, questa è la poetica di Carla de Falco, questa la sua tempra umana, forte, sdegnata, appassionata, così come quando dichiara il suo amore al compagno di vita o all’ultima nata che le dorme addossata sopra l’incavo tiepido delle clavicole.
L’amore è, appunto, il tema principale della quarta sezione della silloge, il cui titolo Esilio personale dice qualcosa in più rispetto ai testi in sé stessi: che l’autrice considera la sua vita privata come un territorio intatto di sentimenti e di piccole felicità, quasi una sorta di separazione dal resto del mondo in cui sembra prevalere l’odio. E, tuttavia, l’amore non è un sentimento escluso dalle relazioni della de Falco con gli altri e con la realtà: il disincanto, il dolore, lo sconforto non rendono la lotta inutile. Al contrario, danno la misura di una struggente tensione verso una trasformazione dell’umanità intera, attestano uno sguardo misericordioso verso l’altro, un ardore empatico, una pietas storico-creaturale: “sono qui a cercare giustizia” immagina di dire l’autrice alla verità che la interroga.
Del resto, la de Falco si autorappresenta ripetutamente in forme risentite, dilacerate, “in bilico perenne/ sopra una vertigine”, che è, poi, la condizione esistenziale d’ogni umana creatura immersa all’interno di un’instabilità e indefinibilità del reale, di una temporalità limitata fra gli estremi della nascita e della morte, fra affermazione di sé e negazione.
Infatti, in quasi tutti i testi della raccolta è evidente la scelta di una bitonalità: zone di luce ed ombre si contrappongono costantemente, immagini positive si mescolano con altre dolorose: sole e spine, terra nera e luce; fango terrestre e volo; colori chiari e squillanti si affiancano ad altri tetri: il sangue nero del vulcano e le lenzuola bianche “stese all’aria”.
Tutto questo per raccontare la complessità della vita, il furioso mescolio di gioia e dolore, di male e bene, ma anche per confessare che la poesia è un modo di cercare equilibrio, senso, motivazione. Sebbene essa sia impotente a guarire l’uomo, l’autrice afferma: “nel dubbio scrivo”, “per vuoto, per ansia, per paura,/come chi osserva da lontano un uragano/ e vi scorge un miraggio rannicchiato”, “per dare dignità al pianto e al riso / senza cedere all’insulto dell’applauso”, per ricucire insieme i frammenti di sé stessa: “chiusa nel divano di casa / a scrivere pagine mancanti,/ mi sono un poco rammendata”.
E, tuttavia, mai l’autrice coltiva solipsismi vacui. L’ultimo testo reset, che è uno di quelli che più mi piace per il suo disordine narrativo ben concertato e per la sovrapposizione della sfera personale e pubblica sottolineata da un’interessantissima coesistenza di più registri espressivi, mostra palesemente la funzione primaria che la poesia ha per la de Falco: il recupero di una comunicazione autentica e profonda in un’epoca in cui l’accesso a certi strumenti digitali induce a credere che essa sia alla portata di tutti.
Ma la de Falco, che, come ogni poeta coltiva il desiderio di una ben più profonda qualità comunicativa, è ben consapevole dell’inganno, se scrive di “covare/l’intima taciuta convinzione/ che tutto questo mio comunicare/ sia solo un rimbombare d’erosione// silenzioso buio che gratta/ dentro la paura./frana inesorabile./ arrestare il sistema”. Già, il sistema, lo stesso che pone ai margini la poesia come espressione “deviante”, e perciò così nociva per il mantenimento di uno status utile agli amministratori di una falsa democrazia.
Id: 995 Data: 02/09/2016 12:00:00
*
 Roberto R. Corsi - Poesia - Italic
Roberto R. Corsi - Poesia - Italic
Cinquantaseicozze
In questa originalissima silloge di Roberto Corsi una particolare attenzione meritano gli exerga (pag.8) che offrono al lettore importanti chiavi di lettura, a cominciare dalla citazione da Pasolini: Ecco quindi la mia conclusione: la rassegnazione non ha nulla da invidiare all’eroismo, la cui comprensione passa anche attraverso la considerazione di una sfumatura psicologica introdotta da una seconda citazione da Miłosz, il quale si chiede perché i poeti per lo più si vergognino di mettere a nudo la loro debolezza. Atteggiamento, quest’ultimo, smentito dall’autore, ma con effetti ambigui, attraverso un’acuta, ilare-grottesca auto-analisi (portata avanti non senza un’abbondanza di dettagli intimi), che però non serve ad assicurargli una piena assoluzione di fronte a sé stesso e agli altri.
La terza citazione da Franco Arminio siamo sospesi tra un passato che non passa e un futuro che è già passato sembra mettere in relazione questi due atteggiamenti, rassegnazione e debolezza, con quell’acuta percezione (propria di coscienze ipertrofiche particolarmente attente agli accadimenti personali e a quelli del mondo come lo è quella di Corsi) del tempo quale costante de-lusione di progettualità sia soggettiva che storica.
L’atteggiamento della rassegnazione, infatti, sembra solo in parte trovare la sua giustificazione in una sorta d’innata inettitudine di memoria sveviana, fatta per altro oggetto, come si è anticipato, diuna corrosiva quanto spiazzante auto-ironia diversamente atteggiata da quella dello scrittore triestino. Essa ha molto a che fare, invece, con la mutata percezione del ruolo del poeta e della poesia nella società attuale fino all’errato convincimento di una sua identificazione con la figura di un intellettuale impegnato, naturalmente di sinistra (anche se in questo nostro tempo sarebbe difficile riconoscerlo a seguito di una trasformazione profonda dell’idea e della pratica della politica), intendendo, fra l’altro, come impegno non tanto, o almeno non solo, un coinvolgimento di natura etico-intellettuale, ma una sorta di propensione all’ostentazione mass-mediale di sé stessi e della propria produzione artistica ideologizzata ed asservita agli interessi di partito.
La rassegnazione, dunque, più che un’innata inclinazione, si delinea come un sentimento reattivo di fronte ad un’incapacità di comprendere il mondo attuale e di trovare in esso uno spazio soddisfacente, a seguito di un’insanabile frattura che fa sentire un certo tipo d’intellettuale (come Corsi) sempre più fuori posto e inadatto.
I fallimenti privati nella sfera erotica, raccontati dall’autore con varianti e notazioni acutissime, sono metafore di un venire meno dell’adesione allo slancio vitalistico, di uno slittamento progressivo verso l’assurdità esistenziale della vita, che non può essere risolta se non con l’annientamento.
I cinquantasei testi che compongono la silloge di Corsi, si configurano, infatti, quali capitoli di un romanzo tragico, o, se si vuole, di una dolente confessione autobiografica (pervasa da una sensibilità poetica sostenuta da un ritmo interiore più che dalla musica degli schemi retorici), come si evince dalla sostituzione di ius con il proprio nome Robertus all’interno di una locuzione uti lingua nuncupassit ita ius esto, che era un formula testamentaria orale.
Tale affidamento all’oralità non fa che dare il colpo di grazia a certi dati di fatto, assunti orgogliosamente come riflessioni personali: il giudizio di inutilità del prodotto poetico, l’impossibile scommessa sull’incidenza dell’arte, l’utopia della sopravvivenza post-mortem, su cui l’autore più volte si trova a riflettere fra ironia e sconforto.
Il quarantottesimo testo, infatti, è una denuncia della desacralizzazione della poesia, dell’umiliante compravendita della notorietà e, dunque, della decisione da parte di Corsi di un’autoesclusione (“Cari tutti, / io mi sono fermato, ho ruminato a lungo i versi imparando/ a vararli da solo, danzando smorzando il silenzio degli altèri. E ho visto negli occhi/ di chi non ha saputo dir basta, scialando assegni a quattro zeri per proclamarsi/ e farsi proclamare poeta, il lampo del dubbio d’irrilevanza, come esantema/ improvviso in vecchiaia: non è cosa da augurare”, pag.63) da questo spesso sordido inganno a favore della salvaguardia di una passione (o abitudine, o vocazione, oppure ostinazione?) a cui non gli riesce di sottrarsi, nonostante tutto.
Dunque, c’è sempre uno scarto, “uno scompenso”, per citare ancora Svevo, “fra l’orientamento che l’individuo dà alla propria vita, e la curva che poi la vita descrive”: da esso si originano la paura, la rinuncia, la solitudine, ma anche la covatura ostinata di un sogno di rivolta estrema che è quello di mandare all’aria non solo la propria vita, ma il mondo tutto, che è poi lo stesso dell’inetto Zeno Cosini, protagonista de La coscienza di Zeno: “Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udirà e la Terra, ritornata alla sua forma nebulosa, errerà nei cieli, priva di parassiti e di malattie”.
La morte, il mare, l’amore sono i tre costanti co-protagonisti di questa narrazione poetica, ma gli ultimi due interpretano soltanto il ruolo di messaggeri di cui la prima si serve per annunciarsi continuamente al mondo, ché il mare dentro lo scrigno germina la rappresentazione del dolore, nasconde creature orrifiche, vomita sulla spiaggia frantumi, scorie, carcasse irriconoscibili (“cane, felino o nutria gigante”, LV, pag. 69)
Il mare di Corsi non ha nulla a che vedere con quello montaliano, simbolo di auto-purificazione, maestro di metamorfosi etiche; e le sue aguglie sono assai dissimili dalle anguille del poeta ligure, sebbene le richiamino per le loro forme “eleganti e oblunghe”, poiché non si fanno come quelle metafore del guizzo erotico vitale e procreativo, ma, al contrario, della morte affrontata con “occhio placido (…) senz’alcuna fibrilla di rimpianto!”, (pag.32).
L’amore, sottratto ad ogni idealità, sottomesso ad altri scopi e materiali intendimenti piuttosto che alla verità del sentimento, porta con sé un inevitabile sconfitta, un groviglio di dolore e tramortimenti interiori; si identifica tutt’al più con l’eros, con la sua ingannevole persuasione alla legge della procreazione, illusione d’eternità, che è invece calco in cui verrà colata la storia di tante morti future.
Né la donna è l’angelo dello Stilnovo, presente anche nei versi del pur pessimista Montale; infatti, non ascende mai verso orizzonti metafisici, ma resta sempre creatura terrena, assolutamente imperfetta, non bastevole, sebbene desiderata e qualche volta per poco vagheggiata come carne da conquistare, da conoscere attraverso i sensi. Se qualcuna di loro rimane legata ad un sentimento di rimpianto, è perché non è mai stata posseduta e si è come cristallizzata in una sorta di intangibilità, di lontananza onirica. Però, tutto sommato, è sempre l’eros l’unica prospettiva per una vita, definita, in modo sorprendente, un “ricciolo di pube”.
È la morte, dunque, la compagna costante della vita. L’autore la mette in scena già a partire dal suo mondo infantile, quando teme, leggendo per caso, su dei biglietti emessi dalla SALT, che “ la compagnia non risponde/ di morte o danni a persone e cose durante il tragitto”. Da allora egli viene abitato permanentemente dal panico di perdere i propri genitori. Così Corsi racconta questo incontro con la paura dell’assenza: “Questo il battesimo di Madame La Mort, la marchiatura a fuoco dell’umano/ nel burroso cervello di bimbo” (XII, pag.23). Eppure, il poeta non evita, in altri suoi testi, di analizzare un rapporto sostanzialmente fallimentare con i suoi genitori, scuotendo da questo sentimento archetipale ogni adesione a formule scontate e sostanzialmente ipocrite.
La desacralizzazione dei sentimenti, della Natura, dell’Amore non equivalgono, però, ad una concezione senz’altro nichilista. Tornando alla citazione da Pasolini quella “rassegnazione che non ha nulla da invidiare all’eroismo” si sostanzia di un’idealità fortemente tradita, di una sofferente consapevolezza di un’impossibile ritorno al mito della purezza; al mito, anzi in sé, come parola di grazia, come poesia.
In questo senso lo sguardo di Corsi sul mondo e su se stesso mi sembra molto simile a quello di Jep Gambardella (protagonista del film La Grande Bellezza di Sorrentino), che a sua volta ricorda lo sdegno mimetizzato da scialo dello scrittore Petronio, testimone della viziosa e babelica società romana al tempo dell’impero corrotto e crudele di Nerone, assimilabile a quella contemporanea. Ad un certo punto del film Jep confessa: “Ho cercato la grande bellezza e non l’ho mai trovata”, e non credo che un’affermazione simile sia lontana dal definire il percorso intellettuale di Corsi.
Pasolini così raccomandava ai giovani impanati nel brodo qualunquista della società borghese: “A tutto ciò si sfugge solo attraverso una esercitazione puntigliosa ed implacabile dell’intelligenza, dello spirito critico.”
È quello che fa instancabilmente Corsi. Il suo eroismo è la rinuncia ai falsi valori della società mass-mediale, l’esilio coatto ma puro ed intransigente, la resistenza interiore, quella resistenza-rassegnazione che l’assimila al destino di una cozza che si aggrappa a qualsiasi scoglio dove potere sopravvivere e difendere sé stessa tra il chiuso delle sue valve, fra l’altro imitate (e, secondo me, non è un particolare banale) dall’impostazione grafica dei testi che si dispongono lungo l’orizzontalità delle pagine, imponendo, a volte, un loro forzato spalancamento che consenta la lettura degli ultimi versi nascosti lungo le ombre prossime alla cucitura. Per non dire che tale disposizione mi sembra anche alludere alla piattezza del contesto sociale ed all’impossibilità di verticalismi metafisici della poesia contemporanea, ma forse vado troppo in là con la lettura di certi dettagli.
Tutto questo è detto da Corsi attraverso un linguaggio stupefacente, che, se per la lunghezza dei versi ed il tono prevalentemente narrativo, rimanda alla prosa, in realtà, per la costante tenuta ritmica, si rivela piuttosto un tentativo di lirica camuffata, che tuttavia non di rado affiora allo scoperto con versi di improvvisa e spiazzante luminosità iconica.
Ma la caratteristica più eclatante di questo linguaggio poetico è il suo febbrile impasto di aulicità e colloquialità (che fa pensare a Gadda, ma anche ai testi cinematografici di Pasolini), di raffinatezza e volgarità, il suo pullulare di citazioni, di luoghi topici, come di invenzioni originalissime, attestanti sia una lunga e ricca pratica di lettura, sia un esercizio severo, al limite dell’intransigenza, per trovare la parola esatta, vera, sferzante, provocatoria, nuova, che giunga al lettore con la precisione di una freccia che voglia ferire (pratica così nota, per esempio, a Céline). Gli echi intessuti in questa tramatura assai scenografica di versi, sono molteplici e vari: le tragedie greche e le favole, la letteratura e le canzoni, gli articoli giornalistici e i saggi, le opere scientifiche e i libretti di musica, i personaggi cinematografici e quelli del mondo sportivo. All’interno dei versi risuonano molte lingue: il francese, il tedesco, il latino, e anche espressioni dell’area dialettale tosco-emiliana.
È evidente, allora, che l’autore non mira, come scrive il prefatore Massimo Seriacopi, a “captare i gusti di un eventuale pubblico per blandirlo e conquistarne consensi e acquisti”. Del resto Pasolini, che a me sembra il punto di riferimento più importante per Corsi, così metteva in guardia gli intellettuali: “Il successo è l’altra faccia della persecuzione”.
Id: 994 Data: 22/07/2016 12:00:00
*
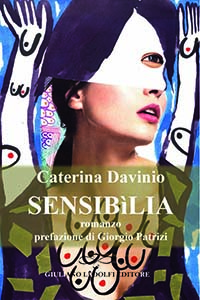 Caterina Davinio - Narrativa - Giuliano Ladolfi Editore
Caterina Davinio - Narrativa - Giuliano Ladolfi Editore
Sensibìlia
A pagina 47 del suo “Il bosco, il mondo, il caos. Come un romanzo”, Stefano Lanuzza scrive: “La poesia, quella vera, dovrebbe spaventare il lettore”. Questa citazione parrebbe inadatta a Sensibìlia, se non fosse che l’autrice attinge a piene mani, per fare avanzare il plot del suo romanzo, alla metafora (ossia alla figura poetica per eccellenza), che raggiunge il suo vertice inventivo nel capitolo VII, il cui stesso titolo: “Metafisica delle narici” favorisce di per sé un approccio tra il surreale e l’onirico.
Ciò premesso, “la poesia narrativa” della Davinio fa davvero spavento, e per il linguaggio crudo, violento, ossessivo, e per l’estremizzazione delle situazioni, e per l’intricato, spinosissimo roveto dei sentimenti, che contribuiscono, man mano che si procede nella lettura, a suscitare un inquietante e sconvolgente sentimento di identificazione con Luna/Carmela.
E non tanto perché le sue vicende possano più o meno coincidere con dei fatti strettamente personali, ma perché esse costringono il lettore a porsi di fronte a quel periclitante e oscuro confine tra bene e male, da cui difficilmente ci si ricorda di essere abitati, una volta messa a tacere la bestia sotto un cumulo di perbenismo morale, di comportamenti piccolo-borghesi, di consunti e abitudinari meccanismi del pensiero.
Luna/Carmela, binomio di “volgare” terrestrità e di metafisica angelicità, rompe gli argini fra il bene e il male: l’amore, dal quale è spinta ad agire, vittima e carnefice allo stesso tempo, origina un sorta di orgasmo mentale che, causando la perdita di ogni controllo psichico-emozionale, determina, a sua volta, una spirale inarrestabile di eventi sempre più malvagi, che ha come punto intermedio l’auto-annullamento nella relazione con il partner e come conseguenza ultima la nientificazione dell’esistenza personale e della vita, in genere.
La Davinio rivela una precisione chirurgica nell’affondare il suo bisturi all’interno di una psiche ormai surriscaldata da un pathos autodistruttivo, all’interno del quale l’emozione più sconvolgente è il piacere del male, che, in genere, costituisce un tabù narrativo: pochi scrittori vi si sono cimentati con tanta lucidità, specialmente quando si è trattato di raccontare il piacere legato ad un rapporto sessuale deviato, al limite dell’aggressività e della pornografia.
Maestro di quest’analisi in ambito letterario è certamente Sade con Le 120 giornate di Sodoma. Teorico Freud: “La natura umana è molto più estesa, nel bene e nel male, di quanto si creda” (in Io ed Es).
Già Caterina scriveva in una sua nota a Il Libro dell’oppio: “Di certe malattie del corpo e dell’anima forse è meglio non parlare, dissimulare, non turbare la suscettibilità di chi al mondo riesce a dipartire con tanta sicurezza il bene e il male, la salute e l’afflizione, il paradiso e l’inferno”.
Ed è questo la cosa che spaventa il lettore: che questa duplicità, questa relazione capovolta tra bene e male diventi per chi la metta in atto, come la protagonista del romanzo, una sorta di norma, fino addirittura a rivendicare per sé una bellezza del tutto autonoma dall’etica, in una sorta di ideale tragico che qualche studioso di psicoanalisi ha voluto vedere come una copertura del ritorno al vecchio ed ormai espulso “senso di colpa”.
La protagonista di Sensibilia non riesce, però, ad eludere del tutto questo senso di colpa, che la Davinio indaga con una correttezza e profondità analitica, le quali presuppongono un’ampia cognizione dei meccanismi della psiche umana e, prima di tutto, di se stessa.
Per dimostrare la “normalità” della deviazione, la Davinio sceglie una protagonista nient’affatto eclatante: Carmela non è più giovanissima, né particolarmente bella, ha perduto la madre, una sorellina, il gatto amatissimo, vive la sua condizione di moglie senza gioia, senza una soddisfacente sessualità, è mediamente colta, ama la musica classica e soprattutto Mozart. Eppure, dopo l’incontro con il signor X, si trasforma in un una sorta di “macchina sessuale”, inseguendo la “bestia” del suo io, tragicamente, teneramente, ossessivamente, impudicamente, distruttivamente, ma senza raggiungerlo o raggiungersi mai. Forse perché da questo sbilanciamento dei “sensi” sembra fuoriuscire, insieme alla sorveglianza dello spirito, ogni possibile interezza dell’io.
È interessante che il romanzo divida le sue sequenze narrative in sette capitoli: sette – si è portati a pensare- come i vizi capitali, sette come l’insieme di virtù cardinali e teologali, a ribadire la violata relazione fra vizi e virtù. Forse. Ma, ancora più veritieramente, sette in quanto somma dei cinque sensi: dell’udito, del gusto, della vista, dell’olfatto, del tatto (ossia le vie percorse in incessanti tragitti dal bene al male, dal piacere alla sofferenza, dall’eccitazione alla depressione, essendo il corpo la sola mappa del viaggio d’ogni vita), e di due sovrasensi, indagatori dell’invisibile e dell’immateriale. Se, poi, si ricorre ad una lettura metaforica, il sesto senso è quello che percepisce il nulla, anzi, è il nulla stesso; il settimo è quello della parola insensata, e, dunque, in modo particolare della poesia.
È, infatti, sorprendente, come all’interno di una vicenda patologica e affannata, la teorizzazione poetica trovi tuttavia il suo spazio attraverso un uso abbondante della metafora: il senso del male è percepito dalla protagonista come “un roditore che mi squassasse all’interno, che mi sguazzasse nelle mie viscere e nel petto”; il doppio nome della protagonista, come si è detto, allude alla doppiezza della natura umana; la bocca è “quella Grande Porta della Città di Kiev”, da cui sgorga, secondo la definizione di Hölderlin, il linguaggio, dei beni il più pericoloso”. Anche la ciliegia che rappresenta il gusto, è figura dell’Eros, “parola enigmatica di un dio al cui suono insolito si può uscire di senno”.
Potremmo continuare così, ricordando l’allusività del nome (Guazzo) del paese in cui Carmela si ritira con il padre per trovare un suo equilibrio, e che “il brillio di smeraldo” delle mosche carnivore è il colore della morte. E andare avanti e trovare altre metafore fino all’ultima pagina, ma senza la potenza visionaria che possiede quel Naso che ,come un personaggio del tutto stravagante ed enigmatico, all’interno di uno stato delirante della protagonista, dialoga con lei proponendosi come emblema della transitorietà della forma e della vita, dell’eterna presenza della morte, del nero abisso a cui convergono i fori oscuri delle nari attraverso le quali trascorre l’inconsistenza del respiro.
E ci sarà un motivo per cui proprio le narici parlano di poesia, esclamando: “Che sarà mai la differenza, che recita l’impossibile! Via via! Il dente è tolto, il dado è tratto, l’anima è resa e il poeta…È fregato!” e ancora: “Così la poesia sarebbe un’estrema padronanza, ma pure un’inattesa, sorprendente sottomissione alle intemperie dei linguaggi; si rimane totalmente schiavi della libertà, solo bendisposti a tutti gli incontri, alle occasioni. L’occasione è un orecchio predisposto al ritmo; si accetti di compiere il misfatto e di rimanere impuniti.” E, poco più avanti: “È questa l’arte? Una confusione sensoriale …strutturata?”.
A me sembra che proprio questa confusione sensoriale strutturata, che è la poesia, come ogni altra forma d’arte, costituisca l’appiglio grazie al quale Caterina si salva dalla morte fisica: durante il suo sonno comatoso, è Mozart, infatti, con la sua musica a sottrarla al nulla fino a riportarla alla superficie della vita in una stanza d’ospedale in cui persone e cose del suo passato “borghese” si fanno guardiani della sua “salute”. Incapaci , però, di colmare quella solitudine che rimane la sola compagna dopo un così feroce attraversamento dei territori del male.
Id: 986 Data: 01/07/2016 12:00:00
*
 Stefano Lanuzza - Narrativa - Stampa Alternativa
Stefano Lanuzza - Narrativa - Stampa Alternativa
Il bosco, il mondo, il caos. Come un romanzo
Il bosco come spazio di trasgressività
All’interno della destrutturazione del genere narrativo, dai primi tentativi della prosa volgare in Italia a quella logico-temporale del flusso di coscienza, per tappe intermedie; e, successivamente, per exempla più vicini, si inserisce il singolarissimo impasto linguistico de Il bosco, il mondo e il caos. Come un romanzo di Stefano Lanuzza, uno di quei pochi autori contemporanei che esercita la scrittura come gesto del tutto libero dal “pervasivo codice del dominio e delle sue predeterminate garanzie di senso”, così come da ogni scopo mercificatorio.
Come in un morality play medievale, il protagonista della narrazione è affiancato da una serie di figure allegoriche, quali la Malinconia, la Bellezza, la Verità, la Morte che ci avvertono del carattere simbolico del bosco nel quale egli si aggira. E come nelle storie medioevali del ciclo bretone lo scopo è la ricerca del Graal, che però“non è in un tempio, ma nel bosco. Questo accoglie un laico castello fatto di muri coperti d’edera e di glicine. Il castello rappresenta la forza creativa e simboleggia, soprattutto, un’iniziazione trascendente e ‘immortalante’”. Il riferimento è chiaramente dantesco (Inferno, canto IV, vv. 106 -150), tanto più che vi abitano spiriti pre-cristiani i quali hanno coltivato la cultura con il solo scopo di acquisire una conoscenza della realtà e dell’uomo lontana da ogni prospettiva escatologica, cosa che per Dante costituisce un limite, mentre per Lanuzza è lo stigma di una vocazione laica, autonoma e pura.
Il bosco, già presente nel titolo della silloge Bosco dell’Essere editata nel 2000 (e, perciò, da leggere quale trait d’union fra scrittura poetica e prosastica, emblematico della fluida continuità della quête intellettuale dell’autore), è indicato, da subito, come uno degli elementi naturali (insieme al mare ed al falco ed alla casa di pietra) del paese natale dell’autore (Villafranca Tirrena): “Nato tra un bosco e il mare in una casa di pietra abbracciata dal glicine e lambita dal volo d’un falco solitario”. Così ha, infatti, inizio Il bosco, il mondo il caos. Come un romanzo.
In realtà il collocamento di quest’opera in prosa all’interno del genere romanzesco, come suggerisce l’autore, non è così ovvio. Pur essendo rintracciabili, infatti, gli elementi fondanti del genere (un protagonista principale, che è lo stesso autore; una serie di comparse o “attori” comprimari; una collocazione temporale per lo più deducibile da una serie di notizie sparse; una serie di cornici spaziali ed un plot con una sequenza di nodi drammatici), la varietà degli esiti espressivi (aforismi, frammenti saggistici, lacerti autobiografici, riflessioni storiche, citazioni, definizioni, abbozzi d’articoli di taglio giornalistico, formulazioni di poetica e molto altro ancora) potrebbe costituire una peculiarità ostante, a meno che non si voglia fare confluire tutto questo in una innovativa tipologia di romanzo, come racconto di un’avventura strettamente intellettuale.
A ciò indirizzano gli attori comprimari, connotati di un forte significato allegorico, la meta-spazialità (“spazio del viaggio nel bosco non è quello topografico, ma dell’esistenza”, pag. 9), l’accumulo delle esperienze e, come prima si accennava, i rapporti di ordine filosofico-conoscitivo che si vengono a stabilire fra bosco, mondo e caos. Il caos, intanto, appartiene ai primi due, ma con una netta diversificazione di senso. Se, infatti, il caos s’identifica con il disordine e l’errore che governano il mondo, quello che appartiene al bosco (Ordinato… caos del bosco, pag. 3) ricorda la visione positiva di certi autori degli ultimi anni del Novecento come Rodolfo Wilkock secondo il quale caos è “il momento di illuminazione in cui si percepisce la verità finora celata, e, mentre con rammarico si constata che perde senso ogni valore fino a quel momento seguito, ci si può immergere in una nuova esistenza”; o come Guattari e Liu Sola, per i quali il caos “è un disordine piacevole e volutamente cercato, una incontrollata proliferazione di linguaggi, di comportamenti” e perciò “un dispiegamento liberatorio di energie”, “la moltiplicazione dei punti di vista e della possibilità di scelta individuale della propria esistenza, che germogliano, come la vita stessa, dalla distruzione e dal rovesciamento dell’ordine preesistente” (Dizionario dei temi letterari, vol. I, pagg. 363, 364, Torino, Utet, 2007).
Una volta vagliati titolo e sottotitolo di Il bosco, il mondo, il caos. Come un romanzo, sarebbe inopportuno distogliere l’attenzione dalla copertina e trascurare l’analisi di un’immagine che si integra perfettamente con la sostanza del testo. Si tratta del celebre ritratto di Don Manuel Osorio de Zuñiga, dipinto da Goya nel 1788. Il bambino, vestito di rosso, tiene legata ad una cordicella una gazza, fissata avidamente da tre gatti. Alla sinistra del bimbo una gabbietta meravigliosamente traforata contiene alcuni volatili: una tortora, sei uccellini giallo-neri e cremisi e dei cardellini. E poiché nel linguaggio simbolico gli uccelli che si alzano verso il cielo rappresenterebbero l’anima e l’innocenza (nelle favole si racconta che chi comprende il loro linguaggio conosce il mistero della vita), ed i gatti le forze del male, si potrebbe pensare ad una illustrazione dei confini che separano il fragile mondo infantile da quello degli adulti, o anche ad una allusione alla natura doppia dei bambini, innocenti nella loro crudeltà, sapientissimi nella loro immaginosa ignoranza.
Lo stesso Stefano Lanuzza definisce il ritratto “un quadro metafora dell’infanzia” che gli ricorda quello più recente di Savinio (Autoritratto da bambino, 1927) e scrive: “‘Fisica’ di Goya e ‘metafisica’ di Savinio: in tali due estremi la condizione dell’infanzia, sospesa tra realtà e fantasia, corpo e sogno, tragedia e beatitudine, incertezza e orrore, un sesso e un altro sesso. Perché i bambini di Goya e Savinio, i bambini in genere, sono spiritualmente ermafroditi: nella stessa condizione dell’artista per il quale – scrive Savinio – “la vita adulta è la continuazione naturale dell’infanzia” (pag.20). Appena prima l’autore aveva definito l’infanzia come una “pregrammaticale lingua morta”, “un’incommensurabile riserva di lessici e urlo muto”: identificandola tout court con quella stessa della poesia alla quale non interessa né imitare il linguaggio della storia o la dialettica ideologica, ma raccontare “la favola tremenda dell’infanzia”. E conclude: “Nessun dubbio nella scelta fra adultità e infanzia: una mente libera sceglierà, per una volta senza dubitare, il proprio cuore giovane. Qualcuno capisce come non si possa restare fedeli che a questo e soltanto a questo?”
E, dunque, il bosco che risuona di voci non-umane, di presenze “in-nocenti” ed “in-fanti”, di creature libere e violente come quelle dei rapaci, che obbedisce ciecamente al ritmo delle stagioni, che è kòsmos e libertà, armonia e follia creativa, dove vivono insieme le annunciazioni di vita e di morte, isola di solitudine, se pure all’interno del mondo, è “la Grande poesia: un bosco, che non fa parte dell’usuale paesaggio della comunicazione”.
Ricomponendo i frammenti sparsi nell’opera dell’autore, si potrebbero ricavare: un compiuto trattato di Estetica della Poesia; un saggio storico sui rapporti politico-economici fra Oriente ed Occidente; uno svelto taccuino di viaggi; un’autobiografia, sia pure sviluppata attraverso pochi punti nodali; una mappa delle letture dell’autore e delle sue preferenze nel campo dell’arte figurativa; una sintesi dei più recenti ed efferati fatti di cronaca; una raccolta di aforismi, ed anche più di questo.
In ogni caso il fare, l’essere, il morire sono sottratti a qualsiasi senso ultimo; prima c’è il Nulla e dopo c’è solo il Nulla. Si comincia la lettura del libro a pagina 3 e, già dopo poche righe, la data di nascita 20-XI richiama quella della morte, nello stesso giorno e nello stesso mese, di Tolstoj: il quale porge al ragazzo che nel frattempo ha sostato confuso e incerto nel “Bosco dell’Essere” l’invito a “svignarsela”. Là egli va per liberarsi “dalle panie del sistema di cose quanto dei propri luoghi stanziali e dell’abitudine dell’‘abitare’ […] fino al rischio dell’esilio (pag. 14), “mano nella mano con un Angelo dalle ali scure” (pag. 16), che infine lo abbraccerà “avvolgendolo fra le coperte d’un letto fatto d’aria” (pag. 89).
Anche in questo libro come in tutti gli altri, non esclusa la sua produzione pittorica, Stefano Lanuzza celebra la trasgressione in compagnia di un falco. Il bellissimo rapace lambisce la casa di pietra dove ha inizio la vita dell’autore (pag. 3); e con esso, nell’età della giovinezza, egli intesse un rapporto d’amicizia. “Attraverso i boschi dei siciliani Nebrodi abitati dalla volpe rossa e dal notturno gatto selvatico, lo porti verso il monte Soro nei posti dove può procurarsi il cibo”, scrive a pag. 105 di Bestia sapiens (2006), dove come esergo viene citata una poesia di Montale dedicata ai falchi, e nella pagina che affianca l’Antefatto campeggia un disegno del volatile ad ali spiegate.
Che altro è il falco? Le risposte potrebbero essere molteplici e perfino fuorvianti, mi avverte lo stesso scrittore cui ho chiesto di rispondere alla domanda: esortandomi a pensare al falco come a una “kantiana cosa in sé”, a guardarlo “come-esso-è”: “una forma estetica perfetta”, che ha sempre stimolato la sua fantasia.
Id: 985 Data: 03/06/2016 12:00:00
*
 Alfonso Lentini - Narrativa - Mauro Pagliai Editore
Alfonso Lentini - Narrativa - Mauro Pagliai Editore
Luminosa Signora
Lettera veneziana d’amore e d’eresia
(Postfazione di Antonio Pane)
“Se fossimo compiuti, ci basterebbe una sola parola. Una sola. Se invece ne usiamo moltissime è perché non abbiamo ancora trovato la parola assoluta, quella che esprime e riflette la totale compiutezza”. Mi sembra di dovere partire da questa affermazione per dire qualcosa di ragionevole su questo libro di Alfonso Lentini, Luminosa Signora, così camaleontico, così originale da sottrarsi ad ogni inquadramento in un determinato genere letterario.
È vero che il sottotitolo recita: Lettera veneziana d’amore e d’eresia, eppure il testo si sottrae a dei tòpoi fondanti del genere epistolare, come per esempio l’intestazione e la determinazione temporale; e, inoltre, l’accostare termini come “amore ed eresia” lo fa slittare verso una sorta di quète du Graal; che sembra avere come meta quella parola assoluta a cui egli allude nel brano precedentemente citato.
Ma la parola assoluta esclude metafisicamente, se non teologicamente, le altre: di fronte al Verbum iniziale, di natura divina, che in sé include il tutto nominabile, si contrappone il linguaggio umano che questo Tutto frantuma in minuscoli segmenti del discorso, così da trasformare la Verità in una moltitudine di ipotesi, in uno strappo irreparabile che rasenta l’eresia.
Lo strappo si concretizza in quella ferita, solco fra due lembi che mai più si toccano, che guasta il volto di quell’io narrante, identificabile non soltanto con l’autore, e infatti i pochi eventi narrati non sono del tutto conciliabili con la sua biografia, ma con un’intera generazione: quella post-sessantottina; e, infine, anche con ogni umana creatura.
La ferita post-sessantottina, narrata attraverso la figura emblematica del padre, grande sognatore e narratore di utopie, riguarda ancora una volta il tradimento perpetrato ai danni di quella Parola Assoluta, spesa da una generazione fantasiosa ed eroica per la conquista dell’ “uguaglianza” e la realizzazione del sogno impossibile di “far coincidere l’uno con il molteplice”.
Il fallimento, essendo determinato dalla friabilità stessa del reale, si emblematizza in quella ferita immedicabile, che può essere anche l’inizio di un desbordamento, di un delirio finale o follia, così come accade al padre del narratore che muore in un’isola della laguna veneziana. È lui che incarna la follia del sogno, dell’utopia, della fede ideologica.
La Parola poetica, che si illude di rifondare il reale e di eternarlo, rappresenta anch’essa un’utopia che attraversa il mondo da sempre. Per questo motivo la luminosa signora è raccontata ora secondo gli stilemi del dolce stil novo, ora secondo una sovrabbondanza metaforica tipicamente seicentesca, ora secondo l’emblema per eccellenza romantico della Luna, non per niente scelta dal Leopardi come la sua “eletta figura”, come direbbe Cristina Campo; ma anche come un’adolescente contemporanea che si veste e si comporta spregiudicatamente e che possiede perfino un cellullare, così come la raffigura spesso anche il poeta Barberi Squarotti.
Chi è, dunque, questa misteriosa e luminosa Signora che dà titolo al testo, se non la Parola poetica che tenta di portare all’Uno tutto il reale? (“Scrivendo non faccio che copiare. Copio il suo corpo, così come lo vedo in sogno”). Quella Parola incantata che sta “fra l’essere e il non essere”, così come la città di Venezia, in cui gli eventi di questa trama insieme “storica” ed evanescente, questi personaggi veri ed utopici hanno la loro ambientazione?
Nella luminosa signora si rispecchia la realtà destinata alla morte, eppure trasportata in una dimensione eternante. E però essa, che è sempre viva, oltre i singoli, oltre i tempi della Storia e delle storie, non può rispondere alla Domanda più importante: perché tutto muore? E se la morte ha a che fare con la parola umana, quale altra parola dovremmo inventare? La domanda è reiterata, disperata, al limite dell’eresia, perché presuppone, come scrive Stefano Lanuzza, “una dubbia divinità o prova certa del fallimento della creazione” (“Siamo ipotesi di esistenza, modelli di creta o di gesso”).
E soltanto una volta, e soltanto nel sogno, sembra che la Signora risponda alla Domanda: “Avreste dovuto raccontare, costruire una lingua, che so, un qualsiasi sistema di segni o figure. Mantenere un filo. E invece. Invece avete permesso che arrivassero. Avete consentito che portassero via le montagne, sradicandole dal suolo come fossero cespugli. Avete permesso che chiudessero a chiave le aquile, riponessero i lupi nei cassetti, le scimmie negli armadi”. La Signora, insomma, dice quello che potrebbe dirgli il padre: che sarebbe necessario fare rivivere certe utopie per ricostruire le montagne, cioè l’altezza dei grandi ideali, le vette dell’utopia. E risponde lei perché la scrittura poetica e l’immaginazione utopica sono un po’ la stessa cosa.
L’altra risposta è quella del narratore che al silenzio distruttivo della Morte oppone l’incantevole personaggio del suonatore di silenzio, che, mentre sta dirigendo i suoi orchestrali, ad un tratto, con uno scatto della mano chiusa a pugno, li fa tacere, immergendo il pubblico in un silenzio incantato, cristallizzato, ma popolato, pieno di suoni immaginari e bellissimi.
Mi rendo conto che questa che sono venuta tracciando sia solo una delle tante letture che di questo libro fervido e cangiante si potrebbero fare. Ma, al di là di ogni interpretazione soggettiva, ciò su cui ogni lettore dovrebbe soffermarsi è la raffinatissima elaborazione stilistica del testo, più prossimo alla poesia che alla prosa. I periodi frantumati, in cui sono disseminati simboli, metafore, immagini fiabesche somigliano a dei versi. Alcuni di essi ricordano per levità e la trasparenza della loro tessitura verbale a dei vetri soffiati, a delle perfette ragnatele che catturano colore e luce. Uno per tutti: “Una barca scivolava sulle increspature e il barcaiolo ritto in piedi sollevava con il remo lembi d’acqua come se girasse pagine trasparenti.”.
Gli echi letterari sono tantissimi: Mann, Vittorini, Montale, gli Stilnovisti, ma mi ha sorpresa di più, forse perché inusuale, il riferimento ad un episodio del romanzo di Curzio Malaparte “La pelle”, in cui, per esattezza nel capitolo settimo, a Napoli, in occasione di un banchetto a cui sono stati invitati ufficiali alleati e signore americane, viene servita la Sirena, pesce dell’acquario della città, che ha l’aspetto di una bambina bollita. A pag. 48 del suo libro, infatti, l’autore, sfrondandola, però, d’ogni elemento macabro, descrive una sirena allevata “in una grande vasca di vetro”, bella come un cherubino “con il sorriso ingenuo e compiaciuto”: immagine fascinosa di una leggendaria età di miti e di sogni, così come ce la restituisce un altro scrittore siciliano: Tomasi di Lampedusa.
Alfonso Lentini ci consegna, allora, un trattato di poetica che è anche una sorta di “manuale” di sopravvivenza etica allo sfascio degli ideali e delle utopie che ha devastato il mondo contemporaneo. E lo fa all’interno di una trama surreale che ha l’allucinazione di un sogno, il movimento lento di uno sprofondamento dentro una dimensione a-temporale.
Id: 978 Data: 29/04/2016 12:00:00
*
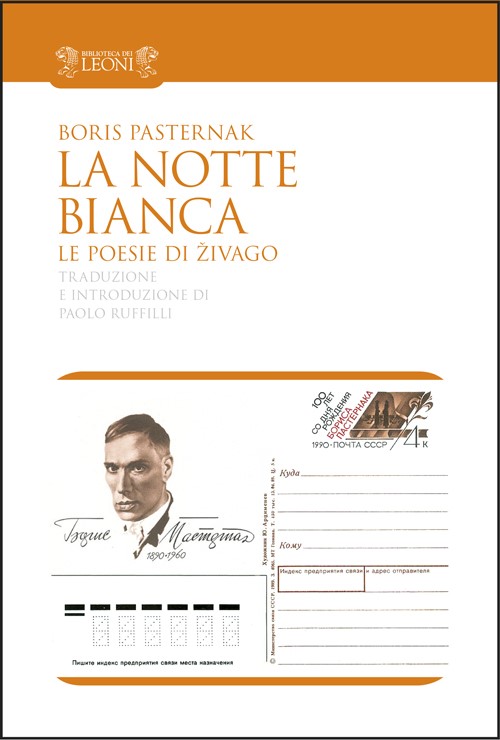 Boris Pasternàk - Poesia - Biblioteca dei Leoni
Boris Pasternàk - Poesia - Biblioteca dei Leoni
La notte bianca. Le poesie di Zivago
Già nell’edizione del celebre romanzo “Il dottor Živago” di Pasternàk per la collana dedicata ai premi Nobel della Letteratura, curata dall’Utet, il prefatore Ettore Lo Gatto scriveva come la parte in versi del romanzo potesse considerarsi “come prolungamento e, più precisamente, approfondimento del monologo dell’autore, dove l’elemento autore e l’elemento Živago si fondono fino a diventare indivisibili”.
Gli fa eco Paolo Ruffilli (che ha recentemente curato le traduzioni delle poesie di Živago per la casa editrice Biblioteca dei Leoni), quando nella prefazione afferma che questi testi poetici “ripercorrono l’intera vicenda di Jurj nel romanzo, facendo da riassunto per “tappe” del percorso esistenziale e costituendo ciascuna la “stazione” e “icona” di una fase, di una meta, di una caduta, di una ripresa, di un ritorno.
Ma certamente il fil rouge più evidente fra prosa e poesia del romanzo è costituito dalla presenza costante della natura, che non ha una funzione descrittivo-ornativa, ma che, al contrario, essendo dotata di una sensibilità quasi umana, potrebbe essere letta come una sorta di “personaggio” aggiuntivo, avente una funzione assai simile a quella del coro della tragedia classica, che commenta, condivide e accentua le vicende personali e le situazioni emotive dei protagonisti.
Una così profonda attenzione da parte di Pasternàk nei confronti della natura ha catturato l’attenzione dei critici che si sono occupati della sua produzione letteraria, alcuni dei quali hanno parlato di animismo, altri di misticismo, o, addirittura, di un panteismo di impronta cristiana.
Tutti, comunque, a partire dalla poetessa Marina Cvetàeva, hanno sottolineato l’elemento “meteorologico” nella poesia di Pasternàk. Lo fa anche Ruffilli, che nella prefazione (pag.19) così scrive: “Sempre e comunque, oltre al nucleo intellettuale o al racconto in sé di ogni singola poesia, restano al lettore, altra virtù della potenza espressiva di Pasternàk, le suggestioni che si scatenano dal compiersi attraverso le parole delle variazioni metereologiche che caratterizzano e attraversano la vita nelle diverse ore e stagioni”.
Le poesie di Živago sono state tradotte per la prima volta in italiano per la Feltrinelli nel 1957 da Pietro Zveteremich; nel 1970 l’Einaudi pubblicò un’edizione speciale con una bella introduzione di Eugenio Montale (che parlò di un “personale imaginismo metaforico e musicale” di Pasternàk). Tra le successive edizioni (a parte le altre della Feltrinelli), è da ricordare quella a cura della CFR (2014) per l’efficace traduzione di Paolo Statuti. Ma la più bella traduzione resta quella che ne fece Angelo Maria Ripellino per la già ricordata pubblicazione, nel 1968, curata dall’Utet.
Adesso il poeta Paolo Ruffilli ci offre una sua traduzione dei testi poetici di Živago; e il confronto con i precedenti traduttori non delude affatto. Piace molto, infatti, l’adozione di una misura ampia del verso, che sottolinea la fluida narratività dei testi e la loro forza irruente, in stretta relazione con la prosa.
Quando è stato possibile, Ruffilli, per restituire al lettore quella musicalissima qualità del lirismo trasfigurante di Pasternàk, ha fatto ricorso alle rime, per lo più alternate e incatenate; e, quando il lavoro di trasposizione linguistica gliel’ha impedito, a consonanze ed assonanze.
Questa attenzione al tessuto sonoro della poesia fu per Pasternàk una sorta di vocazione, tant’è che egli per molti anni studiò musica, e, anche se rimase sempre un musicista dilettante, l’influenza che essa esercitò sulla sua composizione poetica fu notevole. Non a caso Angelo Maria Ripellino parla, a proposito di queste poesie di Živago, di “tessiture fonetiche”.
È probabilmente questa vocazione musicale che gli permette di sentire la natura, le sofferenze e le gioie umane, il mistero destinale di tutte le creature come un solo canto, ora triste, ora lieto, che si alza dalla terra: “Palpebre chiuse, serrate strette,/Supreme altezze del cielo. E nuvole. /Fiumi. Guadi. Acque correnti. /Anni e secoli a venire” scrive in “Fiaba” (pag. 59-63); ed è davvero significativo che questi versi siano ripetuti due volte e che comunque chiudano questa composizione, perché è nella fiaba che il tempo e lo spazio si trasfigurano, che uomini, piante e animali parlano lo stesso linguaggio, che ubbidiscono alle leggi cicliche della metamorfosi e del sacrificio.
Ruffilli, inoltre, lascia intatte metafore e metonimie così care alla poesia dell’autore, ne asseconda i dettagli visivi, la tenerezza, lo stupore, la semplicità così apparente, se non si è capaci di cogliere echi e rispondenze segrete.
Infatti, come ricorda lo stesso traduttore nel presentare la poesia di Pasternak, essa è quella “spugna” capace di restituire in tutti i suoi molteplici aspetti (esperienze, vicende, avvenimenti) e in tutte le sue infinite sfumature “la semplice complessità della vita” (pag. 21).
Id: 974 Data: 08/04/2016 12:00:00
*
 Alessandro Mantovani - Poesia - L’arcolaio
Alessandro Mantovani - Poesia - L’arcolaio
Poesie dopo la festa
Dalla rabbia alla benedizione: il percorso del poeta Alessandro Mantovani
Non c’è bisogno di leggere la breve nota bio-bibliografica di Alessandro Mantovani a pagina 71 di “Poesie dopo la festa” per capire che ci troviamo di fronte alla poesia di un giovane autore. E non perché vi sia una qualche acerbità nella sua cifra stilistica (la quale, invece, appare così matura da permettergli di giocare con lemmi e suoni, di inventarli o di ridare nuova vita ai vecchi) o nelle tematiche affrontate (ché, anzi, i nuclei concettuali intorno ai quali gravitano i versi sono di rilevante portata esistenziale), ma perché vi domina un’energia impetuosa e vitalissima, propria dell’età fra adolescenza e maturità.
Si tratta, insomma, di una sorta di traboccamento del sentire incapace di coincidere con la vita in sé, della quale tenta l’ oltrepassamento attraverso la disubbidienza e la trasgressione fino a sfiorare quel desiderio di morte più simile al corteggiamento di un’altra dimensione ampia e profonda e ad una necessità di rinnovamento interiore (il suo emblema è la vastità dell’Oceano, là dove i fiumi vanno a morire per perdere i loro argini ed espandersi) che ad una vera volontà di annullamento fisico.
L’acqua costituisce la più importante delle figure nate dall’esperienza biografica di questo poeta genovese, trapiantato da qualche anno a Bologna, ma vissuto per un certo periodo di tempo anche in Portogallo, la nazione europea più spalancata ai viaggi per mare, la più gravida di avventure e partenze.
Nelle città portoghesi, presso le rive del fiume Douro, nei bar, per le strade, spesso solo davanti ad un bicchiere di vino, egli prende consapevolezza della necessità di lasciare fuoriuscire, “rovesciare/ruzzolare precipitare” il peso del suo dolore, affinché possa ritrovare l’ “accordatura” con il resto del mondo, come sembra suggerirgli lo sguardo di un vecchio bove (esso risuscita nella memoria quello carducciano insieme alle domande leopardiane sul dolore rivolte alla luna dal pastore errante) mentre rumina “presso lo stomaco del fiume”.
La risposta viene dalle stesse acque in cui il poeta ha rischiato un naufragio (immagino più simbolico che reale, anche se l’impulso a fare è sempre un accadimento importante per la psiche): quelle alla Foz de Douro, da cui scampa, per poi gridare: “sono vivo, di nuovo”.
La presenza del mare non manca nemmeno nelle due sezioni seguenti. (E lascio volutamente da parte la quarta, quell’ Immemoris memor, costituita da un solo poemetto, avente un compito di raccordatura con le precedenti, delle quali è, di fatto, una sintesi in versi, ma non solo, come più avanti dirò).
Nella seconda sezione, Morfologia & Sintassi, il mare torna come simbolo e memoria, poiché a Bologna, dove Mantovani ha scritto questi testi, il mare non c’è. Eppure conchiglie, meduse, alghe, reti da pesca, spigole e merluzzi, ricci di scoglio, barche e gabbiani affollano molti versi risalendo la corrente del tempo e metamorfizzandosi in emblemi: le conchiglie , per esempio, rappresentano i giorni assaliti dalle forze erosive, “zigrinati”, ma allo stesso tempo una voce altra, “fuori dal mondo”; spigole e merluzzi sono “gli errori impigliati nella rete” “che non abbiamo forza a bastonare”; e le alghe tutte quelle cose che ci crescono dentro “nascoste e spudorate”.
Il mare, insomma, rappresenta la profondità, l’abisso del nostro io che invita ad un viaggio di autoconoscenza dal quale riemergere con una più piena consapevolezza di sé.
Nella terza sezione, Piovane, il viaggio del poeta, però, non è per niente ameno: il tono narrativo si fa più tetro e grigio così come l’atmosfera dei luoghi cittadini sempre battuti e quasi infradiciati dall’acqua piovana.
Il lettore viene coinvolto all’interno di uno sperimentalismo linguistico, che, lontano da qualsiasi intento ludico, sembra piuttosto contribuire a disegnare un doppio percorso, sia al di sotto del mondo reale, allo scopo di comprendere i monstra del proprio brodo primordiale interiore, simili a “bestie protozoiche/ amorfe e scodazzanti”; sia sulla sua superficie usando come vettori dei propri sentimenti i suoni, spesso striduli e lancinanti, di molti vocaboli presi in prestito da ogni dove, quasi che la parole del quotidiano e della letteratura non bastassero.
E giungiamo dunque all’ultima sezione di cui s’era fatto cenno, quell’ Immemoris memor, in cui accade una svolta importantissima dal punto di vista psichico e linguistico. Infatti, tutto quel materiale autobiografico, ribollente e in cerca di sistemazione anche espressiva, appare finalmente come digerito e distanziato, al punto che l’autore immemoris memor può darne una valutazione assai più benevola.
È il momento dell’accoglimento, dell’accettazione, della comprensione della funzione del dolore nell’evoluzione di sé stesso come uomo e poeta. Da qui quel tono da laude francescana con il quale Mantovani benedice ogni cosa e persona e luogo e memoria con le parole chiare della consapevolezza e dell’amore, che gli fanno dire all’inizio dell’ultima strofa: “Benedetto e santo tutto/ nella memoria, dove vite ripetute/ sempre gli stessi gesti,/ dove sono sempre anch’io”.
Id: 969 Data: 11/03/2016 12:00:00
*
 Ksenja Laginja - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Ksenja Laginja - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Praticare la notte
La grazia feroce dell’esilio nella poesia di Ksenja Laginja
C’è quasi una ferocia titanica nella poesia di Ksenja Laginja, che fa ciò che raccomanda Paul Valery, da lei citato: “entrare dentro se stessi armati fino ai denti”. Essa è preannunciata dal titolo della silloge: Praticare la notte, che in qualche modo rimanda a quello del celebre romanzo di Céline, Voyage au bout de la nuit con il quale condivide soprattutto quel prendere le distanze dalla vita umana ( per entrambi per lo più dis-umana o sub-umana) fin quasi a desiderare di vivere nelle profondità marine, munita di branchie e pinne anziché di polmoni.
Da qui ha origine quel titanismo, come si diceva, dell’autrice che, nell’ ingaggiare la sua guerra contro il mondo, è costretta a mitizzare, facendone un punto di forza, il peso divorante della sua solitudine, che si erge “alta e verticale” come “una roccia a picco sul mare” su quella che lei chiama “assenza orizzontale”, ossia sul vuoto che le appare l’esistenza, imbastardita com’è dalle medesime costrizioni e addomesticamenti del pensiero comune.
Così, anche se nei versi dell’autrice, sono presenti, sia pure per vaghi accenni, altre figure, è lei che sempre parla a se stessa, che si guarda dentro e si scopre ferita, tormentata, assediata. Se un colloquio c’è, ( e in esso lei trova un qualche ristoro), è quello che stabilisce con la Poesia, la quale, a sua volta, ha da combattere la sua battaglia contro l’opacità del dire, contro l’usura dei nomi, contro la falsità degli enunciati. La poesia, infatti, deve rinominare per essere l’altra lingua, quella autentica e veritiera, la rifondante. Ma si tratta di un colloquio apparente, che continua ad essere, di fatto, un monologo poiché la poeta ( direi il poeta, in generale) è la poesia che scrive: è questa la sua “voce suono visione”, la sua trasgressività, il suo stare nel mondo con fare dissonante, la fede che le permette di “svegliarsi nel mondo/ e praticare la notte”.
Ma c’è anche un’altra notte che le attende l’autrice e la sua poesia: la morte. Nella sezione “Dell’attesa” che segue a quella “Dell’assedio”, è lei la protagonista che preme, si insinua, annuncia il buio ed il nulla, che ha la sua figura nel vento che trascorre e non concede tregua, che si porta via le memorie, “l’odore di grano e cotone in fiore”, i nomi; lei che, come scrive Jaime Saenz, altro autore citato dall’autrice, “ti dolgo, ti vivo e ti muoio”.
Cosa sia la morte, però, è altra cosa di cui quasi nulla ci è dato sapere, così come della vita. Ci sono due testi illuminanti a tale proposito e che ogni lettore dovrebbe mettere a confronto: uno, quello dedicato alla morte, inizia così: Per alcuni è il giorno più bello; e l’altro, quello dedicato alla vita: Ti confesso che non è stato semplice. Nel primo la morte viene definita in molti modi: “il giorno più bello”, “l’estremo scoglio su cui giacere,/ il virtuoso punto d’osservazione,/ il principio, il riscatto, la via d’uscita”, “l’abisso,/ l’ennesimo da cui non poter risalire”, ma anche “l’essenza, il gioco, il riflesso di noi”. Dinanzi ad essa si balbetta, insomma, non si sa altro se non che siamo creature di passaggio. Così come non si comprende cosa sia la vita: “Ti confesso che tutto quel trambusto/ ancora non l’ho compreso/ e mi domando ancora ingenuamente/ cosa sia questo movimento interno/ che squassa l’anima e la carne tutta”.
È in questi testi che l’autrice ci appare nella sua nudità di creatura che sembra arresa all’inafferrabilità del suo iniziare ed essere in un certo tempo e del suo dovere finire per sempre, visto che nessuna realtà ultraterrena, nessuna visione metafisica sembra frapporsi tra questo suo sguardo disincantato e lucidissimo e il tempo che gli sta oltre.
Leggere la poesia di Ksenja Laginja è anche trovarsi di fronte ad una struttura organizzata attorno a dei termini ricorrenti, quali solitudine, assenza, buio, notte (insieme a pochi altri), che s’incastonano all’interno di un tessuto linguistico asciutto e spesso sonoramente cupo, inteso come proiezione di un dolente stato interiore. Ne derivano una forza perentoria, che nemmeno una certa enigmaticità infragilisce, e quella severa grazia che è propria di chi coltiva la disperazione ed il suo sentirsi esule nel mondo.
Id: 968 Data: 04/03/2016 12:00:00
*
 Alessandro Ticozzi - Narrativa - Edizioni Sensoinverso
Alessandro Ticozzi - Narrativa - Edizioni Sensoinverso
Ci vorrebbe la rivoluzione
Un omaggio di Alessandro Ticozzi al regista Mario Monicelli
Il regista Mario Monicelli ha accompagnato la mia vita, spiegandomela, mentre la vivevo, quasi passo dopo passo, in qualità di testimone e narratore dei fatti e dei mutamenti sociali succedutisi in Italia dal secondo dopoguerra all’affermazione della tv commerciale.
Monicelli - questa è la ragione per cui l’ho sempre ammirato - ha saputo farlo, a differenza di altri, senza nessuna edulcorazione o abbellimento, essendo un “idealista senza illusioni”, come lo definì Pietro Germi. Qualcuno lo giudicò cinico, accusa dalla quale egli si difese dicendo che l’avere i piedi ben piantati per terra non è esattamente la stessa cosa.
Di fatto il pregio di questo grande regista, al quale Alessandro Ticozzi rende omaggio con questa pubblicazione, fu la sincerità con la quale distrusse i falsi miti: ideologici, religiosi, sociali, mettendo a nudo i meccanismi del potere e la loro influenza sugli atteggiamenti e le scelte dell’uomo medio.
Il titolo di questo lavoro: “Ci vorrebbe la rivoluzione” rimanda spesso alle dichiarazioni che il regista, ormai vecchio, rilasciò nel corso dell’intervista per Raiperunanotte il 26 marzo del 2010, pochi mesi prima del suo suicidio, gesto (del tutto consono alla lucidità ed al coraggio del suo carattere) con il quale preferì uscire dal mondo dopo la diagnosi di un’ inguaribile malattia.
Il regista, in questa intervista, ripercorre in sostanza la sua carriera, raccontandola come uno specchio veritiero ed attento del progressivo decadimento di una società che ai valori del fare, della solidarietà, della dignità (espresse nel secondo dopoguerra), dopo le accensioni utopiche della lotta di classe, dopo l’imborghesimento del proletariato, già a partire dal fallimento del 1968 (del quale egli svela le false aperture democratiche e dell’alta borghesia e degli intellettuali con un film alla rovescia che è “Amici miei”, un ritratto giocoso anche se infantilistico di quegli adulti odiati dai ragazzi della contestazione) ha sostituito l’acquiescenza, il culto del consumismo, la chiusura nell’egoismo anche più cinico e violento, l’appoggio ad un regime di tipo fascista, come definisce quello berlusconiano, la corruzione, la sopraffazione.
E anche se Monicelli, come il prete che pronuncia l’orazione funebre per il figlio di “Un borghese piccolo piccolo”, sembra augurarsi la morte generale dell’umanità, mostrando di non volere più scommettere sul futuro, prima lancia una provocazione definendosi Comunista in un’epoca in cui questa ideologia è tramontata (e certamente, più che per nostalgia nei confronti del passato, per desiderio di un futuro di valori); e poi lascia un testamento aspro ed eroico, affermando che bisogna smetterla di sperare poiché la Speranza è una trappola del potere. E infatti, in uno dei suoi ultimi interventi in un’aula universitaria, parlando ai giovani studenti, consegna loro il compito di fare la rivoluzione e distruggere “un mondo di rassegnati che non combattono” in uno stato che si dice democratico senza esserlo. Meravigliosa contraddizione di uno spirito rimasto sempre giovane, sempre ribelle, pronto al mutamento in nome dei valori fondanti dell’uomo.
Del resto la “rivoluzione” Monicelli la portò avanti da sempre, girando film che non piacevano alla Chiesa, alla DC, agli stessi partiti di sinistra, a giornalisti e uomini ed istituzioni del potere. Denunciando la stupidità e la vanagloria dello Stato fascista e dei suoi ufficiali che condussero tanti poveri soldati provenienti da ogni parte d’Italia, senza preparazione ed equipaggiamento adatti, non verso un’avanzata trionfale, ma verso una carneficina (La grande guerra, 1959); smontando l’impianto del romanzo cavalleresco e dei suoi falsi eroi con “I soliti ignoti”, i cui protagonisti, invece che al Santo Graal, approdano ad un piatto di pasta con i ceci. E, ancora, accusando la morale cattolica di avere imbalsamato per secoli l’ordine sociale allo scopo di mantenere privilegi ed assetti di potere in “L’armata Brancaleone”, in cui l’età medievale viene descritta secondo quello spirito corrosivo ed ironico (veicolato anche da un godibilissimo “pasticcio” linguistico), che fu proprio anche di Calvino; affermando i diritti femminili, se non addirittura il progetto di un mondo governato dalla volitività, dalla duttilità e dalla solidarietà femminile (in “La ragazza con la pistola”; “Romanzo popolare” e “Speriamo che sia femmina”).
Ticozzi racconta tutto questo con una prosa chiara, agile, documentata, sostenuta da una profonda ammirazione per il regista Monicelli. Il suo lavoro sta fra due interessanti cornici: la prefazione di Ugo Gregoretti e l’intervista a Mimmo Calopresti. Di Gregoretti è interessante la definizione di Monicelli come cattivista, in quanto “un po’ cattivo è, ma molto finge di esserlo”; e del secondo l’affermazione che per il grande regista il “popolare” era “un’idea di semplicità rivoluzionaria”, come dire che in lui durò sempre la nostalgia di una società più povera materialmente, ma più ricca di valori e più credibile, qual era quella ritratta ne “I soliti ignoti” e in “Guardie e ladri”.
Voglio concludere con delle idee personali sul film che, a mio parere, è il più cupo ma anche il più ambiguo tra quelli girati da Monicelli, e perciò il più difficile da comprendere per lo spettatore medio. Si tratta di “Un borghese piccolo piccolo”. Nel 1977, quando esso fu proiettato nelle sale cinematografiche (due anni prima avevano assassinato Pasolini) avevo già 30 anni; ero disoccupata pur essendo laureata, mi ero resa conto pienamente del “disastro” del 1968 e assistevo con angoscia ai fatti drammatici di quelli che furono chiamati anni di piombo. Lo vidi insieme a mio padre e ricordo ancora le nostre diverse reazioni. Lui, sconcertato dalla violenza del protagonista, e tuttavia fortemente simpatizzante con lui (perfino commosso), per una istintiva identificazione con il padre di famiglia privato del suo unico figlio e perciò spinto alla crudeltà per “amore”; io del tutto ammutolita di fronte a un così grave sconfinamento del sentimento in una forma patologica; lui convinto che la predica del prete in occasione dei funerali del figlio fosse rivolta a condannare la violenza dell’attentatore ed a quelli come lui; io, invece, che fosse diretta al protagonista e, in ultima analisi, a tutti gli italiani borghesi del tempo, guastati dalla pratica della raccomandazione, privi di qualsiasi dimensione del sociale, ma anche a tutto quel meccanismo politico che aveva favorito un tale sfascio morale. Io, dunque, non so a chi Monicelli pensasse di rivolgersi, se già non avesse messo in conto che questa figura del padre seviziatore sarebbe piaciuta, nonostante tutto, allo spettatore medio, specie se adulto.Cominciai a leggere vari articoli sul film, tutti contraddittori, ovviamente; ma quello che più mi fece pensare fu uno in cui si diceva che il film era privo di un giudizio o di una condanna ideologici. E, infine, dopo tante letture, ricavai la triste impressione che proprio in quel momento Monicelli avesse cessato di avere fiducia nell’uomo e nella sua capacità di tracciare confini tra il bene ed il male. Ne fui intensamente amareggiata, come se lui mi avesse tolto l’ultimo appoggio per credere ancora in qualcosa. Oggi penso che fosse stato scritto per svergognare le caste al potere, compresa quella religiosa, poiché, infine, l’omelia di quel prete, essendo priva d’ogni misericordia, è, in sostanza, immorale.
Tutte queste digressioni non vanno certo considerate come una mancanza d’attenzione nei confronti del testo: “Ci vorrebbe la rivoluzione” di Ticozzi; tutt’altro; ma, non essendo esso né un testo narrativo, né un testo poetico, né un saggio vero e proprio, e nemmeno un trattato, come l’autore stesso lo definisce nella sua e-mail di presentazione, non vi si adatta una recensione, ma piuttosto una serie di riflessioni e di ricordi che la sua lettura suscita.
Di certo il taglio che Alessandro Ticozzi sceglie per raccontare Monicelli è quello più adatto a sottolinearne l’umanità schiva, lo sguardo lucido, la carica rivoluzionaria, la singolarità della visione.
Ma, quel che è più importante, “Ci vorrebbe la rivoluzione” c’interroga sullo stato di cose attuali, ci costringe a rivedere la qualità e l’utilità del nostro impegno personale. Abbiamo ancora nelle orecchie la condanna netta e risentita di Monicelli della paura degli intellettuali, della loro piattezza morale, del loro attaccamento al più o meno ampio potere personale già acquisito.
Dovremmo tenerne conto, tutti.
Id: 953 Data: 12/01/2016 12:00:00
*
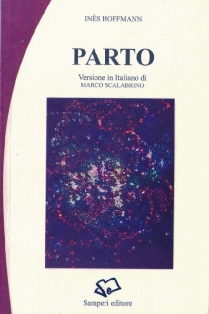 Inés Hoffmann - Poesia - Samperi editore
Inés Hoffmann - Poesia - Samperi editore
Parto
Per definire la poesia di Inés Hoffmann, prendo senz’altro a prestito la bella espressione “opera-creatura”, con la quale una delle autrici più preziose e profonde del Novecento italiano, Cristina Campo, intese caratterizzare la scrittura della Mansfield, come specchio di un’intera vita.
Gliela rubo perché nessun’altra potrebbe meglio significare il percorso biografico tracciato dai testi poetici di Inés, dove si mostrano del tutto scoperti anima, corpo, pensieri ed eventi, così da fare venire alla memoria le stazioni di una via crucis patita sulla propria pelle in tutta la sua crudeltà.
Il rosario dei dolori si sgrana attraverso la recita ossessiva delle negazioni, la reiterazione nominale di sentimenti e percezioni angosciose, la sfilza di un’aggettivazione greve, oscura (oh, quante, quante notti trascorrono cieche e gelide in queste pagine!) culminanti nella figura della bestia, la malattia della psiche, che strappa la poeta a se stessa e la consegna agli altri come una cosa devastata, “un cencio umano” osservato, manipolato, palpato, umiliato, senza attenzione alcuna alla dimensione interiore.
Da questa terribile oscurità Inés, però, si solleva verso la luce, ed è come se partorisse una nuova se stessa: è quello che comunica al lettore il titolo “Parto”, il quale, tuttavia, potrebbe pure essere letto come un verbo; né sarebbe questa interpretazione troppo inopportuna, poiché, di fatto, per ricominciare , ella deve abbandonare luoghi e tempi del suo esistere: la casa familiare, l’ospedale, i muri, “lo svolazzo d’infanzia”, “l’adolescenza stroncata”, “la giovinezza arida di affetti”. Deve partire da colei che è stata per andare incontro ad una persona rinnovata, pronta a portare alla luce “gli smeraldi” sepolti, “lo splendore” della speranza, ad attendere il ritorno “dell’uccello di fuoco” che potrà renderle la felicità. Ma la luce non splende mai assoluta: manda soltanto barbagli brevi o scintillii anche prolungati, perché resta il nodo di una tragica visione della vita, perché un’ombra larga minaccia, anche se lontana.
È per questo motivo che la poesia di Inés mostra non troppo velatamente la sua funzione terapeutica, mistica e trasfigurante, qual è anche quella di Alda Merini, che come Inés Hoffmann conobbe gli orrori dell’internamento, ma li rielaborò con una sorta di “allegria”, che alla portoghese manca.
La poesia di Inés Hoffmann ci è restituita grazie al lavoro di traduzione di Marco Scalabrino, che si tiene abbastanza fedele ai testi originali in lingua portoghese. Superfluo mi sembra fare in questa sede discorsi teorici sui compiti e gli obiettivi dei traduttori (sul tema ho letto recentemente un dettagliatissimo libro di Fabio Scotto); l’importante è che, grazie al suo impegno onesto e sensibile, al suo innato gusto per il ritmo e la sonorità della parola, Inés possa parlare anche a chi non conosce la sua lingua. E davvero ella merita di valicare i confini della sua patria, poiché esprime un mondo complesso e vibrante di sensazioni, sentimenti ed umori che giungono direttamente all’intelligenza del lettore, parlandogli di morte e vita, dannazione e salvezza, che sono i poli dentro i quali pure si muovono tutti gli umani destini.
Id: 951 Data: 22/01/2016 12:00:00
*
 Antonino Cangemi - Racconti - Editore Dario Flaccovio
Antonino Cangemi - Racconti - Editore Dario Flaccovio
d’amore in sicilia, storie d’amore nell’Isola delle isole
E dà per li occhi una dolcezza al core/ che ‘ntender no la può chi no la prova recita il sonetto più celebre di Dante che sviluppa magistralmente la polarità occhi- cuore così diffusa nel “sistema” stilnovistico. Non vi si sottraggono i sedici protagonisti maschili (tutti stregati dalla “bella persona” delle donne in cui fatalmente s’imbattono) delle storie d’amore raccontate da Antonino Cangemi in “d’amore in Sicilia”, il cui titolo sollecita nei latinisti la memoria di una regoletta grammaticale , e, forse, nei musicofili di un vecchio album di Francesco Guccini: “D’amore morte e altre sciocchezze”.
Certo è che il binomio amore-morte costituisce da sempre, dopo quello occhi-cuore, un altro tòpos della letteratura amorosa. L’argomento è così vasto che, a volerlo sviluppare, richiederebbe una galoppata per tutto il territorio letterario, e non solo italiano. Una così ossessiva reiterazione è, ovviamente, cosa assai diversa da quella che segna, oggi, la fine violenta di molte donne, (sebbene tre di queste storie raccontate dall’autore si concludano con l’assassinio di altrettante “eroine”), così da essere diventata un fenomeno di patologia affettiva e sociale di cui molto si parla; in quanto la morte messa in scena dai letterati possiede, piuttosto, un connotato psicologico intimamente radicato nello stesso fenomeno dell’innamoramento fulmineo e passionale, che ha tutto il carattere di un evento drammatico, capace, inizialmente, di sconvolgere i sensi e l’anima, per poi acquietarsi all’interno di una più tiepida affettività. La maggior parte di queste storie, infatti, dimostra che tanto più ardente e calda è la fiammata iniziale, tanto più velocemente essa finirà con l’estinguersi, taluna non reggendo nemmeno all’affiochimento causato dalla lontananza, talaltra trasformandosi in un rapporto “addomesticato”, inserito all’interno della quotidiana routine di coppia.
Si potrebbe, forse, filosoficamente ragionare sull’impossibilità del cuore umano di reggere a lungo la sovrabbondanza nella presenza dell’amato/amata, e perché, al contrario, essa lieviti fino ad uno strazio senza fine nell’assenza e nell’impossibilità del possesso, ma non è certamente questo che c’interessa indagare, adesso.
È, invece, cosa da sottolineare come Cangemi stabilisca con le protagoniste di queste storie amorose, mentre le va raccontando con un linguaggio cristallino e sensibile, una relazione di empatia, ammirandone quell’ardire che le ha spinte a trasgredire regole morali e sociali che avrebbero voluto soverchiare la loro pienezza sentimentale, il loro diritto alla felicità ed alla libera scelta. Queste donne, ribellandosi alle convenzioni per amore, diventano, infatti, soggetti attivi della propria vita con insospettabile determinazione, dimostrando l’ipocrisia di certi clichés anche quando falliscano clamorosamente od operino con apparente o voluta crudeltà.
In questo senso va letta anche la storia d’amore fra Vitaliano Brancati ed Anna Proclemer: in essa, infatti, sebbene la figura più tenera e pura e dolente sia quella dello scrittore siciliano, anche la notissima attrice opera una scelta di passione e di libertà che la “costringe” a scegliere la sua arte sacrificando l’affetto e l’attrazione per un uomo a cui scrive, dopo la sua morte: “Mi manchi Nuzzo. Mi manchi terribilmente”.
Di tutte queste storie immagino che la maggior parte dei lettori, e non solo siciliani, sapessero già molti particolari, e, tuttavia, credo che raramente fossero in grado di calarle correttamente nel loro tempo, avendone assorbito più la trama sentimentale che i risvolti storico-sociali. Ecco, allora, che questo libro, corredandosi di documenti e testimonianze, affrescando in modo rapido e vivido l’ambiente sociale ed il clima storico in cui quegli amori ebbero origine, serve a sottrarli all’indeterminatezza della fiaba e a farci riflettere anche sulle trasformazioni del senso morale e perfino del diritto avvenute in un arco molto ampio di tempo, ché la più antica di queste storie si svolge nel sedicesimo secolo e la più moderna è giunta fino a questo nostro tempo, poiché proprio due giorni fa, il 23 di Novembre, si è spenta, all’età di 102 anni Topazia Alliata, che con il suo Fosco Maraini ha vissuto, come scrive l’autore, “avventure fantastiche” e “atrocità inenarrabili”.
Tra tutte queste storie, l’unica di cui io stessa sia stata testimone per molti anni è quella fra Nat Scammacca e Nina Di Giorgio, avendo fatto parte dell’Antigruppo siciliano (di cui lo scrittore americano fu un grande animatore) ed avendo frequentato la loro casa alle pendici del monte Erice anche dopo la fine di quell’avventura culturale anche per me assai importante. È stato quello fra Nat e Nina un amore difficile, accompagnato da molti dolori, come evidenzia Cangemi, e solo apparentemente conclusosi felicemente con il ritorno di Nat in Sicilia dalla moglie Nina, dopo un’intensa relazione con una donna scozzese da cui lo scrittore ebbe una figlia. I traumi emotivi, infatti, segnarono per sempre la psiche di Nat e il rimpianto per la figlia lontana, che mai più rivide, gli spezzò il cuore, specie dopo che la speranza di un incontro fu distrutta da una telefonata in cui la figlia ormai maggiorenne, che aveva già prenotato il volo per raggiungerlo in terra di Sicilia, gli ebbe a comunicare che non sarebbe più partita: paura di mettersi in gioco? Di modificare la relazione con un padre che non ricordava nemmeno? Nat si è spento rifiutando negli ultimi anni di ricevere amici, chiuso nella sua solitudine e nei suoi ricordi, tra i suoi amati libri.
Mi scuserà l’amico Nino Cangemi se ho voluto aggiungere questi dettagli, ma immagino che questa storia bellissima e dolorosa debba ancora essere raccontata in tutta la sua verità, magari con il supporto di più numerosi documenti e di testimonianze dirette di amici e familiari. Per farlo, forse, ci sarà bisogno che altro tempo trascorra e sciolga reticenze e silenzi.
Un’ultima cosa desidero scrivere: che l’atteggiamento di Cangemi anche di fronte a certi personaggi non del tutto limpidi è sempre pacato, non giudicante. Egli osserva e descrive, piuttosto, gli stati d’animo dei suoi protagonisti con una misuratezza che attutisce perfino gli accadimenti violenti, con una intelligenza del cuore umano che lo tiene lontano da ogni superflua volgarità. Mai egli scivola – e potrebbe essere un rischio facile in un libro come questo - nel voyeurismo, ricordando a se stesso ed ai suoi lettori che ogni persona, ogni sentimento, è degno di rispetto profondo.
Id: 942 Data: 04/12/2015 12:00:00
*
 Claudio Pagelli - Poesia - L’arcolaio
Claudio Pagelli - Poesia - L’arcolaio
La vocazione della balena
Adottando un ritmo versificatorio veloce che racconta con disincanto cose e persone, Claudio Pagelli sembra simulare il flusso anonimo della vita negli spazi di una città onnivora (potrebbe essere, ovviamente, qualunque città dell’occidente industrializzato), che, dopo avere offerto allo sguardo una complessa e brulicante messa in scena sotto cieli privi di qualsiasi dimensione metafisica, puntualmente inghiotte nel buio delle sue viscere addomesticate dalla tecnologia tanti uomini-burattini come un’enorme bocca di balena (il riferimento è chiaramente collodiano). Lo sguardo fermo, a ciglio asciutto, del suo sguardo, che analizza le forme di quell’esilio da se stessi, dal proprio nucleo più intimo, a cui il mondo attuale costringe l’uomo medio in nome della necessità produttiva, dà l’impressione che la sua poesia si regga sulle schegge di una frana ormai antica tra le quali sarà molto difficile aprire un qualche varco.
In questo senso dobbiamo leggere i testi della sezione L’inferno di Chisciotte, che introduce un riferimento letterario di notevole importanza per l’individuazione di un possibile riscatto. Se il capolavoro di Cervantes viene, infatti, contestualizzato nel suo tempo così da coglierne le motivazioni storico-sociali, la follia del prode cavaliere Chisciotte altro non appare che una forma di contestazione estrema ed una necessità, sia pure solo “romanzata”, di recupero di valori ed ideali sepolti dall’incalzare di un mutamento storico, nel quale egli più non si riconosce.
L’inferno di Don Chisciotte ha molto a che fare con il nostro inferno attuale; ed è probabilmente per questo che Pagelli prende a modello questo personaggio evocandolo sia pure in miniatura con la “bandiera rossa della visione”; ed è per questo che l’esortazione rivolta a Sancho Panza a gettarsi in nuove avventure risuona non senza coloriture perfino ideologiche. (La diversità di Don Chisciotte, inoltre, potrebbe essere letta anche come una frecciata all’indifferenza del nostro sistema per la realtà parallela dell’immaginazione, della fantasia, e che, perciò, colloca ai margini la letteratura, e in specie la poesia).
Setacciando attentamente i versi, non è difficile imbattersi in alcune parole o immagini-spia della donchisciottesca “santa ossessione di sogni” e del “nucleo dolce dell’illusione”: può essere una parete tinteggiata di verde e quasi vuota che sembra un mare verticale; il disegno tracciato da un dito su un vetro appannato, l’apparizione di dulcinea (che il nome sia scritto in lettere minuscole annulla il personaggio a favore dell’idea che rappresenta) seduta “fra i papaveri e le stelle”; e perfino l’improvviso irrompere di uno sguardo visionario all’interno di un call-center, così che gesti, volti, oggetti sembrano assumere la fiabesca luminosità di un acquario ed annullare l’insensatezza di un lavoro ripetitivo fatto di formule.
Intanto dall’anonimia di tanti corpi “stretti come fiammiferi in scatola”, il poeta ricava una serie di svelti ed efficaci ritratti, che, pur ribadendo la schiavitù di ciascuno all’imperativo economico (fatta eccezione per il visionario che ancora riesce ad ascoltare “la voce leggera” delle cose), servono a consegnare i vari individui ad una loro specificità umana all’interno dell’ingranaggio. Tutti, in ogni caso, sono riscattati dalla loro infelicità, dallo squallore del sesso senza amore, dalla mancanza di una prospettiva metafisica, grazie alla “buona novella” della poesia.
Il cielo finto della metropolitana probabilmente ha suggerito all’autore il titolo della silloge che suona più o meno così: se con il vero cielo viene annullata la dimensione metafisica, non resterà all’uomo che l’azzurro di quel culo di balena. Ma il “grande pesce” che inghiottì, come racconta la Bibbia, il profeta Giona per poi rigettarlo sulla riva dopo tre giorni e tre notti, è divenuto, come si sa, il simbolo universale della risurrezione; ed, allora, si può congetturare che anche Pagelli vi faccia riferimento alludendo ad una possibile rinascita dell’uomo da una condizione di “morte”; tanto più che sin dal testo iniziale egli canta la persistenza, “mondo dopo mondo”, della luce, la quale continua a “tatuare di stelle la schiena della notte”.
Id: 928 Data: 18/09/2015 12:00:00
*
 Roberto Maggiani - Romanzo - LaRecherche.it
Roberto Maggiani - Romanzo - LaRecherche.it
L’ordine morale del Paradiso
L’ordine morale del Paradiso è un romanzo caratterizzato da una struttura complessa e suggestiva, all’interno della quale convivono dialoghi, riflessioni, lettere, pagine di diario, brani descrittivi e narrativi, che si alternano e si intrecciano fino alla strabiliante esperienza vissuta da Daniele (uno dei tre più importanti protagonisti) durante un temporaneo stato comatoso, e che pure vi s’inserisce con tale veritiera immediatezza da non incrinare la serietà delle tesi esposte e la normalità della trama.
Questo episodio, nonostante la sua natura onirica, ha, allora, la funzione di concretizzare narrativamente quell’idea della cosmonità a cui si accenna già nel prologo dove l’Universo viene pensato e definito come la “Casa comune” di ogni essere intelligente che lo abiti. Sempre nel prologo la presenza degli alieni è supportata da Simone, compagno di Daniele, da un suo avvistamento concreto avvenuto in terra di Calabria. Una simile relazione fra realtà e sogno, dentro la quale facilmente si annullano i confini fra l’una e l’altro, proponendo un concetto di spazialità come infinita possibilità di esistenze e di eventi, viene trasferita anche alla dimensione interiore, così che sentimenti, progetti, idee, guidati dal bene dell’amore, possano avervi diritto a pieno titolo al di là di ogni giudizio preconfezionato e schema costringente.
L’extraterrestre sognato da Daniele durante il coma è, dunque, molto probabilmente la proiezione di quella libertà primaria, prerazionale ed onnisciente, di quell’infinito potere dello spirito libero dai suoi legami con le norme terrene, che gli consente di “vedere” altre realtà ed altri mondi, e di essere, a sua volta, percepito da entità diverse. Dell’extraterrestre e del suo compagno potrebbe, allora, dirsi che esistono con certezza, se è vero che (e questo è un altro credo dell’autore), tutto ciò che è immaginabile è reale.
Daniele e Simone sono una coppia di omosessuali: il primo più spontaneo e meno timido, l’altro più riservato e timoroso. Il loro legame viene finalmente messo in luce dall’incidente subito da Simone che si trasforma nell’occasione che persuaderà la famiglia di lui a sciogliere ogni riserva di natura etica nei confronti della coppia.
Nel romanzo è la vita di Daniele, più che quella di Simone, ad essere raccontata con abbondanza di dettagli concreti e stati d’animo attraverso una serie di dialoghi che egli intrattiene (e durante i quali vengono affrontate le più varie e spinose questioni etico-religiose) con un Monsignore. Essi vengono via via registrati allo scopo di fornire materiale ad un progetto di scrittura, appunto, di un romanzo, ma la sbobinatura, iniziata da Daniele, viene poi proseguita da Simone.
Nel racconto di questa ricchissima biografia, Maggiani si ispira in modo evidente a sé stesso, come si può evincere confrontando certe affermazioni con i numerosi materiali messi a disposizione dall’autore su face-book, o con la sua stessa produzione poetica (l’amore per la fisica, il mare, l’esperienza dell’Accademia, i successi sportivi, la passione per la poesia).
Ma, fra tutti i personaggi che affollano questo romanzo, secondo me, il più sorprendente è il vescovo Alphons Retzinger. Immagino che egli non sia mai esistito; ma se davvero si ispira ad un reale rappresentante della Chiesa, bisognerà ammetterne un’apertura mentale difficilmente riscontrabile nell’ordinario, non solo perché egli non pronuncia condanna alcuna nei confronti di Daniele, lasciando che il suo spirito viva in piena libertà la sua scelta affettiva; ma perché, ad un certo punto, anche lui racconterà la sua vita precedente alla vocazione sacerdotale, rivelando a Daniele le sue storie amorose, tanto con una ragazza, da cui avrà perfino un figlio, che con alcuni suoi amici.
Ma forse non importa che un tale monsignore corrisponda ad un uomo in carne ed ossa; quanto piuttosto che si possa ipotizzare un dialogo così umano e aperto fra i fedeli e i rappresentanti della Chiesa. Egli incarna per l’autore quelle qualità che tutto il clero dovrebbe possedere. Ed allora si legge attraverso l’invenzione di questo personaggio un invito accorato alla Chiesa cattolica perché si apra all’accettazione di ogni forma d’amore fra gli esseri umani.
L’assunto su cui si basa una tale libertà è l’innocenza dell’atto sessuale quando condiviso e vissuto con consapevolezza piena: tutti gli amori raccontati in questo romanzo si nutrono di gesti delicati, accadono dentro la bellezza della natura, sono traboccamenti di gioia e di amicizia, sembrano alonarsi di qualcosa di mistico, una volta caduta la separazione fra la realtà carnale e la dimensione dello spirito.
Possiamo seguire passo passo lo svolgersi della tesi coerente, serrata, appassionata, sostenuta da Daniele per innalzare a dignità l’amore omosessuale: la tutela dei diritti naturali, civili e sociali di qualsiasi persona (pag. 6); la differenza fra etica di Stato ed etica cattolica (pag.11); la necessità di una separazione fra esse per evitare il rallentamento del “progresso dello stato sociale” (pag.13); la riscoperta della trasgressività di Cristo, che ha sovvertito con note di “assurdo e follia” “gli usuali punti di vista”(pag.22); la necessità di sottrarre le persone ad ogni discriminazione “in base alla loro affettività” (pag. 100), e di tornare “ad un’umanità decomplessata” (pag.116) per riappropriarsi del diritto alla felicità (pag. 122), che soltanto è ottenibile grazie ad una rinnovata armonia fra corpo e spirito capaci di danzare con la vita (pag.199). Ma la cosa più eccezionale è che lo stesso monsignore Alphons Retzinger (non senza intento polemico è stato evidentemente scelto questo nome!) approvi questi passaggi logici e talvolta li sostenga e li rafforzi con le sue osservazioni.
Bisogna precisare che il racconto per lo più autobiografico di Daniele non segue un percorso strettamente cronologico, ma è, piuttosto, affidato alla spontaneità della memoria e al naturale svolgimento del dialogo con il Monsignore; e che esso va di pari passo con l’analisi delle proprie esigenze interiori, poiché, di fatto, lo scopo principale perseguito dall’uomo è lo scioglimento di ogni dubbio impediente per la comprensione e la scelta consapevole della strada a cui è davvero vocato da Dio.
Il XVI capitolo del romanzo scioglie la curiosità del lettore: Daniele è partito alla volta dell’Africa, avendo deciso di svolgere laggiù l’attività di insegnante per i bambini di un villaggio. Vi resterà – sappiamo – per sei mesi, dopo i quali tornerà dal suo Simone, che gli scriverà di condividere la scelta e di attenderlo con serenità. La lettera è appunto una testimonianza di armonia tra due necessità non oppositive ma complementari: l’amore per un uomo e l’amore per Dio, poiché, infine, questo è il vero fil rouge del romanzo: l’amore con la sua grazia, la sua libertà, la sua funzione formativa proprio in quanto non ubbidiente che a se stesso. L’amore come desiderio ed aspirazione fondante di ogni uomo: l’Amor che move il sole e l’altre stelle.
Id: 926 Data: 11/09/2015 12:00:00
*
 Narda Fattori - Poesia - CFR Edizioni
Narda Fattori - Poesia - CFR Edizioni
Cambiare di Stato morire di natura
Un’onda musicale ininterrotta si alza dal tessuto dei versi dell’ultima silloge di Narda Fattori, in cui fittamente si susseguono le figure retoriche del suono. Essa si versa nell’orecchio del lettore come quelle nenie di antica memoria che, consegnando i morti alla dimensione del nulla, testimoniavano che la cucitura fra i due mondi poteva farsi solo attraverso la magia dei ritmi. La stessa cucitura opera la Fattori quando abbraccia dentro i suoi versi traboccanti di euritmie tutti i suoi morti come tutti i vivi che sta per lasciare, polverizzando di fatto la distanza tra gli uni e gli altri.
L’originalità della silloge consiste, infatti, nella scelta di un punto di vista, che, in quanto posto sulla soglia fra la vita e la morte, permette all’autrice di distanziare lo sguardo e cogliere con maggiore ampiezza ed obiettività non solo il mondo degli altri esseri viventi, ma anche il senso della propria esistenza nella sua totalità; ed allo stesso tempo di sfiorare e quasi sentire il fiato di quelli che sono già andati e le sia affollano intorno e dentro, come immagini, memoria, e sentimento amoroso.
Si avverte, allora, come un alternarsi fra un movimento d’immersione nelle cose del mondo con il loro concreto pulsare e un altro di emersione in un’aria rarefatta e di svanimento lieve come quello che fanno le farfalle, i fiori e tutte le altre creature dal destino breve. Su quella soglia, la poeta vede la morte nell’adesso come presagio ed immaginazione, ma anche come intermittenza luttuosa nel ciclo delle stagioni; così come intuisce un'altra espressione di vita nell’altrove che preme sulla macchina del cuore che va “a dieci pasticche al giorno”.
L’indagine che, come si diceva, la Fattori compie all’interno del suo percorso biografico, collocato come in un territorio neutro, le consente sia quel contenuto struggimento che scongiura il sentimentalismo, sia la formulazione di un giudizio del proprio operato vibrante ma obiettivo: ne consegue, da una parte, una sorta di pentimento, specie dei peccati d’omissione (“gli esclamativi caduti”), a cui segue la richiesta di un perdono che non viene rivolto ad un’entità assoluta, ma ai suoi vivi ed ai suoi morti; e dall’altra parte l’analisi delle varie tappe esistenziali: l’infanzia e le buone domeniche d’un tempo, l’impegno ideologico abbracciato nella giovinezza, i molti dolori familiari, la vocazione alla maternità, la malattia, ma soprattutto l’incontro con la scrittura poetica, che è “la salvezza di lemmi ri-creati/ porte spalancate non più inferriate/ incontri di res totius/ su fragile argilla – mia voce/ mia vita – mia terra”.
Ma c’è un altro elemento e non di minore importanza in questa silloge poematica di Narda Fattori, ed è la presenza palpitante della natura: colori, fragranze, movimenti, forme, e voci (ricreate attraverso onomatopee e soprattutto abbondanti allitterazioni di straordinaria suggestione – “fra l’erbe che vibravano d’elitre”, una fra tutte ) si susseguono senza sosta, tessendo il canto della bellezza, seppure sempre insidiata dal “tic tac del tempo”, così che la bellezza rimanda alla finitudine e quest’ultima fa maggiormente risplendere la bellezza. Mi viene da pensare al luminosissimo incipit del poema lucreziano che esalta la primavera, hominum divumque voluptas, quando la terra ‘si copre dei fiori più soavi’ e ‘il cielo placato risplende tutto inondato di luce’, per richiamare gli uomini alla vita del qui e dell’adesso e per fugare le ombre della loro paura superstiziosa di fronte alla morte.
Nemmeno Narda ha paura: solo un cambiamento di stato, un morire di natura, sarà, infatti, il suo, un trascolorare, uno svanire, ma lievemente, “a ciglio asciutto”. I suoi versi sono colmi di figure di levità, come la polvere, la foglia, la neve, la piuma, la farfalla, ma niente come questi versi: “con un mazzo di papaveri che si disfa/ due istanti appena dalla presa però/ l’incanto…” raffigurano la fuggevolezza, l’inconsistenza, e il miracolo di quel niente che è la vita. Sono immagini che quasi precipitano l’essere in una dimensione onirica e fiabesca, come accade nelle metamorfosi ovidiane. Dopo sarà un cambiamento di stato: Narda si guarda, si immagina e in questo dopo si vede polvere, “terra per nespole e ciliegie/ terra per gramigna e per ginestre”, ma soprattutto suono di parole attraverso cui ha raccontato tutte le storie e, fra queste, la sua.
Id: 919 Data: 24/07/2015 12:00:00
*
 Angela Greco - Poesia - La Vita Felice
Angela Greco - Poesia - La Vita Felice
Personale Eden
La lingua impetuosa di Angela Greco celebra quell’affondamento nell’abisso (termine tra i più ricorrenti all’interno della silloge) dell’Amore necessario al superamento della frattura fra femminilità e maschilità narrata dal libro della Genesi e fin troppo negativamente giudicata quale colpevole disubbidienza e sprezzatura diabolica (proprio nel senso del dia-ballo greco quale “gettare di traverso”) dalla maggior parte degli interpreti veterotestamentari, che ne hanno sempre taciuto la forte valenza filosofica e gnoseologica, messa invece in luce dal racconto che ne fa Aristofane nel Simposio di Platone: “E così evidentemente sin da tempi lontani in noi uomini è nato il desiderio d’amore gli uni per gli altri, per riformare l’unità della nostra antica natura, facendo di due esseri uno solo”. Quella sprezzatura è così giustificata dalla poeta: ma chi altra ha saputo mostrarti la lucentezza/ piccolissima che scinde la mela dal suo ramo?/ o la non vista eleganza del suo seme a lacrima? E ancora: ci riconoscemmo pronti a iniziare la terra.
Se è vero, infatti, che la consapevolezza di sé e la scoperta dell’altro presuppongono l’uscita dalla immobile sterilità dell’Uno, il dialogo fra femminilità e maschilità genera un reciproco e costante atto creativo, un percorso di ricerca che è coincidente con la libertà dell’adesione al sentimento dell’Amore. Ed è per questo che l’energia amorosa, cantata da Angela Greco, diventa un reiterato movimento insieme verticale ed orizzontale che dilata i confini del corpo individuale, che è, sì, quello dell’amato nel proprio Eden personale, quello dalla cui bocca zampillano sorsi di gioia inebriante, quella cara geografia epidermica ed interiore del desiderio e del congiungimento carnale, ma anche l’Immagine di tutte le creature viventi, del cielo, della terra, della natura tutta, membra dell’infinito corpo del Cosmo: astri avanzati/ trapiantati in tessuti sanguinanti affinché fioriscano aurore. Questa tensione dell’umana creatura finita verso l’Infinito, questa figurazione del Macrocosmo nel microcosmo di gesti, sguardi, emozioni vissute e percepite sensorialmente, non potendo essere razionalmente rappresentata, viene affidata dall’autrice ad un dire emotivo, fatto di allusioni, vibrazioni, sensazioni spesso viscerali, immagini sensuali ed insieme castissime, perché purificate dal canto. In tutto il suo dispiegarsi, infatti, questo inusuale poema erotico (ché uno solo è lo slancio, una sola la fonte tematica, una la profondità e uno il ritmo del fiume ricchissimo delle parole che lo attraversano e ne costruiscono il febbricitante delirio) ha un fondamento certissimo nella convinzione che soltanto lo strumento espressivo della poesia possa veicolare ciò che sta oltre il razionale, oltre il visibile, oltre il dicibile stesso grazie alla qualità del suo corpo musicale, al sortilegio delle infinite combinazioni dei suoni. Non a caso, infatti, la parola “sortilegio” è sottolineata dall’autrice che copia integralmente da un vocabolario di lingua italiana la sua definizione a pagina 25 della sua silloge, a mo’ di exergo per la seconda (A voce, dietro la nuca) delle tre sezioni in cui essa è ripartita.
L’abbondanza del canto di Angela Greco, dunque, ubbidisce sia all’esigenza di affidare le molte sfumature di una stessa emozione ad una circolarità ripetitiva, consona all’inesauribile vigoria del sentimento amoroso che dantescamente muove la Vita, sia alla vitale fantasia del canto. Lo slittamento dal piacere fisico a quello verbale più volte s’insinua nei versi fino a generare quasi una metamorfosi della superficie del corpo in quella cartacea del libro dove le figure dei due amanti diventano segni, emblemi, archetipi, grembi cosmici di un’inesauribile fertilità, intreccio risuonante di energia vitale e verbale. Nei versi si assommano tutte le storie, tutte le attese, tutti i desideri e le tristezze degli Amanti; tremano le assenze dell’Amato ma solo come pregustazioni della sua futura presenza. Non c’è mai un abbandono definitivo, perché esso è annullato dalla continuità dei ritorni: che già ho un dolore che assomiglia alla tua assenza/ o alla speranza del ritorno.
In questo senso il ritmo interiore di questa silloge ricorda il battito mistico del Cantico dei Cantici, la visionarietà de Il castello interiore di Teresa d’Avila o le metafore ardite de La noche oscura di Juan De La Cruz. Ma, soprattutto, vi risuonano la poesia dei Sufi e la concezione araba dell’‘Ishq a cui s’ispira la silloge di Asma Gherib e Saad al Shlah, pubblicata nel 2014 dalle edizioni Arianna: Tango e null’altro (il cui linguaggio pure ricorda largamente per qualità ed intensità di immagini quello della nostra autrice), dove a pagina 14 gli autori così, fra l’altro, lo definiscono nella prefazione: “un matrimonio fra i sensi e gli alfabeti del cosmo e unione fra femminilità e maschilità in modo che diventino insieme due elementi per un solo corpo originale, quello di Adamo”.
Un simile matrimonio è una sorta di santa quête, uno svelamento del segreto del cosmo come complementarità armonica che pure si annuncia in quel denudamento avvenuto nell’Eden biblico attraverso il quale, finalmente, Adamo ed Eva si conoscono e si riconoscono rendendosi degni dell’ Amor che move il Sole e le altre stelle. Così l’Eden personale diventa il Giardino universale della Gioia.
Id: 898 Data: 26/05/2015 12:00:00
*
 Jean Flaminien - Poesia - Book Editore
Jean Flaminien - Poesia - Book Editore
L’acqua promessa
(nella traduzione di Marica Larocchi)
Seguendo il flusso dell’acqua (presenza visiva costante nell’esperienza contemplativa della natura), che l’autore trasforma in una metafora pullulante di significati, la trama poetica de “L’eau promise” di Flaminien traccia, attraverso l’autobiografismo, un percorso investigativo sul destino dell’uomo, dalla sua culla fetale di liquidi umori materni al traghettamento sulla sponda dell’oltre, cui allude perfino l’immagine di copertina del pittore cinquecentesco Joachim Patinir, raffigurante Caronte che attraversa la palude stigia.
Del resto niente più dell’acqua, la cui esistenza è sperimentabile con tutti i sensi, presenta una maggiore fecondità mitopoietica, coniugandosi con l’inquieta e instabile forza creatrice della natura come con la vertigine dell’immaginazione, con la mobilità del pensiero e con il farsi senza sosta del linguaggio, cosi da stare a fondamento di molti testi e opere d’arte sulla creazione e della stessa filosofia presocratica, a cui Flaminien allude nella bella poesia dedicata ad Eraclito fanciullo, che comincia con “Davanti a casa”.
Il fiume di cui parla l’autore francese, come ogni altro scorrendo dalla sorgente alla foce, diventa luogo di “semente” e di “silenzio”, cioè immagine di vita e morte fittamente intrecciate, come nella quattordicesima poesia della prima sezione, dove alle bianche lapidi del “camposanto sull’altra sponda” fa da contrasto il bianco movimento “da un greto all’altro” di “tortore ancelle”; o nel gruppo di testi che rievocano “il mattatoio in bilico, / sbrecciato, oppresso d’edera” dalle cui vittime colava “sull’onda in verticale” il sangue caldo “sciolto dai corpi”, che spesso sporcava il suo corpo di bambino, il quale risponderà alla folgorazione del rosso, disegnando con il sangue sul fondo nero del muro un pesce, illuminando la tenebra e facendo sì che il segno trasformi ogni cosa “in materia incantata”.
È evidente il riferimento alla poesia, che, conservando ciò che naviga sul flutto sempre nuovo ed effimero dell’esistenza, permette, come si legge in un altro suggestivo testo della raccolta, “di custodire l’enigma / per cui le realtà si accendono, grazie a noi”.
La natura materna dell’acqua risuona con empito lirico nella maggior parte della raccolta, ma raggiunge la sua massima espressione in due testi de “L’eau promise”, nel secondo e nel ventiseiesimo della prima sezione, in cui è appunto dominante la figura della madre del poeta, nel primo assumendo in sé la forza archetipa del principio originario, mentre “innanzi al guado” “perde le prime acque” prima di generare il figlio di cui è pregna; nel secondo risanando con l’amore la pulsione caotica del fiume che, straripato dai suoi argini, invade la casa, fino a giungere sotto il letto dove madre e figlio dormono insieme “serena finitezza”. A questa ricomposizione amorosa, quasi un ritorno alla vita uterina, rimanda una delle ultime poesie della raccolta, in cui si spiega anche il perché della scelta del titolo, quando recita. “Dell’acqua-una, / siamo la gente nomade/ promessa nell’ora del compimento, / quando la fluida conciliazione / della mente avrà vinto la sventura.”
Quest’acqua promessa ( e come non ricordarne la simbologia rituale?) ha anche una funzione catartica; infatti, chiedendoci costantemente se siamo buoni: “Buona è l’acqua, buona davvero; / e tu sei davvero buono?” ( 10, sezione prima), “Sozzura, la nostra, sozzura” ( 4, sezione terza), ci invita ad imitarne il dinamismo gaio ed innocente. E allora “In che modo si è fiume?”, si chiede l’autore, e la risposta è “labbra aperte al passaggio / di un abbandono vasto”.
in questo invito, dunque, che il lettore della poesia di Flaminien deve ravvisare il senso del tempo e del suo manifestarsi in forme viventi sempre nuove, ma senza che quelle passate non abbiano il riscatto della memoria e della poesia, e che dal punto d’arresto non nasca qualcosa di simile ad una visione, un altro tempo duttile e felice del dono, della promessa, una rivelazione come quella che la madre faceva al bambino, “Grazie all’acqua / La terra si è fatta / a noi più vicina”.
Id: 882 Data: 20/03/2015 12:00:00
*
 Alfonso Lentini - Poesia - Eureka Edizioni
Alfonso Lentini - Poesia - Eureka Edizioni
Illegali vene
Questo l’autore vuole: salvare ciò che resta ai margini o del tutto fuori, l’appena intravisto, e il non visto e il non detto, evitando che qualcosa o qualcuno venga per sempre obliato. Da qui la necessità di scrivere, pur nella consapevolezza del limite della parola, scrivere per lasciare aperto il dialogo, il flusso della vita, cosa che presuppone l’esistenza di un io e di un tu, che in qualche modo hanno conservato la voglia di mettere in comunione l’esistente, recuperandone la novità e la luce offerta ogni mattina dalla vita che comincia dietro i vetri di una stanza, sempre vocando che “si aggreghi una voce /a una mano più nuova” così da poter dire che “tutto è oriente / e tutto è luminoso / e senza peso”. Contro il continuo rischio di cadere nel vuoto o di rimanere intrappolati in paesaggi algidi ed aspri, la scrittura si offre, dunque, come preghiera, perché tutto venga recuperato e consacrato, sia che si tratti di briciole di pane e di minuscoli insetti, che di tigri, gibboni e giraffe.
L’invito reiterato ad oltrepassare il bianco, il silenzio, la recisione, lo smarrimento, avviene anche per forza di un’instancabile amore nei confronti del corpo musicale delle parole. Sono i suoni, infatti, a cucire i margini aperti della ferita (causata dal desiderio, destinato a fallire, di capire e conoscere ragionevolmente il mondo) attraverso un evento emozionale e/o irrazionale: quello che ha origine “dal lato / sinistro, dalla mano / che traccia un capogiro”, quale può essere un gioco combinatorio di parole con un effetto incantatorio, quasi di lallazione infantile.
L’autore ritorna, allora, al segno come farsi di un sogno in cui il tempo e lo spazio terreni scompaiono a favore di una fluidità senza argini costringenti; ed il lettore dei suoi versi ha l’impressione di compiere un viaggio onirico dove tutte le cose affiorano come significanti allusivi, come icone cariche di annunci misteriosi, di sapienze segrete.
È evidente come il libro ubbidisca ad una consapevole e sapiente partitura compositiva, che fa della Parola la protagonista, rivelando che l’autore è colui il quale, scrivendo, impara da ciò che ha scritto ad avvicinare il visibile e l’invisibile, e che, dunque, l’io (lo scrivente) e il tu (la scrittura) non sono realtà distinte, ma una sola unità nella dinamicità del confronto. Affermazione che facilmente trapassa dalla relazione scrittore-scrittura a quella tra scrittore (io) e lettore (tu), se è vero che, come prima si diceva, la poesia è intesa più come comunione che come comunicazione: è l’appropriamento del corpo mitico-mistico della parola poetica da parte del lettore che esige il suo ritorno, mentre lo vede, lo ascolta e lo interroga, determinandone il destino come un messaggio necessario. L’acuto prefatore della breve silloge, Eugenio Lucrezi, identifica nel tu una donna, ma, sebbene sembri un’interpretazione diversa, in fin dei conti non lo è, dal momento che individua comunque una relazione amorosa.
Ogni poesia di Alfonso Lentini è, di fatto, una relazione amorosa di suoni. Per questo i suoi testi poetici sono da recitare a voce bassa, quasi cantandone lentamente le parole che s’inseguono e s’incastrano fra loro: così nella prima poesia: ghiacci-graffi-tracci, e lastre-incastri; e gole-voli-parole; lago che quasi inverte gole: una manciata di parole che fanno precipitare dall’alto di luminosi ghiacci in un lago, suo “difficile” specchio di parole, ma non senza lasciare graffi e incastri di voli. Un rito solenne di conoscenza che ricorda il sacrificio di Icaro, il primo ad evadere dal labirinto, simbolo dell’assurdità delle prigioni razionali.
Leggi alcuni testi e guarda le copertine di Illegali vene su facebook...
Id: 875 Data: 27/02/2015 12:00:00
*
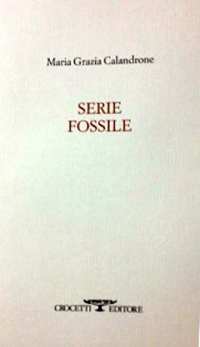 Maria Grazia Calandrone - Poesia - Crocetti Editore
Maria Grazia Calandrone - Poesia - Crocetti Editore
Serie fossile
L’invocazione “tigre-amore, pescami dal mondo profondamente striato / dove guizzo, portami / alla profezia, alla visione vera” (pag.34), non solo consente di definire poematica, proprio in quanto rispondente ad un topos di genere, la struttura della recentissima silloge Serie fossile di Maria Grazia Calandrone, ma anche di inserirla all’interno di una tradizione dalle radici antichissime che fa della poesia una forma di conoscenza iniziatica. L’allusione, all’interno di un altro testo alla “foresta di simboli”, rimanda, in modo specifico, al simbolismo francese ed alla poetica che caratterizza i testi di Baudelaire e Rimbaud.
L’invocazione, inoltre, chiarisce immediatamente l’identità della figura femminile (la poesia stessa) a cui costantemente ed innamoratamente si rivolge l’autrice permettendole di spossessarsi quasi subito del suo “io” (dopo i testi iniziali di ricognizione delle cose del mondo) e di ristabilire quel vuoto pre-verbale, quella verginità primordiale necessari al pronunciamento di un sì, capace di risollevare la materia dal suo marciscimento (“alba che disfi il nero”) e purificarla nella luce dell’albedo. Lo strumento adoperato è la magia alchemica del suono-ritmo della parola poetica, che assume in sé il mondo e lo santifica attraverso le tre fasi della nigredo, dell’albedo e della rubedo. Tale processo alchemico accade, di fatto, testo dopo testo per successivi e sempre più esperti tentativi, come conferma la presenza reiterata di termini come alba, luce, bianca, talvolta accostati o rafforzati da altre immagini (dal bagliore di latte dell’alba, pag.27) quasi per una necessità di estensione e d’intensificazione progressive del chiarore che rinasce dopo il lutto, dopo il pianto “per ciò che si è appena mostrato, per un imperfetto possesso e per la castità oltraggiata, per l’innocenza perduta senza compensazione”, come scrive María Zambrano (in “Verso un sapere dell’anima”). In questo modo l’albedo della lingua poetica o “tecnica bianca di sollevazione” (collocandosi la lingua poetica prima ed oltre ogni forma di comunicazione opacizzante) permette di riappropriarsi della gioia (Della gioia è, appunto, il titolo dell’ultimo capitolo di Serie fossile), che libera l’uomo dal dolore di essere sconfitto dal tempo e dal tradimento delle parole parlate e uccise dal tempo. Il salto dalla dimensione mortale a quella immortale si compie grazie alla fiamma amorosa del cuore: è la fase finale, quella della rubedo, che sacralizza di nuovo ciò che è stato desacralizzato (secondo la citazione dalla Medea di Pasolini: ma ciò che è sacro si conserva accanto alla sua nuova forma sconsacrata). La parola torna ad essere mito e rito: in essa arde il pre-umano e perfino il dis-umano allo scopo di ricondurre ogni cosa nell’interezza dell’Uno, prima della scissura: il fiume Tevere, che “disarginato, traboccato sugli argini / in immature sacche d’acqua” invade una piazza e lambisce le colonne, diventa una potente metafora di questa nuova benedizione (“la beatitudine della città che intanto si spalanca”) del recupero dell’indistinto, del senza-confini.
A questa interpretazione della poesia come porta alchemica verso il segreto del mondo autorizza, soprattutto, il testo di pag. 30-31, nel quale si nominano non solo la nigredo, che trova il suo simbolo nella stryx, e l’alba (o albedo), ma anche la fase del cromo giallo, intermedia fra albedo e rubedo, rappresentata dal sole (“qui nel regno della materia esposta / al principio chiarificatore del sole”, pag. 59). La rubedo è il cuore aperto del drago (o serpente), cioè la consapevolezza dell’Eros come legame universale, nudo ed innocente, anteriore alla vergogna, secondo la citazione da Genesi, 3, 1-7: “Allora si aprirono i loro occhi e conobbero che erano nudi”. Il cuore aperto dell’amore è, infatti, la condizione necessaria per il raggiungimento della rubedo. Essa, come l’autrice scriveva nella sua invocazione, si realizza attraverso il fuoco della poesia, che alla materia transeunte del mondo oppone il suo corpo, ovverossia la materializzazione di struggenti visioni: Canna di flauto / per lodare, restituirmi l’inizio del mondo (pag.20). La rielaborazione simbolico-alchemica delle Sacre Scritture è confermata in più passi, ma soprattutto investe il problema gnoseologico, a partire dalla figura del serpente, che abbandona il suo ruolo negativo di corruttore, e viene, invece, rappresentato come l’uroboro, che nella simbologia alchemica è l’immagine di un processo utile alla raffinazione delle sostanze. E così la mela, il frutto proibito dell’albero del bene e del male piantato al centro dell’Eden, che, colta da Eva, causa la scissione fra Dio e le sue creature, diviene “l’emblema splendido del sangue / della terra”, il dono per eccellenza che viene offerto alla Poesia per la celebrazione delle nozze alchemiche, “per arrivare dentro la tua bocca, o sangue del mio sangue”, per raggiungere “la fedeltà inumana”.
All’interno di Serie fossile sono inseriti due testi in prosa poetica: “Petizione per il rilascio dell’Alba” (pagg. 80-84) e “Insieme MRK1034” (pagg. 130-132), le quali, nonostante l’apparente diversità dei contenuti, di fatto costituiscono due fulcri narrativo-simbolici perfettamente corrispondenti. Il primo racconta una così intima simbiosi affettivo-conoscitiva fra il corpo ipervedente di Alba (o la poesia) e quello della Tenutaria, cioè della poeta, che, quando Alba viene sequestrata dalla Titolare (cioè la Parola consunta e offesa dal tempo quotidiano), la conseguenza è lo spegnimento della gioia e della bellezza del mondo. Da qui la petizione della Tenutaria alla Titolare affinché liberi la prigioniera Alba dietro un riscatto di 10.000 versi d’oro zecchino. Il testo è, dunque, una lettera d’amore che la Calandrone scrive a difesa della Poesia, come gioia, canto, danza, luce, bellezza e oro del mondo.
Il secondo testo racconta, con termini scientifici e immagini spesso liriche, la storia d’amore fra due galassie che, “in attesa di formare l’insieme al quale sono destinate, (…)svolgono un’intensa attività interiore, che porta entrambe ad uno sprigionamento di energie attive (…) esse sono due splendide officine, due fervidi laboratori di stelle. esse irradiano luce”. L’irraggiamento luminosissimo di entrambe, la forza d’attrazione reciproca che provocherà con il tempo un “abbraccio pieno”, una fusione dei due corpi in uno solo, spiega, infine, il senso del titolo: Serie fossile. La poesia, infatti, è simile all’ambra “che si chiude e fluisce verso un’altra creatura della terra per accoglierla irreparabilmente: un corpo anima” (come la simbiosi fra Alba e la Tenutaria; come le due galassie nello spazio); è quel retrocedere ai primordi del tempo, al primo sì, che rinnova il patto di conservazione, continuamente, continuamente. L’ambra della poesia racchiude la vita intatta, nonostante il tempo, diventando la dimora dell’accoglienza duratura “dopo che abbiamo abitato / - soli / come astri - l’effimera / grazia di un mondo fatto per finire”. Inoltre, l’incapsulamento della materia dentro l’ambra richiama l’utero, il luogo e il tempo dell’unità perfetta madre-figlio. La poesia è la maternità della parola. Perciò il figlio salta la rete, nel buio della notte e “Dopo diverse ore di cammino / ha bussato alla casa dell’infanzia / diceva solo mamma non è niente / diceva mamma sono solo / stanco, solo stanco.”
Id: 874 Data: 13/02/2015 12:00:00
*
 Francesca Del Moro - Poesia - Cicorivolta edizioni
Francesca Del Moro - Poesia - Cicorivolta edizioni
Le conseguenze della musica
Le parole che usa Francesca Del Moro in questa sua nuova silloge (Le conseguenze della musica) sono molto larghe, così da potere essere riempite di molti significati, a cominciare dalla musica di cui lei intende manifestare quali siano le conseguenze (altro termine su cui molto c’è pure da dire), visto che, leggendo i testi, si pensa pure alla sonora presenza della poesia e al suo farsi portatrice di altre conseguenze, non sovrapponibili a quelle della prima. Infatti, se l’ascolto della musica, come viene ripetutamente dichiarato, costituisce una sorta di collante che tiene insieme il tempo dell’esistere generando “conseguenze” emotive di addensamento o di rarefazione, caratterizzate ora da un piacere di rispecchiamento, ora da una necessità di fuga dalla realtà; quello della poesia, a cui spesso viene attribuita una corporalità calda e coinvolgente, una bocca sonora che dantescamente “ditta dentro”, determina tanti ripetuti atti di coraggio e di sincerità fino alla brutalità, allo scorticamento di sé.
Allo stesso modo l’amore si dilata e si complica viaggiando fra i due estremi dell’assenza e della presenza, della memoria e del desiderio, insediandosi nella percezione del tempo e come bilancio esistenziale, spesso molto amaro e nullificante; e come motore del presente, che l’avverte, consolandola, del ruolo materno e della presenza di molte relazioni amicali; e, infine, come suggeritore di una vaghezza sentimentale, di un desiderio più contemplato che destinato a un nuovo progetto, in quanto si ha la sensazione che la solitudine amorosa rappresenti per l’autrice una condizione insieme di deprivazione e di privilegio. È vero che Francesca Del Moro lamenta la poca vita che determinerebbe la poca scrittura, però sa perfettamente bene che la poesia nasce da un limite; e, come una delle fanciulle mitiche che versavano l’acqua in un pozzo senza fondo, anche lei versa nel suo vuoto i versi dell’impossibilità di raggiungersi e di raggiungere gli altri. Gli altri, infatti, appaiono in genere, anche quando sono fisicamente vicini, imprendibili, quasi intoccabili, e non solo per timidezza gestuale, ma per quella distanza che si frappone sempre, per quella inutilità delle parole del quotidiano che sappiano dire davvero come stanno le cose, come sentiamo e ci sentiamo. Sembra un paradosso che la poesia così “comunicativa” di Francesca Del Moro possa celare un simile dramma; ma, se si leggono le sue interviste e soprattutto i suoi testi non solo dal punto di vista contenutistico ma anche nel loro aspetto formale, colpisce il fatto che lei insista sul lungo lavoro esercitato sulle parole per giungere a questo risultato di “spontaneità”.
Di fatto il silenzio e/o l’insufficienza delle parole “quotidiane” trapassano come una ferita i versi della Del Moro: quasi tutto è stato perduto per questo, quasi tutte le relazioni sono state e sono limitate dall’incapacità di mettersi in comunione: c’è un testo molto inquietante che ha inizio con “Tu ti sdrai per terra” (pag.52), in cui l’autrice si confronta con un’altra donna che sta a contemplare il cielo stellato a faccia in su, sdraiata per terra, dove pure lei stende il suo corpo, ma guardando in giù, la faccia sporca, il viso schiacciato, le stelle colte solo da uno sguardo obliquo.
Mai parole come quelle di questo testo sono, come dicevo inizialmente, più “larghe”: se le leggiamo alla lettera, appare razionalmente incongrua la posizione scelta dall’autrice per guardare le stelle accanto ad un’amica che ha scelto quella più comoda e naturale per farlo; così che bisogna costringersi ad una lettura diversa, o forse a più di una. Infatti, queste parole potrebbero significare un conflitto tutto interiore tra una spinta a soddisfare le proprie esigenze di astrazione e anche di contemplazione della bellezza più pura e remota, e quella contraria a guardare le cose della terra e viverci dentro intensamente fino a sporcarsene. In questo caso il testo sarebbe una sorta di contemporaneo racconto platonico.
L’altra lettura, credo la più corretta, anche se la precedente mi affascina di più, ma forse solo per ragioni soggettive, è, invece, quella che fa di questo testo una sorta di manifesto poetico, attraverso il quale Francesca Del Moro si colloca nella scia di una recente scrittura poetica femminile (non ‘femminina’, per carità!), in cui s’inseriscono nomi come quelli della Cavallo, della Gualtieri, della Calandrone (ma come capofila porrei Maria Grazia Lenisa, purtroppo non ancora nota come meriterebbe) nella quale il corpo trova per esprimersi un linguaggio di rottura rispetto a quello “cantato” dai poeti uomini, e dalle stesse donne-poete rivolte maggiormente alla propria interiorità. È la rivoluzione che auspicava Rimbaud, il quale in esso poneva la liberazione della donna dal suo status di inferiorità. È Il pensiero dentro il linguaggio, infatti, l’arma che opera i tagli decisivi. Penso, del resto, che, se si accoglie una simile operazione, bisogna convenire con l’autrice che quell’io che parla non si esaurisce in se stesso, ma diventa il pronome di tutte le donne, che dicono, attraverso la poeta, “io sono”.
Detto questo, possiamo anche fare la conoscenza della donna Francesca Del Moro giusto attraverso i suoi versi, scoprire i suoi gusti musicali, comprendere la gioia della sua maternità, condividere la sua solitudine affettiva dopo la separazione, il suo amore per la bella Bologna, sua città d’elezione, i suoi autori preferiti (ai quali spesso si rivolge con freschezza di atteggiamenti, con gratitudine, ammirazione); ma sempre tenendo presente che si tratta di materiali di cui si nutre non solo la sua poesia, ma la scrittura in genere, se desidera veicolare verità e non finzione, sangue vivido e non umori incantevolmente vani.
Id: 864 Data: 09/01/2015 12:00:00
*
 Carla de Falco - Poesia - Edizioni Montag
Carla de Falco - Poesia - Edizioni Montag
La voce delle cose
È una scrittura densa e compatta quella di Carla de Falco, in cui l’insistenza sul male ed il dolore presenti nella dimensione privata come in quella pubblica coinvolge la qualità del lessico, che spesso assume un tono categorico, risentito, commosso. Più raramente, e specialmente quando la consapevolezza del reale cede il passo alla contemplazione, i versi inclinano ad un garbato lirismo, che canta la bellezza del creato ed il mistero dell’infinito spaziale e temporale che sovrasta l’umanità.
L’impressione globale è quella di uno sguardo intriso di profonda pietas, rivolto alle molte creature dell’ “umana famiglia / attaccata con grande fatica /ad un cosmo assolato e durissimo”, e di un’austerità etica che spesso non riesce a rinunciare ad un preciso messaggio, affidato, di solito, ai versi finali dei suoi testi poetici.
La de Falco mostra una sua precipua attitudine a mettere in scena il dramma che sta alla base dell’esistente: le persone, le cose, il suo stesso “io” vivono nei suoi versi una tensione conflittuale, che nemmeno il deus ex machina che è la Poesia, spesso rappresentata come ‘personaggio’ riesce a risolvere, connotandosi anch’essa dei colori di un disastro intimo, quasi una “sommessa apocalisse /d’abisso formidabile e vati oscuri”. Sembra quasi di sentire in questi versi la seconda strofa di “Commiato” di Giuseppe Ungaretti: “Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola / scavata è nella / mia vita come un abisso”, così come in altri testi rivivono atmosfere ungarettiane dolenti, o passaggi, dall’autrice assunti come motivi ispirativi, del saggio “Ragioni di una poesia”. Non per nulla la de Falco sceglie il grande poeta come una sorta di alter ego nel suo viaggio all’interno della poesia, il quale meglio di lei possa dire che cosa significhi cercare, attraverso il versificare, “la più umana verità” delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. Solo che la linea nemica, il fronte che mette a nudo fragilità e orrori dell’animo umano, nella poesia della de Falco si sposta dal campo di battaglia della prima guerra mondiale a cui il fante Ungaretti partecipò, a quello quotidiano con i suoi “chiodi ficcati nella terra”, i “cocci malfermi di case”, “un esercito di profughi composti”, minacciose “mani d’orco” e molte altre immagini e oggetti che, affollando i testi della nostra autrice, dichiarano al lettore la loro funzione di correlativi oggettivi (o, come recita il titolo della silloge, di voci). Quest’ultimi caratterizzano la poesia di un altro grande poeta del Novecento, quell’Eugenio Montale, che innestò la lezione leopardiana nella temperie del suo secolo travagliatissimo e artisticamente fervido e frammentato, portando all’estrema conseguenza la desolazione della perdita delle antiche “favole”. Anche l’autrice ha delle “favole” remotissime da cantare come l’infinito spazio-temporale nella bellissima poesia “la luce morta delle stelle”, la seconda morte di Euridice, la musa Euterpe, la donna-angelo; e perfino la sua stessa giovinezza, se essa si fa anche un simbolo di felicità alla maniera leopardiana, così come l’amore-sogno lasciato “sullo stridulo schiudersi della soglia / ristrutturata della nostra casa”, che ha ceduto il passo alla solitudine, che è forse il sentimento più diffuso e più angosciante dell’intera silloge. Al punto che essa sconfina, come in una celebre poesia di Montale, nel desiderio di contrarre un’amnesia che “laceri per sempre in nebbia fitta / la vista lenta e atroce della vita / che soccombe al vuoto dell’inferno.”
Leopardi, Ungaretti, Montale sono, dunque, palesemente o sotterraneamente presenti nella poesia della de Falco, che consegna ai suoi lettori una lezione importante a chi pensa di potere scrivere versi senza conoscere i grandi poeti del passato. Il compito è quello di interrogare di nuovo le cose del mondo, gli eventi, il proprio mondo interiore e trovare una voce personale, “la formula o l’antidoto per ingannare il tempo ed il suo pianto” - come l’autrice afferma nell’ultimo testo della silloge che intitola significativamente “la mia intervista”, in cui immagina di dire qualche definizione bugiarda sulla poesia e sul suo ruolo consolatore. Questo rifiuto di considerare i versi “un riparo”, come già aveva affermato nella poesia d’apertura (in una sorta di cerchio logico-emotivo compattante) mette, allora, in evidenza, come prima della poesia abbia il suo incontrovertibile valore la condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo, che è quella di una “affollata solitudine”.
Per questo motivo non esiterei ad indicare come messaggio finale della silloge la necessità che gli uomini ritrovino la capacità di amare e di abbandonare “la dura tracotanza silenziosa / di tante, troppe maschere di paglia”.
Id: 857 Data: 02/12/2014 12:00:00
*
 Alessandro Fo - Poesia - Einaudi
Alessandro Fo - Poesia - Einaudi
Mancanze
Angeli, musica e piccole cose
L’ultimo libro di Alessandro Fo Mancanze (edito nel 2014 da Giulio Einaudi) si divide in tre sezioni, la prima delle quali, “Libro d’oro”, aveva fatto la sua apparizione, ma solo in parte, in Corpuscolo (2004). Nell’ultima silloge i testi sono in tutto 19, meno, comunque di quelli che, nel frattempo l’autore aveva aggiunto, avendo preferito “per varie ragioni” escluderne alcuni. È, d’altra parte, questo incessante mettere e levare materiale poetico da una silloge all’altra un procedimento tipico di Fo, che rivela una sempre più selettiva analisi nei confronti della propria produzione, così che, come scrive più volte Davide Puccini in un lungo saggio -La parola del testo- pubblicato recentemente sulla “Rivista Internazionale di Letteratura Italiana e Comparata” (Fabrizio Serra Editore, Roma), essa finisce con l’assumere le caratteristiche di un work in progress. Anche l’Appunto che l’accompagnava e che ora si può leggere in Mancanze è stato in qualche parte modificato; però, per la comprensione del disegno generale della sezione, è molto più utile leggere quello inserito in Corpuscolo, in cui Fo fa riferimento ad un lavoro di dilatazione dei testi dell’ Ave Maria al Padre Nostro e al Gloria. Immutata resta, invece, la dichiarazione di poetica: “Il tentativo era accostarsi al divino non dalla devozione o dalla riflessione teologica, ma da quaggiù, sorprendendone infinitesimali particelle in questa realtà, nella persuasione che, generalmente parlando, specificità e forse compito della poesia sia precisamente cogliere e svelare, nella più favorevole posa, momenti alti, significativi e (per assenza o per incuria di osservatore) negletti, dell’esistenza di cose e persone”.
Questa prima sezione si apre con il testo al Figlio, i cui versi finali “Nulla è mai davvero come sembra,/ma almeno sette volte più complesso” ribadiscono la preferenza accordata a questo numero (che più di una volta ritorna nei testi) dall’autore, come dichiara in Anagrafe, un testo presente in altra raccolta: “Ho sempre amato il sette”. La sua comparsa trova qui una perfetta coincidenza con il numero delle stelle dell’Orsa Maggiore, visibile dal terrazzo vicinissimo al cielo,
e con quello del piano del testo successivo che sei nei cieli, da cui il poeta si affaccia per consolare un bambino in pianto (ma tornerò, tra breve, su questo testo). Questo numero, d’altra parte, si è da sempre ammantato di sacralità sia nelle antiche culture e religioni, sia nella liturgia cattolica: è sufficiente pensare al Libro dei sette sigilli (non deve nemmeno sfuggire l’accostamento fra i due titoli), disserrati i quali, di visione in visione, si giungerà a quella culminante che disvelerà il sacro segreto di Dio.
Dunque, la realtà delle cose, così come appare ai sensi, non coincide con la loro verità, e tutto è “almeno sette volte più complesso”, pur se una tale complessità e segretezza reclami imperiosamente un’interpretazione più attenta di ciò che si offre alla conoscenza. L’autore ammette, infatti, che per la ricerca di Dio avrebbe potuto avviare, come fa Agostino, il metodo ascensionale neoplatonico applicato, consciamente o meno, nel famoso episodio dell’ “estasi di Ostia” con la madre Monica nel nono libro delle Confessioni; e, come aggiunge nei ragguagli: “il caso vuole che il nostro appartamento fosse allora immediatamente a ridosso del cielo, all’ultimo piano di uno stabile in Via Dell’Orsa Maggiore, a Roma, “non lontano da Ostia”.
Molto interessante, per i diversi livelli interpretativi che sollecita, è il secondo testo: che sei nei cieli: l’episodio narrato è semplice. Gli attori sono due: un bimbo rimasto chiuso fuori, e un inquilino del palazzo (lo stesso Fo) che cerca di consolarne il pianto, promettendo di aiutarlo. La lettura letterale è ovvia. Ma essa si fa più complessa, se in quell’inquilino del settimo piano e in quel bambino, laggiù, che “implora il padre”, cogliamo la metafora del rapporto fra l’uomo e Dio: quest’ultimo cerca di manifestarsi alla sua creatura angosciata, che sembra non vederLo e non sentirLo, restando preda il bimbo della sua solitudine, di impotenza Dio. Ma a quest’ultima si potrebbe aggiungere un’altra lettura e vedere in quell’inquilino che abita al settimo piano e in quel bimbo accorato che sta dietro il cancello chiuso lo stesso Fo (tant’è che il bimbo si chiama come lui, Alessandro), che, dunque, si autorappresenta, sdoppiandosi nell’adulto che ormai è dal punto di vista biologico-anagrafico e nel suo “io” più interiore ancora bambino in cerca di un Dio che non trova, anzi, che rinnega “pure/ la pura verità” di averne udito la voce.
I due testi successivi: Il prato metafisico e come in cielo (parla Mario Ciani), che occupano le pagine 10 e 11 sembrano mettere anche visivamente a confronto le creature visibili e quelle invisibili, oscillando, tuttavia, le prime “fra le nebbie del dubbio”, mentre le seconde, pur non concrete, sfatte già nel piccolo cimitero vigilato dalla vicina Basilica dell’Osservanza,si fanno
memoria che può dire: “Simone è qui../ Poi ci sono altri giovani, / Gaia, Claudia, Francesca…”
La seconda sottosezione, ruotando sul concetto del tempo che trascorre inesorabilmente
(Stagioni) fino a condurre ogni creatura vivente alla morte (La visita in ritardo) rappresenta anche un veloce excursus autobiografico, riscattati l’una e l’altro dalle “scarpe di Emma” (Ripristinando indumenti invernali). Le scarpe di Emma è il titolo di una plaquette pubblicata nel 1996: essa, dunque è richiamata (e questa dei richiami da una silloge all’altra costituisce un altro dei procedimenti ricorrenti di cui fa uso Fo nell’organizzare le sue pubblicazioni, come a volere costruire un’architettura globale intorno a degli assi portanti o temi-chiave); le scarpe di Emma, come scrive Davide Puccini nel saggio già citato: “contengono al loro interno il celebre carpe diem di Orazio.” Il senso metaforico è quello già espresso nella plaquette: le scarpe, infatti, rappresentano la poesia “incaricata di vincere la lotta contro il tempo, ma qui come altrove, rappresentata da piccoli oggetti di uso quotidiano, per la differenza di statura tra il poeta moderno e il grande classico, dovrà accontentarsi di salvare l’attimo che fugge, realizzando in proprio il carpe diem, passato da un’aurea regola di vita ad una modesta concezione poetica”.
In tutte e due i componimenti la stagione da sconfiggere è l’inverno (simbolo del male e del dolore); evocato nella prima versione dalle pozzanghere, nella seconda da pioggia, tramontana e gelo; però, se nella prima versione veniva citato il “monumento perenne” anch’esso di oraziana memoria, indicante l’eternità della poesia, qui Fo non indulge a nessun legame fra l’una e l’altra, e invece fa entrare in scena Dio che “invita lungo il lucido sentiero / l’angelo che consola”, dove allora si stabilisce un nuovo legame tra l’atto della scrittura e l’Assoluto, per cui la poesia diventa essa stessa “àngelos”, cioè colei che annunzia il divino, anticipando la sezione terza Figure d’Angeli, in cui anche il testo iniziale (Angelo del Botticelli) allude al nesso arte-angelicità. L’idea della sacralità della scrittura ritorna in benedetto il frutto: nella prima strofa, l’autore rappresenta la scrittura come pensiero che si fa inchiostro sulla carta, veicolando “idee, conforto e affetto”, nella seconda, facendo il percorso contrario, risale dalla scrittura lasciata su un foglio (dove una lei distante gli sta scrivendo, come immagina) al “suo pensiero”, che definisce “lo spicchio di un rapporto, di un progetto,/nientedimeno che un’idea di Dio”. Seguono i testi dedicati a Maria, quelli che sono rimasti dopo una selezione severa, come avverte il “Reliqua desiderantur” che li suggella. Infatti si tratta di soli nove testi. Il numero non è frutto del caso (niente lo è nelle opere di Fo): anche il nove, infatti, come il già ricordato sette, è un numero teologico: nove sono i cori degli angeli, nove le sfere dell’immagine cosmica medievale. E soprattutto il nove richiama alla mente la pratica devozionale della novena, recitata a Maria.
Il primo di questi testi, Ave Maria, ricorda la statuina di legno della Madonna collocata nel reparto Ortopedia dell’ospedale Sant’Eugenio, opera di un “approssimativo” ingegno artigianale di un “devoto cultore”. Essa, con le sue mani “grandi e tozze”, “un po’ scrostate,/tese e aperte, riparo/dagli assalti del male”, rappresenta l’impossibilità da parte dell’uomo di raffigurarsi il sacro, essendo destinato per “mancanza” di verità e fantasia ad un approccio approssimativo, sebbene funzionale alla salvaguardia della “simbiosi di spirito e corpo”, grazie alla quale, attraverso i sensi fisici, si possono comunque avvertire epifanie di chiara bellezza inverante (anche se solo parzialmente) benedetta dallo Spirito. Così come la bellezza di Maria “dev’essersi/ se non tutta/ spartita almeno in parte” fra le donne “che sono nel mondo”, sebbene quella delle donne terrene sappia di precarietà, tanto da spingere Fo ad accampare una questione squisitamente teologica: se cioè le creature “si possano ammirare / con innocenza: senza / colpevolezza” e conclude con una domanda rivolta a San Paolo: “si può amare / il Creatore nelle sue creature?”: “Adesso vediamo – scrive l’apostolo – come in uno specchio, in modo oscuro: ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò perfettamente, come perfettamente sono conosciuto” (Lettera ai Corinzi, 13,1). La questione sta, infatti, nel rapporto tra Perfezione e imperfezione, tra Eternità e caducità, tra Verità ed apparenza; e tuttavia la risposta si suppone affermativa, visto che poi tante donne concrete, e talvolta in parte o perfino fortemente imperfette, assurgono a figure d’angeli nella terza ed ultima sezione.
Intanto, fra la prima e la terza, si colloca Il tono blu. Si tratta di 17 componimenti distribuiti in quattro gruppi più o meno scarni (da uno a cinque testi) dedicati all’amato Chopin, il grande compositore polacco, che, come il pittore Eugène Delacroix, tendeva alla ricerca di quel tono blu, come “suo respiro naturale” e che si approssima a quell’idea di grazia che “si dispiega nel rallentatore” (e mi si perdoni l’avere fuso insieme alcuni versi del primo testo “Grazia (secondo Gide)” e altri di “Diciassette”). Molto probabilmente il numero diciassette è stato scelto in omaggio alla “melodia nel la bemolle/minore del preludio 17”, la più amata da Fo, appunto per quella lentezza di cui si diceva, che la caratterizza.
Questa sezione, forse più delle altre, evidenzia sia “la coltissima scrittura in versi di Fo”, quasi alessandrina, come scrive il critico Massimo Natale (Il Manifesto, 22/6/2014), sia quel tema dell’Assenza che percorre tutta la silloge e che variamente si configura: imperfezione, desiderio, manchevolezza, brevità e dissolvimento di epifanie, e perfino, quella soppressione di testi, in questa come nelle raccolte precedenti, in quanto giudicati mancanti di qualcosa.
Il tono blu è tutto costruito intorno ad una serie di citazioni (dal necrologio apparso poco dopo la morte del compositore il 21 ottobre del 1849; dalla biografia di Jarosław Iwaskiewicz; da Ripellino, da Gide, Virgilio, da “La vita di Chopin attraverso le lettere” a cura di V. Rossella e così via), che però non appesantiscono i testi che lo compongono, ma piuttosto sembrano avere il compito di fare convergere le varie voci, allo scopo di tracciare parallelismi e manovrare agevolmente il filo del tempo, arretrandolo o avanzandolo nel giro di pochi versi, come quando i molti ritratti di Chopin permettono a Fo di paragonarne il volto ai personaggi più disparati: Mozart, Del Piero, Leopardi, Carrai, espediente che serve probabilmente a disegnare l’indefinibilità dell’essenza dell’arte musicale. Il tema della mancanza domina il testo Congedi (Gide in Italia), in cui si racconta l’incontro di Gide con l’Abate di Montecassino, che, seduto in poltrona, “legge una partitura / eseguendola nella mente”; così che “la musica più pura” di Chopin, diventata silenzio, può infine definirsi “una gioia perfetta”. Infatti, solo coincidendo con un’astrazione del pensiero, essa è diventata qualcosa di davvero perfetto, non avendo più bisogno di alcuno strumento materico per esprimersi.
La terza ed ultima sezione del libro ha titolo Figure d’angeli: anche in essa Fo raccoglie testi già proposti in varie sedi, ma non senza averne scartati alcuni, non “in virtù di una poetica del frammento; ma per una sorta di variante della discrezione, combinata con la sensazione che a volte, per amore di serie, chi si cimenta con il comporre poesie rischi di farsi trascinare dai suoi testi e non trattarli con la dovuta severità” (da Un appunto).
L’idea muove da La vita nova di Dante, là dove si legge (34,3): “Onde, partiti costoro, ritornaimi a la mia opera, cioè del disegnare figure d’angeli” (brano che fa da exergo alla sezione).Tuttavia, la figura stilnovistica della donna-angelo passa attraverso la lezione di Montale, specie de La bufera, che l’attualizza proiettandola sullo sfondo della guerra, quasi fermandola su una sorta di limen fra tragedia storica e metafisica, dove tuttavia ella resta inattingibile. Ma le suggestioni, che concorrono alla composizione di questa sezione, sono molteplici: La Venere del Botticelli come la piccola Torun, protagonista di un celebre raccolta poetica di Ekner, Ripellino come Sant’Agostino, Petrarca come il regista Wim Wenders. Né trascurerei le figure femminili disegnate da Giorgio Barberi Squarotti, a cominciare da “Le vane nevi”, soprattutto per l’attenzione ai dettagli dell’abbigliamento (i jeans, le magliette sopra l’ombelico, i piercing, i tatuaggi) e delle acconciature, come a certi particolari fisici -che le rendono così riconoscibili e diverse l’una dall’altra- e all’ambiente in cui si muovono (Fo aggiunge, rispetto a Squarotti, una particolare predilezione per gli elementi dell’arredo degli spazi interni). Tuttavia, c’è da dire che le ragazze di Squarotti, sempre giovanissime e fisicamente perfette, come sospese fra “il gioco amabile di verità sfrontata e di modestia”, rappresentano, più che messaggere celesti, l’impeto amoroso e spavaldo della giovinezza; Fo, invece, scrive in Appunto di volere fissare nei suoi versi: “schegge d’incontri con persone di diversa età, natura e condizione, che in un qualche loro gesto o atteggiamento schiudono un raggio di sostanza angelica”. Così, fra gli angeli di Fo, troviamo anche un passerotto ed un palloncino con la forma di un coniglio blu, e alcuni uomini, come Angelo Ciriaco, un prete indiano, dalla voce naturalmente melodiosa, “umile e mesto”; Angelo Leone, che “cammina molto, e lungo i passi prega”; e soprattutto il Padre già quasi angelo, testo fra i più intensi della sezione, dove, come in molti altri, il dialogo fatto di banali quanto affettuose battute e di ricordi e minimi progetti (purtroppo non destinati a realizzarsi) sottolineano la dolorosità dell’evento prossimo della morte del padre. Fo, infatti, cosi scrive sobriamente nei ragguagli: “Non siamo più ritornati insieme ai mondiali di pallavolo”. Un altro testo tenero ed intenso è quello che ha titolo Angeli su scala, in cui gli angeli sono due (“due capolavori del Creatore”): una ragazza down “preziosa luminescenza bianca con foulard”, poco prima scambiata per una sposa; e un’altra “di occhi bruni acuti e luminosi/ vestita in scuro” (il contrasto cromatico evidenzia maggiormente le loro singolarità).
Lei, la ragazza down, appare come mossa da un curioso quanto vago desiderio di misurare tutto lo spazio intorno: “la vidi scendere le scale”, “si aggirava flessuosa nella sera”, “si dispose accanto a una bellezza giovanile”, “riprese il giro”, “uscì di scena, risalendo le scale”, tracciando, così come il moto incessante degli angeli lungo la scala di Giacobbe a cui va la memoria, quel dialogo fra alto e basso, di cui ogni angelo ha il compito di farsi mediatore.
Un altro incantevole testo è Diffrazioni: angelo bambina, (che ricorda un passo delle memorieproustiane, in cui però domina il biancore dei biancospini)dove le diffrazioni si moltiplicano e si intrecciano mirabilmente come in un gioco prezioso di specchi: così il bianco del giglio che giace nel grembo di un dipinto di Santa Caterina in una chiesetta solitaria, come uscendo dall’illusione pittorica, si fa reale moltiplicandosi in un mazzetto di gigli posto sull’altare che sembrano riverberare la loro luce sulla pelle bianca di una bambina, creando una sorta di crescendo luminoso; intanto che un’altra diffrazione si somma alla prima, quando la voce della madre che chiama la piccola figlia con lo stesso nome della Santa dà luogo ad una sovrapposizione di purezza su purezza, se si considera il significato del nome che vuol dire “la pura”, e la considerazione che quella bimba porta con la sua età il bene dell’innocenza. E così, in questo gioco elegante di rimandi visivi e sonori, la poesia si snoda tra concretezza e visione; e realtà e sovra-realtà fluiscono l’una nell’altra senza soluzione di continuità.
Ora, al di là di quest’analisi per forza sommaria delle tre sezioni di Mancanze, è doveroso sottolineare quei nessi tematici che le collegano e fanno del libro un discorso unitario. Essi sono il dolore e la pietas, il mistero della vita e della morte, il dialogo difficile ma ineludibile fra umano e divino, la bellezza femminile (e direi la bellezza in genere) e la morte; l’atto della scrittura, Dio e il tempo, che, poi, sono quelli attorno cui ruota da sempre la poesia di Alessandro Fo. Non manca in questa raccolta la presenza anche delle creature animali: passeri, chiocciole, cani, formiche, pecorelle, un pettirosso, piante e fiori (cioè, il “brulichio infinito delle vite”), tutto ciò che vive per molto o per poco, e che è segno di un progetto spesso incomprensibile nella sua totalità e soprattutto dell’ “immateriale/dentro il materiale”, complesso e variegato e, tuttavia, offerto ai sensi dell’uomo per un salto verso la conoscenza della Verità, ma anche come possibilità di stabilire particolari relazioni affettive con i fratelli più piccoli. Mancanze, al pari delle altre sillogi, s’avvale di una capacità scrittoria raffinatissima e tuttavia accessibile, classica ed insieme aperta ad un garbato sperimentalismo, tutta giocata su un’attenta ed equilibrata combinazione di sermo cotidianus e di citazioni colte.
Id: 837 Data: 19/09/2014 12:00:00
*
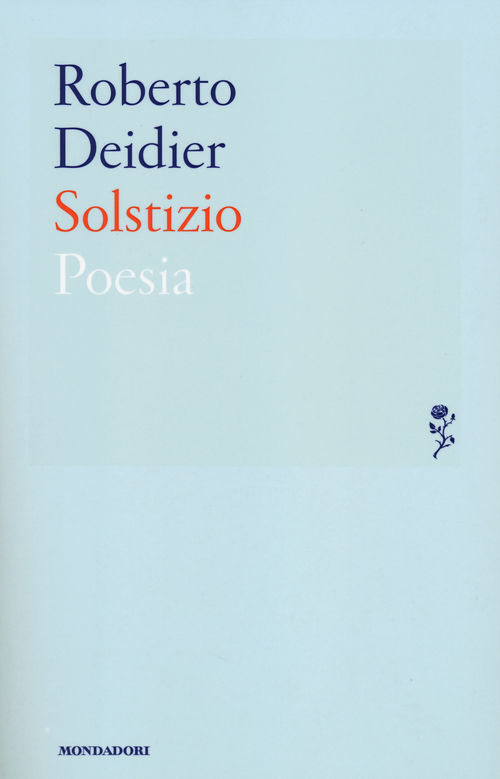 Roberto Deidier - Poesia - Mondadori
Roberto Deidier - Poesia - Mondadori
Solstizio
“Conservare i germogli dall’inverno”: così la Musa di Deidier salva se stessa.
C’è come uno spazio d’occultamento sotto i versi di questo libro: vi cadono le emozioni più profonde, i ricordi, e perfino i nomi dei molti che spariscono nella folla, e degli amori vissuti in case non più abitate, o comunque vuote d’oggetti, di colori, talvolta allucinate ooniriche.
E le città, le vie, i porti, le stanze, sia quelli visitati nel passato, sia quelli che accolgono il tempo presente, non importa se solitari e bui o luminosi, deserti o affollati e vitali - come nella città di Palermo dove da qualche tempo Deidier risiede - sono luoghi d’estraneità in cui l’autore sta e vive solo fra gli altri.
Questa percezione di inappartenenza è, del resto, la cifra esistenziale di Deidier, tant’è che perfino le relazioni amorose se ne oscurano; e a tal punto, che, pur nella prossimità fisica con l’amato ( molto più spesso fantasma baluginante della mente, tra nostalgie, rimorsi, rassegnazione all’incompletezza ed alla clandestinità ), il sonno di lui a labbra appena aperte gli suggerisce l'immagine enigmatica ed inquieta della notte che là si è tutta riversata. Che è come ammettere che la parola recisa dal sonno è la stessa della veglia, rabbuiata, ammalata, ormai, di inadeguatezza, incapace di tessere rapporti di più intima confidenza ed appartenenza, lasciando posto alla più sterile ed amara “discrezione” “dei non visti, usciti di nascosto”.
Tutto, allora, diventa in questa silloge un segnale della perdita, della rovina che sembra attraversare la storia dell’uomo e poeta Deidier, come quella dell’Umanità, a partire dagli stessi personaggi biblici a cui è dedicata un’intera sezione. Essi, sempre alle prese con un difficile e soffocante rapporto con una Volontà inafferrabile, non visibile, che tuttavia entra nel loro privato e ne confonde gesti e sentimenti, vanno spesso incontro alla rovina di se stessi, alla rinuncia ed alla rassegnazione. E così, benché tratti dall’antico libro sacro, essi si fanno figure contemporanee che hanno smarrito l’interezza ed il dialogo.
Lo stesso Adamo diventa colui che rifiuta il ruolo di nominare il mondo, per cercare il silenzio, la ferita, l’abisso. Adamo, allora, è il poeta contemporaneo che non sa più usare i nomi per raccontare il mondo agli altri.
Egli, che preferisce il vuoto, s’apparenta anche alla significativa figura del trapezista, protagonista della terza sezione della silloge, che ormai da anni vive nella sua dimensione sospesa, avendo scelto la separatezza dal mondo e dagli altri, dominato soltanto dall’assillo di perfezionare la sua arte: “Manteneva esercizio e perfezione / Soltanto comportandosi a quel modo”. Questa “figura” della condizione di solitudine esistenziale dell’artista è tratta dal racconto breve di Kafka : Primo dolore, in cui un trapezista, come scrive Ermanno Cavazzoni, dimora “nella sua altezza siderale, lontano dalla curiosità degli spettatori, divorato dall’ansia di non riuscire a superare se stesso”: è questo, infatti, il senso della richiesta - accoratamente accompagnata dal suo primo pianto - al suo impresario di procurargli un secondo trapezio grazie al quale rendere più complesso e spettacolare il suo esercizio. E quelle funi, che per il trapezista di Kafka rappresentano simbolicamente i pochi legami che lo annodano alla vita, diventano per il poeta le parole, sebbene sempre più inappartenenti, sempre meno “religiose”. Solo che inevitabilmente la rinuncia ai rapporti interumani finisce con il lasciare sulla “fronte fanciullesca” del trapezista kafkiano la prima ruga, il cui significato ( per ammissione dello stesso Deidier ) sta anche “in un surplus di bisogno, anche amoroso, che segna la fine della gioventù, la sua schietta indipendenza”, un certo scricchiolio del cuore e della mente, “l’inizio di un tormento mai cessato” di fronte alla difficile vocazione dell’arte: “(…)Come faccio a vivere / Solo con questa sbarra fra le mani?”.
Questa separatezza – se non, spesso, sepoltura tra macerie, fiumi sotterrati, residui, ombre e notti senza sogni, nel presente e, di conseguenza, nel futuro – anche dalla vitalità e dalla speranza, che investe soprattutto la comunicazione e la forza degli archetipi (“Non posso più accendere immagini”), ricorda fortemente “L’AngelusNovus” di Klee, così come lo descrive Walter Benjamin, che in esso vede l’angelo della storia che “ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula rovine su rovine”, intanto che una tempesta “lo spinge nel futuro, a cui volge le spalle”. La sua descrizione ricorda quella del personaggio che introduce le poesie di “Solstizio” diDeidier, visto nel momento in cui “Si era fermato, lo sguardo all’indietro/ Il passo avanti verso l’orizzonte “, mentre tutto intorno non c’è che distruzione. Questa “istantanea senza redenzione” sembra fotografare lo stesso autore, che, nella prima delle sezioni, più volte, anche se mai la nomina, paragona il suo destino a quellodella moglie di Lot, che, voltandosi indietro, divenne una statua di sale.
L’immobilità, il deserto, la bianchezza del sale, il non sapere la meta, la presenza delle rovine sono, infatti, le immagini più ricorrenti nei versi di questa silloge. È, dunque, chiaro come tutto converga verso il problema del linguaggio, in specie quello della Poesia, a cui spetta,più che alle altri arti, il ruolo di salvare la parola come unico strumento di comunione con le cose del reale, e dare fondamento e fattibilità al sogno dell’Uomo e alla storia dello Spirito, quale linguaggio altro, se non “magico”, rifondante.
Non a caso la silloge si conclude con la sezione intitolata “Musa”, alquanto diversa dalle altre e nelle sue soluzioni stilistiche e nel suo contenuto, né descrittivo, né riflessivo, ma piuttosto volto a rappresentare il rapporto fra la poesia e l’autore che sembra mettersi sotto accusa il ricorso alle immagini contro la pochezza del dire e si accorge, intanto, dei tentativi da lei messi in atto per autodifendersi, ben più viva e dotata di volontà com’è dell’uomo, quali: “guardare altrove”, “potare le begonie” e “conservare i germogli dall’inverno”.
L’autore, d’altra parte, riconosce che sono ormai rari i momenti in cui si abbandona davvero a lei, mentre più frequenti sono gli altri in cui ne ha quasi paura per quella sua lingua che sente come “un mostro da evitare”; per il suo salto fuori del tempo ordinario, per la sua “troppa luce” che lo fa fuggire.
Tuttavia egli sa che soltanto la poesia è la sua amata, quella che, se perduta di vista, lo spinge a cercarla affannosamente, a pregarla di rimanere : “Ti chiedo a bassa voce di tornare”.
E non credo che questo appello sia soltanto rivolto a suo beneficio, quanto piuttosto a quello di ogni uomo-poeta, affinché ritrovi se stesso e il proprio mistero attraverso il linguaggio alternativo e salvifico della poesia. Le radici mitiche, religiose, affettive, che qui appaiono turbate e corrose da un eccesso di razionalità, devono essere recuperate nel loro significato vergine ed autentico, affinché tutti possano conoscere “il nome vero del gioco che facciamo” e recuperare “la felicità sommersa”. È così che si apre tra i versi uno spiraglio di luce e dal solstizio d’inverno il tempo sembra anelare alla “pura luce estiva, che è luce della lingua, quando è il centro di se stessa”, come mi scrive in un messaggio privato l’autore stesso.
Id: 828 Data: 01/08/2014 12:00:00
*
 Roberto Maggiani - Poesia - Italic
Roberto Maggiani - Poesia - Italic
La bellezza non si somma
La bellezza non si somma di Roberto Maggiani è un libro compatto e cristallino, nato da uno sguardo tenero e innamorato verso tutte le cose della terra e del cielo, nel cui cuore Maggiani trova la presenza divina, testimoniata soprattutto dalla Bellezza.
E, siccome, come direbbe Dante, la Bellezza si squaderna per ogni dove, ne consegue quell’attenzione (rivelatrice sia di una forma mentis di stampo scientifico che della tensione di una vivida spiritualità) nei confronti anche dei dettagli, letti come minuscole ma in sé perfette epifanie. Infatti, certe descrizioni sono così minuziose da richiamare il motto latino “ut pictura poesis”, come potrebbe dirsi a proposito di quella di una lucertola inserita nel testo “Regni”, che sembra tradurre in parole l’illustrazione di un manuale scientifico; e però, ad arginare il rischio di una caduta nel mero descrittivismo, per quanto prezioso possa apparire, è il loro valore metareale che le trasforma in simboli di una ricerca sulla provenienza e sulla destinazione, attraverso la quale misurare e spiegare la trama dei rapporti fra le creature tutte, e tra esse e la divina energia.
Al vertice della Bellezza Maggiani pone, direi biblicamente, il corpo umano. L’indugio amoroso sui dettagli (le dita dei piedi, le unghie, il bianco della pianta, le vene, le caviglie) costituisce lo strumento più adatto ad esprimere la stupefacente architettura dell’insieme. In “Ritratto” (a pagina 20) è la considerazione della perfezione a trasformare un corpo maschile (non si può, nel leggere questi versi, non pensare alla statuaria greca d’età classica e di conseguenza al Rinascimento) in un altare sul quale compiere i riti della sessualità. Lo sguardo rivolto alla nudità, simile a quello di un autore erotico come Kavafis, si trasforma in contemplazione, coincidendo esso con uno spazio sacro (appunto come un tempio) nel quale il Tutto si raccoglie e differenzia nei suoi elementi: mare, cielo, frutti, semi, a cui via via sono paragonate quelle così amate membra. Così nei versi: “Nel tuo preciso ansimare si solleva il cielo”, Maggiani canta il ritmo cosmico battuto dal cuore come anche l’estasi “divina” del piacere amoroso.
Dunque, ancora una volta, Maggiani dichiara allo stesso tempo fedeltà alla scienza ed alla poesia, al di là del pregiudizio di una loro impossibile alleanza linguistico-creativa, trovando il punto d’incontro nell’experiri, che dalle superfici delle cose risale sia alle leggi che le regolano, sia al loro intimo mistero, approdando alla totalità della Sapienza, a quell’Intelletto d’amore, che ancora una volta ci riconduce alla visione dantesca.
A testimoniare questa continuità e duplicità dell’experiri è l’abbondanza delle similitudini, le quali, pur servendo, secondo gli scopi della retorica, ad accostare fra loro somiglianze di cose lontane con effetti di dilatazione spazio-temporale, si fondano sul valore simbolico-metaforico del reale e, ancora una volta, sullo stupore che suscita la sua bellezza fino al punto di non potere essere descritta che rimandando ad altro.
Da qui si origina l’accumulo, in questi testi, delle cromie più abbaglianti e quasi mistiche dell’oro e dell’azzurro, nel tentativo di ricreare certi istanti irripetibili del giorno e della notte, ma sottilmente ombrate dal sentimento della precarietà (di certo il più congeniale alla Bellezza), che assume come emblema il mare, la cui mutevolezza acquorea e cromatica diventa la scena vasta ed aperta che accompagna il cammino umano e spirituale dell’autore.
Infatti la silloge di Maggiani, attraverso la frammentazione dei testi, ora brevi ora lunghi, mentre ricostruisce un itinerario concreto in altre terre, diventa metafora di un parallelo percorso filosofico-religioso. Dominante è il paesaggio portoghese, sebbene non sia l’unico, con i suoi porti, la musica, la natura, la storia, e, soprattutto, il respiro dell’Oceano, che, quando è in burrasca, fa risuonare nell’orecchio del lettore, in versi di grande effetto musicale, il cigolio dei cavi d’ormeggio e delle sartie, il rumore della pioggia che cade sull’acqua, la voce del vento, il ritmo della milonga.
Il viaggio, che spinge a usare tutti i sensi per esplorare e conoscere e che mai esaurisce il suo fascino e la voglia di proseguire, che, mentre accresce il sapere, espande il desiderio di ciò che non è ancora visibile o udibile, è anche, però, un’ammissione dello smacco conoscitivo dell’uomo.
Infine, Maggiani approda alla socratica conclusione di sapere di non sapere: e, tuttavia, nell’accoglimento del limite, fa di quest’ultimo la piattaforma del salto amoroso verso Dio, destinatario di uno dei testi più coinvolgenti, in cui l’autore riassume la posizione intellettuale che informa la silloge e che gli permette di considerare la poesia come uno strumento d’indagine della dimensione metafisica a partire dalle cose concrete e, nonostante la consapevolezza del rischio (noto a lui come ad ogni altro uomo) di non sapere e potere ascendere al Mistero, finendo con il misurarlo e circoscrivere in canoni troppo umani.
I versi che così recitano: “Ti cerco instancabilmente / ed è solo per la nostalgia che ho di te / che scrivo poesie” costituiscono una dichiarazione di poetica che pone al centro del desiderio conoscitivo come del gesto creativo proprio il concetto di limite, così che, come ci ha insegnato Leopardi, l’infinito si genera dal finito.
Un testo emblematico in questo senso è a pagina 35, in cui Terra e Cielo appaiono uniti dalla contemporaneità di due diversi eventi. In realtà il testo si svolge secondo una linea descrittiva attenta, come al solito, ai dettagli di una scena che appare agli occhi in un determinato luogo e in una determinata ora; ma, improvvisamente, nell’ultima strofa, dopo avere focalizzato un uomo che si immerge, nelle prime ore del mattino, nelle acque di una piscina; l’attenzione del lettore viene spostata sul lontanissimo Marte, dove, intanto, sta atterrando la sonda spaziale Curiosity.
Ora è proprio questo rapido accostamento a sottolineare il loro iscriversi nell’enigmatica estensione dello spazio e del tempo. Del resto, sostiene Maggiani, non solo è misterioso e talvolta inquietante ciò che infittisce l’enigma del distante, ma anche ciò che cade sotto i nostri sensi, tanto è vero che accanto al mondo organizzato a misura d’Uomo, senza andare lontano, esistono i “Regni” delle altre creature: quello degli uccelli, per esempio, o delle lucertole, o delle carpe, della cui visione del mondo nulla conosciamo.
Una tale lettura stratificata della realtà che dà luogo alla complessità della visione esistenziale di Roberto Maggiani, mi sembra efficacemente rappresentata dal testo “Energia-Fiamma”. Nella prima strofa un lessico prevalentemente scientifico descrive il mondo come una bolla di luce ed energia. Fin qui, appunto, giunge il processo conoscitivo linguistico-intellettuale dello scienziato, che, nel riassumere un sapere, si avvale di un’immagine tratta dalle sue osservazioni. Nella seconda strofa si fa strada il livello psichico-emotivo di chi conosce per intuizione, emozione e suggestione irrazionale: ed ecco il santone che cammina sulle braci, indifferente all’oggettività fisica del dolore. Il soggetto, infine, della terza strofa è l’energia creativa. Procedendo dal più grande al più piccolo (ma la bellezza non si somma, ricordiamolo!) l’autore si giudica come poeta, rivelando una certa scontentezza nel constatare il limite della propria poiesis, così da affermare: “Ho urgenza di penetrare il Cosmo – / ma non riesco ad andare così a fondo / (…) [parafrasando, non riesco a spingermi con le parole] / più in profondità – nei giacimenti – / non riesco proprio ad arrivare.”
Una tale dichiarazione rappresenta anche una presa di coscienza dell’impossibilità, al di là delle capacità personali, del linguaggio in sé di fronte a ciò che è incomunicabile. Al punto che il limite, piuttosto che una deficienza, appare come un segno della potenza di Dio: detto questo, è facile comprendere il poeta quando conclude che la sua poesia si origina dalla nostalgia di Dio, che è come dire dall’Essere che si sottrae alla morte, sconfiggendone lo scandalo. In questo senso Dio e poesia prima vengono accostati con una congiunzione per poi finire con l’identificarsi, per cui Dio è poesia e viceversa.
E, dunque, la vera conoscenza si colloca in un altrove a cui nessuna parola umana può giungere se non con un salto irrazionale e inspiegabile, simile a quello con cui ciascuno di noi passa dallo stato di veglia a quello del sonno: “Quando ti assopisci / c’è un momento in cui sussulti: / è breve il passo verso il mondo dei tuoi sogni – / basta un piccolo slancio – / un saltello oltre il fluire della veglia.”
www.robertomaggiani.it/la_bellezza_non_si_somma.asp
www.facebook.com/labellezzanonsisomma
Id: 792 Data: 28/02/2014 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Poesia - I Quaderni di CNTN n. 28
Aa. Vv. - Poesia - I Quaderni di CNTN n. 28
Nuovi Salmi
I nuovi salmi: bocca a bocca con Dio.
Antologia curata da Padre Ribaudo e Giovanni Dino.
Dio: cercarlo, amarlo, invocarlo, dubitarne, negarlo, e addirittura insultarlo, spodestarlo della sua onnipotenza, farne un abisso, un errore, bruciare per Lui o lasciarlo in una gelida distanza; ma sempre sentirlo come la domanda essenziale dell’esistenza, quella che determina in modo fondamentale un’inclusione o un’esclusione dalla dimensione della filialità divina, una scelta di continuità soltanto biologica o metafisica.
Così nel corso dei secoli passando attraverso vari sistemi filosofici, costruzioni ideologiche, antitesi e scontri teologici, lodi e bestemmie di scrittori e poeti. Una pesante eredità, un infinito sfaccettarsi del sentimento religioso, una laboriosa oscillazione del guazzabuglio che è il cuore umano, come lo definì Manzoni.
Ma tutto questo non appartenne ai salmisti che collocavano al centro della storia d’Israele un Dio che li aveva eletti come il suo popolo, quello da difendere da ogni assalto nemico e a cui assicurare un giorno una grandezza senza limiti; che credevano con ferrea certezza che Lui dall’alto dei cieli ascoltasse i loro lamenti e le loro suppliche e perfino approvasse i loro sentimenti di odio ed esaudisse la richiesta di vendetta contro i nemici, che della propria vita facevano un insieme di giorni tributati come riti santi alla sua potenza. Loro che erano convinti della fragilità dell’uomo e dell’impossibilità di non macchiarsi del peccato, ma che, al contrario di altri sistemi teologici, riconoscevano nella colpa l’implicita redenzione, perché “Il ritorno a Dio – scrive Magghid di Mezzitch – è nel peccato come l’olio nell’oliva.”
Una forte soggettività (e però sempre posta nell’ottica di una coincidenza tra l’io ed il noi, tra il bene individuale e collettivo, l’io come elemento corale) contraddistingue i salmi, spesso una certa terrena, troppo terrena umoralità, poiché in fondo il loro Dio Unico non è così distante dagli dei pagani. Egli nutre sentimenti d’ira, di gelosia, di vendetta, anche se può e sa amare gli Israeliti come figli prediletti. Infatti la caratteristica nuova di questo Dio unico degli Israeliti è la capacità di stabilire un rapporto d’amore con ognuno di loro. Manca ancora quel respiro cosmico che darà all’amore tra Dio e l’uomo -ogni uomo vivente sulla terra e addirittura ogni essere creato, come dirà San Francesco- la predicazione di Gesù, incarnazione del Divino Verbo. Con lui si spalanca l’Amore e con l’amore la libertà.
Che è soprattutto libertà d’espressione, e quindi anche rischio, soprattutto se la parola è quella dei poeti, non perché essa sia , come scrive Turoldo, “risoluzione e pacificazione del conflitto “ che è in sé “il mistero paradossale del Cristianesimo”, ma perché ne è, comunque “sua massima espressione” ed “apertura”.
Bisogna tenerne conto quando si sfogliano le pagine antologiche de “I nuovi salmi”, che raccolgono le voci di tantissimi poeti italiani e non, cattolici e non, religiosi e laici, credenti e agnostici. E non importa se i grandi sono mescolati ai più piccoli, perché, pur volendo essere un’opera letteraria, l’antologia vuole farsi soprattutto testimonianza della temperatura spirituale di questo nuovo millennio.
Davvero c’è un legame tra questi salmi contemporanei e quelli biblici? Può definirsi questa operazione voluta da padre Ribaudo e da un poeta come Giovanni Dino, cantore appassionato delle cose dello Spirito e delle creature, corretta e soprattutto “utile” ai lettori?
Qui, infatti, non si trattava di ispirarsi ai salmi (come hanno fatto già in tanti, come Spaziani, Turoldo, Ungaretti, e molti altri) di attingerne bellezza e fermenti poetici, immagini e toni, ma di rifondarli in chiave moderna, perché fosse palese in che modo l’uomo d’oggi sappia lodare Dio, supplicarlo e percepirne la presenza nella storia.
La prima osservazione è che, in generale, la potenza espressiva dei testi biblici, l’abitudine uditiva al loro linguaggio in quanto presenti nella liturgia cristiana, abbiano influito non poco sulla composizione dei nuovi; e soprattutto, abbia esercitato una sorta di pressione e di limite la considerazione della loro sacralità, al punto che alcuni poeti hanno come tradotto in un linguaggio moderno il testo loro assegnato, sicché le varianti vanno riscontrate nella libertà della struttura e nella variazione dei ritmi; e però c’è senz’altro una caratteristica del Dio d’Israele, la propensione alla vendetta, che viene sempre respinta ( fatta eccezione per pochissimi autori), al punto che un poeta aggiunge in nota di non potere continuare il suo salmo perché mai potrebbe invocarla contro chicchessia; e questo rifiuto, al di là della reinvenzione più o meno originale del salmista contemporaneo, sta a dimostrare che il messaggio cristico, la sua nuova morale, hanno profondamente mutato il rapporto fra l’uomo e Dio, che Dio davvero è ormai sentito come padre di tutti gli uomini, come Amore; anche se di una qualità inafferrabile, misteriosa, indefinibile, e, spesso, muta.
L’amore che c’è e non si esprime : così lo percepiscono molti fra questi poeti contemporanei, arresi alla ratio dell’economia, assediati da forme di comunicazione sempre più invasive e dallo sfascio dell’ambiente, eppure a Lui così intimamente vicini, quando si aprono alla meraviglia del creato, quando si accusano d’indegnità consapevoli della grandezza divina del loro spirito, quando riconoscono nel vuoto lo splendore del pieno che verrà, quando percepiscono il nulla come ciò che ancora Dio non ha manifestato; quando, pur accusandolo di essere troppo silenzioso, ne hanno tanta fame e sete e ripetono le parole già dette, già infuse sulla bocca dei profeti e dei salmisti e di Gesù e dei Dodici.
L’altra rivoluzione del Cristo, Dio che si abita anche carnalmente il tempo, sta nell’attualizzazione di molti di questi salmi che invocano la rigenerazione, la katastrophé, ispirandosi anche alla visionarietà sublime e “barocca” dell’Apocalissi, accogliendo l’attesa del dissolvimento del velo che copre la verità. E non manca l’ardore mistico, quello che d’un salto attinge la magnifica incorporeità dell’assoluto attraverso l’esaltazione dei sensi, quali strumenti di conoscenza, secondo la sapienza orientale; cosa che non è del tutto identica al sentire degli antichi salmisti che cantavano questi testi accompagnandoli con strumenti musicali oppure con una forte gestualità del corpo, ma per sottolineare la totale dedizione della creatura al suo Creatore.
Che cosa significa, allora, leggere questi nuovi salmi? Significa guardare, stupefatti, la trama complessa dello spirito umano e udire, con commozione, la resistenza della preghiera.
È, infatti, il salmo una preghiera; e cioè il testo più assurdo che un uomo possa concepire, perché, mentre la pronuncia, l’uomo sa che non c’è strumento di comunicazione che possa recapitarla al destinatario, perché il Destinatario non si sa bene dove stia, e se mai l’ascolterà; e proprio per questo rimane il testo più bello e forte e il gesto più colmo di speranza e di umiltà, specie quando, più che nel tempio, collettivamente, è recitata nel chiuso della propria mente, fra le mura di casa.
Certo, questo è il tratto comune fra i salmisti della Bibbia e quelli contemporanei: avere sulla bocca il nome di Dio, respirarlo, assimilarlo, chiamarlo, rassicurarlo del nostro amore per Lui, rassicurarci del suo amore per noi.
Una scala tra cielo e terra si erige con tutte queste parole, e le parole salgono come messaggeri sonori, hanno le ali dell’anima, sfondano il confine tra visibile ed invisibile.
Sempre, sempre questo è il tentativo: cum-prendere il mistero. Tutti i nostri genitori c’insegnarono a guardare il cielo notturno e da bambini, allora, sentimmo palpitare mani, occhi e cuori, abbiamo percepito qualcosa al di là delle cose visibili, un breve, magnifico schianto dei sensi. E abbiamo interrogato, più grandi, luna e stelle come il pastore del Leopardi.
Dunque, a maggior ragione, in quest’epoca in cui più cresce il sapere della scienza, più si ingigantisce il mistero ( non è affatto il contrario, come si dice), visto che quest’ultimo sempre sopravanza il primo ( come dire: più si conosce del Dio manifesto, più aumenta il non conosciuto del dio nascosto) sono estremamente utili e belli questi salmi, che esprimono l’inquieto spirito della modernità. Sono la voce delle nostre limitatezze e della nostra gloria, della nostra debolezza e della nostra forza, del nostro essere e del nostro volere essere, del nostro errare e del nostro bisogno di purificazione, delle nostre paure e dei nostri sogni.
L’uomo! Se lui non riuscirà mai a conoscere Dio, Lui ci conosce già tutti ad uno ad uno. E forse, tutto sommato, ha dato una mano a comporre questa antologia, e, come già gli antichi salmisti, ha in-spirato i nuovi. No, certo, non dico che li ha “dettati” ( come non ha dettato nemmeno nulla agli antichi salmisti), ma che la parte divina di noi è stata invitata a dire di sé e di Lui dal compito assegnatole. Poesia, secondo un etimo fenicio, significherebbe Bocca di Dio. L’espressione si può leggere in due modi, a seconda se consideriamo il complemento di specificazione secondo un’accezione soggettiva o oggettiva. Io suggerirei di accoglierli entrambi: bocca a bocca con Dio, poetando, si saldano insieme, per virtù d’amore, “ragione e comunicazione, conoscenza e progetto”, secondo le parole di Ermanno Bencivenga, parole che qui uso con altro senso, essendo state estrapolate da un discorso diverso, ma che bene si addicono a quanto desideravo dire, e che spero di avere detto in modo sufficientemente chiaro.
Id: 653 Data: 21/12/2012 12:00:00
*
 Nicola Romano - Poesia - Pungitopo Editrice
Nicola Romano - Poesia - Pungitopo Editrice
Gobba a levante
Il titolo di questa silloge di Nicola Romano, che riporta la prefazione di Paolo Ruffilli, allude alla gobba lunare rivolta ad oriente, quando il bianco astro sia avvia alla sua oscurità temporanea che la sottrarrà alla vista degli uomini. Ovviamente, ci troviamo davanti ad una metafora, il cui senso riporta alla fase declinante della vita. Oltre ad una sequenza di versi molto significativi, dalla loro lettura si evidenzia il timbro complessivo, ovvero la nota di testa, come si dice nell’arte difficile e raffinata della distillazione dei profumi; quella stessa nota che Romano fa uscire attraverso la propria voce e con l’atteggiamento stesso del corpo, altro linguaggio sul linguaggio.
Ecco, allora, farsi strada, l’ultima delle tre note; quella di fondo, la più persistente, che sale poco a poco fino a rivelare l’origine del travaglio; e questa è la nota di morte. Il libro ne trabocca (già dal titolo) e in alcuni testi essa preferisce manifestarsi attraverso una serie di correlativi oggettivi o attraverso un certo colore lessicale, ma c’è un testo in cui raggiunge un picco desolato e un’angoscia senza rimedio, ed è quello che s’intitola lapidariamente “Ai Rotoli”, che è uno dei cimiteri più noti ed affollati di Palermo. Viene immediatamente alla memoria la famosa antologia di “Spoon River” di Edgar Lee Masters, poiché anche in questo caso si passano in rassegna, attraverso le iscrizioni sulle lapidi, le biografie di molti deceduti. Ma si tratta di una somiglianza apparente e superficiale, perché, a parte la brevità degli accenni biografici, questi ultimi non son raccontati dal morto, come accade nel testo dell’autore americano, ma tratti fuori dalla retorica della commemorazione dei vivi che si affidano per lo più a frasi fatte, spesso bugiarde che danno una dimensione di spessore minore a queste vite già andate e in qualche modo banalmente comunicate ai visitatori. Per tutte queste cose Nicola Romano scrive, lui che vede le proprie iniziali dentro l’INRI della croce cui sta appeso il Cristo: per trovare il suo vero luogo, il suo vero tempo, la vera armonia del canto, poiché la sua poesia ha la grazia del canto. Egli cura con pazienza la musica dei versi, li rende armoniosi attraverso una fatica così amorevole che non ci si accorge nemmeno che abbiamo di fronte testi spesso confezionati secondo il ritmo degli endecasillabi, a testimonianza di una misura conquistata e di una volontà di rimanere dentro la più feconda novità che sa essere sempre la tradizione.
Id: 582 Data: 11/05/2012 12:00:00
*
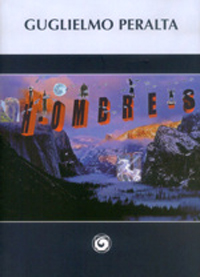 Guglielmo Peralta - Narrativa - Genesi Editrice
Guglielmo Peralta - Narrativa - Genesi Editrice
H-ombre-s
Ci sono delle opere letterarie che si sottraggono ad una precisa definizione e H-ombre-s di Guglielmo Peralta è una di queste.
Intanto vi abbonda più la riflessione che l’azione, più il monologo che il dialogo, così che potrebbe definirsi in qualche modo un saggio romanzato sulla funzione e la necessità della letteratura e su altri aspetti che intorno ad essa da sempre si dibattono: Perché si scrivono opere letterarie? È più piena e completa la vita letteraria o quella che viviamo? Qual è il rapporto fra l’idea e la scrittura? Tra l’autore e i personaggi? Tra l’autore e il lettore?
Potrebbe, questo romanzo, essere pure definito un’autobiografia o, meglio, una biobibliografia romanzata, visto che Peralta, attraverso esso, rende omaggio agli autori che più ha amato, mostrando al lettore in modo assai singolare la propria biblioteca e il proprio percorso di formazione; e potrebbe, ancora, essere pensato come un trattato di metafisica romanzata, poiché, attraverso i monologhi e i dialoghi dei personaggi messi in scena, egli affronta importanti quesiti etici e scioglie un inno alla grandezza del Creatore ed ai suoi doni, tra cui quello della scrittura, grazie alla quale lo scrittore può porglisi quasi a fianco in qualità di inventore di mondi paralleli. Ma, soprattutto, H-ombre-s a me pare la teatralizzazione della filosofia elaborata da Peralta, nota come soaltà, intorno alla quale egli ha pure scritto un manifesto vero e proprio e che ha dato nome ad una pregevole rivista edita a Palermo per più anni. E, a proposito di teatralizzazione, “H-ombre-s” presenta caratteristiche più di opera teatrale che di romanzo, per cui ci si augurerebbe di vederlo rappresentato sul palcoscenico di un teatro.
Forse, a ben riflettere, H-ombre-s costituisce un insieme di tutte queste cose e, forse, qualcos’altro in più. Insomma, il romanzo H-ombre-s di Peralta è davvero un’opera originale, direi unica nella storia della letteratura contemporanea.
Protagonisti di questo romanzo sono alcuni personaggi della letteratura di tutti i tempi, che cercano di autogiustificare la loro esistenza dandosi una dimensione più certa di quella di icone di carta, desiderosi di una vera vita, in modo che, come ipotizzano “la morte, quella ricevuta insieme con l’immortalità, quella subita, per incanto, da occhi estranei” possa essere “espulsa dai loro corpi di nebbia”, ed essi diventino capaci di accogliere “come autentica compagna e senza remore, la morte mortale” salendo “dal regno delle ombre all’impareggiabile regno della luce”.
Il luogo in cui si svolge la vicenda è il Castello dell’agrimensore K., con la sua altissima torre, la biblioteca, la valle, un fiume lontano, un ponte ( che rappresenta il passaggio dalla vita sognata per i personaggi alla vita vera del mondo) immersi in una notte senza fine, allucinata, tra incubo e struggente finzione.
La struttura del romanzo appare come il risultato di una personalissima elaborazione di elementi tratti da diversi autori della letteratura: l’atmosfera ricorda quella del Purgatorio dantesco, poiché tutti i personaggi sembrano in attesa della beatitudine promessa, sospesi fra il ricordo della propria imperfetta vita letteraria e il desiderio della visione suprema che li affiancherebbe agli essere umani. Simbolo di quest’attesa, come dicevo prima, è il ponte che sovrasta la valle e resta a lungo lo scenario di micro-eventi, emozioni e perplessità, fra ripetuti indietreggiamenti e piccoli avanzamenti che sembrano reciprocamente annullarsi, come le provvisorie decisioni sul da farsi via via dibattute. A Dante rimanda pure l’uso abbondante dell’allegoria; per esempio, la Torre rappresenta, come svela Beatrice, la misura incolmabile delle idee. Ogni piano è un cielo in cui brillano le idee generatrici delle opere. La Torre cresce e s’infinita di nuove idee per emanazione divina attraverso gli autori. Questa torre, non si può fare a meno di notarlo, è l’esatto capovolgimento di quella di Babele, torre del caos e della disgregazione verbale, mentre qui il decimo cielo rappresenta la Parola di Dio, dalla quale la parola umana discende.
La personalità, invece, e gli atteggiamenti psicologici dei personaggi ricalcano quella sottigliezza intellettuale, quel complesso e sofistico ragionare propri dei personaggi pirandelliani e quella drammaticità di sentimenti estremi che caratterizza gli eroi tragici di Shakespeare.
I dialoghi a tesi fra i personaggi rimandano, invece, a quelli del filosofo Platone per la ricchezza delle metafore, la qualità poetica e la vibrazione del sacro che li animano.
Infine, il sogno di riunire tutti i personaggi e i libri della letteratura è simile a quello della Biblioteca universale di Borges.
Perfino il linguaggio è fatto di tòpoi letterari e come infarcito di continue citazioni che però non appaiono più tali, perché convergono in una pronuncia “soale” tutta peraltiana, a metà tra sogno della lingua letteraria (spesso anche fiabesca ed oleografica) ed il realismo del linguaggio comune. La sua qualità dominante, lirica ed effusiva, porta in sé l’impronta del lungo esercizio poetico dell’autore, ma anche del suo spazio interiore, delicato e spirituale.
Potrei ancora continuare in questa disamina, ma ritengo bastino queste osservazioni per sottolineare come le caratteristiche dei diversi autori letti da Peralta si siano amalgamate in una concezione unitaria, armoniosa e singolare. E come, in ultima analisi, come prima accennavo, anche questo romanzo s’inserisca all’interno della filosofia della soaltà che è cosa tutta peraltiana, cioè di quell’amalgama di sogno e realtà, in cui, come scrive acutamente nella prefazione Sandro Gros Pietro, che ne è anche l’editore, “tenta il teatro nel teatro, la pittura dentro la tela, il significato oltre il significante, l’individuo fuori dalla storia, la verità fuori dal mondo”.
Questo romanzo rivela anche una solida eticità ed una centralità cristica, così da determinare anche una lettura nuova di certi capolavori della letteratura, come accade per K., protagonista de Il processo di Kafka, attraverso la bocca del Padre, uno dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello; cosi come nuova è la lettura del mito di Narciso per bocca di Beatrice.
Ogni personaggio di questo romanzo rappresenta una qualità umana, una sfaccettatura psicologica molto evidente: Sonja la fede nella Bellezza e nel Sacrificio di sé, Sierva Maria l’amore al suo più alto stadio di purezza ed elevazione spirituale; K. la ricerca di un’identità, ma anche l’uomo, che non accogliendo in sé la colpa, non sa amare gli altri; Pinocchio l’incontro fra materia cosale e materia umana, ma, in senso più lato, la fantasticheria e l’infanzia; Amleto il disagio d’essere, il dubbio; Orfeo il poeta che vuole trarre alla luce l’altra faccia del canto; Euridice la consapevolezza che con i sensi non si può conoscere la verità; Odisseo la curiosità per le cose terrene e, in genere, i valori del mondo pagano; il Padre ( uno dei “Sei personaggi in cerca d’autore) il rimorso del peccato ed il desiderio di redenzione.
Tutti i personaggi, questi e gli altri che non ho nominato, sono, però accomunati dalla consapevolezza della necessità e dell’utilità della letteratura, pur soffrendo per la loro natura di creature soltanto sognate dall’uomo. Facciamone parlare alcuni, uno dopo l’altro:
Beatrice (parlando ai personaggi): “Anche se siete solo delle Ombre, grazie a voi l’uomo partecipa del mistero della vita, ovvero della Bellezza della creazione”.
Il Padre: “Attraverso di noi l’uomo si guarda vivere, facendosi più umano; a volte più estraneo; oppure si distrae, semplicemente, o si scopre divino”.
Odisseo: “Noi non siamo nati Ombre per inseguire la vita, ma per rappresentarla agli uomini come in uno specchio affinché attraverso di noi (…) si prodigassero per seguir virtute e conoscenza e mettersi in cammino verso la verità.”
Sierva Maria. “I libri sono la prova e la giustificazione estetica della nostra strana e favolosa esistenza.”
Amleto: “Ora ci giunge il respiro accattivante dei libri che ci tiene tutti abbracciati e siamo noi quel respiro che è spiraglio di luce.”
Sonja: “Le lacrime versate e raccolte nei libri bagnano gli occhi di qualche gentile lettore, ne innalzano l’anima e la purificano…C’è bellezza nei libri! E i libri, non sono forse il corpo con cui abbracciamo il mondo?”
Adesso veniamo alla trama del romanzo, sebbene i fatti siano davvero pochi, per cui preferirei parlare di alcuni punti vitali, psichico-emotivi: K. arriva nel Castello dove trova riuniti i personaggi della letteratura di tutti i tempi, ai quali Beatrice, la musa di Dante, promette la visione del Decimo cielo. Tuttavia, anche dopo questa promessa, i Personaggi tentennano fino al punto di stare per cedere al consiglio di Odisseo di bruciare la Biblioteca e fare cessare per sempre la produzione dei libri, così che le loro anime, liberate dal sogno, possano emigrare nei corpi degli uomini per vivere un nuovo e vero romanzo. A lui si oppone, e ovviamente, Montag, l’eroe di “Fahreneit 451” di Ray Bradbury, che esalta la Bellezza custodita nei libri e, citando il passo dell’Apocalisse, in cui si dice: Furono aperti i libri e fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere…”, la investe di un’aura di sacraIità. La stasi della scena viene interrotta dall’improvviso salto di Pinocchio dal ponte e dalla sua morte in una chiazza di sangue che è, secondo l’opinione del Padre dei “Sei personaggi”, la prova che il burattino è morto e vissuto veramente, “che vera fu la metamorfosi dalla sua natura di legno all’umana natura” e che, dunque, sarà per loro più semplice, “essendo più vicini al vero”, avverarsi. A questo punto si inserisce il discorso di Don Chisciotte che espone la teoria della soaltà peraltiana, sostenendo che il sogno non è fantasia ed ha il primato sulla realtà che esso stesso genera. Successivamente prendono la parola le Cose stesse che cercano di dissuadere i Personaggi dal volere vivere in un mondo abitato dal caos e dalla follia informatica, incitandoli a tornare nel Castello: esortazione che viene rafforzata da quella del Padre che mette in risalto la necessità per gli uomini di rinunciare al male. Anche Odisseo, eroe pagano, comincia a capire che il passaggio verso l’immortalità va cercato in profondità attraverso il ponte verticale, cioè attraverso un’ascesa spirituale realizzabile solo grazie ad una guerra giusta ed altruista per salvare la specie umana dagli umanoidi. Ancora una volta il dialogo fra i personaggi viene interrotto dall’irruzione di alcuni uomini- rinoceronti (con evidente allusione a Jonesco), uno dei quali si ferma, mostrando di reggere sulla groppa nientemeno che Pinocchio redivivo, il quale chiede l’aiuto degli altri per lottare e rinconvertire i rinoceronti in esseri umani, nella convinzione che “Finché c’è fiaba, c’è ancora speranza per l’uomo!”, così come l’apparizione di un liocorno testimonia la necessità per gli umani di storie, di favole e di poesia. Infine i Personaggi conquistano la visione del decimo cielo, cioè la Galassia dei segni, il paradiso della scrittura, l’Empireo in cui campeggia l’albero della Visione.
Questi nodi narrativi costituiscono l’occasione per una serie di dialoghi e monologhi, anche se in questo romanzo la differenza fra le due cose è molto sottile, poiché anche i monologhi si riverberano sulla psiche degli altri personaggi determinando mutamenti, dubbi, sentimenti corali.
Per finire, va sottolineato che tutti i Personaggi, anche quelli pagani, compiono, di capitolo in capitolo, un percorso verso l’Amore cristico e che è per questo che diventano degni della visione del Decimo Cielo. Dice, infatti, Sonja, la più ardente e quasi mistica fra i personaggi: “L’amore e la compassione saranno il nostro progresso spirituale” e, ancora, “Solo l’amore riconduce il mondo a Dio”.
Id: 499 Data: 25/11/2011 12:00:00
*
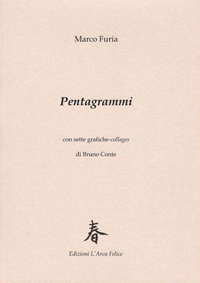 Marco Furia - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Marco Furia - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Pentagrammi
Si aggiunge alla gioia acustica anche quella visiva: una vivida luce accompagna suoni e ritmi dispiegando anche in questo caso una serie di varianti legate all’intensità ed alla durata. Occhio ed orecchio diventano, dunque, i naturali alleati del poetare, proponendosi anche quali punti forti della poetica di Marco Furia, secondo il quale la poesia si offre al pubblico di lettori come una rielaborazione del mondo visibile attraverso un impasto linguistico che del primo trattenga la luce e ne ridica la forza dinamica attraverso la vibrazione melodiose del secondo.. Se, infatti, anche le tenebre e la notte sono evocate, esse diventano territori di ispirazione e perciò anche di conoscenza e di novità creative,
Il poemetto di Marco Furia mi fa venire alla mente la poesia barocca di un Marini, ed in particolare l’elogio della rosa presente nell’Adone, sia per l’abbondanza delle immagini e della metafore, sia per la particolare fluidità della pronunzia poetica; ma c’è da dire che, mentre là si ricercava soltanto la meraviglia ( lemma, comunque, più volte presente nei versi di Marco Furia ) ed il poeta sembrava non avere altro scopo che riprodurre come in uno specchio la sontuosa bellezza della natura e del mondo, in questo testo, invece, come si legge nella prefazione di Mario Fresa, questi strumenti hanno la funzione di disegnare “un dialogo con una dimensione altra e sfuggente”, come se essi fossero specchi da cui le cose si riverberino all’infinito, come in certe prose di Borges.
Ogni tanto, infatti, l’autore sembra perdere la rotta all’interno del suo stesso labirinto di specchi e di suoni ed allora si pone delle domande dalle quali sgorgano altri versi ed altre domande, come a dire che la poesia, posta di fronte alle più profonde problematiche esistenziali, non può dare una risposta definitiva, e tuttavia può offrirsi come strumento di consolazione e di stupore.
Le grafiche di Bruno Conte con i loro sobri e misteriosi ritmi geometrico-chiaroscurali, talvolta sorpresi da inaspettate spezzature, sembrano accompagnare senza alcuna forzatura il dinamismo di luce ed ombra, superficie e profondità, di questo testo a cui il lettore deve abbandonarsi, dimenticando, se vuole davvero goderlo, ogni solito schema di ascolto e di giudizio.
Id: 351 Data: 19/10/2010 12:00:00
*
 Giacomo Cerrai - Poesia - L’Arca Felice
Giacomo Cerrai - Poesia - L’Arca Felice
Camera di condizionamento operante
L’attraversa il tono monocorde della domanda ansiosa ed inquieta, ma vana, poiché si sa senza risposta nella consapevolezza che l’ascolto del proprio inconscio e la pretesa di una risposta metafisica sono destinati all’ammutolimento della parola che azzardi questo percorso. Che la poesia, benché si ponga sempre sull’orlo del baratro di domande capitali, non riesce, non è delegata a dare una qualunque risoluzione, sicché la sua sorte è quella di sostarvi per sempre, tentandolo.
Qualche testo termina, infatti, e significativamente, con i punti di sospensione: una sorta di segnale visibile dell’afasia “di una richiesta inascoltata”, come scrive nell’intensa prefazione Mario Fresa.
Gli eventi accadono nello spazio della casa, la quale, benché quotidianamente frequentata, appare connotata da una qualità evanescente, nonostante la minuzia di qualche particolare, l’elencazione di oggetti domestici, la memoria di qualche gesto o parola , sicché finisce con il configurarsi come una metafora. Essa, infatti si colloca fuori da un tempo certo, minacciata all’esterno da un temporale, all’interno da “uno sforzo sproporzionato al battito d’ali”, sebbene si alluda al contemporaneo dramma sociale e storico di una “violenza in vendita”. Del resto, la casa, per la psicologia del profondo è un simbolo importante, che allude all’io, al proprio spazio interiore, al quale, dunque vanno attribuite le stesse qualità e caratteristiche dell’altra.
All’interno delle sue stanze – ma, qualunque sia la sua probabile estensione, essa è percepita simbolicamente come “una scatola” asfittica ed asfissiante - si svolge una vita precaria, sospesa, estraniata, quasi la recita di un dramma delle cui trama la coppia che vi alberga ha solo un ruolo di comparsa. Ogni atto appare come rallentato, quasi non appartenente perfino a chi li compie.
La solitudine, l’insensatezza confermano, dunque, il duplice fallimento di una comunicazione amorosa profonda così nella sfera privata come in quella spirituale, e si affiancano a quella delle cose stesse “polvere di polvere” sgretolantesi, perché “prive di messaggi”. E, tuttavia, nonostante questa dolorosa percezione, Dio non è negato: è piuttosto un Dio celato, muto, lontano, che “non ascolta, / spoglia gli alberi e il giorno, spoglia la vita stessa”; un Signore di morte e silenzio, al posto del quale risponde “il merlo beffeggiatore”, provocando lacrime silenziose, sussulti di dolore, implorazioni, dubbi, di tra i quali balugina un desiderio d’amore e di corrispondenza che costituisce la trama sotterranea di un’anima desolatissima ma non oscurata.
La plaquette contiene un pensiero visivo di Roberto Matarazzo.
Id: 346 Data: 05/10/2010 12:00:00
*
 Stefanie Golisch - Narrativa - Cosmo Iannone Editore
Stefanie Golisch - Narrativa - Cosmo Iannone Editore
Luoghi incerti
Come, allora, parlare di Luoghi incerti abbandonando gli usuali schemi dei generi per una lettura critica che non lo tradisca troppo, e come devo orientarmi? – mi chiedo. E, dopo avere interrogato il libro più volte, leggendolo e rileggendolo, tormentandolo con appunti, sottolineature e altri segni, mi accorgo che l’orientamento mi viene suggerito proprio da quel rapporto speciale stabilito da subito fra la data della propria nascita, indicata in modo piuttosto approssimativo, e quella, del tutto precisa e, dunque, privilegiata, della costruzione del muro di Berlino, come dire che la Golisch avverte la Storia della Germania come un recipiente rispetto alla propria esistenza.
Ed è un orientamento di lettura che a me sembra fornire la chiave giusta per entrare nella pagine di questa scrittura così libera, che assomma e mestica avvenimenti autobiografici e storici, critica letteraria, analisi e riflessioni, percorsi di vite tanto dei propri familiari come di altri. E che ha lo scopo di mettere in luce, oltre i fatti, rievocati secondo un’altalena temporale che segue l’andamento delle memorie e delle riflessioni, disciplinato soltanto da esigenze interne al testo, le atmosfere, gli stili di vita, le scelte etiche che caratterizzarono almeno due generazioni fra il 1920 ed il secondo dopoguerra. Ma anche di rispondere alla domanda che spesso vienerivolta ancora oggi alla generazione dei cinquantenni e quarantenni di nazionalità tedesca: che cosa sapessero i loro genitori e i loro nonni dello sterminio degli ebrei.
Stefanie Golisch analizza con lucidità quella che definisce una “vergogna collettiva rimossa” e che ha generato “lo stordente silenzio” da cui è stata avvolta la sua infanzia. Scrive, infatti: “Ancora negli anni settanta del secolo scorso, lo sterminio degli ebrei era un tabù assoluto. Sia in famiglia sia scuola si evitava attentamente l’argomento”. E che questo silenzio ha generato “un muro tra le generazioni, fatto di diffidenza e di sospetto, una guerra non dichiarata tra i figli che vogliono sapere e i padri che tacciono insistentemente”.
Bisogna sempre tenere conto di questi sentimenti, di questo scontro generazionale, per comprendere il valore emblematico che assumono le biografie dei nonni e la difficoltà confessata dell’autrice di costruire un dialogo profondo con la madre e il padre all’interno di un crogiuolo di silenzi, sospetti, volontà di capire, incapacità di amare, rari slanci dell’anima. Perché le sia necessario, per scrivere questo libro, usare quelle bugie “per arrivare all’oscena verità” sua e dei suoi avi.
E perché, di contro, Stefanie Golisch voglia “fare qualcosa” per “loro”, le tante vittime dell’olocausto. E perché abbia tradotto le poesie di Selma Meerbaum-Eisinger, morta giovanissima in un campo di lavoro in Ucraina : “mi dà la sensazione – dichiara - di potere trasformare il mio imbarazzo in qualcosa di costruttivo, concreto, visibile”. Non un tentativo – come aggiunge poco dopo – “di rendere giustizia alle vittime, ma di restituire a una di loro il suo inconfondibile volto.”.
Questa “curiosità” per i volti dei morti della Shoah, i “volti mancanti”, come li chiama lei, la carica di volontà di vedere, quando negli anni ottanta, visita il campo di concentramento di Auschwitz., e , per non “allontanare l’accaduto”, come vorrebbe forse la guida, la scrittrice guarda ad una ad una le foto dei deportati che riempiono le pareti di un interminabile corridoio, come se, appropriandosi dei loro lineamenti, di quella che fu la loro tangibilità fisica, immaginandone, fino a percepirle in sé, vite e sofferenze e sogni abbandonati e dolori, possa restituirli in qualche modo agli altri, possa dare voce ad un terribile silenzio, immagine ad un vuoto.
E’ da questo nodo psicologico irrisolto che si origina quel singolare tono narrativo, sospeso tra spietatezza e compassione, che caratterizza la scrittura della Golish, nella convinzione che per “com-patire” si debba guardare ad occhi spalancati, allenandoli a guardare orrori e dolori, storture e santità, in quanto facenti parte della cosa oscura e incomprensibile e caotica che è la vita, e della natura di ogni essere umano. Che solo dopo avere “provato quel dolore segreto, possiamo sentire – come scrive Ingeborg Bachmann, una delle autrici amate dalla Golisch – (in modo diverso) ogni esperienza ed in particolare quella della verità.”
“Luoghi incerti” finisce, allora, con l’essere anche un libro di formazione: quell’approccio dell’io verso se stesso, di cui l’autrice parla nella e-mail inviatami per guidarmi alla lettura del suo libro, viene narrato, infatti, attraverso le varie tappe di una crescita dalla infanzia e dalla prima adolescenza fino alla giovinezza e al trasferimento in Italia, quando il muro tra le “due” Germanie crollò, ma non così la differenza fra le due popolazioni, non così tutto l’inevitabile groviglio di sentimenti, contraddizioni, ottusità, volontà di lasciarsi alle spalle il proprio passato e lo sguardo accusatorio dei pochi sopravvissuti e di tutti gli altri. Né cessò, naturalmente, il conflitto interiore dell’autrice, ormai “in esilio” in Italia.
In un clima storico tanto difficile, in tanta palese disarmonia generazionale, tra verità taciute troppo a lungo e voglia di verità, in cui “ognuno si salva come può: dimenticando, rimuovendo, negando, inventando, negando…”, segnato anche da stridori etico-estetici, l’io della protagonista appare insicuro, disorientato, perfino nel rapporto con la propria fisicità, quasi che il suo corpo, al pari di qualsiasi altra forma, non l’esprima davvero e sia un qualcosa di incongruente con la sua più profonda interiorità e la percezione della propria identità femminile: “Non è, la mia vita, un album di fotografie con la copertina azzurra e non è nemmeno un diario, ma piuttosto una gigantesca tela, una specie di collage prodotto senza alcun criterio estetico dove esplodo in mille pezzi, incerta tra cose e uomini, irriconoscibile a me stessa e probabilmente agli altri.”
E per di più è il racconto di una formazione “al femminile”, assai più complessa e difficile di quella vissuta dagli uomini della sua stessa generazione, proprio perché ha dovuto non solo affrontare le incongruenze e le ambiguità di un periodo storico, ma anche quelle legate ad un nuovo modo di essere al mondo come donna, prima, e poi come intellettuale. La Golisch racconta, infatti, insieme alla sua storia, quella di tante altre donne cresciute in quelle città di provincia della Germania, tra povertà, stenti, e quotidiane cure, incapaci di pensarsi, di assumere consapevolezza di sé, confinate nei loro ruoli di sempre, umilmente accettati, e perciò incapaci di comprendere la generazione delle loro figlie e nipoti, indecise se dovere gehen oder bleiben, come scriveva Uwe Johnson.
E racconta anche il suo approccio con la letteratura “per stare nel mondo”, insieme agli autori che l’hanno accompagnata nella crescita, che l’hanno spesso confusa più che illuminata, e nei confronti dei quali ella ha intrecciato, da giovane, relazioni spesso ossessive, di sovrapposizione d’identità, amandoli e tendendo la sua intelligenza alla comprensione più possibile profonda dei loro mondi interiori, come fossero persone vive, poiché così dichiara: “Non faccio differenza tra i vivi e i morti, li ascolto tutti e li racconto tutti.” Ma con una particolare predilezione, va aggiunto, per gli anarchici, i ribelli, i dimenticati, gli apparentemente vinti, ed invece fieri e infelici aristocratici dell’esistenza, come Uwe Johnson che si isola in una stanza sotto terra e scrive contro il tempo e la morte, e che Stefanie incontra “con gioia, meraviglia e spavento”, perché ne ha bisogno per comprendere meglio se stessa ed il suo “essere storico intrecciato in un passato che non si può ignorare”. E come Tolstoj, Baudelaire, Rimbaud, Celan, P. Roth, Bachmann, e tanti altri che usano le parole per chiedere al lettore “audacia e coraggio di vita”. E perciò le maneggiano come un bisturi, fissando lo sguardo nelle più intime fibre del vissuto.
A proposito del rapporto della Golisch con la lettura e la scrittura, sono molto illuminanti il capitolo Uno scrittore tedesco, dedicato all’amato Uwe Johnson, e quello titolato Leggere, perché in essi si trovano delle dichiarazioni che palesano in qualche modo una poetica dell’autrice, a partire da questa così “gridata” e perentoria: “Provo repulsione istintiva per gli autori che si credono in possesso della verità.”
Di questo infatti si tratta: può la letteratura raggiungere la verità, The hearth of darkness, come scrive lei stessa preferendo una reminescenza letteraria, dove l’attendono “pazientemente i coltelli?” No, non è possibile: è la risposta a cui dobbiamo giungere, tenendo conto di quanto lei dice. La letteratura, dunque, è un altro dei “luoghi incerti”, sebbene si affanni per un suo connaturato imperativo etico-estetico, a cercare la verità; solo che la verità sembra essere la somma di tutte quelle che via via gli autori raccontano, (scrisse già molto prima di lei la problematica, originale Virginia Woolf: “La verità si può ottenere solo mettendo insieme molte varietà di errori”) con la conseguenza che lei, come ogni altro lettore, ha trovato nei libri il suo io e tutti gli altri mille contrari. “I libri – scrive – mi hanno spiegato e non spiegato il mondo”, e, in ogni caso, non hanno fornito “una via d’uscita”, alimentando casomai la “compassione per il caos che regna su di noi, la solitudine, la nostra condanna e il nostro sublime privilegio.”
Lettori e scrittori appartengono ugualmente ad “una grande in felicissima famiglia che tira avanti così: consolata e rassicurata dal dolore altrui.”
Già basta fare scorrere il dito sulle sequenze in cui si divide il capitolo Leggere per capire quanto si è detto: Non c’è salvezza, La solitudine, Atmosfere, Trovare alleati, Sfuggire alla realtà in altro modo, e così via, con un una piccola riflessione sull’ultima qui elencata ( ma l’ordine nel capitolo è diverso ): che realtà e verità non coincidono, perché la verità sta dietro o aldilà o altrove che nella realtà che appare, che “è una chimera, anche se cercarla è un dovere inesauribile, “un atto morale che non ha riguardo di nessuno”.
Una cosa è certa per la Golisch, che proprio il luogo più incerto, cioè la letteratura, è l’unisca sua “dimora possibile”.
I libri letti dall’autrice – aggiungo – sono stati, in ogni caso, ottimi maestri di stile, se si considera il valore squisitamente letterario della sua scrittura. il suo nitore lessicale, la bella tessitura sintattica, la chiara costruzione dei personaggi, secondo il convincimento che è “proprio l’intreccio tra forma e contenuto” che fa della scrittura “un veicolo di verità”.
Id: 345 Data: 01/10/2010 12:00:00
*
 Maria Grazia Cabras - Poesia - Edizioni Gazebo
Maria Grazia Cabras - Poesia - Edizioni Gazebo
Canto a soprano
Due obiettivi, all’apparenza, sovrabbondanti rispetto al numero esiguo dei versi, se quest’ultimi non fossero caratterizzati da una forza inversamente proporzionale alla loro quantità, se ogni parola non fosse fatta di una “sostanza accesa” e i versi non fossero, ciascuno, le battute di un dramma, i cui protagonisti sono soltanto due, ma di proporzioni gigantesche e di natura enigmatica: l’anima femminile e la poesia.
Né si tratta di un dramma inteso come contrapposizione ostile, bensì di un confronto amoroso e tuttavia doloroso, poiché l’una e l’altra non sono definibili e la loro guerra è combattuta sul filo della smisuratezza e dell’indicibilità, in nome di uno dei più strani paradossi, poiché nulla di più simile sembra esserci fra l’una e l’altra, femmina e parola, entrambe di natura archetipale, selvatica, primigenia, e nulla insieme di più distante, nel momento in cui, per esprimersi, tra l’una e l’altra si incunea la scrittura, che si prefigura come una spezzatura, un rovello, un limite.
Tutto il mondo interiore della Cabras sembra attraversato da un vento emotivo che tenta la traversata “il fango delle piene / e il fiume / senza barca, né fune”, ma con una scorta di parole infuocate, cieche e insieme luminose, che ustionano come scintille dell’ombra e nell’ombra stessa del dire.
E’ questa consapevolezza, tuttavia, a rendere la parola dell’autrice, che si esprime nel suggestivo, arcaico, sonoro dialetto sardo-nuorese, assai accosta all’infanzia stessa della lingua, alla sua sorgente* La sonorità delle parole vibra con un’intensità febbrile, cerca la coincidenza fra le cose e la verità, ferisce insinuando “unghie nello sterno”, ingaggia un corpo a corpo con l’autrice, ben consapevole che tentare di capire “è un problema di carne / e ossa rotte // di marmo cavo e buio”.
Alla fine del suo periglioso itinerario, ancora l’autrice, e non potrebbe essere altrimenti, congeda il suo gesto scrittorio con due capitali domande: “dove il segreto delle domande?” e “dove la pietra più riposta?”: le rispondono i versi successivi con un susseguirsi frenetico di allitterazioni: “nell’attesa di chi sono / sillabando seguo un suono // sibila / la lingua barbarica / scorge la sorgente.”
Id: 334 Data: 27/08/2010 12:00:00
*
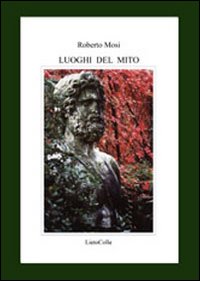 Roberto Mosi - Poesia - LietoColle
Roberto Mosi - Poesia - LietoColle
Luoghi del mito
E’ anche oltremodo interessante come l’autore si ponga l’obiettivo di prolungarne l’efficacia al di là della cristallizzazione che su esso incombe, sfaccettandone l’applicabilità e suggestione creativa con l’accogliere altri modi ed atteggiamenti del sentire popolare: è il caso del “mito” di Vasco Rossi; o, sia pure in chiave negativa, dei boss della Camorra.
Per lo più il mito classico viene sottoposto ad un’operazione di contaminazione attraverso l’ambientazione moderna di situazioni e figure topiche come emblemi immutabili della storia singola e collettiva. Sono, a mio parere, i momenti più alti di questa poesia, come in “Orfeo” e“Saffo”, giusto per fare qualche esempio, in cui il mito, nella prima, di Orfeo ed Euridice, conduttori di treni nella metropolitana di Firenze ( Cerbero è il treno), diventa occasione di denuncia dei mali della società contemporanea e simbolo di una nuova speranza. Nella seconda, invece, dove troviamo citazioni da Saffo, Alceo, Proust, la figura mitica della poetessa di Lesbo assume le sembianze di una ragazza d’oggi che scrive “in vernice spray sul muro// davanti alla scuola”: “Lasciateci amare come vogliamo”.
Non mancano neppure le rivisitazioni ironiche e perfino mordaci di personaggi e dei come “Ulisse” ed “Ermes”, il primo trasformato in un viaggiatore alle prese con ritardi e ripetuti approdi serali nella sua dimora dove solo il cane Arturo saluta/ il ritorno, la coda ritta, mentre Penelope già “dorme stizzita”; il secondo nella stessa immensa rete telematica, che immette “dai calzari alati” una caterva di messaggi a favore (o a danno?) dei milioni di frequentatori di blog.
Questo libro che compone, con gli altri che l’hanno preceduto, una sorta di quintetto poetico sul percorso del poeta all’interno dei luoghi (siano essi intesi come spazi geografici, mentali, interiori, onirici, culturali), sembra, pur nella sua specificità, contenerli tutti, aggiungendo nuove tappe, nuove occasioni di conoscenza, nuove mappature culturali e, allo tesso tempo, creando una circolarità di motivi ed umori, che sono le spie di un progetto consapevole di scrittura.
Id: 319 Data: 02/07/2010 12:00:00