chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Giorgio Mancinelli
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
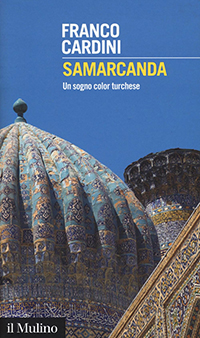 Franco Cardini - Saggio - Il Mulino
Franco Cardini - Saggio - Il Mulino
Samarcanda
Se come ho detto in precedenza, (recensione a ‘Istanbul’ in larecherche.it - 2014), Il futuro della modernità passa da Istanbul in cui il passato si congiunge con il futuro, questo nuovo libro di Franco Cardini dedicato a ‘Samarcanda’ segna una fermata doverosa a quel ‘medioevo’ che ci parla della storia ch’è stata, straordinariamente legata agli eventi che abbiamo appresi in ‘Istanbul’ allorché si chiamava Bisanzio e successivamente Costantinopoli, e al cui culmine vergono molti degli accadimenti succedutisi. Come nello svolgersi di una matassa con più cime, tali erano le ferrovie che dall’Europa prendevano la via verso l’Oriente propriamente detto, era assegnato a Samarcanda il termine ultimo i binari della gloriosa ferrovia dell’ Orient Express, quasi che il mondo finisse di lì a breve in un oltre irraggiungibile.
Ciò per quanto la letteratura insegni esservi altre terre ancora più lontane, attraversate da popoli che avevano fatto del nomadismo la loro ragione di vita e la loro sopravvivenza, si è di fronte a territori sconfinati in cui si producevano essenze profumate e olii pregiati, dove si cavavano minerali e pietre preziose, spezie e aromi che da Samarcanda prendevano le così dette rotte verso quell’Oriente favolistico descritto con molta approssimazione da carovanieri e mercanti, avventurieri e viaggiatori in cerca di fortuna. Una di queste è forse la più conosciuta ‘Via della Seta’, di cui si narra ne ‘Il Milione’ di Marco Polo e ancor più si favoleggia in ‘Le mille e una notte’, summa anonima di racconti sublimi, per quanto talvolta conditi di rosso sangue. Nessun’altra città è equiparabile a Samarcanda, come fine e inizio d’una realtà che sfocia nell’irreale metafico dell’immaginazione.
“Potenza di una città sognata: ci arrivi e ti stupisci che esiste davvero. Nessuna città ha un nome così evocativo: appena lo pronunci l’Oriente ti assale. Samarcanda è l’etsrema tra le Alessandrie fondate dal re macedone (Alessandro il Grande). È la città delle fortezze e dei sepolcri, c nodo carovaniero sulla Via della Seta, il maggior raccordo commerciale di terra fra Cina ed Europa; è la sede del Gur Amir, tempio e santuario, centro del mondo dalla cupola turchese sotto la quale il grande Tamerlano dorme per sempre. Parla una lingua in cui coesistono e si contrappongono tre alfabeti – cirillico, latino, arabo – come specchio della lotta tra chi ancora guarda al vecchio colonizzatore russo, chi sostiene l’islamizzazione e chi vorrebbe giocare sino in fondo la carta dell’Occidente.”
È quanto scrive Franco Cardini a quella che dovrebbe essere una sorta di ‘nuova guida’ per avvicinarsi alla città nel modo più completo possibile della sua conoscenza e che invece – come l’autore ci dice – è quanto impossibile fare perché la storia di Samarcanda è indubbiamente assai complessa, in primis per gli stravolgimenti subiti nella fin dalle sue origini; secundis per la complicanza delle spartizioni e delle successioni dei suoi molteplici personaggi che hanno fatto la storia. Un groviglio di nomi somiglianti l’uno all’altro che il lettore non riesce a rammentare e neppure a seguire nella moltitudine delle vicende narrate che, in fine – come del resto tutta la storia dei popoli – elenca un susseguirsi di guerre fratricide, di sconvolgimenti di potere, di abusi e supremazie.
Tuttavia il libro si mostra come una ‘guida storica e artistica’ della città di Samarcanda che – in certi casi – riporta alla luce quanto in realtà non è dato da vedere al visitatore odierno, il quale è spesso chiamato a far leva sulla propria fantasia per immaginare ciò ch’è stato, o che forse è stato fino a un certo ‘tempo’ e che non è più. In quanto tra restauri e rifacimenti ex-novo non sempre all’altezza, è il volto della nuova Samarcanda sempre più meta del turismo occidentale ed asiatico non sempre condiviso e partecipato. È questa la cifra prioritaria della guida in cui un più che generoso Franco Cardini suggerisce al lettore di scindere da ciò che riguarda propriamente il ‘medioevo passato’ e ciò che ci aspetta di quello che sarà il ‘medioevo futuro’, poiché sempre di ‘medioevo’ si tratta. Ed ha ragione lui, perché nel decorrere del secondo millennio cui assistiamo inebetiti e scettici, nulla o poco è stato fatto che si allontani dalla verità assoluta del passato dal quale possiamo prendere le mosse per una nuova esistenza e coesistenza umana.
Inutile continuare a batterci il petto in un ‘mea culpa’ che non ci darebbe ragione, non ci sono colpe da attribuire se non a noi stessi, all’evolversi di fatto di una supremazia cercata, voluta, violentata, che pone l’Occidente v/s l’Oriente; la religione Cristiana v/s quella Musulmana; come la storia insegna nel suo ripetere gli stessi sbagli fatti in illo tempore fino al grande disastro degli scontri di razza che – purtroppo – continuano fino ai giorni nostri e che non voglio qui elencare. Se mai il passato ci abbia insegnato qualcosa, una delle voci più attendibili che riemergono dalla storia e regolarmente smentite, ci dice che questa (la storia) si ripete e che nel bene e nel male questo siamo. Il significato eziologico di questa affermazione va quindi oltre mentre ci sospinge verso un ritorno al passato catastrofico senza soluzione, o magari … verso una presa di coscienza che dovrebbe servirci da monito, ma ne dubito fortemente.
In ‘Samarcanda’ l’autore si pone e pone il lettore davanti a un quesito straordinario quanto realistico: che la favola (l’illusione, la leggenda, il mito, l’apologo) sia in fine migliore della realtà artata che stiamo vivendo (?). Ed ecco che Samarcanda è la ‘città sospesa’ molto più in alto delle nostre teste, valica i confini della nostra immaginazione di lettori, avvalendosi della del ‘sogno’ della letteraria ‘una notte oltre le mille’ passate a sognare, recuperando quel che è insito nell’animo umano di sollevarci dalle bassezze in cui fin troppo spesso siamo caduti. E nel risollevarci, guardare oltre l’esistenza che abbiamo fin qui vissuta, con nuovi propositi d’incanto verso ciò ch’è stato e nuovi programmi di vita.
Per cui visitare per la prima volta o ritornare nei luoghi già visti, e rileggere attraverso i personaggi che hanno fatto la storia di certi accadimenti costruttivi, “sempre che la realtà di quegli eventi lontani non sia altrettanto tremenda ma più realistica”, equivale oggi a riappropriarci del ‘sogno’ che ha fatto di Samarcanda la città ideale dei sognatori: “come usano dire i musulmani, solo Dio ne sa di più”. La vista dei complessi architettonici sopravvissuti, delle numerose moschee dalle splendide cupole turchesi, i monumenti più insigni, i favolosi crittogrammi che erroneamente definiamo come ‘arabeschi’, le cuspidi dei minareti che svettano esili verso il cielo, regalano ancora al visitatore momenti di sublime bellezza e di quell’alone di ‘romanticismo’ che in fondo chi viaggia in questi luoghi è ciò di cui ognuno va alla ricerca.
“Certo, come vi assicureranno tutti i cittadini d’una certa età, «non è più il bazar di una volta», quello descritto dai viaggiatori romantici. E i meloni non vengono più scaricati dai vecchi, bisbetici ma straordinari «cammelli battriani», queli bassi, coperti di lungo pelo, a due gobbe, ai quali Stefano Malatesta ha dedicato un libro bellissimo (“Il cammello battriano. In viaggio lungo la via della seta”. 1997); e nemmeno da quei tipici carretti a due grandi ruote dalle lunghe stanghe, gli arba, che ricorderanno straordinariamente a chi di noi non è più giovane quelli che si vedevano fino a qualche decennio fa nelle nostre campagne. Ora ci si serve di prosaici camion dal mefitico scarico, che però si riscattano per gli alti castelli in legno dipinto e fasciato di stoffe multicolori che li addobbano facendoli somigliare a immensi galeoni corsari: specie quando sfrecciano per strada a velocità mozzafiato”.
Una pagina di colore, certo, che insieme a tantissime altre contenute nel libro, ben rende il senso, nonché il profumo di ciò che un viaggiare siffatto comporta; nel senso di una lunga narrazione mai interrotta se non dalla fine e dall’inizio di ogni nuovo capitolo, fornito di numerose note esplicative, linguistico-fonetiche, cronologiche, storiche, letterarie e bibliografiche che aiutano il lettore a districarsi nella lettura dei siti e dei monumenti che man mano l’autore disciplinatamente illustra, accompagnando il visitatore quasi ‘per mano’ a livello quasi circoscrizionale. Ciò vale a dire: ‘nella storia come nella visita dei luoghi’:
XI Capitoli, una Presentazione e un Epilogo, inoltre a un Appendice, numerose citazioni e note a non finire:
Si va dal racconto leggendario della sua nascita, ai massacri succedutisi durante le discendenze dei potenti Samanidi e Karakhanidi; dalla ‘Via della Seta’ e delle ‘Spezie’, all’arrivo dei Mercanti e dei Missionari; da Marco Polo a all’impero Ottomano; da Gengis Khan a Tamerlano; dalle invasioni alle spartizioni odierne dei Balcani; dal Grande Gioco intavolato da germani e inglesi all’arrivo dell’Armata Rossa; ma ed anche di religione e società, di Islam, di Sufismo, di vecchio e nuovo potere operaio ecc. “per capire l’oggi, e sognare il domani.”
“Ma sarebbe una paradossale e contraddittoria formula magica, del tipo di quelle reperite in certi misteriosi manoscritti dei quali si parla nelle ‘Mille e una notte’: in grado di rendere immortale chi la pronuncia, ma dotata del potere di uccidere chiunque, appunto per pronunciarla, sia costretto a leggerla”. Si denota in questo passaggio una volontà propria dell’autore, l’accentramento d’una conoscenza sopra le righe che da sempre diffonde nei suoi libri, coltivata da quella ‘curiosità’ che rende il visitatore l’assoluto protagonista della storia che sta vivendo.
Come di solito, mi fermo qui, anche se ho trovato utile (quanto accattivante) da parte dell’autore l’avvisaglia dedicata al lettore nella precedente guida a Istambul: “Viaggiatori avveduti e turisti intelligenti che mettete in conto di affidarvi, prima di partire, a voluminose guide: nelle mie intenzioni – e nelle mie speranze – l’ideale sarebbe che lasciaste da parte libri, guide e mappe e vi affidaste fiduciosamente a queste pagine. Certo, questa è la «mia» Samarcanda. Non pretendo che diventi anche la «vostra»: mi basterebbe che quanto qui leggete vi aiutasse a trovarla”.
Mettersi in viaggio.
“E ora lascia vagare il tuo sguardo su Samarcanda!
Non è forse la regina della terra? Fiera al di sopra di tutte le altre città,
e i loro destini nelle sue mani?” (E. A. Poe)
Di Franco Cardini:
“Testimone del tempo. Ritorno a Coblenza”, Rimini, Il Cerchio, 2009
“7 dicembre 374. Ambrogio vescovo di Milano, in I giorni di Milano”, Roma-Bari, Editori Laterza, 2010
“Cristiani perseguitati e persecutori, Roma, Salerno Editrice, 2011
“Il turco a Vienna”, Roma, Laterza, I Robinson. Letture, 2011
“Gerusalemme”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2012
“Istanbul”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2014
Non rimane che augurarvi: Buon Viaggio!
Id: 1057 Data: 22/09/2017 12:00:00
*
 Franco Cardini - Saggio - Il Mulino
Franco Cardini - Saggio - Il Mulino
Istanbul
Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, un viaggio attraverso chiese cristiane, alti minareti e grandiose moschee, bazar e labirinti di piccole strade in cui una moltitudine variopinta di turisti spesso s’inoltrano senza neppure conoscere ciò che osservano con tanto clamore, mescolando al mito la narrazione della storia che i luoghi, e non solo quelli adibiti al culto, raccontano di conquiste e distruzioni, di regni caduti e risollevati, di splendori e meraviglie, ma anche di ricchezze e fasti così come di ombre e oscurità improvvise nonché di orrori e miserie umane che nel tempo ne hanno fatto una ‘seduttrice, conquistatrice, sovrana’. L’unica città al mondo che più d’ogni altra sfugge ostinatamente dalla sua cornice ‘metropolitana’ per innalzarsi al di sopra delle sue cupole nel mistero che la contempla, separata dal resto del mondo, come di soglia posta fra Oriente e Occidente a rimarcare un’ultima possibilità di congiungimento.
Quasi una ‘fibbia di civiltà’ che pure contiene le due diverse sponde del vecchio e del nuovo mondo (la Roma Imperiale e la Nuova Roma), non necessariamente in contrasto con la modernità dei tempi, né con il medioevo in cui ciò che rimane del passato debba considerarsi oscuro e polveroso. Il futuro della modernità passa da Istanbul, una città viva in cui ogni pietra, ogni accadimento, parla della storia che sarà, una storia ancora tutta da scrivere in cui il passato si congiunge con il futuro. Una storia che Franco Cardini pone come ‘in prospettiva’ e che un soprassalto di civiltà salverà dall’eterno conflitto con se stessa e con il mondo intero, la cui vera identità è forse da cercare nella conoscenza (mai obsoleta) di ciò che la distingue, all’interno del conflitto religioso che ne contende la supremazia. In quel suo essere stata Bisanzio e poi Costantinopoli e in epoca moderna essere Istanbul la cui ‘storia’ va riletta e reinterpretata secondo il punto di vista degli storici arabo-mussulmani, osservata dalla parte opposta del Bosforo, cioè dalla parte orientale-balcanica, per acquisire veridicità.
Dunque non una qualsiasi guida ma più di una semplice guida, la città di ‘Istanbul’ contenuta in questo libro ‘unico’ rivendica a suo favore un confronto con l’approssimarsi del tempo che la separa da noi occidentali per riprendere a correre nel tempo della realtà, in cui il dibattito delle idee (che ci siamo fatte) su di essa, trovano un loro riordino della costruzione smessa, intrapresa in illo tempore, della Nuova Roma, con quella in atto di Istanbul in quanto nuova città metropolitana condivisa e sostenibile. “E ora proviamo ad avvicinarla fisicamente, la gran Città: dalla terra attraverso le vie che la raggiungono provenendo dai Balcani e dalla «Turchia europea», l’antica e gloriosa Tracia; dal Mar nero e dal Mar di Marmara attraverso i varchi del Bosforo e dei Dardanelli; dal cielo, puntando dritto sui suoi minareti e quindi attraversando, dall’aeroporto Ataturk, i suoi quartieri settentrionali.
Dal cerchio delle sue caotiche e iperabitate periferie dove lussuose residenze ipermoderne, grattacieli vertiginosi e miserabili bidonville coabitano e contrastano, fino al centro dei mosaici di Santa Sofia e dei padiglioni del Topkapi. E percorriamo da lì, da quel centro, il labirinto dei suoi quartieri ora sontuosi ora sordidi, in saliscendi o addirittura quasi sempre ripidi, dove con mirabile impudicizia ruderi romani, fatiscenti dimore ottomane di legno, superbi palazzi e postmoderni, talora improbabili edifici si alternano e si mischiano in un disordine che per spiegarci il suo significato avrebbe bisogno solo di una formula magica in grado di conferirgli senso”. Innumerevoli quindi i punti di osservazione suggeriti, e quanti aspetti inusitati da quelli proposti al visitatore e dal turista che si voglia chiamare; tuttavia la differenza è quasi totale perché ciò che si propone il visitatore è qualcosa di diverso da ciò che riesce a malapena a cogliere il turista. C’è un mare di cultura di mezzo, la conoscenza in primis, cosicché documentarsi, consultare, aprirsi è quanto suggerisce di fare Franco Cardini con questo ‘libro’ documentatissimo di storia, di aneddoti ricercati, d’arte e di stili, di usi e costumi di popoli a confronto, che in ‘Istanbul’ egli propone come una lunga narrazione mai interrotta:
“Ma sarebbe una paradossale e contraddittoria formula magica, del tipo di quelle reperite in certi misteriosi manoscritti dei quali si parla nelle ‘Mille e una notte’: in grado di rendere immortale chi la pronuncia, ma dotata del potere di uccidere chiunque, appunto per pronunciarla, sia costretto a leggerla”. Si denota in questo passaggio una volontà propria dell’autore, l’accentramento d’una conoscenza sopra le righe che da sempre diffonde nei suoi libri, coltivata da quella ‘curiosità’ che rende il visitatore l’assoluto protagonista della storia che sta vivendo.
“Ed eccola Istanbul: caotica e rumorosa eppur fasciata dall’assordante silenzio delle sue pietre e dei suoi secoli; cupa sotto l’abbacinante sole meridiano che obbliga a chiudere gli occhi o a proteggerli dietro spesse lenti color verdi o bruno; iridescente nella coltre di bruma che così spesso la fascia nei crepuscoli; luminosa di millanta luci nelle notti con e senza luna, con e senza le stelle. Inutile illudersi di conquistarla. (..) Istanbul non si conquista, esiste solo un modo per impadronirsene. Lasciarsene impadronire. (..) si fa presto a dire Istanbul. La città è propriamente una e trina, divisa in tre parti: dalle acque del golfo mediterraneo detto Mar di Marmara a sud – Propontis, la «Propontide» (il mare anteriore) -, il vasto e profondo bacino lungo 280 chilometri e largo 80 che attraverso i Dardanelli comunica con il Mar Egeo e che verso nord si biforca insinuandosi a nordest in uno stretto che misura più o meno una trentina di chilometri (Bogaziçi), che separa la costa europea dall’asiatica fino al Mar Nero; dal Corno d’Oro (Haliç), l’ampio fiordo che dal Mar di Marmara e Corno d’Oro, è la vera e propria sede dell’antica Costantinopoli”.
Dacché si comprende come Franco Cardini procede nell’illustrarci un suo (fra i molti possibili) itinerario per visitare la città, spostandosi di conseguenza da una zona all’altra, da una storia all’altra, da una realtà all’altra e raccogliere così quello che si definisce lo ‘spirito del viaggio’ che tutto coinvolge e trasforma: in cui la storia si fa dapprima leggenda per poi entrare nel mito. È allora che la narrazione di Istanbul diventa ‘una città nel mare della storia’; i frangenti dei mari che la bagnano ‘i flutti del tempo contro il molo dell’eternità’; la falce di luna simbolo dell’Islam turco ‘il segreto del crescente lunare’ che rischiara le notti del harem e del Serraglio, con le sue storie ‘romantiche’ e ‘sanguinarie’, tuttavia eccitanti quanto sconvenienti (per la nostra cultura). E inoltre le musiche, le danzatrici di ‘belly dance’, i sultani coi loro ‘padiglioni’ ricoperti di tappeti e cuscini, il tè alla menta, il caffè turco, l’hammam (sauna), le armi dalle impugnature incrostate d’oro e di pietre preziose, i vapori odorosi di essenze pregiate ecc. ecc.
In una parola: “Istanbul. Cioè per i romantici nostalgici Costantinopoli, per i dotti e i potenti la Nuova Roma, per l’antica leggenda ottomana il Rosso Pomo da cogliere. E ancora e sempre, Bisanzio: il chiaro di luna sul Bosforo, l’immagine da cui si è partiti, che riconduce (..) nella fitta cortina di nebbia che tanto spesso l’avvolge nei crepuscoli delle mezze stagioni (..) ma anche a tante altre impressioni e a tanti altri ricordi. Perché tale spettacolo è forse quello che, più di ogni altro, ha impressionato chiunque l’abbia vista per la prima volta, (..) regina più volte violata e sempre risorta, santa vergine e divina meretrice, centro misteriosamente posto a dominare contrapposta periferie tra Asia ed Europa, tra Cristianità e Islam, tra antichità e modernità, tra Oriente e Occidente..”.
Accompagnati dalla guida esperta di Franco Cardini sostiamo per un istante davanti al Gran Palazzo, in turco il Sarayi (da cui l’italiano Serraglio), cioè il palazzo imperiale d’epoca ottomana: “Si trattava in realtà di un insieme di giardini e padiglioni (..) separato dal resto della città da una cinta muraria esterna, all’interno della quale si situavano – come il visitatore moderno può ancor oggi constatare – spazi ordinati in cortili e giardini disseminati di padiglioni adibiti a vari uffici e servizi. Entriamo quindi nell’immenso complesso che ancora oggi prende il nome dal suo portale fortificato aperto verso la piazza Sultan Ahmet, il ‘Topkapi’, ovvero la «Porta del Cannone», praticabile da parte di sudditi e di stranieri fino ai quartieri riservati ai militari di guardia, ai funzionari di governo, alle donne”. Ben altre sono le porte che si richiamano alle diverse ‘corti’, a cominciare dalla «Grande Porta» (Bab-|Alì), denominata anche «Soglia della Felicità» o «Sublime Porta» destinata a divenire proverbiale:
“Nel non sempre né del tutto gratuito immaginario occidentale – che a torto ne trascura tuttavia la funzione politica, diplomatica e amministrativa – il Topkapi è, al pari dell’Alhambra di Granada, un grande giardino del potere, del piacere e del peccato all’interno del quale si muovono accanto a sultani e gran visir, il profilo di molti dei quali è sbiadito dal tempo, le inquietanti e affascinanti silhouette di certe «serve padrone» divenute addirittura delle autentiche ‘kingmakers’ (fautrici/creatrici di re) e spesso sconvolgenti. (..) In quelle raffinate ma austere stanze (harem) si stenta ad ambientare le immagini e le fantasie che la parola stessa ‘harem’ si porta dietro. Immagini sensuali se non addirittura lussuriose, fasciate per giunta dal mistero e dal fruscio arcano di antichi fantasmi, (..) più spesso teatro di amori, di complotti e di delitti”…
Mi fermo qui, anche se ho trovato utile (quanto accattivante) da parte dell’autore l’avvisaglia di retro-copertina dedicata al lettore: “Viaggiatori avveduti e turisti intelligenti che mettete in conto di affidarvi, prima di partire, a voluminose guide: nelle mie intenzioni – e nelle mie speranze – l’ideale sarebbe che lasciaste da parte libri, guide e mappe e vi affidaste fiduciosamente a queste pagine. Certo, questa è la «mia» Istanbul. Non pretendo che diventi anche la «vostra»: mi basterebbe che quanto qui leggete vi aiutasse a trovarla”. Ha scritto Iosif Brodskij (citato nel libro): “Ci sono luoghi in cui la storia è inevitabile come un incidente automobilistico – luoghi in cui la geografia provoca la storia”.
Ed è così, qui ogni pagina racconta più d’una storia, una dentro l’altra che s’intersecano a formare un grande quadro d’insieme, finanche poetico che permette al lettore di spostarsi dal reale all’immaginario con la disinvoltura che solo Franco Cardini, per questo unico e quindi raro, ha nel districarsi in certe faccende di per sé complicate, che cedono, arrendendosi, alla sagace penna del narratore per eccellenza che occupa un suo preciso spazio nella nostra letteratura, in quanto storico e saggista, che ha sfruttato al meglio la sua potenza istruttoria negli studi sul Medioevo di cui è indubbiamente il più apprezzato conoscitore di scritti cristiani e arabo-islamici. Inutile qui ripercorrere la sua enciclopedica attività professionale la conoscenza della quale è oggi accessibile su tutti i media, così come citare la sua sterminata bibliografia. Pertanto mi limito a segnalare quelle che sono le sue più recenti pubblicazioni:
“Testimone del tempo. Ritorno a Coblenza”, Rimini, Il Cerchio, 2009 “7 dicembre 374. Ambrogio vescovo di Milano, in I giorni di Milano”, Roma-Bari, Editori Laterza, 2010 “Cristiani perseguitati e persecutori, Roma, Salerno Editrice, 2011 “Il turco a Vienna”, Roma, Laterza, I Robinson. Letture, 2011 “Gerusalemme”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2012 “Istanbul”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2014 comprende inoltre un’ampia appendice ricca di note, cronologia, carte, glossario, bibliografia e delle bellissime riproduzioni d’arte.
Giunti al dunque, non mi resta che augurarvi: Buon Viaggio!
Id: 871 Data: 12/03/2015 12:00:00
*
 Alessandro Ticozzi - Saggio - Edizioni Sesnsoinverso
Alessandro Ticozzi - Saggio - Edizioni Sesnsoinverso
La voce e il cinema: Arnoldo Foà attore cinematografico
Arnoldo Foà: La personalità della sua voce nel cinema italiano
«Un attore così, chi ha avuto la fortuna d’incontrarlo lo sa, bastava creare la situazione per ottenere immediatamente reazioni misurate e in perfetta sintonia con il personaggio … Un uomo dotato di un’ironia tagliente, un finto burbero, molto dolce in realtà e con un senso critico assolutamente disarmante ed esilarante: saltava agli occhi la modernità della sua testa, sempre viva e stimolante grazie a una vivacità intellettuale e a una curiosità per il genere umano incredibile. Un uomo positivo, molto colto, raffinato - a dispetto delle sue provocazioni - e con un grandissimo senso del rispetto per il lavoro degli altri, specie se appassionati e professionali …Un vero professionista, da prendere a esempio.»
La nota in calce è di Luciano Melchionna, regista, che ha avuto la fortuna di lavorare con Arnoldo Foà in più di un’occasione e che ci ha fatto dono di una tra le più ‘emozionanti’ pagine del cinema italiano: nella figura del nonno muto in ‘Ce n’è per tutti’ (2009). Lui ‘la voce’ per eccellenza del cinema italiano, ma anche la maschera irraggiungibile di molte pellicole da ‘non protagonista’ diretto da grandi registi dello schermo; colui che ha dato ‘la voce’ in qualità di doppiatore ad artisti di levatura internazionale come Peter Ustinov, Anthony Quinn, Toshiro Mifune, John Wayne, Broderick Crawford e numerosi altri; si è ritrovato privato della sua stessa ‘voce’. Ma sarebbe un errore non da poco valutare quella sua ultima apparizione sullo schermo come una dismissione di ruolo che ne sminuisce le capacità intellettive di attore consumato o che, superati i novanta, non abbia più nulla da dire.
Al contrario Foà nel cammeo del ‘nonno muto’ raccoglie cent’anni di cinema italiano, che lui stesso ha contribuito a costruire passo dopo passo, ma è forse meglio dire, interpretazione dopo interpretazione, sui palcoscenici dei molti teatri che ha calcato, a diretto contatto con quel pubblico che fin da subito ne ha stimato le qualità di attore, le sue straordinarie capacità d’interprete, la ‘personalissima’ voce che lo distingueva da tutti, tale da essere ‘unica’ riconoscibile anche in una sola vaga battuta. Ed è anche sbagliato dire, come ho appena fatto, una ‘vaga battuta’, perché non accadeva a Foà di pronunciare una sola ‘nota’ fuori del pentagramma, una sola parola o fosse anche una semplice esclamazione, che non aderisse alla battuta di uno ‘pseudo copione’ preordinato del personaggio che interpretava.
“Le sue interpretazioni sono memorabili, incisive, esito di un attento studio, passione e misura drammatica elette..” rammenta Alessandro Ticozzi, autore del libro “La voce e il cinema: Arnoldo Foà attore cinematografico” (SensoInverso 2014), rieditato in occasione del primo anniversario della scomparsa del grande attore; sia che scaturissero dalla penna di Plauto, di Aristofane, di Shakespeare, di Calderon de la Barca, di Gogol, di Shaw o di Pirandello; come da quella di Leopardi, di Garcia Lorca. Jean Cocteau o Rod Mackuen; sia di Menotti, di Costanzo o di Alessandro Baricco. La sua ‘voce’ riusciva ad esprimere una certa visione del mondo che sarebbe risultata autentica nel rivelare un ‘proprio stile’ di conversazione con il pubblico teatrale, radio-televisivo e cinematografico, ed anche registico e scrittorio.
Già, perché altri aspetti meno conosciuti se non dagli addetti ai lavori e non solo, ai quali il libro su Arnoldo Foà è dedicato, ci rammenta inoltre essere stato scrittore ironico, regista e produttore di autori classici e contemporanei, oltre che di se stesso. Nonché che è stato diretto da registi di teatro del calibro di Luchino Visconti, Luigi Squarzina, Giorgio Strehler, Guido Salvini, Luca Ronconi e Roberto Guicciardini. Ma si vuole qui parlare di cinema e allora non si possono non citare i registi che lo hanno diretto fin dalle sue prime pellicole che pensate risalgono agli anni ’30 del secolo scorso. Più esattamente Alessandro Blasetti che lo diresse in ‘Ettore Fieramosca’ (1938); Pietro Germi in ‘Il testimone’ (1945); Ignazio Ferronetti in ‘Fuga nella tempesta’ (1947); Mario Camerini in ‘La figlia del capitano’ (1947); e poi i numerosi film di Mario Mattoli del quale mi piace ricordare il film di cappa e spada ‘I cadetti di Guascogna’ (1950); e Joseph Losey in ‘Imbarco a mezzanotte’ (1952); Christian-Jacque in ‘Lucrezia Borgia’ (1953); Mario Soldati ‘La mano dello straniero’ (1953); Mario Monicelli ‘Totò e Carolina’ (1955); Carmine Gallone ‘Cartagine in fiamme’ (1959).
Ma è anche il caso di citare Orson Welles che lo diresse in ‘Il processo’ (1972); Damino Damiani in ‘Il sorriso del grande tentatore’ (1973); Giuliano Montalto in ‘Il giocattolo’ (1978); Paolo Costella del demenziale ma altrettanto piacevole ‘Tutti gli uomini del deficiente’ (1999) con la Gialappa’s Band; Ettore Scola del quale mi piace qui ricordare ‘Gente di Roma’ (2003); fino ad arrivare ai giorni nostri con Citto Maselli di ‘Le ombre rosse’ (2009) e, ovviamente Luciano Melchionna di ‘Ce n’è per tutti’ (2009). Non in ultimo Maurizio Sciarra, regista cinematografico che lo diresse in ‘Quale amore’ (2006) un dramma psicologico ispirato a Lev Tolstoj ha detto di lui: “Grande uomo e grande attore non sempre sono doti che si trovano nello stesso corpo. Ma in Arnoldo coesistono, perché c’è una grande anima. E la passione per il suo lavoro, la sua abnegazione, la sua gioia di recitare, ti fanno sentire a tuo agio. Sono anche io uomo di poche parole, ma con Arnoldo ho avuto subito la sensazione di essere a mio agio, amato e apprezzato. E questo per un regista è un dono impareggiabile.”
L’elenco qui riportato della sua filmografia è necessariamente incompleto in ragione di una scelta programmatica rilevante solo i nomi più conosciuti tra italiani e stranieri che meglio rendono la grande diversità dei ruoli e il suo impegno artistico. Diversità di ruoli che in Arnoldo Foà non significava diversità di ‘impostazione di voce’ bensì di ‘colore’ o meglio di ‘tessitura’, in cui il ‘tono’ egli raramente spingeva oltre il proprio limite naturale, se non quando per esigenze di copione era costretto a gridare (shout) e, pur tuttavia, mantenendo un suono nitido, benché ‘tenuto’, rappresentativo di una voce ‘ideale’, decisamente maschile, capace di grande espressività. Una voce inconfondibile, soprattutto una voce impostata come la sua, ha sempre il dono di essere estremamente ‘leggibile’ ora modulandola a suo modo secondo il ruolo che interpretava, ora a seconda della forza interiore che egli intelligentemente esprimeva nel personaggio interpretato. Risulta che pochi siano stati i suggerimenti dati a Foà dai registi sull’interpretazione di questo o quel personaggio; senz’altro inferiori a quelli che egli stesso ha trasmesso loro nell’interpretarli magistralmente, cosa che gli veniva spontanea.
Foà stesso si trovò a dire: “Se non vengo utilizzato in cinema come mi spetterebbe, data la mia capacità (modestia a parte), è perché i registi, specie quelli nostrani, si trovano imbarazzati di fronte a me per i suggerimenti che accettano dato che sono costretti a riconoscerne il valore, ma che si seccano di dover subire”. Un esempio, qui riferito da Giovanni Soldati che lo diresse in ‘L’attenzione’ (1985): “Spesso Arnoldo proponeva sfumature differenti, e io ho sempre accettato consigli da lui. Persino al doppiaggio Arnoldo proponeva versioni differenti, e io accondiscendevo. Io ho sempre fatto come voleva lui e poi, anche, come volevo io.” Ciò la dice lunga sul perché Arnoldo Foà tutto sommato non sia stato utilizzato al meglio dal nostro cinema che lo ha relegato, per così dire, a secondi ruoli relativamente ‘importanti’ che ne hanno in parte offuscato la grandezza.
Ma se la voce di Arnoldo Foà rappresentava esattamente la persona che la possedeva, i suoi occhi non erano da meno. Spesso considerati lo ‘specchio dell’anima’, egli “...recita con lo sguardo, con la mimica, con il corpo, limitandosi a fissare quello che accade intorno”, a dimostrazione che il suo ‘guardare’ era pregno di quel carattere arguto e ironico che egli esprimeva come persona, di per sé attraverso gli occhi. Talvolta inquietanti, indubbiamente espressivi di un’intelligenza viva. Come ebbe a dire Ettore Scola che lo ha diretto in ‘Gente di Roma’ (2003) quand’era già avanti con gli anni: “Anche il carattere è importante in una persona, e quello di Arnoldo è vivo e intelligente: è un intellettuale, come dimostra anche nei suoi libri, e anche questo ne fa una persona completa e affascinante nell’interagire col pubblico.”
Quello stesso pubblico sempre più numeroso che lo ha applaudito in ‘Novecento’ di Alessandro Baricco per la regia di Gabriele Vacis, al cui personaggio la natura d’attore e l’uomo Arnoldo Foà ha restituito quella credibilità che forse il romanzo in origine neppure aveva, benché reduce da un grande successo di critica e di pubblico a livello internazionale: “La mia idea sarebbe quella di farlo da fermo ... non dovrebbe muoversi questo personaggio, perché è un personaggio che parla, che ricorda ... Novecento è un ricordo continuo di un qualche cosa che ha fatto vivere questo personaggio. Lo ha fatto vivere in corrispondenza, naturalmente, di quello che ricorda … E stranamente è come se lui non esistesse. Come se questo personaggio - Novecento - che lui ricorda con tanta intensità fosse … fosse lui stesso. E questo è quello che dovrò fare. Dovrò far capire chi è questo personaggio che mi ha colpito talmente da farmi addirittura invecchiare col ricordo di sé … Non sono più neanche ricordi suoi, è come se lui vivesse quello che ha vissuto il personaggio che sta ricordando. L'interessante di questa storia, è che il protagonista non esiste, non c'è. Il protagonista è ricordato, rivissuto … da me. Dovrò studiarmelo bene. Per entrarci dentro. Io spero che dopo quello che riuscirò a fare, si dica che sono un artista. Lo spero. Peggio per voi se non l'avrò saputo fare: non saprete chi era il personaggio di cui vi parlo e meno che meno chi sono io.”
Alessandro D’Alatri che lo ha diretto in ‘La febbre’ (2005) ha detto di lui: “L'esperienza umana e professionale di Arnoldo è davvero straordinaria. È uno dei più importanti testimoni artistici della nostra storia contemporanea. La cosa che mi ha sempre colpito è la sua attitudine alla "leggerezza". Il suo approccio, sia al set che alla vita, avviene sempre con la delicatezza dello sguardo di un bambino. È un insegnamento che noi tutti non dovremmo mai trascurare. Arnoldo Foà ha una sua età anagrafica, ma in realtà ha conservato un atteggiamento adolescenziale. Nulla lo sorprende più di tanto e tutto lo interessa. Quello che però lo rappresenta più di tutto è il suo sguardo ironico, e allo stesso tempo implacabile, sulla società, la vita, la storia.”
Ed a noi piace ricordarlo così. Grazie Arnoldo!
Id: 867 Data: 13/01/2015 12:00:00
*
 Roberto Peregalli - Narrativa - Bompiani
Roberto Peregalli - Narrativa - Bompiani
Proust. Frammenti di Immagini
Roberto Peregalli ‘Proust. Frammenti di Immagini’ – Bompiani 2013 Una eloquente e pregiata biographie di Marcel Proust come non si era mai scorsa finora, rivissuta nei luoghi e nelle immagini della Recherche che l’autore del libro ha ricreato, quasi con meticolosità viscontiana, dentro una sceneggiatura scrupolosa, aggirandosi fra oggetti, abiti, cappelli, arredi, carrozze, automobili, orologi che hanno scandito il ‘tempo’ di un’epoca relativamente lontana, il cui stentato riverbero lascia posto alle ombre, ai misfatti, alla superficialità di una società edulcorata e decadente. Luci ed ombre sapientemente dosate e ricreate dall’occhio stesso dell’autore che si propone in veste di fotografo di eccezionale capacità artistica, e che sembrano fare da contrappunto a una scrittura rapida, essenziale, quasi intimista, in cui la vita di Proust è rivissuta nella sua quotidianità, flashback e riflessioni comprese, appunto come per una riduzione filmica le cui immagini in sequenza si offrono per una lettura dinamica coerente alla scrittura stressa. Un operare di non poco conto se si pensa alla selezione in fase di montaggio delle scene di un film. Si potrebbe dissentire sulle scelte fatte di commentare le didascalie alle immagini che, al contrario di quello che si può pensare, fanno da cornice ai ‘frammenti’ tratti dai quaderni dello stesso Proust ma, solo se non conoscessimo il modo ‘impressionistico’ dell’autore della Recherche di prendere i suoi appunti. Per quanto, invece, si può ancor più apprezzare lo sceneggiatore che ha dato vita a una scrittura creativa che toglie di mezzo orpelli letterari e preconcetti morali, lasciando l’autore ‘nudo’, protagonista assoluto di se stesso. Notevole è il rapporto scrittura/immagine lì dove l’autore del libro definisce lo status organizzativo della ‘biographie’ secondo la tesi che egli si impegna a dimostrare nelle pagine che seguono e che si lascia leggere come un romanzo d’appendice, quasi fosse la cronaca o il sequel di qualcosa che sta accadendo sotto gli occhi del lettore. Appunto nella dinamica che solitamente accompagna il lettore del libro e/o chi guarda il film che l’autore, in questo caso Roberto Peregalli in quanto regista, ha inteso fare della propria ‘tesi’ cinematografica. Una lettura certamente impegnativa perché innovativa che certamente accresce l’esperienza del lettore sempre più indirizzato verso le nuove tecniche scrittorie che s’accompagnano alla frequentazione sul web di testi analitici e quantistici che vedono il campo linguistico ridotto all’essenziale quando espresso in chiave minimalista. Sotto un certo aspetto, malgrado l’autore del libro ostenti una verve narrativa letteraria necessaria allo scopo, (si tratta pur sempre di affrontare un monumento della letteratura mondiale), non è avventato qui parlare di quantistica. Ovviamente si sta parlando di pensiero e/o di filosofia ‘quantitista’ legata alla fisica solo a livello concettuale, come possibilità della mente di esistere entro un diversa realtà in grado di influenzare ciò che pensiamo in dipendenza ai messaggi ricevuti (Emoto), e quindi dalle emozioni che sopraggiungono istantanee nel momento stesso della lettura. Quanto dev’essere capitato all’autore del libro che, già infatuato dalla lettura della Recherche, ha elaborato la sovraesposizione del messaggio emozionale alle immagini viste e/o intenzionalmente cercate nel tempo. “Le povere cose che fanno il nostro mondo. Il tempo che si muove e ritorna, lascia traccia. Scrive il nostro destino. il tempo che si perde, nel senso di perdere del tempo (Deleuze), non solo quello perduto. Si deposita negli anfratti dell’esistere, dà luce. Le pieghe del mondo entro cui si trovano le immagini della verità.” – scrive Roberto Peregalli nell’Introduzione che si conferma ‘quantistica’, in ragione di invenzione e utilizzazione relative alla memoria; mentre è ‘minimalista’ nell’essere ‘catalogo ragionato per frammenti di immagini’. Allora ogni superficialità: “dialoghi puramente formali, i riti mondani, il lembo di un vestito, le gocce d’acqua su una foglia, i tetti, le finestre, il mare”, così come “Il sesso, la gelosia, l’amore, l’amicizia (e la sua miseria)” diventano protagonisti di un infinito a se stante, ‘perduto’ nel vuoto cosmico (cioè un pieno) che la filosofia quantistica relativizza come sostanziale. Ecco che “gli eventi macroscopici, come la vita, la morte, la guerra, la storia, sono visti attraverso il microscopio del tempo. È il canto dell’essere. (...) La superficie che sfiora l’abisso.” Tutto questo è nel mondo che Marcel Proust ha re-inventato nella sua costante e interminabile Recherche; tutto quanto ruota ancora oggi intorno alla letteratura e nel nostro quotidiano, seppure con modalità e superficialità diverse. Tuttavia parlare di ‘superficialità’ è scorretto quanto detrattivo, poiché essa è parte integrante del mondo e del modo in cui viviamo la realtà. Perché allora non domandarsi quale è la realtà in cui siamo immersi o piuttosto sommersi? O qual è il modo migliore per non lasciarsi travolgere dalla realtà? Presto detto: la superficialità è la risposta a entrambi gli interrogativi, in ragione che serve a stemperare le necessità e le precarietà che incombono nella vita. In senso figurato, come una sorta di cartina tornasole, decisiva e irrefutabile a conferma della straordinaria capacita di osservazione di Marcel Proust, che se ne serve “per decifrare la materia del mondo, illuminando l’infinitesimale piccolo (..) per guardare dentro l’abisso e trasformandolo nello specchio dell’essere”, quell’abisso che è in lui stesso. Non è forse questa l’essenza della Recherche che il suo autore si trova a percorrere? Sì, sostiene Roberto Peregalli, secondo il quale Marcel Proust “Percorre sentieri non battuti, non segnalati nelle mappe della Storia. Sta ai margini degli eventi epocali, ma li registra con precisione. Il passaggio al nuovo secolo è un cambiamento assoluto, di cui la prima guerra mondiale è solo una conferma.” (...) A una società basata sui riti della rappresentazione si sostituisce un sistema planetario che azzera le differenze sociali e le riposiziona sulla base della ricchezza economica”. Ed ecco la parola che cercavamo per dare adempimento alla tesi concettuale di tutta la Recherche proustiana: ‘rappresentazione ’. Un po’ recita e un po’ spettacolo in quanto performance e raffigurazione di ciò che ‘in realtà’ è percezione emotiva di ‘frammenti di immagini’ che tornano e si compongono in un insieme che è scenico, scenografico, teatrale. In quanto teatro di scrittura è testo, copione, sceneggiatura per un’ennesima rappresentazione di se stessi, di ‘quanti’ si trovano a recitare una parte nel ‘grande teatro del mondo’. “È una ritrascrizione, spogliata della sua sonorità melodica (data dalla sequenza delle parole), ridotta all’osso. Sicuramente un tradimento, una visione parziale, una riduzione in frammenti, lampi, baluginii di quell’architettura immane. (La Recherche) L’idea di immortalare la scena prima che tutto si disfi e si frantumi nel fiume del Tempo. Guardare per un istante un mondo colto nell’attimo del suo essere sospeso, in bilico sul nulla”; dove il mondo si specchia nel suo contrario in bilico tra la realtà e l’irrealtà del momento, e pur sempre fantastica. In Proust tutto ciò appare tra le righe del testo, solamente accennato, ma costituisce il tessuto prezioso di cui è fatta la trama delle sue visioni. (...) Nella sua essenzialità è questa la prima traccia di un film che vorrebbe mostrare queste immagini una di seguito all’altra, lasciando tra le pieghe della loro dissolvenza la possibilità di un’altra lettura, l’impronta di un universo sognato e vissuto, che ha catturato nella sua trama immensa la fragilità della nostra vita”. E certamente, di altra lettura si tratta, in cui l’insolito aderisce perfettamente ad altre aggettivazioni, come raro, curioso, particolare. Ma cosa c’è di così ‘particolare’ in questo libro lo svela la struttura dei capitoli, a cominciare dai luoghi geografici e quotidiani in cui la vita di Marcel Proust trova il suo svolgimento come Parigi, la Senna, il Bois de Boulogne, Balbec, Venezia ecc.; ai personaggi esaminati nei loro risvolti psicologici Swann, Gurmantes, Charlus, Albertine e lo stesso Proust, visti ognuno nel loro entourage di amicizie più o meno altolocate, nelle tipiche défiance nobiliari, nelle loro devianze particolari che hanno portato alla struttura circolare della Recherche con le sue tremila pagine fitte. Fino a quel quarto capitolo dal titolo significativo “Sodoma e Gomorra” in cui l’autore rimette al lettore la sua ‘autentica’ conclusione, convinto che l’umanità stesse andando verso il degrado totale, proprio come era stato per gli abitanti delle due città nominate. La scelta del titolo è probabilmente dovuta alla scelta stessa dei temi ricorrenti in tutta l’opera, e che sono il tempo e la memoria, nonché il frutto di esperienze autobiografiche, con particolare rilevanza al tema della devianza maschile e femminile, come l’omosessualità e il lesbismo. Nel modo stesso che Roberto Peregalli sembra far rilevare senza voler dare necessariamente un giudizio, tra l’altro non richiesto, alle tendenze sessuali dell’autore Marcel Proust, né alimentando il pettegolezzo per il piacere del gossip. Tuttavia il libro è ricco di informazioni in qualche caso anche inedite che l’autore riporta con dissacrante, perché personalissima, voracità di scrittore o, per dirla in senso cinematografico, ingordigia di regista che ambisce di “toccare le corde del nostro sentire e ci invita a riflettere sui falsi miti che invadono sempre più prepotentemente il nostro mondo”. ‘Il resto è silenzio’ – scriveva Shakespeare nella chiusa finale dell’Amleto. “Il resto è tutto ciò che rimane” – sembra voler accennare Roberto Peregalli rifacendo il verso a Marcel Proust, al suo costante cercare ‘e a trovare’ nella superficialità dei sentimenti umani il nocciolo nascosto delle emozioni, fulcro ed essenza di “A la recherche du temps perdu”. Un trovare che la ‘teoria dei quanti’ oggi conferma anteponendola al ‘vuoto’ e a quel ‘nulla’ a cui narratori e poeti hanno rivolto lo sguardo in ricerca dell’assoluto. Roberto Peregalli, milanese, laureato in filosofia. In quanto allievo dell’architetto Renzo Mongiardino, lavora in Italia e all’estero, e firma le scene di alcune opere liriche. Per Bompiani ha pubblicato ‘La corazza ricamata’ (2008); ‘I luoghi e la polvere’ (2010) e ‘L’invenzione del passato’ con Laura Sartori (2011).
Id: 815 Data: 27/06/2014 12:00:00
*
 Mauro Germani - Saggio - L’arcolaio
Mauro Germani - Saggio - L’arcolaio
L’attesa e l’ignoto
‘L’attesa e l’ignoto’ - L’opera multiforme di Dino Buzzati – a cura di Mauro Germani. Ci sono autori cui si dedica solo un breve spazio allorché si viene a conoscenza di un loro exploit letterario o drammaturgico e poi si dimenticano. A volte si torna a parlare di loro come di qualcosa che è stato e senza particolare entusiasmo. Di certo non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a un ‘grande’ anche se la sua opera, in passato, aveva fatto un qualche scalpore scaturendo intorno a sé qualche riprovazione, più dalla parte dei critici che dei lettori. Mi riferisco a ‘Il deserto dei tartari’, l’opera che l’aveva visto affermarsi come scrittore, oltre che come giornalista del Corriere della Sera. Ma non c’è che dire, c’è sempre tempo (oppure no?) per guardarsi indietro e recuperare. È accaduto così anche a me, quando, poco più che ventenne, mi trovai a fare l’incauto acquisto di quel primo romanzo ‘Il deserto dei Tartari’ uscito nel 1966, nella allora ‘collana’ Oscar Mondadori e messo in vendita per poche lire, anticipato dall’uscita di un libro di George Bernanos, e non ricordo chi altro, il cui nome sicuramente iniziava con la lettera ‘a’. Il romanzo, in prima uscita nel 1940, aveva poi vinto lo Strega nel 1958, cui aveva fatto seguito nel 1959 ‘Un amore’ pubblicato sempre per i titoli della Mondadori nell’anno 1963 e da cui Gianni Vernuccio, regista, nel 1963 aveva tratto un film con Rossano Brazzi e Agnes Spaàk, che non ricordo di aver mai visto. Non era quella l’età in cui mi sarei chiesto chi mai fosse Dino Buzzati, a me sconosciuto, se non fosse perché avevo uno scaffale da riempire. Comunque mi piaceva leggere e poco importava se il libro fosse prezzolato o meno. Fu così che il romanzo mi coinvolse per la sua scrittura scarna, essenziale, finalmente sfrondata dai lacci ottocenteschi, e che oggi definirei nichilista se non addirittura fondante di quella ‘modernità liquida’ così definita da Z. Bauman, per cui ‘l’utilitarismo fonde le unità in massa totale, perdendo nel processo tanto l’identità degli individui quanto la loro separazione’. Mi sono perso oggi, come ricordo mi persi allora nel seguire il tenente di prima nomina Giovanni Drogo “...come un incubo concentrazionario accoglie chi lo sogna”, e che infine s’impone come la cifra del futuro percorso di romanziere di Dino Buzzati. Non posso dire se egli sia mai uscito dal ‘deserto’ in cui si è rinchiuso, certo ha aperto la porta di un labirinto psicologico di estremo interesse per la futura ricerca letteraria del ‘novecento’ italiano e non, iniziata con “La coscienza di Zeno” (1923) di I. Svevo, e “Auto da fé” (1935) di E. Canetti, seguito da “Uomini e no” (1945) di E. Vittorini e, successivamente, da “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (1979) che restituiva al lettore “..quel piacere di leggere” frutto di una eccezionale stagione letteraria che andava qui ricordata. Fu poi la volta dell’uscita del film che Valerio Zurlini trasse nel 1976 dal romanzo omonimo, suggellato da un cast stratosferico da far morire d’invidia Hollywood e che, in verità, rendeva degna sequenza al romanzo. Sia per il collante che lo legava al testo, pressoché inalterato; sia per le immagini fotografiche memorabili, magistralmente fotografate da Luciano Tovoli e, accompagnate dalle musiche di E. Morricone che, ricordo, aggiungevano al film momenti di stretta intimità con i luoghi (landscapes e interiors), al pari di ‘paesaggi dell’anima’ circondati dal nulla, al nulla votati, nel susseguirsi immobile di giornate tutte uguali che, nelle ore dell’attesa, si consumano fino allo sfinimento, all’esaurimento della luce, allo scacco tirato da una morte liberatoria e consolante che, al dunque, arriverà “..per una vita che non ha voluto, né saputo, essere vita”. Mi sembra qui utile citare Giuliano Gramigna (*) il quale, nella ‘prefazione’ al volume ‘Buzzati romanzi e racconti’ (I Meridiani Mondadori), apre ad unasorta di ‘sdoppiamento’, che partendo dai racconti, sarà caratterizzante di tutta l’opera del romanziere: “..ossia secondo una metaforizzazione già narrativa, Buzzati si estraniava da «quel passante sconosciuto» che aveva scritto i suoi libri, «uno straniero, un misterioso personaggio di cui conosco ben poco», rifiutandosi di spiegare, in un articolo successivo, come erano nate le sue storie”. Da cui si ricava come nei ‘racconti’ vi sia in nuce tutto ciò che viene dopo. Infatti è altrettanto vero che da un semplice ‘racconto’ possa scaturire il successivo grande ‘romanzo’ che non viceversa, così come da una negazione di fondo, possa arrivare un’affermazione che di fatto ci trova impreparati a riconoscere. È il caso di questa raccolta di ‘prose’, con i contributi inediti di critici, poeti e scrittori contemporanei, che riscopriamo non solo l’opera multiforme di Dino Buzzati, ma anche il suo aspetto forse meno conosciuto, cioè il poeta, il drammaturgo e il librettista d’opera, che forse fino ad ora non avevamo appieno valutato. Citare qui tutti gli interventi – sebbene alcuni brevi – è pressoché impossibile, pertanto mi limito a sottolineare quelle che sono le tematiche affrontate nei testi che ho trovato di grande interesse letterario per quanti vogliano fare o rinverdire la propria conoscenza attorno alla figura di questo autore così poco citato e che invece meriterebbe il nostro ricordo e il nostro plauso: “Il segreto e la morte nei romanzi di D. Buzzati”, “Il romanzo dell’essere e del nulla”, “L’esilio del re delle favole”, “Buzzati poeta”, “Buzzati e il teatro: un amore non ricambiato”, “Buzzati e la pittura: il filo invisibile”, “Buzzati al cinema”, ed ovviamente le rispettive ‘schede bio-bibliografiche di tutti gli autori’ presenti. Contenente, inoltre, alcuni saggi già pubblicati nel dicembre 1991 sulla rivista ‘Margo’ che Mauro Germani – curatore della raccolta – ha stilato nel numero monografico dedicato alla figura e all’opera di Dino Buzzati. Impreziosiscono il volume le interessanti ‘confessioni’ in forma di intervista rilasciate al curatore dalla sig.ra Almerina Buzzati vedova dello scomparso scrittore. Indubbiamente in passato è stato scritto molto su Dino Buzzati, tuttavia con questa raccolta si riapre qui un discorso che in qualche modo si era interrotto senza una vera ragione, forse a causa di quel disuso che le lettere comportano in sé, nonostante occupino un posto nella biblioteca personale di quanti amano leggere libri, e che pure rimangono lì tra“l’attesa e l’ignoto” di essere riscoperti. Rileggere una raccolta di racconti, un romanzo, o un’opera poetica, talvolta restituisce al lettore attento qualcosa che gli era sfuggito in prima lettura, così come rivedere un film che si è già visto ci fa rivivere le emozioni e rinfranca i sentimenti che ci sembravano spenti. È questo il segreto della memoria alla quale non possiamo non chiedere di continuare a vivere in noi, in certi momenti di intensa comunione con la nostra vita, quella che abbiamo vissuta e quella che avremmo voluto vivere, oltre, ovviamente, all’illusione dell’attesa e dell’ignoto che da sempre ci riservano ‘il sogno e l’illusione’: “..Era molto più delicato e tenero di quanto si credesse. Era fatto di quell'impalpabile sostanza che volgarmente si chiama favola o illusione: anche se vero” (Dino Buzzati dal libro "Le notti difficili"). Ed è qui che si riapre il discorso tutto letterario sul ‘fantastico’ di Dino Buzzati, in cui l’autore dei racconti insegue l’intenzionalità dell’appropriarsi del ‘tempo’ pur sapendo della sua imprendibilità, della sua ‘irraggiungibilità’. Di fatto, in molti suoi racconti come nei romanzi, egli configura ‘il tempo dell’attesa’ che lo separa e lo coinvolge nella ‘morte’; e questo è reso possibile solo rifacendosi all’esistenza (ovviamente non moralista e neppure favolista dell’autore), travolto dell’opera suggestiva e inesorabile del ‘tempo’ che, come il ‘destino’ si lascia afferrare solo nella condizione della solitudine della ‘morte’: “...Un po' più in là della tua solitudine, c'è la persona (ciò) che ami”. (Dino Buzzati da “PensieriParole”). Dino Buzzati è stato uno degli autori più significativi della letteratura del novecento, ha svolto la professione di giornalista del “Corriere della Sera”. Tra le sue opere, oltre quelle citate nel testo, vanno ricordati i romanzi “In quel preciso momento” (1950); “Sessanta Racconti” (Premio Strega 1958); “Le notti difficili” (1971). Romanziere e drammaturgo è stato anche pittore assai originale.
Id: 756 Data: 07/01/2014 12:00:00
*
 Edgar Allan Poe - Racconti - Gargoyle Books
Edgar Allan Poe - Racconti - Gargoyle Books
I viaggi immaginari
Edgar Allan Poe “I viaggi immaginari”: Esplorazioni stravaganti e impossibili in giro per questo e altri mondi – Gargoyle 2013. “Per avere paura non occorre un motivo preciso, (..) ma quando si ha paura è bene sapere perché” recita un aforisma di Èmile Ajar (Romain Gary) che bene si adatta all’atmosfera ricreata in questo libro postumo, ‘assemblato’ a distanza di centocinquanta anni circa dalla morte di E. A. Poe, e che raccoglie numerosi racconti, tra i meno conosciuti dell’autore, e sottotitolato da una ipotizzabile chiave di lettura che recita così: 'Esplorazioni stravaganti e impossibili in giro per questo e altri mondi’ che ne permette la godibilità. Con questa raccolta, infatti, si delinea l’importanza di un’operazione editoriale che restituisce al lettore un altrettanto valido ‘materiale letterario’, altrimenti destinato all’obsoleto, in una nuova veste critica e rispettiva traduzione. Lo ‘sgomento’ su cui E. A. Poe fa leva in questi racconti, e che ben possiamo definire ‘paura’ in nuce, a uso e consumo per i successivi racconti dell’ ‘horror’ più complessi che segneranno la sua produzione di maggior respiro, è qui fruita come ‘esercizio di stile’ più propriamente detto, cui l’autore si rifarà costantemente nei suoi scritti successivi. In realtà non c’è una ragione specifica che lega questi racconti all’ ‘orrifico’, pur tuttavia in essi si discopre quella che è la ‘madre di tutte le paure’, la ragione fondamentale della ‘paura’, e cioè ‘il timore del male’ che porta in sé la morte: “Ah, la Morte, lo spettro che si sazia a tutti i banchetti! Quante volte ci siamo persi in considerazioni sulla sua natura! Che mistero quel suo frenare la felicità umana dicendole «fin qui, ma non oltre!»”. È detto nel racconto “Colloquio di Monos e Una” presente in questa raccolta e che, ancora oggi, suona di grande attualità – chi mai l’avrebbe detto? – soprattutto quando Poe affronta il suo avvicinamento a Dio. “Come è facile ipotizzare dall’origine del disordine, chi era stato contagiato dal sistema e dall’astrazione si era avvolto nelle generalità. Fra le altre idee strane, aveva guadagnato terreno quella dell’uguaglianza universale e di fronte all’analogia e a Dio, a dispetto dell’alta voce ammonitrice delle leggi (..) che pervadono così vivamente ogni cosa del Cielo e della Terra, nei tentativi selvaggi fatti per far prevalere la ‘democrazia’ su tutto. Purtroppo questo male era scaturito fatalmente dal male principale, la ‘Conoscenza’”. Per poi riscontrare che: “L’uomo non poteva che conoscere e soccombere. (..) Il mondo sotto l’assillo del desiderio smodato della conoscenza, era invecchiato prematuramente. (..) E mi sembra che persino il nostro senso per ciò che è forzato e innaturale, anche se assopito, avrebbe potuto fermare a questo punto la nostra corsa” – verso quella felicità, che l’autore sembra rincorrere e mai raggiungere, anche quando egli s’arresta al cospetto di Dio nel racconto “L’isola della fata”: “Mi riferisco alla felicità che si prova nella contemplazione dei paesaggi naturali (che gli vengono messi di fronte). In verità, l’uomo che vuole ammirare nel modo giusto la gloria di Dio sulla terra deve ammirare quella gloria in solitudine”. Per poi assicurarci che “..lo spazio, e perciò la massa, è un’importante considerazione agli occhi dell’Onnipotente. (..) Né il fatto che lo spazio sia infinito può negare che la massa sia un oggetto per Dio, poiché può darsi che ci sia un’omogeneità fra lo spazio e la materia che lo riempie. E dal momento che noi vediamo chiaramente che la vitalità di cui è dotata la materia è un principio, anzi a voler estendere il nostro giudizio, è il principio fondamentale dell’opera di Dio, mi sembra quasi illogico immaginare che sia limitato alle regioni dell’infinitamente piccolo, dove quotidianamente lo rintracciamo, e non si estenda a quelle dell’infinitamente grande.” Ma forse all’epoca di questo racconto la ‘purificazione’ doveva ancora avvenire e Poe non sembra qui andare alla ricerca di un riscatto che non arriverà: “Le parole sono cose vaghe (..) e l’uomo, come razza, per non estinguersi del tutto doveva ‘rinascere’ (..) e si trasformerebbe, alla fine, nell’uomo purificato dalla morte, dell’uomo il cui intelletto sublimato non sarebbe più avvelenato dalla conoscenza, dell’uomo redento, rigenerato, beato e immortale, ma pur sempre dell’uomo materiale” – afferma. Per poi andare incontro alla propria ‘morte spirituale’ dicendo: “Il dolore era poco, molto era il piacere. Ma nessun dolore o piacere era di natura morale” e il termine ‘purificazione’ qui usato fa riferimento alla radice greca ‘fuoco’, divoratore, la fine di tutto”. “Esiste uno e un solo evento che renda metaforico ogni altro impiego delle parole, l’evento che conferisce a quei termini il loro significato primario, originario, incontaminato e non diluito – avverte Zigmunt Bauman (*). Quell’evento è la ‘morte’. (..) La morte incute paura per via di quella sua qualità diversa da ogni altra: la qualità di rendere ogni altra qualità non più superabile. Ogni evento che conosciamo o di cui siamo a conoscenza – ogni evento, eccetto la morte – ha un passato e un futuro. Ogni evento – eccetto la morte – reca una promessa, scritta con inchiostro indelebile anche se a caratteri piccolissimi, secondo cui la vicenda «continua». (..) Soltanto la morte significa che d’ora in poi niente accadrà più, niente potrà accadere, niente che possa piacere o dispiacere. È per questa ragione che la ‘morte’ è destinata a restare incomprensibile a chi vive, e anzi non ha rivali quando si tratta di tracciare un limite realmente invalicabile per l’immaginazione umana. L’unica e la sola cosa che non possiamo e non potremo mai raffigurarci è un mondo che non contenga noi che ce lo raffiguriamo”. È dunque questa la vera leva su cui fa pressione l’autore dei presenti racconti e dei suoi romanzi più apprezzati: la ‘paura della morte’. Ecco che allora, per dirla ancora con Bauman, quella ‘materialità’ instabile che Poe prende qui a riferimento, si trasforma in ‘immaterialità liquida’ del suo e del nostro tempo. A voler dire che in fine nulla è cambiato, che la ‘rinascita’ dell’uomo è ancora sospesa nelle alte sfere di un ‘di là a divenire’ di cui non siamo che spettatori estatici e sgomenti. E così resteremo fino ai nostri giorni, irrimediabilmente, fatalmente, inevitabilmente. Ma a che cosa Poe fa riferimento in questi suoi “Viaggi Immaginari”, improbabili per quanto incredibili? – ci si chiede. E la risposta giunge immediata: ‘al sogno’, che non rinnega i suoi risvolti visionari, allucinati, deliranti, che lo tengono legato al vagheggiamento, alla brama utopica, alla chimerica bellezza, sinonimi specifici della visione onirica; e che lo proiettano nell’incubo ‘orrifico’ d’una bellezza illusoria, irraggiungibile, il cui splendore abbaglia la ‘realtà’, trasformandola in desiderio, speranza, aspirazione, fino allo stordimento, all’accettazione dell’irreale, del soprannaturale ch’è nel ‘profondo’ di ognuno di noi. Per cui le esplorazioni potrebbero non finire mai e, infatti, non finiscono mai e ‘l’immaginario’ di riferimento insito in questi racconti diventa la realtà di una scoperta affascinante che l’autore svolge all’interno di se stesso. “Allora questo non è un sogno..” – fa dire l’autore ad Eiros personaggio metafisico di un altro felice racconto intitolato “Conversazione di Eiros e Charmion” dal risvolto ‘mitologico’ che, come nei “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese e successivi di almeno un secolo, si narra di un ‘mistero racchiuso nel mistero della morte’. Per lo più derivati dalla fascinazione, tipica dell’epoca, del ‘mesmerismo’ di Franz Anton Mesmer, vissuto nel Settecento, che ne aveva elaborato la teoria basata sul ‘fluido’ magnetico (fisico) che, secondo le sue teorie era all’origine del corretto funzionamento del’organismo umano, in armonia con quello universale. Fascino che ritroviamo nel racconto “Rivelazione mesmerica”, presente in questa raccolta, in cui un soggetto ‘mesmerizzato’ in punto di morte descrive la vita nell’aldilà, parlando del regno delle ombre, e che Poe riprenderà in “La verità sul caso di Mr. Valdemar” che sarà di riferimento ricorrente nella sua produzione letteraria. Mitologia dell’aldilà, regno delle ombre, enigma e ‘suspense’ della vita, mistero dell’esistenza, non sono che mondi estremi di cui Poe scrive riciclando un modello poi divenuto ‘archetipo’ del romanzo ‘poliziesco’, del ‘giallo enigmatico’, dell’ ‘incompiuto gotico’ caratterizzato dal carattere ‘misterioso’ o ‘macabro’ delle vicende descritte, o meglio, verosimilmente ‘sognate’, in cui logora la propria breve vita. Sviluppatosi dopo la seconda metà del Settecento, il genere narrativo ‘romantico / orrifico’ era caratterizzato dall’unione di elementi romanzeschi della letteratura cosiddetta ‘gotica’, riferita alla tendenza culturale anglosassone di ambientazione tenebrosa del ‘romanzo nero’(noir), i cui temi portanti sono l’amore perduto, i conflitti interiori, il soprannaturale, il cui iniziatore è considerato Horace Walpole con il suo romanzo “Il Castello di Otranto” del 1764. Dopo H. Walpole, la cui influenza è inequivocabile negli scrittori polizieschi, e non solo, fin dalle origini, E. A. Poe si pone come diretto continuatore del genere, cui faranno seguito l’inglese R. L. Stevenson “Lo strano caso del dott. Jekyll e del signor Hyde” (1886), l’irlandese Bram Stoker “Dracula il vampiro” (1897), lo scozzese A. Conan Doyle, “Le avventure di Sherlock Holmes” (1892); gli americani Agatha Christie “Assassinio sull’Orient Express” (1934); e Rex Stout “Orchidee Nere” (1942), solo per citare i più noti, fino agli scrittori statunitensi H. P. Lovecraft “L’ombra venuta dal tempo” (1934) considerato il ‘Poe cosmico’, e Stephen King “Le notti di Salem” (1979), nei quali vi è un’esplicita metafora dell’eterna lotta tra bene e il male. “Che bisogno c’è, Charmion, di descriverti la scatenata frenesia del genere umano? – fa chiedere ancora l’autore ad Eiros – Ancora un altro giorno e il male non era ancora tutto su di noi. Era evidente, adesso, che sarebbe stato il suo nucleo a raggiungerci per primo. Si era verificato uno strano cambiamento tra gli uomini e il primo senso di dolore era stato il segnale terribile del lutto e dell’orrore universali”. Ecco l’altro punto critico dell’opera di Poe: “l’orrore universale”. Nel contesto ‘liquido-moderno’ innescato dal grande sociologo Z. Bauman (op.cit.), il pensiero metodologico rincorre la ‘paura’ e ne sviscera i numerosi aspetti: dalla sua origine (la paura della morte e la paura del male), alla dinamica d’uso (volontà e necessità della paura); dall’orrore dell’ingestibile (precarietà e insicurezza come derivati della paura), al terrore globale (problematicità e catastrofismo insiti nella paura): arrivando, nella sua efficace analisi, a proporci i ‘rimedi’ o, perlomeno, le precauzioni e i suggerimenti per affrontare quelle che sono le ‘paure’ più diffuse, che egli ritiene nate e alimentate dalla nostra costante insicurezza. “Desidero sostenere la mia ferma convinzione secondo cui l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa” – declama Franklin Delano Roosevelt, da cui si evidenzia che la ‘paura’ altro non è che: “Il pieno compimento, in tutti i suoi minuti e terribili particolari, delle profezie bibliche che minacciavano l’apocalisse del fuoco e della distruzione” – come la identifica Poe. Una paura per così dire ‘ancestrale’ che tutti noi ci portiamo dietro, fin da quando: “D’un tratto, ardeva in una specie di fiamma, per il cui abbagliante splendore e l’infuocato calore nemmeno gli Angeli nell’alto Cielo della pura conoscenza conoscono un nome”. “Molti viaggeranno, e la conoscenza ne sarà accresciuta” – scriveva il Profeta Daniele (circa 610 a.C.). Di fatto, l’importanza del ‘viaggiare’ di questi racconti restituisce al lettore quanto da me espresso in “Lo spirito del viaggio” (Etnomusica 10 su questo stesso sito), è di tipo antropologico, e pone in risalto alcune verità della ragione che valgono per ognuno di noi come per uno sdoppiamento della personalità, quel “dentro di me, fuori di me” che ci permette di confrontarci con ciò che ci sta attorno, e che ci procura quel ‘brivido di bellezza’ che a volte ci fa trasalire e che è all’origine dell’entusiasmo che releghiamo al ‘vivere insieme’. Quell’emozione momentanea e quindi passeggera che da un senso ai molti perché della vita, congiuntamente al nostro sistema neurobiologico, soggettivo, relazionale e culturale, che carica di importanti significati l’idea che abbiamo del ‘viaggio’. Aspetti questi che interagiscono e s’influenzano a vicenda, con la conseguenza che le emozioni costituiscono esperienze multiformi, anche conflittuali e ambigue, che attraversano tutto il nostro potenziale investigativo e che ci spingono alla crescita culturale e all’evoluzione conoscitiva. Ma andiamo, dunque, alla scoperta dei diversi significati del ‘viaggio’, abbandonandoci però a quello che ‘lo spirito’ in libertà d’azione ci riserva, e cioè di quella ‘musica’ che pur sentiamo ‘dentro e attorno a noi’ come un richiamo, senza chiederci il perché del suo fluttuare nell’universo sonoro che ci circonda, e che infine ci permette di comprendere e utilizzare al meglio la nostra esistenza, tra ‘l’essere e il divenire’, di quei viaggiatori instancabili che in fondo noi siamo. Perché, ammettiamolo, il ‘richiamo del viaggio’, sia esso ‘sogno’ o ‘allucinazione’ in cui si confonde “..il piacere che deriva dalla dolcezza dei suoni con la capacità di crearli” è innegabilmente affascinante e rigenerante. Poe lo sa, e si lascia abbindolare dal’richiamo’ della musica nell’insuperato racconto “L’isola della fata”: “La musica, infatti, più di ogni altra attitudine, è in grado di dare completo godimento per i suoi vantaggi spirituali, ma c’è un godimento che si trova sempre alla portata degli sconsolati mortali, ed è forse l’unico che ha bisogno del sentimento accessorio della solitudine.” Ed è a ciò cui io recensore faccio costantemente appello, quello che lega la letteratura alla musica, al sogno, all’illusione del viaggiare ‘in questo e in altri mondi’, il piacere sottile che viene dallo ‘spirito’ che finalmente liberato dagli orpelli del quotidiano, si libra ‘in solitudine’ e inizia a volare. Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849) fu uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore, storyteller e saggista statunitense, inventore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico, finisce per diventare anche uno dei rappresentanti maggiori del racconto nero e dell’orrore in genere. La sua stessa morte presenta più di un enigma. Il 3 ottobre 1849 lo scrittore fu ritrovato delirante nelle strade di Baltimora, "in grande difficoltà, e bisognoso di immediata assistenza", secondo l'uomo che lo trovò, Joseph W. Walker, fu portato all'ospedale Washington College, dove morì domenica 7 ottobre 1849, alle cinque del mattino. Poe non rimase mai sufficientemente lucido per spiegare come si fosse trovato in tali gravi condizioni, né come mai indossasse vestiti che non erano i propri. Alcune fonti affermano che le ultime parole di Poe furono «Signore aiuta la mia povera anima.» Tutti i referti medici, compreso il suo certificato di morte, sono andati perduti. I giornali dell'epoca attribuirono la morte dello scrittore a una "congestione del cervello" o "infiammazione cerebrale", eufemismi comuni per le morti dovute a cause disdicevoli come l'alcolismo. L'effettiva causa della morte rimane comunque un mistero; alcune ipotesi comprendono delirium tremens, epilessia, sifilide, meningite e rabbia. Come affermato poi dal cardiologo dell'University of Maryland Medical Center, R. Micheal Benitez nella sua relazione pubblicata nel settembre 1996: "Non si può dire con certezza che la rabbia fu causa della sua morte dal momento in cui non ci fu un'autopsia, tuttavia questa è l'ipotesi da considerare più veritiera in quanto deliri, tremori, allucinazioni e stati confusionali, sintomi tipici della rabbia, non possono essere spiegati con l'abuso di alcool poiché Poe smise di assumere queste sostanze sei mesi prima del ricovero in ospedale. (*)Zigmunt Bauman "Paura liquida" in Laterza 2008.
Id: 754 Data: 01/11/2013 12:00:00
*
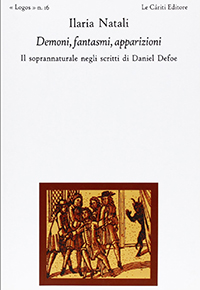 Ilaria Natali - Saggio - Le Cáriti Editore
Ilaria Natali - Saggio - Le Cáriti Editore
Demoni, fantasmi, apparizioni
Tradizione e memoria culturale si coniugano in questo libro di Ilaria Natali dedicato al ‘soprannaturale negli scritti di Daniel Defoe’, scrittore inglese vissuto nel XVIII secolo, la cui trattazione trova il proprio peculiare interesse nel proporci alcuni scritti poco conosciuti (alcuni tradotti per la prima volta in italiano) e, nel riproporci quelle che furono le tendenze letterarie e teoriche di un’epoca, il Settecento, definito il secolo «dei lumi della ragione», detto anche dell’ ‘Illuminismo’. Questo lo sfondo, tuttavia, prima di parlare di questo libro, permettetemi di spendere qualche parola su Daniel Defoe e il XVIII secolo in cui egli visse ed operò. Un secolo di grandi trasformazioni formative, di innovazioni sociali ed economiche, dell’avanzamento tecnologico in generale, nel progresso culturale dei popoli, in cui si decuplicò la crescita dell'alfabetizzazione, nacquero le prime istituzioni laiche che si prefiggevano lo scopo di diffondere la formazione intellettuale e la scienza, e che determinò il conseguente mutamento della condizione culturale e il formarsi di una cultura al passo con i tempi. Di fatto la nuova cultura formatasi in Inghilterra e in Francia poi diffusasi in gran parte dell'Europa, fu caratterizzata da una nuova fede, quella nella ragione e nel potere illuminante della conoscenza, proponendo una concezione laica della vita. Basato sui principi d'uguaglianza e di libertà di tutti gli uomini l' ‘Illuminismo’ portò cambiamenti in vari campi, abbandonando l'idea radicale della storia tracciata dalla Provvidenza di Dio. Sebbene la Chiesa cattolica fosse vista come la principale responsabile della sottomissione della ragione umana nel passato, e la religione in generale fosse indicata come causa della superstizione e dell'ignoranza, l'Illuminismo non fu un movimento anti-religioso e si schierò contro ogni forma di fanatismo lottando in favore della tolleranza, cioè della possibilità per chiunque di professare liberamente la propria fede. Nato a Londra nel 1660, Daniel Defoe (*) morì a Moorfields, nei pressi di Londra nel 1731. Indicato come il padre del romanzo inglese, fondò la rivista The Review, destinata a durare dieci anni e diventare una pietra miliare nella storia del giornalismo. Quasi tutti gli articoli erano dello stesso Defoe, che, pur dichiarandosi indipendente, in realtà aveva un accordo con il primo ministro Robert Harley, che gli aveva promesso l'amnistia per vecchi fatti di bancarotta in cui era coinvolto. In ogni caso, l'opera giornalistica di Defoe fu pionieristica; si ritiene che egli abbia in pratica fondato il giornalismo tabloid. Come giornalista, in realtà lavorò attivamente con lo scopo di convincere il Parlamento scozzese ad accettare l'Atto di Unione con il Parlamento inglese, poi stipulato nel 1707. Nel 1714, sempre lavorando sotto mentite spoglie per il governo, riuscì a entrare nella redazione di un settimanale giacobita. Scoperto sei anni dopo, si vide costretto a porre fine alla sua attività di giornalista. Nel frattempo, dopo l’evento Moll Flanders (pubblicato nel 1722) e considerato la sua prima grande opera letteraria, aveva continuato a scrivere romanzi; nel 1715 pubblicò The Family Instructor, e nel 1718 quello che sarebbe diventato il suo più celebre romanzo, Robinson Crusoe. Subito dopo, scrisse due romanzi sequel di Robinson Crusoe: Ulteriori avventure di Robinson Crusoe e Riflessioni serie di Robinson Crusoe. A Robinson Crusoe seguirono numerose opere minori, incluse diverse false autobiografie (di famosi criminali o di altri personaggi pubblici, come nel caso della cortigiana "pentita", Lady Roxana) e una quantità di romanzi (tra gli altri, Memorie di un cavaliere, Il capitano Singleton, Il colonnello Jack e La peste di Londra). Defoe non era in realtà interessato a creare o sviluppare il romanzo a fini letterari. Egli era soprattutto un giornalista e un saggista, ma anche un professionista della penna pronto a mettere il suo considerevole talento al servizio del miglior offerente. È senz'altro significativo il fatto che prima di dedicarsi al romanzo, buona parte della vita di Defoe fosse già trascorsa: quando scrisse il suo capolavoro, il Robinson, aveva già 58 anni. Inoltre, pubblicò i suoi romanzi cercando, in generale, di farli passare per storie vere (memoriali e autobiografie) per renderli più appetibili al pubblico dell'epoca (non si deve dimenticare che il motivo principale per cui Defoe scriveva era, a quanto pare, la necessità di pagare i propri debiti). La messa in scena ebbe successo, e solo molto tempo dopo la pubblicazione si comprese che i libri di Defoe mescolavano fatti veri (nel Robinson Crusoe la storia del marinaio Alexander Selkirk) con dosi generose di invenzione letteraria. La miscela di realtà e finzione, attendibilità e sensazionalismo, propositi edificanti e gusto del racconto a fine d'intrattenimento costituiscono nella scrittura di Defoe quel genere intimamente ibrido che è il romanzo moderno. Starà poi ad altri, successivi scrittori di diversi paesi sfruttarne le potenzialità; ma di certo la prima sintesi narrativa funzionante (prova ne è il successo di cui ancora godono oggi questi libri) è stato l'astuto e "disonesto" Daniel Defoe. Ma perché di un ritorno oggi al ‘soprannaturale’ e perché proprio Defoe? L’ampia materia letteraria di cui si compone questo libro è stata trattata in passato da eruditi con migliaia di volumi, discussa e analizzata, o meglio ‘eviscerata’ dall’involucro di quella Magia Bianca cui essa è di riferimento, e che sempre viene occultata a più riprese ma che, non ha mai smesso di esercitare la sua forte presenza ed essere visitata da milioni di persone in tutto il mondo, anche a loro/nostra insaputa, e tale da interessare anche chi non ha mai approfondito un certo ordine di studi. Ad essa, oggi, non si fa più riferimento, tuttavia è simbolo della ‘materia dei sensi’ costitutivi la natura umana. Il riferimento apre a quella parte dell’ ‘inconscio’ (Jung, Freud e altri), insito del nostro ‘Io’ interiore: “..fra la carne che trascina in basso incatenando alla terra lo spirito che solleva e spinge in alto; fra la ragione che pretende di spiegare i fenomeni della vita e della morte; fra il dubbio che annienta e deprime e la fede che esalta; fra l’odio che distrugge e l’amore che crea, l’amore, principio e fine dell’Universo” – (cfr. Jean d’Essigny (**), prof. di decrittazione medioevale e dei segreti della magia pentacolare), e materia di questo libro in particolare. Poiché non mi è possibile esprimere un giudizio neutrale intorno all’operato di una ricercatrice, quale dimostra d’essere Ilaria Natali, che scava nel profondo filologico dei testi, mi limito a spostare l’obiettivo da una vera e propria recensione, nell’opportuna circostanza di semplice notazione. Per le ovvie ragioni che l’autrice non pone qui una ‘tesi’, bensì si limita a veicolare il lettore attraverso le interiorità letterarie di una materia molto discussa e che prende origine dalla ‘tradizione orale’ secolare, se non addirittura millenaria (satanisti, manichei e altri); la cui ‘entità’ è d’appartenenza a quel ‘mondo sensibile’ ed ‘estremo’ che sfocia nel ‘soprannaturale’, ivi annessi quei sinonimi e contrari che la ‘tradizione’ accoglie in sé. Scrive Henry Bourne (ecclesiastico citato dall’autrice del libro): “Non c’è niente di più comune nelle località di campagna di una famiglia che si raduna attorno al focolare in una sera d’inverno a raccontare storie di apparizioni e di fantasmi. Niente da obiettare; ma questo accresce la naturale pavidità umana, e spesso fa sì che queste persone immaginino di vedere cose che appartengono solamente alla loro fantasia”. Apparentemente, era anche ritenuto legittimo che il mondo dell’occulto fosse rappresentato in determinati generi letterari, come osservato da P. M. Spacks (citato dall’autrice): “Sebbene nel diciottesimo secolo gli atteggiamenti nei confronti della realtà del soprannaturale fossero variegati e spesso ambigui, anche i critici più razionali generalmente ritenevano che i personaggi soprannaturali avessero un posto legittimo nel testo poetico e teatrale”. Pertanto, possiamo qui parlare di sovrumano, trascendente, prodigioso, miracoloso e, soprattutto, di spirituale, mistico, ascetico, inerenti a un ‘mondo estremo’ (al di là, paradiso, inferno ecc.), ultimo, finale, grandissimo, luminosissimo cui fanno riferimento le religioni dei popoli abitatori di questo mondo che anelano ad esso, e con le dovute ripercussioni socio-politiche, economiche ed etiche, che ne condizionano la sopravvivenza. Al giorno d’oggi, e ne siamo tutti pressoché coscienti, regna una strana mescolanza di volgarità e raffinatezza, di avarizia e liberalità, di crudeltà e di valore, di mollezza e di energia, di oppressione e prevaricazione che favoriscono, da un lato un ritorno al ‘naturale’ (terreno, umano, magico ecc.); dall’altro un’ulteriore spinta verso il ‘soprannaturale’ o sovrumano (contemplativo, religioso e mistico), che sfocia nello straordinario, nel sublime, ecc. L’autrice, Ilaria Natali, dà risalto a un aspetto più di altri che, invero, spoglia i testi da lei oculatamente analizzati e li riveste di ‘attualità’, quella stessa che deve aver spinto Defoe al recupero (non propriamente integrale della tradizione), ai fini di un ritorno alla ‘fede religiosa’ cosiddetta ‘moralizzante’. Sebbene la ‘morale’ non fosse lo scopo principale dello scrittore, il suo operato è di tipo ‘moralistico’, semplicemente perché li restituisce a una ‘consuetudine’ e a una indubbia ‘moda’ letteraria tipica del secolo che l’ha prodotta (gothic, horror, fantasy, fiction) ed entrata nel quotidiano svolgersi della vita. Certe ‘cose’ esistevano perché esistevano e perché nessuno le aveva mai messe in discussione: “Con le nostre fantasie diamo forma a tante apparizioni quante ne vediamo realmente con i nostri occhi, e molte di più (...). Ma da ciò non consegue che non ci siano cose di questo genere in natura; che non ci sia rapporto o comunicazione tra il mondo degli spiriti e quello in cui viviamo, (...) che gli abitanti delle sfere invisibili non si prendano mai la libertà di fermarsi quaggiù sul globo terrestre, o di far visita ai loro amici (...). La domanda, a mio parere, non è se gli spiriti vengano veramente tra di noi o no, ma: chi sono quelli che vengono?” – così scrive D. Defoe e che l’autrice Ilaria Natali ha tradotto per noi, spiegando, nelle note al testo il modo in cui ha operato: “Nel corso della trattazione, ho definito genericamente gli ‘esempi’ inclusi nelle opere occulte di Defoe con i termini ‘storie’, ‘racconti’, o ‘resoconti’. Queste definizioni possono apparire problematiche, poiché lo statuto del testo è spesso ambiguo: non è presentato come fiction, ma come relazione di un evento, o episodio reale. La ben nota dialettica che caratterizza il rapporto tra ‘cronaca’ e ‘fiction’ nella prima metà del Settecento interessa in modo particolare gli scritti di Defoe e ha portato alcuni studiosi, quali Mayer e Kincade, a mettere in dubbio che le sue opere possano essere definite fittizie. Tuttavia, come nota Ian Watt, «l’aspetto di totale autenticità (...) autorizza (...) confusioni», poiché la «trascrizione della realtà» può essere considerata, in questi casi, una convenzione letteraria. Alla luce di queste osservazioni, ritengo sia lecito attribuire natura fittizia anche a questi testi, presentati come verità documentarie solamente come strategia alternativa”. Fino a prova contraria, spiegano i testi più antichi: “Dove c’è Dio, c’è il Diavolo. Chi crede in Dio crede nel Diavolo. Chi è scontento di Dio e non ha né rassegnazione né paura, si rivolge al Diavolo” (cfr. aut. cit.). Da cui i differenti aspetti (coloristici) della Magia: bianca, rossa, nera. Quella che qui rientra nel nostro interesse e, in primis, in quello dell’autrice è tuttavia la Magia Bianca perché contiene quelle ‘verità’ (praticate anche dalla chiesa cattolica) “..consistenti nel cercare Dio e il suo incontro fatto di Parola, Grazia, Comunione, che insegnano a vivere” (cfr. aut. cit.). Acciò è fatto riferimento in alcuni famosi testi esoterici, per cui il ‘rituale evocatorio’ è parte integrante della Magia Bianca: “Chi utilizza questo rituale, (cfr. aut. cit.), solitamente opera per il bene del suo prossimo ed è indotto a entrare nei pensieri e nei sentimenti cristiani e trovare il segreto dell’amore che non è tesoro umano, ma divino. La scienza sacra della vera magia, quella che aiuta e protegge, si serve del segno della Croce, segno di Redenzione e adopera la Croce, simbolo elevato e le preghiere che aiutano in ogni momento della vita, favoriscono le naturali inclinazioni e possono portare a una evoluzione spirituale”. Troviamo dunque ‘riti amatori per i defunti’; ‘rituali evocatori amorosi per i vivi’; ‘esperimenti di magia amatoria’; inoltre a ‘preghiere per la buona salute fisica e psichica’; ‘rituali per l’accrescimento dell’energia interiore’ e numerosi altri da usare a fin di bene per ottenere protezione, amore, fortuna. Al contrario, in questo nostro mondo frenetico e inquieto in cui tutti vorrebbero primeggiare, molti altri riti iniziatici e settari, in numero soverchiante, sono rivolti ai poteri della mente, i cosiddetti ‘rituali neri’, coi loro infami rituali di sangue che si espongono al male. Ma non di questo ci occupiamo in questa trattazione. È lo stesso Defoe a mettere in discussione quanto da lui stesso affermato in prima istanza, trasferendo il tutto in una ricusazione che ha il sapore del pentimento: “Credo (e non penso o sono del parere), che con le nostre fantasie diamo forma a tante apparizioni quante ne vediamo realmente con i nostri occhi (e anche con le orecchie) nell’inganno, e ci convincono a credere (certezza di plagio), di vedere spettri e apparizioni, e di udire rumori e voci, quando, in realtà (quindi non artificio né fiction), né il Diavolo né altri spiriti (soggetti fittizi), maligni o benigni (accettazione del bene e del male), si son presi alcun incomodo per noi (o almeno nessuno è tornato indietro a dirlo). Ma da ciò non consegue che non ci siano ‘cose’ di questo genere in natura”. “Lo spettro di Defoe – scrive ancora l’autrice – può essere inteso come un’entità ambigua che oscilla tra il messaggio divino e la proiezione interiore: come si vedrà dall’analisi dei testi (inclusa nel libro qui preso in considerazione), spesso è difficile individuare il confine tra l’attività (oggettiva) di una presenza esterna e quella della mente (onirica), o della coscienza (della morale) umana. Tant’è, ad esempio, che Defoe impiega per definire le entità spiritiche, sembra essere attentamente studiata. Il termine «ghost» (anima, spirito) è usato solo raramente; sono molto più diffusi in alcuni casi «genius» (spirito tutelare) o «daemon» (spirito incorporeo, manifestazione demoniaca), ancor più «apparition» (anime trapassate), etimologicamente legato all’Epifania (lo stesso della rivelazione di Cristo ai Magi), attestato nel significato di «fantasma» dal 1601”. Come già J. Swift e O. Goldsmith, anche D. Defoe si lasciò coinvolgere dal ‘mistero’ di grande attualità, che rileggeva e rielaborava – avverte ancora l’autrice: lasciando in sospeso le problematiche suscitate dai singoli casi e, forse per non andare ‘contro i principi della dottrina cristiana’, spesso sostiene che: “..tutti gli spiriti di cui si può parlare, o di cui si crede di vedere l’apparizione, devono essere uno di quelli elencati, devono essere un angelo o un diavolo, non ve ne sono altri, non ve ne possono essere altri”. Una sorta di ritrattazione? No. Nei due sottocapitoli che compongono il capitolo primario intitolato “Il corpo e l’anima”, l’autrice spiega come il ‘retelling’ defoliano si appropri della tradizione e della memoria culturale selezionando il materiale narrativo che, trasformato e distorto, implica una modificazione delle storie narrate, per così dire ‘rinnovate’, perché inserite in un contesto diverso dal ‘modello originale’ che, in certi casi, determinano sostanziali cambiamenti di senso. Così come in “il mutamento nella dialettica tra fact e fiction” l’autrice si espone nel dibattito critico, tutt’ora in atto, all’interno del quale «la dialettica tra ‘fatto’ e ‘finzione’ è caratterizzata non solo dalla ‘contaminazione’ di eventi fittizi e reali, ma anche da un’attenta gestione di testimonianze, autore, narratore, personaggi e lettore ideale». Se ne può dedurre che alla base delle storie narrate sia soprattutto la trasmissione di un messaggio fondamentale, religioso o filosofico, una sorta di ‘morale’ che non è intaccata da un intento per così dire ‘educativo’ posto al centro del soprannaturale. Non è forse questa la ‘funzione’ primaria della Tradizione? Lo scopo del suo rinnovarsi costante? Farsi strumento partecipe della Storia degli umani? Del perché continuiamo a voler essere protagonisti del segreto più grande che sia dato, e che ha nome ‘vita’ o forse ‘morte’, e che per questo chiediamo, imprechiamo, preghiamo un Dio misterioso e ignoto, che possiamo soltanto immaginare benevolo? Come a suo tempo scrisse Pirandello (***) parlando con Diogene: “...ma è assolutamente arbitrario il negare che tali disposizioni (umane) non esistessero o non potessero esistere. (...) A buon conto nulla v’è di più serio nel ridicolo e di più ridicolo nel serio. (...) Diverso il pianto, secondo questa critica, e diverso naturalmente anche il riso degli antichi”. C’è molto di tutto questo e altro ancora nella trattazione di Ilaria Natali che il breve spazio di una recensione non richiede di approfondire ma che il lettore attento saprà cogliere dietro l’arcano mondo estremo (e quindi occulto) di questo libro tuttavia stupefacente, ancorché temibile (orrifico) e indimenticabile (come lo sono ‘L’inferno’ di Dante, o il ‘Faust’ di Goethe), certo di trovare segnali e illuminazioni per continuare da solo una ricerca esaltante. Note: (*) Daniel Defoe, ‘L’opera completa’ – Meridiani Mondadori (**) Jean d’Essigny, cfr. in (***) Luigi Pirandello, ‘L’umorismo’ – Oscar Mondadori
Id: 747 Data: 22/11/2013 12:00:00
*
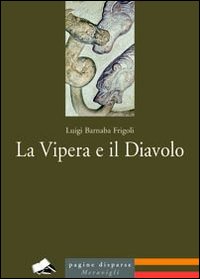 Luigi Barnaba Frigoli - Narrativa - Meravigli Edizioni
Luigi Barnaba Frigoli - Narrativa - Meravigli Edizioni
La Vipera e il Diavolo
“La Vipera e il Diavolo” - Edizioni Meravigli 2013 Se volessimo perseguire una, tra le molte chiavi di lettura di questo ‘romanzo storico’ (oggi diremmo di fiction), ambientato nel Medioevo alla fine del ’300 e riferito alla dinastia dei Visconti, in cui si narra lo scontro, senza esclusione di colpi, tra lo spietato tiranno Bernabò e lo scaltro Gian Galeazzo, suo nipote, per la conquista del trono di Milano, certamente finiremmo per soffermarci (per ovvio piacere della lettura), alla manierata immagine in cui Gian Galeazzo: “Fermo sul sagrato, si fregò la barbetta appuntita, richiamando alla mente i versi di Giacomo da Lentini: «Meravigliosamente un amor mi distringe …» ”. A voler sottolineare, per così dire, quel sentimento che, posto in chiusura del delizioso capitolo dedicato all’ ‘amor cortese’, narra dell’improvvisa infatuazione del giovane nipote per sua cugina Caterina, figlia di Isabella e Bernabò Visconti. L’avverbio, in incipit al ‘sonetto’, (che si vuole inventato dallo stesso G. da Lentini), è tipico della produzione letteraria della Scuola Poetica Siciliana, improntata, quasi esclusivamente, sulla poesia d’amore che verosimilmente veniva ‘cantata’ o quantomeno ‘intonata’ dai cantastorie girovaghi per le Corti d’Europa, dedicata, con tecniche di linguaggio spesso sofisticate, alla ‘dama / donna / madonna del castello’ in epoca feudale. Tuttavia il tema ‘amoroso’ che pure ricorre qua e là nel romanzo, e che ritroviamo in quasi tutte le ‘biografie’ della grandi famiglie (Borgia, Gonzaga, Sorza, solo per citarne alcune), tale da far pensare sia la causa del loro disfacimento, non è affatto quello dominante. Ben altri temi lo sovrastano e va detto che i signori viscontei non sono da meno degli altri negli intrighi di corte, tantomeno sono avulsi dalla caparbia sete di potere che li trasforma in strenui oppositori del Papato che ne contrasta l’operato, soprattutto l’estensione geografica dei loro possedimenti. La produzione letteraria, fin qui molto esigua sui Visconti di Milano, ce ne dà un’immagine che assume conoscenza di cronaca, di fatti feudali legati più a spartizioni familiari e intrighi di corte, eresie e scomuniche che non illuminano i cosiddetti ‘secoli bui’ della storiografia italiana se non, per quel gusto che hanno certi storiografi d’incedere nei ‘misfatti’ (leggi scelleratezze e nefandezze oltre che agli abusi di potere) rintracciabili in tutte le epoche e in tutte le ‘società’ dall’antichità al medioevo ad oggi. A differenza d’altri, in questo libro, l’autore aggiunge però alcunché che lo distingue, per dire di una qualche cosa che fa la ‘diversità’, inquadrando la ‘storia’ in ambito quotidiano e popolare con riferimenti presi sia dalle cronache storico-letterarie, sia dalla memoria più o meno ‘orale’ delle leggende e dei racconti folcloristico – tradizionali. E non è poco, se si pensa che molto spesso ciò che definiamo ‘storia’ è credibilmente ripresa dalla tradizione orale dei popoli che l’hanno ‘reinterpretata’, verosimilmente da coloro che l’hanno vissuta e trasmessa alle generazioni successive al periodo storico in cui (la storia) si è verificata. Una doppia lettura quindi che man mano si arricchisce di aneddoti cruenti e talvolta succulenti, che si colora di sentimenti anche contrastanti, che più spesso sollecita la nostra curiosità verso un progressivo avanzamento all’interno della conoscenza di un’epoca (tristemente ritenuta buia) e tuttavia illuminata da strali luminosissimi di eccezionalità: si pensi ai nostri scrittori e poeti di laudi e sonetti amorosi, allo svilupparsi delle arti che anticipano il Rinascimento italiano, alle consuetudini religiose, al flagello dell’eresia, all’inquisizione. E perché no ai condottieri, ai prezzolati avvocati e banchieri, al potere dei Signori feudali, al dominio spirituale della Chiesa di Roma e dei suoi Papi, ma anche a quei predicatori che attraversavano l’allora nascente Europa inveendo contro l’arroganza e gli abusi dei suoi governanti. Si pensi alla ‘stregoneria’, alle ‘danze macabre’, all’esistenza spaventosa del ‘diavolo’, alla ‘magia’ e all’alchimia capaci di sconvolgere la mente e l’esistenza dei potenti della terra e che daranno luogo alle nefaste liturgie settarie, ai ‘roghi’, prevenendo con molto anticipo quelli che saranno gli ‘scismi’ e le guerre di religione. E ancora, per non chiudere il cerchio in chiave di negazionismo, vanno ricordati i grandi maestri dei ‘cicli’ pittorici, che sempre in quegli anni illustravano, decoravano, scolpivano, costruivano i fondamenti dell’arte; quella stessa che dalle nostre città si spalancava al mondo intero e della quale dovremmo (al contrario di quanto succede oggi) andare orgogliosi. Non è un caso che l’autore del romanzo-cronaca-fiction ci regala un’immagine strepitosa di quella che sarà la costruzione ‘immaginifica’ e superba della principale costruzione dell’allora Mediolanum, il grandioso Duomo a compimento di un ciclo di ‘cattedrali bianche’ che invero, malgrado gli accadimenti accorsi ai loro ‘sponsor’, ancora oggi imperlano il Nord Italia a testimonianza del grande impegno economico-culturale di un potere che puntava ‘non solo allo scettro ma anche alla gloria eterna’. L’autore, riprendendo una leggenda diffusa, narra che Gian Galeazzo Visconti decise di fondare il Duomo di Milano dopo aver sognato il Diavolo. Egli però, non chiarisce quale demonio gli si sia presentato in sogno per tormentarlo al punto da spingerlo a esorcizzarlo attraverso l’edificazione della più famosa e maestosa cattedrale del mondo. È andato da sé, dunque, che a turbare i sonni del futuro duca di Lombardia sia stato Belzebù. Ma se, invece, non fosse stato Satana, re degli inferi, a terrorizzare il sovrano? Se fosse stato, ad esempio, il suo più acerrimo nemico? Ovvero, Bernabò Visconti. Il fratello di suo padre Galeazzo II, che, esattamente un anno prima dell’inizio della costruzione del Duomo (il 6 maggio 1385), lo stesso Gian Galeazzo aveva fatto arrestare, con un tranello in piena regola, e rinchiudere nel castello di Trezzo sull’Adda, per poi, si dice, avvelenarlo. Fin qui la ‘cornice’, ma veniamo alla ‘tela’ e successivamente alla buia ‘parete’ che sostiene la storia. «Siamo a Milano, seconda metà del Trecento. Un solo trono, due pretendenti: Gian Galeazzo, ambizioso, scaltro e risoluto rampollo della famiglia Visconti, e Bernabò, suo zio, il terribile e spietato ammazza preti e fustigatore del popolo, entrambi pronti a tutto per conquistare il potere, indiscusso e totale. Le cronache dell’epoca descrivono Bernabò, che governò su Milano dalla metà del XIV secolo, come un despota feroce e vendicativo tiranno, assetato di potere. Un Diavolo, appunto, che, sempre secondo la leggenda, eliminò il fratello, padre di Gian Galeazzo, dando il via a una vera e propria sfida per lo scettro lombardo. (..) Una rivalità destinata a diventare scontro senza esclusione di colpi, tra congiure e intrighi, esecuzioni e duelli, incantesimi e tradimenti, invidia e sangue, amore e odio. Trame oscure scandite da antiche leggende intessute nell'ombra. (..) La resa dei conti, tra ‘Vipera e Diavolo’ (da cui il titolo del romanzo), non tarderà ad arrivare. E sarà per la vita o per la morte. In palio, oltre allo scettro, la gloria imperitura, o l'eterna dannazione. La fine della guerra fratricida è nota: fu Gian Galeazzo a trionfare, lo dice la storiografia. Ma in che modo? E a che prezzo? Non è chiaro, ma a ben dire il senso della vittoria si basa su un motto: "… convinci il mondo che non stai spodestando un parente rivale, bensì liberando la cristianità da una piaga. Da usurpatore diventerai messia …".» Altro aspetto accattivante lo si riscontra nella ricostruzione ‘virtuale’ dei dialoghi che intercorrono fra i personaggi storici e quelli letterari re-inventati all’uopo dall’autore, restituiti cioè a una scrittura attenta e concisa di quello che doveva (o poteva) essere il linguaggio dell’epoca, scarno e manchevole di aggettivazioni, (certamente meno di quelli che io stesso utilizzo in questa recensione), e tuttavia farcito dalle contaminazioni del ‘volgare’ del parlato quotidiano, sul ‘latino’ di uso ecclesiastico in uso fin oltre il medioevo. Il latino, va qui detto, era comunque la lingua della ‘cultura’ dell’epoca, per così dire dei regnanti, dei letterati, degli speziali e ovviamente del Cristianesimo ufficiale, più o meno come è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Da cui la struttura ontologica del linguaggio utilizzato, sebbene lontano da certi formalismi neoplatonici, aiuta il lettore a fondersi tutt’uno con il ‘tempo’ di cui narra la storia. Riscopriamo così molti ‘nomi propri’ in uso all’epoca come, ad esempio, quelli delle armi e delle armature utilizzate nei duelli, di palafrenieri e istruttori di equitazione, di oggetti d’uso comune, di manieri e castelli, di carceri e metodi di tortura, nonché di artifici ‘magici’ e successivi roghi di streghe, di alchimisti e aromatari (erboristi) che, coi loro ‘veleni’ risolvevano talvolta le diatribe dei potenti. Di non poca rilevanza l’aspetto ‘metafisico’ di tutta la vicenda narrata, incorsa alla famiglia Visconti, da cui il ripetersi di eventi peculiari all’umanità da quando questa viene raccontata in tutte le sue sfumature e nella sua atroce realtà. Se ci immergiamo per un istante in quelli che sono gli eventi accorsi nella Storia fin dai suoi albori, riscontriamo che l’avidità del potere, la smania di possedere, la stoltezza degli ottusi, da sempre crea mostri di cupidigia all’interno di ‘faide’ familiari, le cui vicende ‘personali’ talvolta, hanno stravolto l’esistenza di antichi popoli, coinvolgendo regni e nazioni. Questa, purtroppo la buia ‘parete’ che sostiene il quadro della storia che, nel bene e nel male, ci accomuna alla stragrande anomalia che perseguita l’umanità. La tela presenta una trama di ‘tragedia’ in corso dai tempi di Omero fino a Shakespeare, da Tolstoj a Tommasi di Lampedusa e oltre fino ai giorni nostri, in cui i dissapori e la discordia tra gli uni e gli altri, aumentano di generazione in generazione, e sembra che non possiamo farci niente, anche se ci accorgiamo che a scrostare il vello di muffa dell’inettitudine con cui abbiamo ricoperto la ‘parete’ della storia, viene giù l’intonaco e a nulla è servito aver ricoperte le malefatte con cui l’abbiamo innalzata. Il tempo della ‘tragedia’ è sempre presente ieri come oggi – sembra dire l’autore del romanzo, e l’aver riportato (riletto) alla luce dei giorni nostri un così funesto passato possa essere di futuro impedimento a ché ciò si ripeta nel tempo. Anche se oggi assistiamo a un capovolgimento della situazione tragica (di un Vincenzo Monti ad esempio) quando la tragedia classica rivelava una sua ‘sacralità’ di fondo che riscattava l’empio misfatto della storia: "Libertà che stolta / in Dio medesmo l'empie mani adopra". L’incipit del romanzo è folgorante: «Bartolomeo, in che guaio ti sei andato a ficcare!» cui risponde uno scrittore del tempo, certo Franco Sacchetti: «Credi tu sempre, maledetta serpe, regnar vivendo pur de l’altrui sangue, a tutti velenoso tarlo? Tu se’ iniqua e maligna sterpe; chi più ti serve, più doglioso langue.» Ed ancora l’autore avverte: “Tutti gli aneddoti inseriti in corsivo nel romanzo, così come molti degli elementi narrativi che ne compongono la trama, sono liberamente ispirati a novelle originali incentrate sulla figura di Bernabç Visconti, signore di Milano. Si tratta di leggende diffuse tra il popolo lombardo e toscano sin dalla seconda metà del XIV secolo, giunte fino a noi drazie a cronisti e autori minori attivi tra la fine del Trecento e l’inizio del Cinquecento. Un patrimonio letterario pressoché sconosciuto e, per questo, da riscoprire. “La vipera e il Diavolo” è il primo romanzo di Luigi Barnaba Frigoli, giornalista, ex redattore di Cernusco in Folio, che ha deciso di tentare la difficile avventura di scrittore. Nato a Milano si è laureato in Lettere Moderne sulla Storia economica e sociale del Medioevo.
Id: 742 Data: 11/10/2013 12:00:00
*
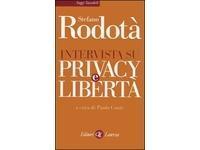 Stefano Rodotà - Paolo Conti - Saggio - Editori Laterza
Stefano Rodotà - Paolo Conti - Saggio - Editori Laterza
Intervista su Privacy e Libertà
Quando nel 1927 Fritz Lang produsse la pellicola “Metropolis”, uno dei capolavori del cinema espressionista, forse non pensava di poter dire così tante cose attraverso le sole immagini. Infatti il film ‘muto’, per quanto potesse dire o voler dire, riusciva a entusiasmare in quanto tale. All’epoca non tutti avrebbero saputo leggere le didascalie, vigeva ancora molto analfabetismo. Tuttavia i sintomi del malessere generale che colpiva le classi meno abbienti dei lavoratori c’erano già tutti e, in un certo senso, il film si rivelò profetico per le generazioni che seguirono. Da un certo punto di vista tecnico, il film è universalmente riconosciuto come modello di gran parte del cinema di fantascienza che ne seguirà, fino ai giorni nostri. Un film all’avanguardia del suo tempo, che mostrava come l’avanzamento tecnologico poteva essere utilizzato dai potenti per dominare l’intera umanità (nel caso specifico la città), ma che al tempo stesso poteva diventare un’arma al servizio dei lavoratori sfruttati come schiavi nei sotterranei della megalopoli. Metropolis è difatti una prova di gigantismo visivo senza pari che vive di un sincretismo debordante che, nonostante lo scoperto approccio interdisciplinare, riesce a garantire un'intrinseca ed irripetibile unitarietà narrativa. Ma non siamo qui per parlare di cinema quanto invece dell’aspetto più ‘sensazionale’ che il film a sua volta metteva in evidenza, cioè alla “essenzialità di un underground spoglio e oppressivo in cui è relegata un'umanità resa schiava dalle macchine” e dalla radicalizzazione della società, nello scontro tra ‘capitale’ e ‘proletariato’ (tutt’ora in atto): del potere esercitato tra la costante organica del controllo come cinico calcolo, e l’inorganica perversità del lavoro, come utilità asservita all’economia e all’accrescimento del potere da parte di chi detiene il controllo della società. Intrinseco era nel film il discorso a volte inquietante che ci riguarda tutti sulla difesa della ‘libertà’, di cui non si parla o almeno non in maniera approfondita. Soprattutto lì dove la ‘libertà’ contrasta con le nuove tecnologie. A questo proposito Stefano Rodotà in ‘Intervista su Privacy e Libertà’, scrive: “So bene che vi è una propensione crescente, ma le derive tecnologiche sono sempre pericolose. Dobbiamo sempre partire dalla premessa che non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è, per questo solo fatto, pure eticamente ammissibile, socialmente accettabile, giuridicamente legittimo”. Il libro, cui si fa qui riferimento a cura di Paolo Conti nella veste di intervistatore del professor Stefano Rodotà, indaga i vari significati che la parola ‘libertà’ ha assunto nel corso dell’avanzamento tecnologico e della globalizzazione tutt’ora in atto, non si esime dal fare una corretta speculazione tra libertà individuale e socio – economico - politica, giusta nell’evidenziare e riformulare, sulla base delle impostazioni della Comunità Europea, quella che è l’opera del Garante in difese della ‘privacy’ dell’individuo e “la facoltà di scegliere l’ampiezza del contesto” in tutte le sue forme e le sue applicazioni. È inequivocabile che molti di noi non sanno attribuire alla figura del Garante e all’istituzione di un Ufficio apposito, il significato e il riconoscimento che meritano, attivi “nell’assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità della persona nel trattamento dei dati personali”, codificata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’individuo dalla Costituzione dell’Unione Europea. Sin dal suo insediamento l’attività del Garante, del quale il professor Stefano Rodotà è stato presidente dal 1997 al 2005, ha riguardato ogni settore della vita pubblica e privata dei cittadini in ogni settore sociale, economico e culturale del paese, con particolare rilievo nei settori delle telecomunicazioni, del credito e delle assicurazioni, della sanità e del lavoro, del giornalismo e della comunicazione, della videosorveglianza, del marketing, della genetica. Il ricorso al Garante è previsto dal Codice sulla Privacy per far fronte all’esercizio immediato dei diritti riconosciuti dalla legge a tutela della persona giuridica connessi al trattamento dei dati personali in materie di grande rilievo deontologico, come il giornalismo, la ricerca storica e statistica, i sistemi di informazione creditizia. Non solo, bensì per il trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute, agli orientamenti sessuali, all’appartenenza a partiti politici, confessioni religiose, organizzazioni sindacali ecc. ed anche in determinati ambiti come, ad esempio, nei rapporti di lavoro, nel settore sanitario, nel campo della ricerca e delle libere professioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti che eviti la creazione di banche dati e al trasferimento dei dati personali. E questo all’unico scopo di alcuni ‘perché’ che l’intervistatore chiede al prof. Rodotà proprio all’inizio del libro: «Come poter fare liberamente le nostre scelte senza pagare il prezzo di ingiustificate stigmatizzazioni sociali? La privacy può capovolgersi in ‘tirannia dell’intimità’, o essere la base sulla quale ciascuno di noi edifica liberamente la propria personalità? “Facendo il giurista – scrive ancora Rodotà – tutto questo si è tradotto nella ricerca delle connessioni tra i grandi diritti e quelle che venivano chiamate le piccole libertà e che, invece sono le libertà vere, quelle che ci consentono nella vita d’ogni giorno di non essere prigionieri di pressioni, condizionamenti, limitazioni qui, nella vicinanza con il modo d’essere concreto d’ogni persona, scopriamo i legami sociali, l’influenza dell’ambiente culturale, politico ed economico, i mutamenti imposti dalle tecnologie d’ogni tempo, che modificano la struttura della città e dell’abitazione, l’intero sistema delle comunicazioni, il nostro stesso corpo. Bisognava indagare i rapporti tra tecnologie e diritti”. Ma il prof non si ferma qua, affronta in pagine su pagine quelle che sono le divergenze tra le diverse parti interessate della giustizia, dell’economia, del sociale con esempi, citazioni impreviste e imprevedibili, dal lontano medioevo all’800 fino ai tempi nostri, come ad esempio quella dello scrittore americano William Faulkner sulla violazione della ‘privacy’ risalente al 1955: «Solo le opere di uno scrittore sono a disposizione del suo pubblico, finché quell’uomo non commette un delitto e diventa materia di cronaca nera la sua vita privata è unicamente sua». Un documento davvero straordinario, non vi pare? Non meno di quello riferito a George Steiner, il grande studioso di letteratura, il quale – ci illumina il prof – sostiene che “il momento in cui una persona deve avere il massimo di intimità è quello della lettura”. Di certo una golosità per i lettori de larecherche.it che non si aspetterebbero di avere il diritto di poter leggere on-line indisturbati e starsene da soli con se stessi, “… in un rapporto molto ‘chiuso’ con la pagina scritta, al riparo dal mondo esterno”. Tuttavia la domanda ficcante di Paolo Conti su un esempio ‘tangibile’ dell’aspetto ‘visivo’ della ‘privacy’ finisce col farci conoscere un aspetto del nostro prof tutto di un pezzo, finanche poetico (ve lo dice chi lo ha conosciuto di persona), e che Rodotà riferisce al quadro di Edward Hopper ‘Hotel Room’, come un autentico manifesto: “Raffigura una ragazza in una stanza d’albergo, svestita, seduta su un letto. Ha appena buttato le scarpe da una parte, accanto a lei c’è un bagaglio non ancora aperto. È assorta nella lettura. È un atto esclusivo, sembra impossibile interferire in quel rapporto della donna con il libro. A contribuire a questa atmosfera ci sono i colori freddi, i piani squadrati tipici di Hopper, certo. Ma soprattutto c’è la scena rappresentata. Però io vedo in questa idea di intimità da tutelare, non una chiusura verso il mondo esterno. Intuisco invece la possibilità di riflettere su ciò che si trova al di là di quella stanza, cioè il resto dell’umanità. Perché un libro è piena solitudine ma anche piena libertà, perché porta conoscenza, curiosità”. Con ciò arriviamo all’indice e alle nuove tecnologie, quelle del web, di internet ecc. che guarda caso sono di primario interesse per la ‘privacy’, “… poiché attraverso il loro dilagare, siamo continuamente pedinati, spiati e non ce ne accorgiamo”. Siamo di fronte a George Orwell “1984”, nel quale è descritta nei minimi particolari la società, la struttura degli edifici e il potere mediatico che l’occhio del “Grande Fratello” esercita sulla popolazione? Oppure, come pure scrive il prof Rodotà, citando le pellicole “Nemico pubblico” il film di Michael Mann che descrive le attività dell'FBI durante la grande depressione per reprimere la forte ondata di criminalità portata dalla povertà; o “La conversazione”, in cui Gene Hackman vede microspie e microfoni dappertutto, siamo allo svelamento di chi cerca di far vedere quello che accade realmente e che riguarda tutti noi ‘indistintamente’ e che magari “qualcuno vorrebbe nascondere o interpretare a senso unico?”. Il prof sembrerebbe voler rispondere ‘entrambe le cose’. Ma allora è allarmismo! esclama qualcuno. Noi sappiamo che le cose stanno davvero così e che: “Viviamo in una società sempre più sorvegliata: le telecamere per strada, il telepass, le chiamate dal telefono cellulare, le tracce che lasciano le carte di credito; soprattutto, la nostra presenza su Internet. Siamo letteralmente pedinati anche se con strumenti più raffinati rispetto al passato”. «La privacy? La avete ormai solo nella vostra testa, e forse nemmeno in quella» che fa il paio con un’altra citata «Ormai tutti avete zero privacy, rassegnatevi». Un vero nemico della tecnica? – chiede ancora l’intervistatore – al quale il prof risponde di “non aver mai assunto un atteggiamento né tecnofobo, né tecnofilo a riguardo. Come dire, né fatalista né entusiasta. (...) Penso semplicemente che la tecnologia ormai si sia insediata nella nostra vita quotidiana, ma che occorra governarla per evitare che diventi padrona delle nostre stesse esistenze”. È un fatto che la Rete e Internet accrescono le preoccupazioni legate alla tutela della personalità e quindi della libertà, sebbene entrambe molto complicate da gestire. Tuttavia sono divenute indispensabili alla vita quotidiana, risponde alle esigenze più elementari e la qualità stessa della vita è cambiata, notevolmente migliore rispetto al passato. Internet ha modificato non solo l’economia e la sociologia, ma persino la linguistica. Il linguaggio che usiamo è quello tecnologico legato alla connessione, ai tasti invio, spam, taglia e incolla, clip, smart, e-mail, store ecc. al punto che oggi, per indicare una ricerca in Rete, si usa anche il verbo «to Google». È sempre una questione di regole – avverte Rodotà – a una intuizione della privacy come strumento di tutela in cui rientrino soprattutto le minoranze (indifese) e i dissenzienti (talvolta indifendibili) e che in ‘democrazia’ vanno comunque tutelati. “Abbiamo sempre bisogno di spazi di libertà e, nella storia dell’uomo, non si è mai avuto uno spazio di queste dimensioni. La libertà in Rete è preziosa, e non può essere subordinata a parametri di normalità, all’accettazione del conformismo in nome dell’efficienza economica, della sicurezza, della tranquillità politica. Dico insomma che l’uso commerciale di Internet è inevitabile e anche giusto, ma non è possibile immaginare una cancellazione assoluta dei luoghi virtuali di libera manifestazione del pensiero. (...) Ormai nessuno che si occupi di privacy, di protezione di dati, può pensare di farlo seriamente in una dimensione puramente nazionale. Internet è globale, la circolazione delle informazioni non conosce frontiere, ovunque si pongono gli stessi problemi”. Problemi che noi tutti vorremmo vedere risolti al più presto, o comunque regolamentati da apposite leggi a tutela della nostra privacy e della nostra libertà che, non dobbiamo dimenticarlo, riguardano non solo il ‘diritto’ ma la nostra stessa inviolabile identità. Serve una diffusa conoscenza di quelli che sono i nostri ‘diritti’ per poterli difendere e la dovuta intransigenza di non permettere che essi vengano elusi o cancellati in nome di un avanzamento tecnologico che guarda – come in ‘Metropolis’ di Fritz Lang – soltanto all’accrescimento di un potere economico che di fatto annulla quella che è la nostra ‘dimensione umana’. Non dobbiamo permetterlo! Il prof Stefano Rodotà è ordinario di Diritto civile all’Università ‘La Sapienza’ di Roma è stato il Garante negli anni in cui ha presieduto il Gruppo dei Garanti Europei, ha partecipato alla Convenzione che ha scritto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha collaborato tra l’altro alla norma sulla protezione dei dati personali come ‘diritto fondamentale’, ed è personalità riconosciuta a livello internazionale. Ha pubblicato numerosi libri sull’argomento: ‘”Il terribile diritto”, “Il diritto di avere diritti” (recensito in questo stesso sito), “Questioni di Bioetica” ed “Elogio del moralismo” (di prossima recensione), tutti editi da Laterza. Paolo Conti è giornalista professionista, inviato speciale del ‘Corriere della Sera’, si occupa di attualità, problemi dell’informazione e beni culturali. Con questa “intervista…” dedicata al prof. Rodotà egli ha voluto sottolineare la grande importanza delle tematiche sottolineate, a volte inquietanti, ma che sono come mai prima, di grande rilevanza psicologica che interessano e coinvolgono ognuno di noi.
Id: 703 Data: 28/05/2013 12:00:00
*
 Salvatore Violante - Poesia - CFR Edizioni
Salvatore Violante - Poesia - CFR Edizioni
La meccanica delle pietre nere
Apparsa nella collana di ‘poesia politica e civile’ Epos, questa nuova antologia poetica di Salvatore Violante prende spunto da un accadimento geologico, avvenuto in illo tempore, dell’eruzione vulcanica del Vesuvio, la cui polvere lavica ricopre, nella psicologia campana e nell’idea concettuale del poeta, i substrati generazionali fino ai giorni nostri, sviluppando una ‘meccanica’, reiterata nel tempo, che tutto tempra: la storia antica e recente, l’ambiente e i suoi abitanti, le favole e i miti ad esso legati, le menti e i pensieri, le poesie e le canzoni partenopee. ‘Meccanica’ che, a sua volta, diviene comportamento, interazione, sperimentazione, variazione di ‘valori discreti’ detti ‘quanti’, che fungono da base a nuovi sistemi filosofici dove, per esempio, la ‘luce’ è descritta solo come un’onda e la ‘materia corpuscolare’ solo come particella, entrambe proprietà di un dualismo che irrompe nella lirica di Salvatore Violante stravolgendone la scrittura, nell’indeterminazione di un lessico entrato nella forma-poesia-canto partenopea, che è quella del ‘carme’ declamatorio, enfatico, impetuoso e fin troppo appassionato. Forma che s’avvale d’una lontana proprietà ieratica, intuitiva quanto arcana, maturata sotto la lava, ‘le pietre nere’, provocatorie di una struggente passionalità che coinvolge, esaspera, esacerba e talvolta logora le potenzialità psichiche dell’intelletto e dell’ingegno, per cui talora se ne è travolti, logorati da quell’ ‘appucundria’ che qualcuno ancora oggi traduce con ‘malinconia’ ma che può essere anche nostalgia, noia, mal di vivere, mal d’amore, insoddisfazione, solitudine, ed anche tutte queste realtà insieme, e che alla fin fine uccidono la quella che è da sempre considerata la ‘filosofia’ tipica di chi le subisce. Salvatore Violante è mago in questo, ha rivestito la filosofia di un alone di mitica osservanza nel formulare i suoi ‘carmi’ contrapponendoli all’interno di un ‘dualismo di valori discreti’ soffusi qua e là di umana pietà, quando si rivolge al passato, nulla negando al futuro che lo aspetta – che ci aspetta, quando affronta la dura realtà che ci sovrasta. Leggere queste liriche lo ammetto, non è stato un diversificare le mie letture navigate, bensì un impegno civile, un destreggiarmi inconsueto in acque agitate che non lasciano intravvedere il fondo e che pure rimandano, quasi specchiate, immagini di un ‘sé’ obliterato. Non la speranza mistica del poeta quindi, né l’audacia tipica dell’eroe combattivo che ci si aspetterebbe da un impegno preso, bensì l’imprudenza umana, la sconsideratezza di chi ‘ama’ la vita, in qualunque veste essa si presenta, anche nella forma ‘quantistica’ dell’appucundria che riempie, colma, occupa; o nell’indeterminazione di ciò che realmente siamo, impegnati nelle avventure che spettano al nostro futuro.
Id: 682 Data: 05/04/2013 12:00:00
*
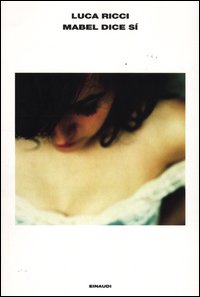 Luca Ricci - Narrativa - Einaudi
Luca Ricci - Narrativa - Einaudi
Mabel dice sì
“Mabel dice sì” di Luca Ricci – Einaudi 2012 Ecco un piccolo-grande libro che si legge in un’ora o poco più, un tascabile della collana “L’ Arcipelago” Einaudi che spazza via tanti tomi voluminosi per dire, in fondo, le piccole-grandi cose di cui pure ci si dovrebbe occupare e delle quali invece non ci si occupa mai e che sono il vero sale della vita. Di quelle “vite degli altri” che in certo qual modo ci riguardano da vicino, che ci sfiorano o ci toccano nel vivo del nostro quotidiano, coinvolgendoci nella loro scia e, qualche volta, spazzando via i nostri logori sentimenti di critici impertinenti. Mabel nella scrittura dinamica e scaltra di Luca Ricci è qui a dirci che possiamo anche continuare a vivere nell’ignoranza totale dell’umanità che ci gira intorno, ma che non abbiamo alcun diritto di giudicarla, perché ciò che a noi qualche volta ‘sembra’ non è detto che poi corrisponda a verità, sempre che la verità stia dalla nostra parte. E, inoltre, a dirci che si può essere uguali pur nella disuguaglianza dei pareri, pur nella diversità degli intenti, e che non bisogna ergersi a giudici e frettolosamente giudicare, mai. “Così è, se vi pare” – fa dire Pirandello alla signora Frola e che “Mabel” di Ricci trasforma in “Così è, se vi piace”, con lo stesso distacco ma con la stessa umanità che trova nelle semplici parole dette – che il critico Andrea Cortellessa ha definito “ridotte al grado zero”, e che pure ci danno l’esatta dimensione “dell’inimmaginabile”. Quella stessa ‘verità’ che in fondo tutti noi inseguiamo da sempre e che vorremmo far nostra perché dovrebbe convincerci che siamo nel giusto quando, al contrario, non lo siamo quasi mai. Questa è la tesi che – secondo il mio immodesto parere – dobbiamo altresì smettere di mettere in campo ogni volta per appropriarci del ‘presente’ e trascinarci in un futuro che non ci appartiene, perché nel giudicare gli altri ci limitiamo a non giudicare noi stessi e non facciamo della nostra vita “quell’opera d’arte” che Mabel, a suo modo e in tutta libertà, ha deciso di “fare” della sua, e che a mio parere le riesce benissimo. Mi permetto qui di aggiungere una massima che il grande sociologo Zigmunt Bauman ha scritto nell’incipit di un suo libro: “La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no …”, a cui mi permetto di aggiungere “… e che ognuno deve sentirsi libero di ‘spendere’ come più gli piace … che noi lo vogliamo o no”.
Id: 668 Data: 26/02/2013 12:00:00
*
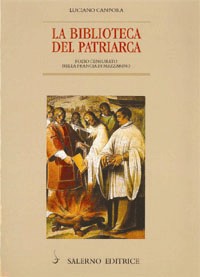 Luciano Canfora - Saggio - Salerno Editrice
Luciano Canfora - Saggio - Salerno Editrice
La Biblioteca del Patriarca
La Biblioteca del Patriarca. Fozio censurato nella Francia di Mazzarino
“Intorno alla metà del Cinquecento, a Venezia, nei primi anni del Concilio di Trento, riemerse dal ‘tesoro’ di Bessarione un libro straordinario: la Biblioteca di Fozio, patriarca di Costantinopoli vissuto nel IX secolo. La sua riscoperta era stata salutata con gioia e trepidazione. Ai dotti e agli umanisti parve l’arca salvifica che riportava alla luce dal ‘diluvio turco’ – come allora si disse – tanti autori greci. Dal mondo cattolico, invece, soprattutto dai suoi vertici culturali, fu guardata con sospetto: l’autore era pur sempre il ‘diabolico’ artefice della lacerazione con Roma da cui era scaturito lo scisma d’Oriente. Solo all’inizio del secolo seguente quell’opera fu pubblicata: per tre volte nel giro di mezzo secolo, e sempre da editori protestanti. La terza e più fortunata edizione, quella di Rouen (1653), cela un mistero. Da chi fu allestita? Cosa nasconde la criptica sigla al termine della prefazione? Perché la tiratura fu manipolata e la prefazione scomparve? Ma scomparve del tutto? La questione viene risolta dalla dotta sagacia di Luciano Canfora, il quale conduce il lettore in un percorso ricco di sorprese da Bisanzio alla Francia di Mazzarino, all’Europa protestante, sullo sfondo delle guerre di religione”. “In certo modo, Fozio fu l’archetipo del recensore – tanto che Saintsbury lo definì felicemente «il patriarca recensore». Bizzoso, idiosincratico, aspro, questo grande studioso ci dà ogni volta un’immagine vivissima e puntigliosa dei ‘libri’ di cui parla, si tratti di romanzi fantastici o di opuscoli teologici. Interi mondi si aprono davanti a noi, dove non solo incontriamo tanti tesori scomparsi, ma siamo guidati da uno ‘sguardo bizantino’: così riusciamo a capire con quali occhi, nel IX secolo, si guardava a ciò che per noi sono ‘ i classici’ (greci e latini), nonché a quelle tante altre meraviglie che il tempo ha cancellato. Il recupero operato in questa dotta edizione da Nigel Wilson, uno dei massimi bizantinisti, ha la prerogativa di aver scelto, nell’immensa selva delle schede di Fozio, quelle che, per ragioni varie, parlano più vivamente a un lettore di oggi, commentandole e introducendole in modo che questi testi tornino ad assumere tutto il loro affascinante rilievo”. “Fozio è una delle figure più espressive dell’intera storia bizantina e dell’Impero Romano d’Oriente, personaggio (..) in grado di soffermarsi su tutto lo scibile umano e discernere adeguatamente in qualunque occasione fosse richiesto il suo parere, tanto di metodologia religiosa quanto di metodologia ed applicazione pratica relativa alla politica. Nella sua vita egli ricoprì tutte le cariche civili e religiose che alla corte del Corno d’Oro (Costantinopoli) si potevano ricoprire. Fu protospatario, segretario di Stato, senatore, ambasciatore, patriarca, insomma nulla fu negato alla sua attività. (..) Dal punto di vista politico-religioso egli scavò ancor più il solco tra le tesi della chiesa ortodossa e quella cattolica adoperandosi per gettare le basi di ciò che sfociò circa due secoli più tardi (1054) nel cosiddetto Scisma d’Oriente, la separazione d’intenti tra due visuali diverse della stessa religione cristiana: celebri le sue allocuzioni sul Filioque, emblema portante della filosofia teoretica del potere Papale in occidente. (..) Fozio ha scritto molto come abbiamo detto, e su tutte le materie che componevano le conoscenze dell’umanità, ha insegnato creando una scuola feconda e piena di discepoli che hanno finito per formare una cerchia ristretta di persone fedeli a cui lui poteva in ogni momento rivolgersi per consiglio o per l’impostazione di una dialettica da elaborare. Fozio si può definire come un umanista che ha preceduto di molti secoli coloro che professarono poi quest’impostazione socio-culturale. Egli precorreva semplicemente i tempi ed i modi rispetto al resto dell’umanità dotta e benpensante ed anche le sue opere si presentano sicuramente all’avanguardia rispetto a quelle dei coetanei. La sua opera maggiore è considerata senza dubbio la Biblioteca o Myriobiblon, una recensione accurata ed esauriente di tutti quelli che avevano avuto un importante passato nella storia sia greca sia romano-bizantina, sia politica che religiosa: la forma di recensione è la più idonea a definire questi scritti perché egli usa il tono e la preparazione tipica del censore indipendentemente sia egli favorevole o contrario all’esaminato. (..) E’ evidente, e si nota certamente, come Fozio non concepisca modelli diversi da quelli del classicismo greco nella valutazione del recensito, ma è altrettanto evidente la sua originalità nell’esporre la forma letteraria in maniera senz’altro innovatrice, piacevole e del tutto diversa rispetto a quella a cui s’era abituati in precedenza, tant’è che la sua polivalenza sullo scibile umano lo porta anche a scrivere un’opera come le Amphilochiae Questiones, dove egli, in forma di risposta trattata rispetto a presunte richieste formulate da Anfilochio, parla diffusamente su svariati argomenti (oltre 300) sbalordendo per l’efficacia delle sue analisi sempre profonde e lucide. Gli siamo debitori soprattutto del fatto che egli, illustrando i vari personaggi, ci presenta una società in continua evoluzione nello spirito e nella prassi quotidiana: l’analisi ed i testi che riporta sui primi cristiani, introvabili fino a quel momento, danno modo d’approfondire il momento storico nel contesto in cui essi operavano, in realtà egli non lascia nulla d’intentato, scrive sui mitomani o sui romanzieri come scrive su medici, analisti politici o dotti geografi. (...) Evidentemente la sua produzione letteraria rispecchiò il modo di porsi ed il modo di soffermarsi sulle questioni politiche e sociali, la prospettiva che aveva in relazione ai personaggi che s’erano susseguiti nel corso dei vari secoli dalla fondazione dell’Impero d’Oriente rientravano quindi in una sua logica ben precisa e tutto era ricondotto alla sua veduta immensa, certamente per portata culturale, ma anche spesso troppo soggettiva. (...) Dobbiamo in ogni caso ringraziare, e non dovremmo mai stancarci di farlo, questo saggista, perché proprio per merito suo abbiamo avuto la possibilità di conoscere fatti storici, uomini, scritti che altrimenti non sarebbero mai giunti fino a noi". Enrico Pantalone, autore di questo articolo – che qui riporto in sintesi – non parteggia certo per una della due parti, cerca di porre nella maniera più semplice ed obiettiva il periodo in cui Fozio ha vissuto, uno dei momenti storici più drammatici ed intensi del dopo Roma, il momento in cui le due “discendenze imperiali” – quella occidentale franco-tedesca-latina e quella greca – si scontravano duramente, sia politicamente che ancor più teologicamente. Qualche secolo prima v’era stata la separazione territoriale, ora v’era anche quella socio-religiosa, nulla sarà mai più come prima: per l’occidente “romano”sarà l’inizio del commino e della rinascita verso il dominio assoluto del mondo allora conosciuto, per l’oriente “romano” inizierà il lento e drammatico declino fino alla dissoluzione totale. Vi chiederete perché di questa insolita recensione che innanzi ad una formulazione critica ripercorre in forma di ‘cronaca’ la pubblicazione di un libro che si considerava andato definitivamente perduto nel rogo dei testi di Fozio, il Patriarca deposto nell’867 e condannato all’esilio in conseguenza del Concilio di Costantinopoli (869), che innescò la secolare diatriba tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente e che, qualche tempo dopo, portò allo scisma definitivo tra le due diverse confessioni, sebbene sia avvenuto un secolo e mezzo dopo di lui. Ovviamente una ragione c’è e non è frutto della sola curiosità, ma prende spunto da una mostra “Lux in Arcana: l’Archivio Segreto Vaticano si rivela” visitata appena un anno fa ai Musei Capitolini di Roma, più esattamente nelle splendide sale del Palazzo dei Conservatori, in cui, per la prima volta, venivano esposti importantissimi e straordinari ‘tesori’ della documentazione storico-letteraria, politica e teologica di quanto intercorso tra le diplomazie vaticane e il resto del mondo. Esemplari unici di documenti redatti da insigni imperatori e vicari di Cristo, in calligrafie che talvolta rasentano l’impossibile finanche oggi coi mezzi di cui disponiamo, rilegate e conservate in coperte di oreficeria e custodie di passamanerie di una ‘bellezza’ tale da trasformare ogni singolo libro esposto in vera e propria forma d’arte a se stante, illuminata da quella ‘luce che si sprigiona nei recessi più bui e al chiuso di ferrosi chiavistelli, dai preziosi manufatti scrittorii che brillano della propria creatività’. Quasi si volesse impedire ad essi di far ascoltare i costrutti delle parole, il suono veemente delle frasi, le condanne e gli abiuri, le scomuniche ma anche gli accordi diplomatici e quant’altro e capire quali scopi hanno assolto nei secoli, in quale relazione essi si pongono con gli eventi di cui serbano memoria. Va detto (e lo dico) che, insieme ai numerosi reperti della storia, mi sarei aspettato qualcosa di più segreto, e perché no dei testi evangelici originali mai visto in 2000 anni di storia, o l’Editto costantiniano, ecc., e forse, finalmente, l’esemplare dell’edizione del “Rothomagensis” di Fozio, pure conservata alla Biblioteca Apostolica Vaticana. E non certo per un eccesso di bizzarria quanto di desiderio di conoscenza e perché ritengo sia essa opera di grandissimo interesse divulgativo, non esclusivamente a uso degli studiosi, quanto per un raffronto ‘visivo’ diretto con ciò che si conosce (assai poco) della letteratura bizantina tout-court, e della quale non si trovano molti riferimenti se non sporadici, nei testi redatti dagli storici arabi delle Crociate, di molto successive agli anni in cui Fozio commenta i testi della sua ‘Biblioteca’. E della quale oggi ci giungono distorti gli echi, così come diversi lo sono le testimonianza politico-religiose e culturali che non completano il quadro solitamente offerto dalle sole fonti occidentali. Ma ahimè non conosco neppure quei testi, oltre all’impossibilità di leggerli nella lingua originale in cui furono redatti, benché ritengo che possano offrire allo storico e all’appassionato di letteratura (in questo caso io che scrivo), uno squarcio interessante di quei secoli così lontani da noi. Ma questa volta c’è di più del semplice riscoprire la ‘bellezza’ del pensiero antico o le capacità scrittorie di un letterato di grande valore quale è Fozio. È interessante, credetemi, immergersi nelle diatribe, anatemi e scomuniche (ops!), che hanno tinto di ‘giallo’, o di profondo ‘nero’ se preferite, quanto occorso alla ‘Biblioteca’ di Fozio, sulle cui pagine si sono scontrati illuminati e sapienti, grecisti e latinisti, teologi e papi, chiese e religioni. Non in ultimo un Concilio a Costantinopoli che, con accuse senza fondamento verso Fozio, ne decretò la sua deposizione (per ben due volte) da Patriarca, l’esilio da parte di Leone VI di Bisanzio, pensate detto ‘il filosofo’, e la segregazione in un monastero in Armenia, dove la morte lo incolse nel 893. E, successivamente al ‘rogo’ di tutti i suoi libri. Ma come la storia talvolta vuole, Fozio ottenne il suo riscatto quando fu proclamato Santo dalla Chiesa Ortodossa. Nel frattempo, i suoi lasciti letterari, avevano posto le basi teologiche e politiche per lo Scisma d’Oriente, ed anche negli ordinamenti del ‘diritto’ di ogni paese europeo, contribuendo fortemente all’opera di elaborazione di testi normativi emanati da Basilio I di Bisanzio e poi dal figlio di questi Leone VI , conosciuti anche come ‘I Basilici’. È grazie a Fozio e al suo contributo dato alla storia della letteratura bizantina, che si è conservato il ricordo di molte opere, per lo più andate perdute, di fondamentale importanza della letteratura greca classica. Autore inoltre di poesie e di una raccolta di sentenze morali Fozio occupa oggi, giustamente, uno spazio rilevante nelle collezioni bibliotecarie di numerose Università, Librerie, Musei e Mediateche che si possono (più o meno) consultare. È tuttavia all’opera sopra citata di Luciano Canfora (medaglia d’oro ai benemeriti della scienza e della cultura della Repubblica Italiana) considerato un «profondo conoscitore della cultura classica», al cui studio egli applica «un approccio multidisciplinare» attivo negli studi e nella pubblicazione di numerosi testi ‘capisaldi’ storici, che ha trasformato la ‘vicenda’ di Fozio in un ‘quasi’ thriller dal titolo “La Biblioteca del Patriarca” che ha come sottotitolo: ‘Fozio censurato nella Francia di Mazzarino’ e che si legge come un romanzo dai risvolti decisamente ‘noir’ a fronte di una documentazione ‘precisa nei termini quanto oculata nell’esposizione’ cui non mancano riferimenti propri dell’arte, curiosità filologiche e momenti di ricercata ‘bellezza’ letteraria. Riporto qui sotto l’incipit di uno dei capitoli: “Il rogo dei libri di Fozio”. “Al di sopra delle ampie sale in cui è sistemata, oggi, la parte ‘visibile’ della Biblioteca Vaticana si estende un immenso salone: il ‘salone sistino’, così detto perché il suo assetto architettonico e gli imponenti affreschi che lo adornano risalgono appunto all’iniziativa di Sisto V (1590). Oggi si entra in quel salone dalla parte sbagliata, e questo attutisce, o comunque riduce di molto, l’effetto didattico che gli affreschi intendono produrre. Bisognerebbe ‘leggerli’ infatti partendo da quello che attualmente è il fondo del salone: è di lì, cioè dall’originario ingresso, che dovrebbe incominciare la ‘lettura’ dell’ampio testo figurato che occupa le immense pareti. L’osservatore ha sulla destra la storia delle Biblioteche di Mosè, degli Ebrei, di Babilonia, di Atene, di Alessandria, dei Romani, di Gerusalemme, di Cesarea, degli Apostoli e, infine dei Pontefici; e sulla sinistra la storia dei Concilii ecumenici, a cominciare da quello di Nicea, sotto Costantino il Grande, fino all’VIII Concilio ecumenico (Costantinopolitano quarto), svoltosi sotto il regno di Basilio il Macedone a Bisanzio e del Papa Adriano II a Roma negli anni 869-870. Intercalati tra gli affreschi che raffigurano le varie assemblee conciliari figurano altri affreschi, talvolta di pari dimensioni, talaltra di dimensioni minori, che illustrano gli effetti ‘librarii’ dei Concili, per lo meno dei più importanti: dalla distruzione dei libri di Ario, in conseguenza del Concilio di Nicea, alla distruzione - sempre nel fuoco – dei libri di Fozio (il Patriarca deposto nell’867 e condannato, per volere di Roma, nell’VIII Concilio) a seguito appunto dell’assise costantinopolitana. La disposizione è sapiente e accuratamente calcolata. L’affresco in cui si osserva il rogo dei libri di Fozio viene a trovarsi esattamente di fronte, sulla parete opposta, rispetto all’immagine di Sisto V che approva il progetto di ristrutturazione del salone e poggia una mano protettiva su di un libro, mentre gli architetti gli illustrano il progetto. Particolare da non dimenticare: il salone sistino era l’originaria ‘sala di lettura’ della Biblioteca Vaticana. I lettori erano, per così dire, circondati da codesto ‘ciclo’ pittorico apertamente e intenzionalmente didattico. Una didattica che si estende anche ai piloni, alle quadrate colonne che sorreggono il soffitto, sulle quali sono raffigurati i vari alfabeti”. Immaginate, dunque, questa è la scena, oggi diremmo la location del ‘film’ che Luciano Canfora, senza premeditazione, ha escogitato per dare il primo ciak alla regia del suo ‘giallo’ storico intorno alla ‘censura’ dei testi di Fozio. E lo fa con ordine meticoloso, ricostruendo ‘passo dopo passo’ tutti gli accadimenti, un susseguirsi di ‘scoop’ che si alternano alle vicende storiche autentiche, escogitate da filologi e librai nonché da editori trasgressivi delle norme che già, in quell’epoca lontana, lavoravano a trasformare il ‘commercio’ dei libri (dei papiri, delle pergamene redatte a mano, degli in-folio), in vere e proprie ‘guerre’ di accaparramento, di primato, di potere culturale e sociale del ‘libero’ pensiero, che oggi riconosciamo essere patrimonio dell’umanità intera. Ma nulla si è fatto e si fà per sostenere la ‘ricerca’ di quanti, tra studiosi, scienziati, specialisti della conservazione libraria, artigiani ‘professionisti’ della carta e della stampa ecc. Senza contare quante opere di grande valore letterario sono andate disperse o perdute nel corso di questi ultimi cinquant’anni, per l’incuria dei suo detentori, perché rubate e non denunciate, trasferite all’estero da trafficanti senza scrupoli, o semplicemente fatte sparire e mai recuperate, da chi invece dovrebbe tenerne la cura e la conservazione. Le cronache anche recentemente si sono occupate di queste sparizioni ma, al fine del loro recupero, non si conosce neppure dove cercare o che cosa si dovrebbe cercare. Per questo ho ritenuto doveroso quanto necessario parlare in questo lungo excursus scaturito dalla Mostra “Lux in Arcana” visitata di recente al Palazzo dei Conservatori di Roma che, oltre all’allestimento pregevole ed ai suoi limiti inevitabili, se non altro, ha restituito a tutti noi, per tutto il tempo della sua durata, il piacere ‘incommensurabile’ di un incontro con la storia artistica e la cultura aulica di un tesoro che è e deve rimanere di tutti. Anche per questo va salvaguardato. Invito quindi ognuno che abbia o sia a conoscenza di testi poco conosciuti o del tutto dimenticati di ‘farli conoscere’, cioè di portarli all’attenzione del pubblico dei lettori. Solo in questo modo potremo salvare un patrimonio che è della ‘conoscenza’ ed eredità dell’umano sapere.
Fozio “Biblioteca”, a cura di Nigel Wilson – Adelphi 1992 Enrico Pantalone, “Fozio: La figura più grande della cultura bizantina” art. in ‘Archeologia e Storia’, gennaio 2013. M. Bendiscioli, A. Gallia, “Annales bertinienses (857)” in “Documenti di Storia Medievale 400-1492, Mursia 1970-1973
Id: 664 Data: 19/02/2013 12:00:00
*
 AA.VV. - Rivista - Corriere della Sera
AA.VV. - Rivista - Corriere della Sera
’La Lettura’ - Corriere della Sera
“LA LETTURA” – Supplemento al Corriere della Sera #53 – Domenica 18 novembre 2012. Non capita spesso di avere a portata di mano un compendio di notizie letterarie – poetiche - artistiche che raccoglie, se non tutte, comunque tantissime, info riguardanti ciò che accade in Italia e nel Mondo completamente riservato alla ‘cultura’. Questa parola che è sulla bocca di tutti (specialmente dei politici, dei governi tecnici, dei partiti di destra come quelli di sinistra e dei sindacalisti quando si avvicina il tempo delle elezioni), e che pure spaventa chi dovrebbe gestirla (che subito dopo si dimentica pure di averla pronunciata venendo meno a tutti gli impegni presi), almeno quanto chi si trova a subirla (paura di leggere quello che non vogliamo sentirci dire). Ma la sete e la fame di ‘cultura’ vince su tutto e tutti e si fa spazio da sola, al pari della sete e della fame ‘vere’ che ci costringono a tirare la cinghia. Ben venga dunque l’iniziativa ‘gratuita’ per il lettore del Corriere della Sera, di informare il pubblico dei suoi lettori e quindi l’ ‘opinione pubblica’ sulle tendenze dell’arte, le novità librarie, i movimenti letterari, gli indirizzi poetici, le curiosità astruse che, in qualche modo, ci fanno sentire ‘vivi’, partecipi di quella cultura un tempo anche ‘nostra’ che negli ultimi tempi abbiamo demandato ad altri (francesi, inglesi, americani), solo perché non si può elargire ‘fame e sete’ a un popolo già assetato e affamato. La politica non lo vuole. Non si può dare ‘cultura’ a un popolo che ha nel proprio DNA il ricordo dei sovversivi carbonari, la strage di Portella della Ginestra, i Moti insurrezionali di Napoli, le barricate delle Cinque giornate di Milano, il G8 di Genova, gli scontri con la Polizia dei giovani di Roma. La politica sa che la ‘cultura’ è un campo minato a cielo aperto, allora preferisce manganellare le insurrezioni popolari contro il malgoverno, concedere all’anarchia di svolgere la sua rivoluzione silenziosa, sedare le manifestazioni per l’Illva, per il Sulcis, per l’Alcoa, per la Tav; che, in fondo è come ammettere che un popolo, il nostro, debba vivere nell’ignoranza. Intanto però, ci obbligano a mandare i nostri figli a scuola ad apprendere un mare di stronzate inutili, mentre con una botta di mano tagliano i contributi alla ricerca, all’istruzione e quant’altro; ci riempiono la testa di calcio, di insulsi programmi TV dove non si fa altro che alimentare la fame con piatti succulenti che nessuno mangerà mai, e che altro non fanno che aumentare la fame e la sete. Ma se la fame ci ottenebra la vista, la sete di ‘cultura’ ci rischiara la mente, ed ècco che gli articoli in “La Lettura” non si limitano ai soli richiami ‘letterari’ ma si spingono nei rimproveri proprio contro quella falsa ‘politica’ che nega la ‘cultura’ con la recessione economica (Federico Rubini), con la finanza vampira (solo contro i poveracci), e invita al richiamo del ‘libero arbitrio’ (Marta Serafini e Filippo Sensi), al dibattito delle idee (Antonio Carioti), alle ‘pari opportunità’ dismesse (Paolo Di Stefano), alla serialità che ci ottunde (Ivan Cotroneo). Perché, diciamocelo, in fondo fare cultura è fare politica a 360 gradi, è aprire la porta alle idee, alle confessioni, alle ipotesi, e perché no, alla fantasia. Allora ben venga la ristampa di “Le botteghe color cannella” di Bruno Schulz (Einaudi 2012) e al recupero di quell’infanzia del mondo che abbiamo smarrita, dove il sogno alimentava il sonno di tutti, (scrittori, filosofi, politici, santi e tutti gli altri) e che fece dire all’autore: “Nessun sogno, per quanto assurdo e insensato, si spreca”, né si può ritenere vano (art. di Ugo Ricciarelli). Ma chi non ha mai messo piede (non ha letto), nel “Il sanatorio all’insegna della clessidra”, o non è mai entrato in una clinica psichiatrica, non può conoscere davvero cosa significa sognare. È questa ‘La Repubblica dei sogni” in cui Schulz si avvale non più della fantasia, bensì della realtà dei sogni, del quanto di ‘vero’ i sogni hanno da raccontarci, e forse di utopistico. Possiamo noi, oggi, considerare utopia ‘La città del Sole’ di Tommaso Campanella? O forse fantascienza ‘Utopia’ di Tommaso Moro? Sarebbe come contestare a Zigmunt Bauman la nostra appartenenza a quella ‘liquidità’ (entro la quale ci andiamo nascondendo), e che il sociologo ha individuata e studiata nei suoi numerosi trattati “Vita liquida”, “Modernità liquida”, “Paura liquida”, “Amore liquido” (editi da Laterza), e che ritroviamo ampiamente esposta nell’articolo di Marta Serafini e Filippo Sensi “Democrazia liquida” quale forma di democrazia partecipata: “Ossia uno stato di transizione tra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta, che funziona grazie al sistema delle deleghe e che si è sviluppata soprattutto on-line”. Tuttavia preferisco qui concludere con le parole del politologo americano Robert Paul Wolff ritenuto il padre della ‘democrazia liquida’ che, già nel 1970 si espresse così: “Un governo per il popolo è benevola schiavitù, un governo del popolo è vera libertà”. Riprendiamoci dunque il maltolto con l’andare alle urne e far valere quel diritto sancito dalla nostra Costituzione con il ‘voto’. Altrimenti... neppure i sogni ci salveranno.
Id: 648 Data: 27/11/2012 12:00:00
*
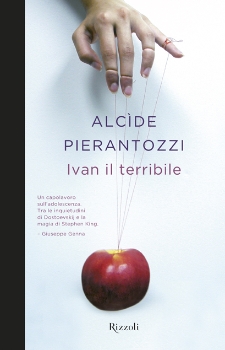 Alcide Pierantozzi - Romanzo - Rizzoli
Alcide Pierantozzi - Romanzo - Rizzoli
Ivan il terribile
Mai immagine di copertina mi è sembrata più indovinata di quella che illustra questo nuovo libro di Alcide Pierantozzi dopo il successo ottenuto con il primo riuscitissimo romanzo ‘Uno in diviso’ (Hacca 2006), e l’altro ‘L’uomo e il suo amore’ (Rizzoli 2008), perché permette di individuare, con un colpo d’occhio, quella realtà che, invece, il titolo spinge a rivolgere la mente altrove: alla biografia intricata quanto oscura, di un famoso personaggio storico. Qui l’immagine di Mike Bailey indica che a muovere i fili della storia è il ‘peccato’, quella mela che ci rende tutti deficitarii di legalità, di moralità e di sapienza, come se la ‘storia’ non abbia mai insegnato niente a nessuno, e che l’ultima generazione non sia contemplata nel suo riscatto. La dimensione, la sua profondità, è andata perduta, consumata dalle generazioni che l’hanno preceduta, e quel ‘peccato’ si è trasformato in alienazione mentale, delirio coerente che stravolge tutto e tutti. Specialmente chi è costretto a vivere in un piccolo centro di una provincia dimenticata o nella periferia logora e abbandonata di una qualsiasi megalopoli, là dove tutto è lecito, finanche essere biasimato per la propria “adolescenza che spaventa perché vera: scaltra ma capace di assoluto, spietata.” Ma è quest’essere spietata che rende la realtà rappresentata da Pierantozzi, maggiormente cruda, nella sua pur esile linea descrittiva, che pure arriva “fino al cuore del disastro delle famiglie” e della società rabbiosa e sgraziata in cui ognuno è costretto a vivere, nonostante la parvenza di ordine, organizzazione, equilibrio che l’ha consumata. Fino a quando non si smentiranno le differenze razziali, di religione e di ogni altra ‘diversità’, ‘Federico’ e ‘Sara’, (i due personaggi del romanzo) saranno sempre i martiri del nostro tempo, insieme a Jack Frusciante, a Mary (per sempre), e tanti altri che abbiamo dimenticati. Non sarà così per ‘Ivan’ (Brando, Dean, e tutti i Rocco del cinema) che, per quanto terribile, è invece l’eroe selvaggio e arrogante di tante storie quotidiane, che leggiamo sulle pagine dei giornali. Per il quale la società non fa niente per migliorare la sua condizione verosimilmente ‘negativa’, che diventa ignobilmente ‘positiva’, perché in fine egli è l’unico a sentire pulsare la ‘vita’ e la trasmette agli altri, pur con la sua grossolanità, la sua rozzezza e quella ‘volgarità’ che sotto il cielo ci accomuna tutti.
“Voglio spiegarti come funziona il mondo, Federico. Quello che fa arrivare qualcuno da qualche parte è la sua spregiudicatezza” – rammenta l’autore a Sara, lanciando più di un interrogativo al lettore. Una frase capace di annullare le molte barriere che abbiamo alzate a difesa di questo nostro ‘feudo di sale’: “È la cattiveria di Ivan a essere così seducente?” Oppure...? Lascio al lettore di scoprirlo.
L’aggancio poetico che penso si addica a questo pur giovane autore è di Walt Whitman che, in: ‘Io canto l’individuo’, ci dà la chiave di lettura del suo ‘personalissimo’ scrivere che si fa ‘sociale’:
IO CANTO L’INDIVIDUO
Io canto l'individuo, la singola persona,
al tempo stesso canto la democrazia (..) l'organismo, da capo a piedi, canto,
la semplice fisionomia, il cervello: la Forma integrale
e la Femmina canto parimenti che il Maschio. (..)
Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza,
lieto, per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano,
canto l'Uomo Moderno.
(liberamente tratta da "Foglie d'erba", a cura di Enzo Giachino, Einaudi 1980)
Id: 623 Data: 28/09/2012 12:00:00
*
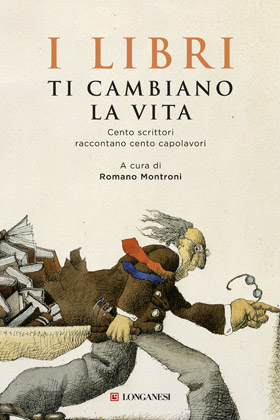 Romano Montroni - Narrativa - Longanesi
Romano Montroni - Narrativa - Longanesi
I libri ti cambiano la vita
“Il libro vero parla sempre al momento giusto. Lo inventa lui, il momento giusto; con il colore della parola, con la singolarità della battuta, con il piacere della scrittura” - scrive Ezio Raimondi in “Le voci dei libri”, ed è così. Avviene tutto per sintesi, addirittura potremmo dire per simbiosi, data dalla necessità interiore che ci fa stendere la mano verso un libro e non un altro. Perché è proprio quello di cui necessitiamo in quell’istante e che funge da richiamo. Così accade per il colore o la mancanza di colore di quella copertina, della grafica che ci cattura lo sguardo, ci lusinga, ci abbindola. Quante volte abbiamo aperto un libro e scorrendo le sue pagine ci è sembrato di aver trovato proprio quello che volevamo leggere, o magari, solo sentirci dire? Ogni libro ha un suo odore, non è forse così? Poco dopo che lo maneggiamo, riconosciamo nella carta e nell’inchiostro un sottofondo odoroso che lo fa nostro, per cui sappiamo dire finanche dove siamo arrivati a leggere senza l’uso del segnalibro. Altre volte, rammento, di aver sfogliato un libro e averlo subito riposto, perché non lo sentivo adatto a me; oppure averlo ricevuto in regalo e messo via, nel limbo delle attese. Come dire, in stand-by, aspettando il momento migliore per leggerlo e che talvolta è arrivato dopo anni, che quasi non rammentavo neppure di averlo. Invece era lì, come è detto in apertura, aspettava il momento giusto, per imporsi alla mia attenzione, e accipicchia, quante volte l’ha spuntata Lui, il Libro e devo ammettere che ‘in qualche modo’ mi ha cambiato la vita. È accaduto con “Pinocchio”, “Cuore”, “Tre uomini in barca”, e con “Bel-Ami” quando ormai avevo l’età giusta, con “La luna e i falò”, “I fratelli Karamazov”, “Il Maestro e Margherita”, e tantissimi altri. Ma il grande libro che più mi ha conquistato, e che è quasi stupido citarlo, è stata “La Divina Commedia”, a seguire “I promessi sposi”, “Iliade” e “L’Odissea”, “Don Chisciotte” e poi “L’interpretazione dei sogni”, “L’idiota”, “La nausea”, “L’odore dell’India”, “Cent’anni di solitudine”, “Memorie di Adriano” e immancabilmente e irrimediabilmente “La Recherche” di Marcel Proust. Quanti altri? Tantissimi, che per uno come me, che legge anche il biglietto del tram, non basterebbe questa recensione per elencarli tutti. Ma forse avrei dovuto citare, oltre quelli degli scrittori, i nomi dei poeti che dopo Dante si sono susseguiti instancabilmente nelle mie letture: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Pasolini, Ungaretti, Neruda, Hölderlin, Kerouac, Carver, ecc. ecc. O forse i grandi saggi ... Chiedo scusa, smetto subito di tediarvi. Fatto è che mi è capitato più volte di aprire un libro e “trovare”, quasi come un trovarobe di teatro, qualcosa che in verità non stavo cercando ma che, guarda caso, era esattamente quello di cui avevo bisogno. A dircelo è il curatore di questa intelligente e originale raccolta Romano Montroni, la cui idea di mettere assieme, per quanto diverse, le esperienze letterarie di cento scrittori, giornalisti, compositori, attori, più o meno conosciuti, più o meno lettori, più o meno impegnati. I quali, hanno dato fuoco ai loro ‘segreti’ librari, lasciandosi scoprire in attitudini letterarie inconsuete e, in qualche caso, inaspettate e, “con generosità hanno accettato di condividere emozioni, sensazioni e pensieri nati dalla lettura”. Inutile dire che la geniale idea non poteva che venire a un esperto del settore librario quale è Montroni “un uomo che dei libri ha fatto una delle ragioni della propria vita”, il quale, con questa raccolta, ci propone anche qualche ripensamento, ad esempio, affiancando pareri diversi di uno stesso libro; ri-proponendo alcuni libri “secondi” destinati al dimenticatoio e che, guarda caso, vale invece la pena di riscoprire. Inoltre ci sono libri di cui, personalmente parlando, non conoscevo l’esistenza, perché forse il loro odore, il loro colore, il loro ‘essere’ essenzialmente lontani dai miei interessi, a suo tempo, non mi avevano attratto. Ed ecco un altro termine di raffronto, l’attrazione, il fascino, la seduzione e l’incanto, lo scherzo intelligente di esistere eppure di nascondersi a noi cercatori d’oppio letterario che, stanchi, lasciamo talvolta al caso di offrirci le sue leccornie passate. È il caso de “La gola”, “Il profumo”, “Follia”, “Ritratto dell’Artista da Saltimbanco”, di cui, forse, non troverete notizia neppure in questa raccolta ma che pure consiglio di leggere per la loro ricercatezza e nascosta seduzione. “Un libro fatto di libri” quindi, che riapre una discussione sempre in corso e mai conclusa, sulla lettura e sui lettori, nel momento in cui i mezzi, gli scrittori, gli editori, i lettori, stanno cambiando con il cambiare della società e dei suoi interessi. Fa colpo trovare lo “Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana”, proposto da Cesare Bartezzaghi, nel momento in cui la ‘lingua’ sta perdendo e acquisendo connotati talvolta controversi. O “L’arte della cucina moderna” proposto da Allan Bay, quando ormai sembra non si parli d’altro ma che forse torna utile per contrastare le ‘stupidità’ di certi programmi televisivi, improbabili quanto inutili. Interessante è dir poco l’enunciato di Ginevra Bompiani che in “Vari” ipotizza quanto segue: “Se i libri non ti cambiano la vita, certo la fanno. (..) Direi piuttosto che i libri ti costruiscono la vita, la ondeggiano, la sprofondano e poi la sollevano, come un sentiero in cresta fra le colline. (..) I primi libri, quelli letti da bambino, le danno la patina l’illusione specifica. (..) I libri letti da ragazzi non hanno autore, sono sottomarini anonimi che colpiscono e affondano la corazzata bambina. Non c’è difesa da loro, non c’è protezione. L’emozione e la cattura sono totali. (..) L’emozione non ha sempre a che fare con la qualità, piuttosto con la forza. Quando si invecchia, si scopre che l’emozione è una forma di malattia. Non sempre si guarisce, ma quando la malattia si spegne, si rimane svuotati, come in una mattina di ottobre, tersa, pungente, senza veli di nebbia, persi in un orizzonte che non ha segreti”. Ed è questa malattia che spesso diventa ‘magia’ capace di stravolgere la vita con le parole. Una ‘magia’ che incanta e che lascia spazio ai sogni, alle illusioni, al canto lirico e alla poesia, quando ottimisticamente “credevamo altresì di trovarci all’alba di qualcosa di nuovo”, quel qualcosa che Enrico Brizzi nel parlarci de “Il giovane Holden” di Salinger, ci ha condotti per mano nella sensazione d’incredulità irreligiosità e diffidenza che ci attraversa tutti. Romano Montroni per primo, forse, ha dato a questa nostra epoca, la dimensione di come davvero “I libri ti cambiano la vita”.
Id: 619 Data: 14/09/2012 12:00:00
*
 Emanuele Trevi - Romanzo - Ponte alle Grazie
Emanuele Trevi - Romanzo - Ponte alle Grazie
Qualcosa di scritto
“Qualcosa di scritto”, e aggiungerei: “...perché nulla vada dimenticato” finalista al Premio Strega (ha perso per 2 voti rispetto a Piperno), è tutto un rincorrersi di ‘congiungimenti e allontanamenti’ come le pagine di un diario che l’autore, Emanuele Trevi, scrive ad effetto per incastrarvi il “suo presente” fatto di ricordi e annotazioni, che è all’origine del titolo. Una sorta di deja-vu cinematografico in cui vengono esaminati fotogrammi di esistenze passate, interni ed esterni di vite vissute interiormente, piuttosto che realisticamente, in cui l’autore ‘forza’ il lettore a entrare, volente o nolente, e ricercare nell’oblio della memoria, la zona in ombra di un sé che all’inizio nulla dice della profonda conoscenza dei due ‘soggetti letterari’ P.P.P. e L.B. (alias Pier Paolo Pasolini e Laura Betti). Ma subito il dialogo romanzato coi due si interrompe per dar luogo al ‘saggio’ tout-court, in cui ‘riporti’ e ‘congiunzioni’ del passato offrono all’autore momenti significativi di un vissuto ‘limbico’ che non poteva aver assaporato a suo tempo. Se c’è più Trevi in questo diario/saggio solo lui può dircelo. Vero è che lo scopriamo più attento e misurato, ma forse solo più maturo, che abbandona le valutazioni della politica per abbracciare in pieno la forma letteraria e la congiunzione culturale col passato che solo l’esperienza gli permette di riscoprire. Forse più vicino al ‘saggio’ che al romanzo (non per saggezza s’intende), questo ulteriore scritto di Trevi s’impone per l’accostamento al ‘partecipato’ (interiormente parlando), a quella cultura (fonte di conoscenza) che ancora, e soprattutto oggi, ci riscatta da un oblio esacerbante in cui ‘tutto’, dall’infimo al sublime, viene dimenticato. Ma non solo questo è il tema del libro, per quanto profondo possa sembrare il riscatto o l’espiazione cui sembra tendere l’autore, sempre che egli speri (?) in una redenzione che non arriverà. Altresì egli propone una sorta di “viaggio iniziatico” per affrontare l’antico ma sempre valido discorso dell’ “eterna congiunzione”, o forse “diversificazione” (dipende da che parte la si osserva), tra il ‘bene’ e il ‘male’. Lì dove il ‘male’ va ricondotto, secondo Georges Bataille, all’essere “l’unica congiunzione possibile al bene”. È così che ‘Salò’, ‘Divina Mimesis’ e ‘Petrolio’ come tante altre opere pasoliniane fanno il loro ingresso nell’immaginario letterario/cinematografico del ‘male’ a fin di ‘bene’, ove infine scopriamo che ‘non può esserci bene se non si tocca il fondo del male’. Così Dante, Sade, Caravaggio, Michelangelo, Genet, Artaud, Dostoevskij, Bukowski, Baudelaire, Wilde, Pier Paolo Pasolini, e tutti gli altri ‘maledetti’, non avrebbero ragione di essere. Lo stesso vale per Laura Betti, rediviva Demetra/Persefone nelle vesti di ‘mater maleficarum’ dei misteri eleusini, avrebbe qui ragione di essere rappresentata, se l’autore non le avesse imposto l’insolita veste di ‘maitresse’ violata e violante di esistenze altrui, affacciata al limite della soglia, oltre la quale si è perduti per sempre. Quella stessa soglia che Trevi dice va attraversata in ragione del ‘conseguimento’ o il ‘raggiungimento’ di quell’assoluto, bene/male, cui noi tutti infine tendiamo, ma che forse non ci è dato. “Qualcosa di scritto...” dunque, “...per non dimenticare”, apre a un fare ‘letteratura’ originale e innovativa, da cui ripartire per una nuova stagione del romanzo introspettivo.
Di Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, collaboratore di la Repubblica, Il Manifesto, Il Foglio, Il Messaggero va qui ricordato per la sua recente conduzione su Rai Radio 3, di “Le musiche della vita” in onda la domenica, a cura di Diana Vinci.
Emanuele Trevi sarà protagonista della serata dedicata a “Incontri con l’Autore” alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto - 8 luglio ore 21.30, ingresso libero - per la presentazione del suo ultimo romanzo, appena pubblicato da Ponte alle Grazie.
Id: 598 Data: 06/07/2012 12:00:00
*
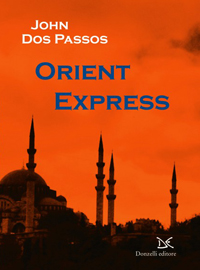 John Dos Passos - Narrativa - Donzelli Editore
John Dos Passos - Narrativa - Donzelli Editore
Orient Express
Un lungometraggio di Km di scrittura dinamica come solo può esserlo lo scorrere della pellicola sullo schermo eppure non è un film, bensì il reportage autentico di un dopoguerra visto attraverso lo sguardo, un tantino cinico e distaccato, del viaggiatore eclettico quale poteva essere John Dos Passos nel 1925/27. Ma non immaginatevi un percorso visto soltanto attraverso il finestrino del treno, in quegli anni, almeno fino a oltre il 1950, l’Orient Express non era ancora la gloria delle ferrovie nel mondo, piuttosto rappresentava un viaggio nel segno dell’avventura, che il guizzo rapido dell’autore, con una scrittura lineare e avulsa da pregiudizi di sorta, racconta con brio e un pizzico di ironia, senza lasciarsi prendere da facili sentimentalismi o piagnistei sulle cause e le conseguenze di un sfacelo imperiale che stravolse il mondo. Lo si direbbe un diario di viaggio, e almeno in parte lo è, se non fosse per quella trama sottile che l’autore insegue in ogni pagina, quasi come in un romanzo noir, e che porta a fare del suo viaggio, un costante avvenimento di situazioni e circostanze che arricchiscono il viaggiatore di notizie sugli usi e i costumi della gente che incontra, sui modi di essere e di comportarsi di intere popolazioni viste attraverso il caleidoscopio del reporter colto e raffinato che serba la sua dignità sulla punta della penna. Chissà se forse la vecchia ricaricabile col pennino d’oro non abbia influenzato la sua scrittura (?), tant’è che risulta erudita ed efficace ad ogni passaggio, senza urti e scossoni di sorta. Tale da lasciarmi pensare, che seppure qua e là dovesse risultare un poco approssimativa, lo si debba a un difetto di traduzione. Ma come si sa il passaggio da una lingua all’altra necessariamente lascia indietro qualcosa, che invece nella trama non sembra aver perso niente. Il percorso ferroviario che, solo ipoteticamente all’epoca era ‘diretto’ da Venezia attraverso i Balcani fino a Costantinopoli, e di lì attraverso i Balcani fino a Baghdad e Damasco, non corre su un binario unico o preferenziale. Come nel “giro del mondo” di Verne si è qui alle prese con interruzioni e soste improvvise, personaggi che entrano ed escono dalla scena in un battibaleno, giusto il tempo di prendere un tè, una volta nell’antica Bisanzio, un altra a Trebisonda o lungo le pendici dell’Ararat, un’altra a Baghdad e ancora a Damasco “in nome della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fraternità”. Ma non sono questi i temi della Marsigliese, come lo erano un tempo della Rivoluzione? Di quel passato e di quegli sfaceli non poi così remoto che sembra non averci insegnato niente, se ancora oggi stiamo qui a combattere gli uni contro gli altri, per la supremazia di questo e l’altro stato, per la subordinazione di uno o l’altro popolo, come se non fossimo tutti uguali, tutti quanti bisognosi di pace e di serenità. Che cosa ci facciamo noi qui? Dove stiamo andando? Lo stesso Dos Passos se lo chiedeva già allora se scrive: “Con il passare dei giorni, le colline si fanno sempre più aride e spoglie, (..) e poi ci ritroviamo a serpeggiare tra un mare verde brillante e promontori gialli riarsi dal sole. D’un tratto il treno è intrappolato in mezzo a mura fatiscenti color senape, e le rotaie si infilano tra cipressi e cumuli di immondizia, (..) e poi si arresta impercettibilmente come a un binario morto”. E dire ch’era solo ieri, e il tempo davvero sembra essere passato invano.
John Dos Passos (1896-1970) scrittore e giornalista è l’autore di alcuni capisaldi della letteratura americana come Manhattan Transfer, 42° parallelo, e altri. Viaggiatore fin dall’infanzia, non smise mai di spingersi al di là dei confini statunitensi: dal Medio Oriente al Messico, dalla Russia al Sudamerica. Il suo tenace impegno politico, che lo portò in Spagna durante la guerra civile, ne fa una delle figure più significative e turbolente nel panorama degli intellettuali del Novecento.
Id: 590 Data: 26/06/2012 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Rivista - Gruppo Editoriale l’Espresso
Aa. Vv. - Rivista - Gruppo Editoriale l’Espresso
MicroMega - Almanacco di Filosofia
Contributi di Flores d’Arcais, Mancuso, Pievani, padre Coyne, Diamond Pogge, Beeck, Rosanvallon, Lefort, Rawls, Van Parijs, Corradetti, Ferraris, Viano, Semprìm.
Come ci avverte Hannah Arendt già nel frontespizio: “La libertà di opinione è una farsa a meno che non venga garantita l’informazione fattuale e i fatti stessi non siano sottratti alla controversia”. Che dire? La controversia è insita nell’opinione, altrimenti che opinione è? In realtà quella aperta tra Paolo Flores D’Arcais e Vito Mancuso nel testo d’apertura “Il caso e l’illusione: Dio e l’anima immortale di fronte al tribunale della scienza” si pone su questa scia nella convinzione che “nulla possa essere ragionevolmente affermato che contraddica ciò che oggi la scienza ci dice. Penso che in realtà condividiamo anche alcuni valori essenziali etico-politici, non però il modo di «fondarli». E oltre a questo dissenso –non l’unico in verità – sul fondamento della morale ci dividiamo sulle due convinzioni esistenziali più profonde: l’esistenza di Dio e di un’anima immortale” . Concentrati sui dissensi pur esistenti e profondi fra i due, che in verità si dibattono in modo tutt’altro che ‘arrendevoli’ assistiamo a una schermaglia tutt’altro che ortodossa, anzi dire piuttosto eterodossa e ingenerosa perché superflua: “Tu credi in Dio e nell’anima immortale, io no”. Ma se un’affermazione come questa porta ad accendere ancor più la controversia, è maggiormente interessante andarsi a leggere come i due si conducono nel labirinto che hanno appena scoperchiato e che chiede di essere percorso (da entrambi) fino in fondo, ben inteso dopo aver raggiunto il centro della ‘questione’ filosofica-verbale-letteraria, affatto facile, e non solo perché si trascina da millenni. “Un’ipotesi superflua è un’ipotesi inammissibile?” È la domanda, cui anche noi vogliamo e dobbiamo rispondere, se non altro per confermare una possibilità di accesso a quella libertà (alla controversia) cui si riferiva Hannah Arendt all’inizio. Quindi andiamo a posizionarci tutti (noi lettori) sulla stessa linea di partenza dei due autori pronti ad entrare nel labirinto ma prima controlliamo bene che nessuno, e dico nessuno soprattutto Flores d’Arcais, novello Teseo, che non nasconda da qualche parte il filo di Arianna. Sarebbe per lui fin troppo facile raggiungere per primo il centro della ‘questione’ e uscire vittorioso dal labirinto, dopo averci detto che in fondo il Minotauro/Dio “era soltanto un’ipotesi superflua”. Sarebbe come se il viaggio labirintico mirasse a quella sorgente che è anche “la scaturigine radicale del senso e del linguaggio; quel cammino spirituale che accetta e conduce fino in fondo la grande sfida iniziatica di morire-per-rinascere”. Questo intende Kerényi quando scrive che, “per risvegliare la realtà mitologica del labirinto dobbiamo immaginarcelo dentro di noi, e trasferirci in esso”. Tuttavia l’autore riafferma la sua fiducia umanistica quando asserisce che il mondo della mitologia è “un mondo dell’uomo”: un mondo cioè, “totalmente orientato sull’uomo” (insieme filosofico e storico-religioso). Noi quindi, l’uomo (sapiens, sapiens?), viene da chiedersi? Bene risponde Vito Mancuso: “Sulla base della scienza non si può costruire alcuna metafisica, ma non si può neppure distruggere alcuna metafisica”. E noi? L’essenziale è la profetica/poetica certezza che il labirinto è un passaggio, un attraversamento e che, in fondo, come oscuramente sa “la vita stessa”, una soluzione si troverà, una via d’uscita c’è pur sempre. Se non dalla metafisica, certamente dalla filosofia per quel diritto/dovere che abbiamo di sopravvivere.
Di grande interesse “Evoluzione e contingenza” di Telmo Piovani, il quale ci pone davanti a un’altra quaestio non meno drammatica della precedente: “In questo quadro, che fine fa l’idea di Dio? È possibile pensare un Dio che non abbia previsto le conseguenze della sua stessa creazione? Un Dio, dunque, dell’immanenza e della contingenza? Per l’ex direttore della Specola Vaticana, è l’unico Dio pensabile. Come dire che è l’unico Dio possibile (?) “Vorrei premettere fin da subito – egli dice – un punto fondamentale: nella migliore tradizione giudaico-cristiana, ogni qualvolta noi parliamo di Dio finiamo semplicemente per balbettare (..) essendo di conseguenza spinti a rispondere in qualità di creature di Dio, viventi e intelligenti”. È davvero così, alla fin fine sembriamo tutti balbuzienti, finanche Dio stesso, per quello che ci dicono di Lui, sembra rifarci il verso, quasi Egli fosse lo stesso eroe del labirinto che si spinge audace verso la morte, in cerca dell’uscita per una-nuova-rinascita. E alla fine “solo il sapiente non si lascia ingannare dall’enigma: lui solo sa ingannare l’inganno, sa trovare la via d’ingresso, sa riconoscere il luogo della “svolta” per il ritorno. La “svolta” è facile, la via del labirinto non è ingannevole, questo eroe può gioire del labirinto, per lui il “passaggio è sicuro”, il poros conduce al di là dell’ostacolo, discioglie l’enigma dell’aporia” (Corrado Bologna). È possibile lo scioglimento dell’enigma, lo svelamento del mistero? “Le idee religiose non sono sorte come risposte alle domande; le religioni non sono soluzioni di problemi: esse aumentano piuttosto i possibili problemi del mondo, e in modo considerevole, diventando presupposti di questioni e risposte”. A noi quindi non rimane che il dubbio di affidarci alla cieca volontà di Teseo, alla sua supremazia, soprattutto quando afferma che nell’idea di Dio non è prevista alcuna conseguenza alla sua stessa creazione, e che Dio, dunque, sopravvive nell’immanenza e nella contingenza di quanti di noi hanno chinato la testa alla sua supremazia di Eroe vincitore sopra tutto e contro tutto, se non addirittura contro se stesso. Oppure, affidarci a quel “libero arbitrio” insito/intuitivo che ci vuole – come appunto affermava Hannah Arendt, per la quale “La libertà di opinione è una farsa a meno che non venga garantita l’informazione fattuale e i fatti stessi non siano sottratti alla controversia”. E questa non è più filosofia, quanto invece è metafisica, cioè pura invenzione pre-intenzionale.
Va qui detto che gli interventi che seguono su “L’origine e il futuro dei diritti umani” di Jared Diamond, “Lo scandalo della fame” di Thomas Pogge, “Mondializzare i diritti umani” di Ulrich Beck, “Sulla democrazia” di Claude Lefort e “Dialogo sull’Europa” di Philippe Van Parijs, non fanno che evidenziare quelle che sono le autentiche necessità dell’intera comunità umana di oggi che abbisogna di qualcosa di più “terreno” su cui far affondare le proprie radici per una rinascita sostenibile anche “spirituale” che vede il comportamento di Dio (soprattutto del Dio cristiano) coerente e responsabile all’interno di una Chiesa che va incontro alle genti non con l’arroganza della spettacolarità, quanto con l’umiltà francescana del puro amore per l’amore. Ma forse è chiedere troppo, la lucidità patinata della Chiesa non ha ampliato il dialogare di Cristo, l’ha solo imposto e continua a farlo sbagliando, mentre invece dovrebbe spalancare le braccia alla innovazione e alla scienza, perché solo in questo modo sarà in grado un giorno di abbracciare la vera grandezza di Dio. Faccio qui riferimento al testo “Solo la fratellanza ci può salvare” di Jorge Semprùn in conversazione con martin Legros, che ci permette, se non una rivalsa, di riprenderci almeno quella speranza di cui questa società sente più il bisogno. È dunque questa la direzione in cui bisogna andare, tutti su un’unica strada, partenza/arrivo, che attraversato il labirinto abbandoni “Le debolezze del ‘pensiero debole’” di Maurizio Ferraris e C. A. Viano, per “mettere in relazione il mondo della scienza (della filosofia, della creatività, della poesia), con quello del (buon) senso comune”.
Come lo stesso M. Ferraris afferma in chiusura del suo articolo: «La grande accusa mossa ai filosofi di aver “sempre offerto giustificazione alle finzioni”».
Id: 586 Data: 29/05/2012 12:00:00
*
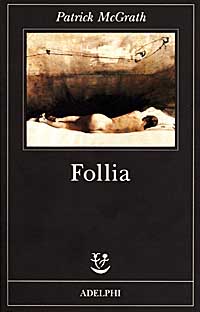 Patrick McGrath - Narrativa - Adelphi
Patrick McGrath - Narrativa - Adelphi
Follia
Una corrispondenza indissolubile tiene legato l’amore alla follia come la vita alla morte. Una equazione quasi scontata si direbbe se la soluzione non fosse che all’amore interiore, veritiero, intimistico, non corrispondesse un grado di follia estremo, viscerale, profondamente vissuto come quello intriso di libidine vischiosa, dell’olfatto che sale alle narici e che traspira attraverso l’epidermide, in queste pagine fortemente letali. Ci si accorge ben presto che nessuno di noi (lettori) è avulso dal trovare in queste pagine qualcosa che lo riguarda da vicino, nell’inconscio che pure ottenebra la tormentosa vicenda dell’amore, in ciò ch’è insito nella ‘follia’ d’amare cui ognuno va soggetto. Perché non c’è amore senza conoscere quel fuoco inspiegabile, incomprensibile, che attanaglia gli uni agli altri in una morsa che non lascia scampo se non nella morte. Inutile illudersi che dalla presa ci si possa infine liberare, chi vi riesce indugia nella finzione, nell’illusione che alla vita corrisponda un’altra vita o la possibilità del risorgere in un'altra vita, diversa, nuova, straordinariamente felice. È falso, ci dice l’autore, alias lo psichiatra-narratore di questa storia d’autentica follia, al punto che egli stesso s’innamora della sua paziente Stella, che in una seduta gli rivela la profondità e l’incontrollabilità di una scelta scriteriata: “Non si controlla un innamoramento, non è possibile. La verità è che non ho scelto affatto”. È questa l’anamnesi di una verità patologica che ci rivela in pieno il mistero della nostra fragilità di fronte a un sentimento oscuro come l’amore, divertente ed eccitante, piacevole e allarmante quanto spaventoso, aggressivo e violento, che in qualche modo ci rende umani. E qui l’autore, in quanto essere umano, si rivela narcisista ancor prima che un infatuato edonista, si offre e ci offre, la possibilità di un riscatto da qualunque accadimento sia fatto in nome dell’amore, col dire che ciò avviene: “Senza una ragione al mondo, ovviamente, o forse proprio per questo, sì, perché la fiducia, e la speranza e l’amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione”.
Ma se la trama non ci è nuova, lo stesso Freud s’innamorò della sua paziente Anna O., cosa che gli fece dire: “Il fatto di dipendere dall'oggetto amato fa calare l'autostima, chi ama è umile. Chi ama ha, per così dire, rinunciato a una parte del suo narcisismo, e tale parte può essere rimpiazzata solo dal venire ricambiato in amore”. E se come Freud ancora dice: “La lingua serve non solo ad esprimere i propri pensieri ma soprattutto a comunicarli agli altri”, dalle pagine di questo romanzo apprendiamo che “i motivi base per ogni azione umana sono la sessualità e l’ambizione”, e non ci resta che ammettere che “l’amore” sta “all’odio” come perfetto opposto di questa vicenda “cupa e tormentosa”. A chiunque (di noi lettori), in tal caso, riuscirebbe impossibile anche solo darsi un contegno e potrebbe perdere le proprie fragili sicurezze: “In alternativa all’odio Stella provava solo indifferenza, un senso di vuoto, di morte, di freddezza in cui riconosceva una forma di aggressività passiva”, valutabile come una forma di “follia” ancora più audace, perché più intransigente quanto intollerabile, che inquieta chi ne è succube, facendolo sentire sempre sotto scacco, al quale non concede possibilità di scampo. Se non volete mettere a repentaglio la vostra integrità morale e psichica non leggete questo romanzo perché potreste scoprirvi qualcosa di “voi stessi” che non vi piacerà, ché in amore tutto può diventare lecito, se suggerito da un sentimento profondo che porta alla follia. Sulla scena letteraria odierna ormai non si muovono che fantasmi, pur tuttavia ingegnosi e attenti a scuotere le tende del palcoscenico impolverato dei nostri sentimenti, con nuove sceneggiature, nuovi protagonisti, nuovi abbagli di luci, per cui, alla fine, l’applauso è di rigore. Ma seppure lasciamo ad Emily Brontë di fornirci la chiusa del dramma, nell’ombra delle quinte è l’anziana “Lady Chatterley” a suggerirci cosa davvero significa amare.
Adeguati alla lettura di genere:
David Herbert Lawrence – “L’amante di Lady Chatterley”
Emily Bronte – “Cime tempestose”
Grazia Deledda – “Canne al vento”
Oscar Wilde – “Il ritratto di Dorian Gray”
(saggi/romanzi su S. Freud)
Irving Stone – “Le passioni della mente”
Jed Rubenfeld – “Linterpretazione della morte”
Id: 581 Data: 19/06/2012 12:00:00
*
Jean Starobinski - Saggio - Boringhieri
Ritratto dell’Artista da Saltimbanco
Jean Starobinski “Ritratto dell’Artista da Saltimbanco” – Boringhieri 1984 (ristampa)
Molti in verità sono i libri che porterei con me in un ultimo viaggio, per rileggerne alcuni nel tempo dell’attraversamento, se non fosse per l’extra che mi verrebbe richiesto, dovuto al sovrappeso. E sarebbe un eccesso bagaglio che comunque pagherei volentieri. Pochi tuttavia sarebbero quelli che mi accompagnerebbero fino alla meta, cioè oltre la soglia della nuova casa che dovrebbe ospitarmi: la Bibbia, la Divina Commedia, le Mille e una Notte, il Milione e sicuramente questo piccolo “non meno grande degli altri” libro di Jean Starobinski. Un breve saggio (che si legge come un romanzo) pari ad un ‘gioiello’ che mai arte orafa abbia elaborato, e c’è più di un perché che lo rende ‘prezioso’. Mai come questa volta sto parlando di un ‘libro’ per il piacere di descriverne il contenuto nella pur brevità del testo che l’accompagna: il discorso iconografico affine alla tematica dell’arte, l’accessibilità della scrittura elegante per quanto ricercata, la pregiata scelta poetica che include Baudelaire, Apollinaire, Rilke ed altri, la sobrietà del ritratto culturale di un mondo quasi scomparso che rivive in queste pagine al pari di una resurrezione.
Il ‘libro’ (l’autore) attinge alla ‘storia dell’arte’ estrapolandone l’elemento ludico del Clown: Buffone di corte, Arlecchino, Pierrot, Augusto ecc. di shakespeariana e goldoniana memoria (solo per citarne alcuni), districandosi in un percorso immaginativo che sfugge finanche all’ottimo cultore; a quella ‘storia del teatro’ che i migliori critici non hanno saputo districare; alla raffinata critica letteraria per cui le parole acquistano senso; alla psicologia del profondo incredibilmente attuale, spiegata con la garbatezza di chi (l’autore), pur dovendo fronteggiare una ineluttabile ‘fine’, riesce a farci amare. Ma preferisco qui rifarmi alla colta introduzione: “Ritratto del critico da domatore di fantasmi” dovuta a Corrado Bologna, la cui peculiarità sta nel fornire al lettore la chiave di lettura della ‘cifra’ letteraria e psicologica di Jean Starobinski che, altrimenti, finirei per sminuire o malvolentieri scopiazzare.
“Il saggio si interroga sulla natura dell’interesse che da più di un secolo gli artisti hanno portato alla figura del saltimbanco, dell’acrobata, del clown, sino a identificarsi in quella. La scelta dell’immagine del clown non è solo d’ordine pittorico o poetico: sotto mentite spoglie equestri, gli artisti hanno spesso consegnato il proprio autoritratto, e insieme si sono interrogati sulla natura della propria condizione, per molti versi affine a quella del saltimbanco: da Flaubert a Jarry, da Joyce a Picasso, a Henry Miller. Frutto di una sensibilità originalissima in cui si mediano livelli diversi di lettura critica – da quella psicologica a quella più propriamente letteraria – la rivisitazione del mito del clown sembra qui assumere la stessa levità fantastica dell’oggetto che descrive: emerge così una storia di immagini e per immagini i cui significati reconditi vengono accennati, sfiorati, mai imbrigliati in una trama di spiegazioni totalizzanti”.
Totalizzante è invece la straordinaria ampiezza della tematica che si apre davanti ai nostri occhi nel rivivere con occhio critico i momenti salienti di un qualcosa che è parte integrante della nostra ‘storia’ personale, almeno di quanti di noi, ancora oggi, vedono nell’arte circense e in particolar modo nella figura del clown, quel ‘meraviglioso’ che ci ha accompagnati durante l’infanzia e ancora oggi ci sorprende e ci affascina, con quel tanto di malinconia che ci accompagna. La ‘Grande Fiera’ e il ‘Luna Park’ come sinonimi che si compenetrano e si completano a vicenda. Chi non ha vissuto questa esperienza, forse, non comprende ciò di cui sto parlando, tuttavia era, e tutt’oggi lo è, si pensi al “Cirque du Soleil” (*) che ha estrapolato e continua a farlo, quel mondo fantastico dell’arte circense, che andava ‘oltre’ i limiti geografici della comprensione e della conoscenza: quella ‘Piazza Universale’ (**) in cui noi ragazzi e non più giovani ‘clown senza arte ma pur sempre clown’, avremmo volentieri giocato all’infinito.
Jean Starobinski, nasce a Ginevra nel 1920, psichiatra e critico letterario, ha insegnato Storia della letteratura francese e Storia della medicina presso l’Università della sua città natale. La sua vasta produzione saggistica annovera fra l’altro importanti studi su Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Montaigne e Baudelaire. I suoi libri, tradotti in una dozzina di lingue, sono stati di valido aiuto per la critica contemporanea, arricchendo di nuovi punti di vista su vasti temi, il panorama critico letterario. Si è occupato in numerose opere della creazione poetica nella poesia contemporanea e dei problemi dell'interpretazione: i suoi saggi sull'arte del XVII secolo sono ormai considerati dei classici. La sua esperienza di medico e di psichiatra lo spinsero a studiare la storia della malinconia (in Trois Fureurs, 1974); è membro dell'Académie des sciences morales et politiques dell'Institut de France e di numerose altre accademie francesi, europee ed statunitensi. Fra i riconoscimenti più significativi alla sua attività figura l’assegnazione nel 1984 del “Premio Balzan” per la storia e la critica letteraria; nel 1998 ha vinto il Premio Grinzane Cavour.
Opere: (selezione)
• La scoperta della libertà (1964), trad. it. Milano: Fabbri, 1965.
• Il concetto di nostalgia (1966), trad. it. Alessandro Serra, in Antonio Prete (a cura di), Nostalgia. Storia di un sentimento, Milano: Raffaello Cortina, 1992.
• Anatomia della malinconia, Venezia: Marsilio, 1983.
• La coscienza e i suoi antagonisti (1981), trad it. Marina Astrologo e Simona Cigliana, Roma: Theoria, 1995, n.ed. Milano: SE, 2000.
• La malinconia allo specchio. Tre letture di Baudelaire (1989), trad. it. Daniela De Agostini, Milano: Garzanti, 1990.
• Storia del trattamento della malinconia dalle origini al 1900, trad. it. Franco Paracchini, Milano: Guerini, 1990.
• La maschera e l'uomo, intervista di Guido Ferrari, Milano: Jaca Book, 1990.
Note:
(*) Cirque du Soleil - DVD Panorama “Drailion” – “Saltimbanco” – “Varekai” – “Alegria” – “Nouvelle Expérience” – “Quidam” – per una trasformazione del tuo mondo in arte e allegria.
(**) “La Piazza Universale: giochi, spettacoli, macchine di fiere e luna park” – Catalogo della Mostra a cura di Elisabetta Silvestrini – Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari Roma – Mondadori 1988.
Id: 566 Data: 17/04/2012 12:00:00
*
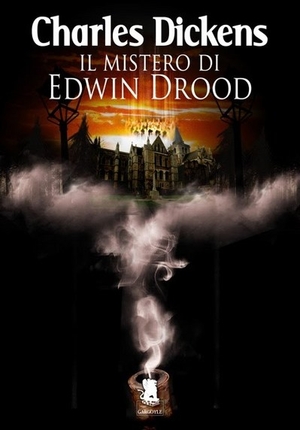 Charles Dickens - Romanzo - Gargoyle
Charles Dickens - Romanzo - Gargoyle
Il Mistero di Edwin Drood
IL “CASO” LETTERARIO
Per commemorare i duecento anni della nascita del ‘genio inglese’ della letteratura, (del quale davvero pochi si sono ricordati), esce in libreria l’unico ‘mystery’ della sua produzione di romanziere: “lI mistero di Edwin Drood” l’opera incompiuta di Charles Dickens (Portsmouth, 7 febbraio 1812 – Gadshill, 9 giugno 1870), ultimo romanzo scritto dall'autore e pubblicato postumo nel 1870. Dalla sua pubblicazione le supposizioni su come Dickens avrebbe portato a termine la storia si sono susseguite a iosa: eminenti scrittori, letterati, registi cinematografici, autori televisivi, di teatro, narratori e disegnatori di fumetti se ne sono occupati a più riprese per trovare (riscrivere) un finale all’accattivante mystery rivoluzionario della letteratura fine ’800. La partita è ancora aperta in quanto le poche note, lasciate dallo stesso Dickens, sviano dal permettere al lettore di avvalersi della propria ragione o fantasia per condurre la storia a una certa conclusione. Il resto sono allusioni, sottigliezze, performance più o meno argute, cauterizzazioni di ferite psicologiche instaurate nei personaggi, che essi stessi non riescono a risolvere. E chissà se lo stesso Dickens volesse dare una ‘chiusa’ al romanzo oppure lasciarlo all’arguzia dei suoi moltissimi lettori (?). Fatto è che possiamo classificarlo tra quei romanzi che, pur risentendo dell’epoca (vittoriana) in cui è stato scritto, rompe con l’epoca stessa per accedere al ‘noir’ moderno, col farsi portatore di una nuova fase di scrittura che va oltre la costruzione della realtà sociale cui l’autore stesso ci aveva abituati. Prevenendo quasi la veemenza del ‘maestro del brivido’ per eccellenza, Alfred J. Hitchcock, Dickens ci dice che nulla esiste al di fuori del testo, insegnando a tutti coloro che verranno dopo come far sparire il mondo all’interno del testo. Esattamente come A. Hitchcock fa, cioè lasciare allo spettatore la parte più interessante del racconto: quello di pensare-dedurre-immaginare il finale che sia consono con le proprie aspettative. Cosa che ognuno di noi spettatori-lettori-affabulatori fa, sia che legga un libro o visioni un film, sia quando racconta una storia-fiaba-fatto di cronaca che lo ha colpito ed elabora secondo la propria esperienza culturale, o la propria visione dell’esistenza, spesso accalorandosi e immedesimandosi ora in questo ora in quel personaggio che più lo rappresenta, così mettendo in moto una sorta di manuale ontologico che ci permette di capire e farci capire dall’interlocutore. Ma chi è Edwin Drood? Un nessuno qualsiasi (e questo è il succo del romanzo), un giovane della ricca borghesia inglese prossimo al matrimonio che sparisce in circostanze misteriose, del quale le indagini (psicologiche) non ci dicono nulla di più di quanto è detto nelle righe a lui dedicate. Un’apertura dell’autore all’allora psicoanalisi freudiana che si affacciava sulla scena medica proprio sul finire del secolo? Non lo sapremo mai, anche se indubbiamente, dopo averci propinato (si fa per dire) le angherie della società nei suoi romanzi precedenti, Dickens sentiva il bisogno di riscattare una colpa ‘letteraria’ non sua. Fatto è che gli elementi per inglobarlo nel filone ‘mystery’ ci sono tutti, dalle bambole di Carroll, alle segrete di Poe, ai cimiteri di Lovecraft, ai soggetti ‘psichici’ di de la Mare, Machen e Blackwood prosecutori del filone cosiddetto ‘gotico’, che da Walpole passa per E.T.A. Hoffmann, Irving Washington, che portano al ‘fantasy’ e includono gli autori praghesi, per finire con Alfredo Castelli creatore di ‘Martyn Mystere’ che di Edwin Drood si è occupato, nel fumetto "Martin Mystere" nn. 77-78: "La regina degli gnomi" - "Il ragazzo prodigio" (agosto-settembre 1988).
La morte di Dickens (avvenuta in circostanze misteriose) ha reso sconosciuto per sempre il seguito della storia. Comunque, Dickens lasciò scritta una traccia base della storia e di come aveva pensato di concluderla, in una lettera spedita al suo biografo e amico John Forster. Tuttavia, vista l'incompiutezza del romanzo, non si sa se Edwin sia stato ucciso o sia fuggito. Diverse ipotesi sono state fatte da allora. Sebbene il killer non venga mai rivelato, il libro offre molteplici indizi del fatto che il colpevole sia John Jasper, lo zio di Edwin, e pensate, semplicemente per l’ossessiva bramosia-gelosia del nipote che sta per sposarsi con la ‘bella’ (bambola) Rosa Bud di cui è segretamente e follemente innamorato. Cosa che John Jasper, durante un assolato pomeriggio, quasi un anno dopo la scomparsa di Edwin; lui le confida che il suo amore per lei è così grande che non avrebbe esitato a togliere di mezzo il nipote se fosse stato necessario per coronarlo. Ma ecco entra in scena Dickens/Freud/Hitchcock che si avvale di un qualcosa che lo zio Jasper aveva detto durante il suo annebbiamento dovuto all'oppio. Jasper dice a Puffer alla fine del libro: «Supponiamo che tu abbia in mente qualcosa; qualcosa che stai per fare... Lo fai solo nella tua fantasia, stando sdraiato qui? ... L'ho fatto più e più volte. L'ho fatto centinaia di migliaia di volte in questa stanza». Mr. Jasper si sta forse riferendo qui all'omicidio di Edwin? Forse, chissà, il bello è nel fatto che la sfida è ancora aperta e ognuno di noi (lettori-scrittori-narratori) possiamo ancora dare una svolta alla storia che un ‘grande’ della letteratura ci ha lasciato in eredità. Il libro inizia con un uomo, che più tardi scopriremo essere John Jasper, che esce da una fumeria d’oppio a Londra. La sera dopo, Edwin Drood va a trovare Jasper, suo zio, il direttore del coro della cattedrale di Cloisterham. Edwin gli confida i suoi dubbi circa il suo fidanzamento con Rosa Bud. Il giorno seguente, Edwin visita Rosa al convento di suore dove lei risiede e frequenta la scuola. I due bisticciano bonariamente, cosa che sembrano fare spesso durante le visite di lui. Nel frattempo, avendo un forte interesse verso il cimitero della cattedrale, Jasper cerca la compagnia di Durdles, un uomo che conosce il cimitero meglio di chiunque altro... (il resto vi aspetta in libreria). Ma è interessante conoscere quali sono, fin qui, le opere che ne sono state tratte. Lo scrittore inglese Leon Garfield nel 1980 ha tentato di trovare un finale a ‘Il mistero di Edwin Drood’, dando alle stampe una nuova versione dell'opera completa dei capitoli mancanti. Così i due autori italiani Fruttero & Lucentini che, sempre nel 1980, hanno indagato sulla scomparsa di Edwin, con il loro ‘La verità sul caso D.’, in cui i più grandi investigatori della letteratura sono chiamati a risolvere il caso. Di certo l'ipotesi degli scrittori, esposta da Hercule Poirot, è affascinante e fantasiosa: Edwin rappresenta lo stesso Dickens, anch'egli morto in circostanze misteriose. Interessante è anche quanto apprendiamo dagli autori di “Martyn Mystere” in cui si parla ampiamente del romanzo. Inoltre, un bambino stranamente molto sapiente, si immagina e scrive una fantasiosa e ben riuscita fine del celebre libro di Dickens, nel quale Neville Landless (altro innamorato in pericolo di vita) l'avrebbe drogato grazie all'oppio fornito da Rosa, minandone la sua capacità di pensiero. Jasper si rivela quindi il vero tutore della ragazza, che conoscendo i suoi disturbi psichichi la protegge da eventuali brutte figure che potrebbero portare a pensare che sia pazza. Addirittura Jasper assolda un attore, che non è che Ditcher. Alla fine Neville, scoperto, si suicida e Ditcher, sposa una Rosa ormai guarita, della quale si era innamorato, come se fosse davvero stato Edwin Drood. Ancora nel 2009 lo scrittore statunitense Matthew Pearl pubblica il romanzo di ambientazione storica ‘Il ladro di libri incompiuti’ (titolo che trovo straordinario), in cui la sorte del romanzo incompiuto di Dickens si intreccia con quella del suo autore. Nello stesso anno in cui anche Dan Simmons riscrive il romanzo dickensiano col titolo ‘Drood’.
In italiano il romanzo è stato pubblicato:
Trad. e cura di Stefano Manferlotti, Guida, Napoli 1983 (con introduzione di Guido Almansi). Trad. di Pier Francesco Paolini, Rusconi Libri, 1984 (con introduzione di Edward Blishen e illustrazioni di Antony Maitland).
Trad. di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Einaudi, 1990 (ed. ridotta, riscritta e continuata con il titolo ‘La verità sul caso D.’) a cura di Marisa Sestito, Utet, Torino 2009.
Nuova edizione riveduta e aggiornata, traduzione di Stefano Manferlotti, Gargoyle, Roma, 2012.
Versioni cinematografiche:
1909 ‘The Mystery of Edwin Drood’ di Arthur Gilbert (UK-Gaumont) con Cooper Willis.
1914 ‘The Mystery of Edwin Drood’ di Herbert Blaché, Tom Terriss (World FIlm) con Tom Terriss.
1935 ‘Mystery of Edwin Drood’ di Stuart Walker (Universal) con Claude Rains.
Nel 1960, appare alla tv britannica in una serie omonima di 8 episodi di 30 minuti l'uno.
1993 ‘The Mystery of Edwin Drood’ di Timothy Forder (UK-First Standard Media) con Robert Powell.
Suggerimenti:
Consiglio di leggere la forbita introduzione curata da Stefano Marfellotti dopo la lettura del romanzo.
Nota: (ma non ce n’era assolutamente bisogno)
Charles Dickens è stato uno scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico, noto tanto per le sue prove umoristiche (Il Circolo Pickwick), quanto per i suoi romanzi sociali (Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili), è considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi, nonché uno dei più popolari.
Id: 554 Data: 23/03/2012 12:00:00
*
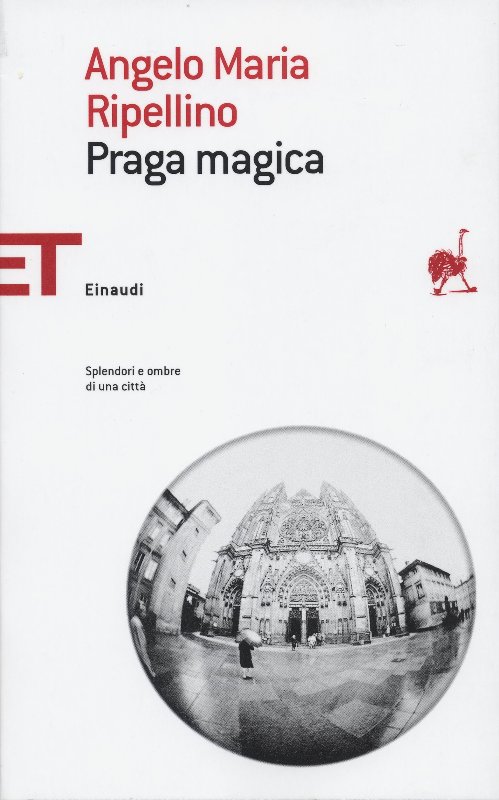 Angelo Maria Ripellino - Saggio - Einaudi
Angelo Maria Ripellino - Saggio - Einaudi
Praga Magica
Bohumil Hrabal, Franz Kafka, Vladimìr Holan, Vitezslav Nezval, Oscar Wiener, Gustav Meyrink e almeno mille altri letterati della Mitteleuropa, ma anche sovrani, eroi e santi, poeti, artisti, scultori, architetti, fanfaluchi, maghi, alchimisti, astrologi, rabbini, poveracci, ubriaconi, miserabili, streghe e puttane sono qui riuniti nella ‘grande piazza universale’ che Ripellino ha ricostruito per chi, armato di buona volontà e poco discernimento delle lingue slave, abbia voglia di conoscere ‘I segreti e i misteri di Praga’, come un tempo si usava almanaccare certi libri che accoglievano di tutto un po’, articolandosi tra storia e leggenda, nel labirinto oscuro d’un passato mai del tutto dimenticato. Chi ha visitato Praga di recente ha avuto senz’altro la ‘sensazione’ di imbattersi in qualcosa di straniante, che va dallo ‘straordinario occulto’ al ‘meraviglioso decadente’, che sposta l’obiettivo attraverso il tempo, ora per accalappiare, ora per stordire il visitatore attratto. Il Golem è nato qui, nel decrepito Quartiere Ebraico fatto di strette e tortuose vie che portano tutte al vecchio dismesso Cimitero. Il Castello che, una volta attraversata la Città Vecchia (Stare Mesto), la Moldava che scorre tra gli archi gotici del Ponte Carlo, e Mala Strana, è quello esaltato da Kafka. I personaggi che vi si incontrano sembrano tutti usciti dai quadri antropofagi dell’Arcimboldo. Ma i riferimenti non finiscono qui, Ripellino vizia il lettore goloso di conoscere le ‘storie’ degli altri, le ‘vite’ di quanti hanno fatto di questa città, una città magica per eccellenza, un vivaio di fantasmi che continuano a ‘vivere’ nelle pieghe pietrose della città gotico-barocca, a invadere le strade e le piazze e mescolarsi nel brulichio della folla di turisti, di viaggiatori, di poeti, e di quanti ‘illusionisti del tempo che passa’, vagano tra i banchi e i rifiuti del ‘tandlmark’ il vecchio mercato che raccoglie di tutto. Ed écco, il ‘sensazionale narrativo’ accalappiarci nel gioco vorticoso, impossessarsi del lettore fino a farlo diventare, personaggio del grande teatro del mondo: farsi alchimista nella via a questi dedicata; Golem nelle case sbilenche del quartiere ebraico; spassarsela nottetempo con le statue volanti del ponte Carlo e, perché no, entrare in una vecchia ‘taverna’ male illuminata dalle fioche lanterne a gas, che la modernità ha strasformato in elegante luogo di ritrovo, e rivivere le sgangherate nottate da lupanare al suono di un organetto e grida e risate gustando le specialità gastronomiche innaffiate da buoni vini locali, o birra. Ma divagavo, e già Ripellino ci invita (ci trascina per i capelli) a fare incetta dei famosi ‘cristalli di Bohemia’ che per lui sono i ‘pettegolezzi’ e le ‘dicerie’ della gente (artisti, poeti, narratori) sebbene trascritte in opuscoli, incunaboli, fogliacci, carta straccia, in forma di romanzi, leggende, fiabe, racconti, poesia. Sì poesia, perché Ripellino cosparge la sua raccolta di poesia liquida, solo apparentemente superficiale lì dove osserva un bel quadro, o accarezza un statua scolpita nella pietra, il suo sguardo penetra la vernice del quadro per vedere quelle che c’è dietro, graffia via la crosta che il tempo ha lasciato sulla pietra per scoprire ciò che vi è sotto, quasi la pietra avesse un’anima. Ebbene l’autore non nega che un’anima ce l’ha, l’anima della pietra, così come ce l’ha lo scalpello che l’ha scalfita, così com’era nella mente e nello sguardo dell’artista che l’ha scolpita. E ce la racconta, come fosse la sua, scandagliata fino all’inverosimile, in pagine memorabili dove finanche il passante s’arresta davanti alle statue disseminate sul Ponte Carlo, e “ostenta un assorto sussiego fissando le calcinose pupille nel vuoto dei cieli”:
«Sia che rassembrino conversioni e miracoli, le statue di questo cammino della perfezione hanno tutte sostanza teatrale nei gesti, nel pathos, nello sventolio delle tonache. L’orgoglio , la spocchia, una certa spacconeria si mescono in esse con l’ansia di vincere pesantezza che le avvince alla terra. Penso all’enfasi dei santi … Nessuno di questi santi appare inerte e appagato e, a differenza di Praga stessa, nessuno soffre di catatonìa: sulle scoscese come dirupi ribalte dei piedistalli danno simultaneamente spettacolo con esagitate o solenni movenze da istrioni celesti e con abilità equilibristica, a ogni mossa rischiando di scivolare dai disagiosissimi greppi. … Nemmeno dopo il tramonto le statue cessano di recitare. Un tempo la diceria sosteneva che a mezzanotte discutessero con desertissimi termini e capziosità teologale, e nelle taverne gli ubriachi ne riferivano i dialoghi immaginari».
Sì, certo, il lettore distratto potrebbe biasimare che questa Praga non esiste più, ma non avrebbe ragione, perché Praga è ancora lì, magica e orgogliosa di esserlo che aspetta una sua visita. Città d’oro, città dalle cento torri, sinfonia di pietre, colori e forme, così viene da sempre descritta, come una delle più belle capitali europee: città di sortilegi, vetrina di splendori, labirinto febbrile, teatro di quinte, circo di clownerie, ma attenzione, la ‘fiaba’ di Praga riscritta da Ripellino rivela una città singolare dotta e intrigante, dal fascino misterioso e irresistibile, che strega. Lo rivela il suono delle parole, un italiano forbito che avevamo quasi dimenticato, aggettivi inusuali, velleità linguistiche, articolazioni oggettivali, manipolazioni poetiche, satiriche, clownesche che pure danno alla scrittura una fluidità quasi incandescente. Si è presi nel gioco dei rimandi, del sentito dire, mentre invece è tutto straordinariamente e infaticabilmente documentato, con una meticolosità certosina, calligrafata, che quasi sembra di leggere, al posto dei capitoli, resoconti di viaggio, esperienze inusitate trasferite in corrispondenza, come tante lettere spedite a mittenti sconosciuti, così, per celia, o forse più astutamente, per finzione teatrale:
«Ancor oggi, ogni notte, alle cinque, Franz Kafka ritorna a via Celetnà (Zeltnergasse) a casa sua, con bombetta, vestito di nero. Ancor oggi, ogni notte, Jaroslav Hasek, in qualche taverna, proclama ai compagni di gozzoviglia …».
Id: 519 Data: 21/02/2012 12:00:00
*
 John Underwood - Romanzo - Newton Compton Editori
John Underwood - Romanzo - Newton Compton Editori
Il libro Segreto di Shakespeare
“ANONYMOUS”, dal libro di John Underwood, al film di Roland Emmerich.
John Undewood “Il Libro Segreto di Shakespeare” – Newton Compton Editori 2001.
“Anonymous” – film di Roland Emmerich , distribuito da Warner Bros. Pictures Italia.
Lo stesso artificio del “teatro nel teatro” così come si è poi rivelato passando dal “teatro al cinema” è quello che ritroviamo da sempre nel passaggio dalla letteratura nel teatro o nel cinema, cioè uno stravolgimento d’intenti che se da un lato si arricchisce d’immagini, talvolta anche stupende, dall’altro s’incontra con una irrealtà superiore, che va oltre e che supera se stessa, come per continuare il gioco di parole dell’inizio, di “irrealtà nell’irrealtà”, dove l’illusione supera di molto l’immaginazione, che qui diventa “fantastoria”. È il caso della domanda che si chiedono i due autori (e non solo) del libro e del film attorno alla paternità delle sue opere: Se Shakespeare …? Alla quale io aggiungo: Perché Shakespeare …? La risposta data al probabile “anonymous” autore della vasta letteratura shakespeariana è la stessa contenuta sia nel libro che nel film: “Perché voi siete il Tempo!”, che risuona come l’unica possibile, la sola accettabile a quasi quattrocento anni dalla morte dello scrittore. Di fatto si offre qui una risposta ai tanti enigmi dietro la figura di Shakespeare, mettendo a nudo un particolare periodo storico dove le rivalità e i complotti nell’Inghilterra Elisabettiana (fedelmente ricostruita) erano all’ordine del giorno e forse (dico forse), il Duca di Oxford Edward de Vere, poeta e drammaturgo del XVI secolo, non avrebbe potuto scrivere per il teatro, o almeno non certi drammi che riflettevano la vita di corte e fatti ad essa inerenti che vedevano coinvolte figure autorevoli come, ad esempio, il potentissimo consigliere di corte o il precedente re o la stessa regina. Fatto è che al Globe di Londra, il teatro dove le opere di Shakespeare venivano allestite e riconosciuto fulcro del teatro elisabettiano, quelle rivalità e complotti interni alla Corte Reale venivano smascherati con la messa in scena “borghese nella scrittura ma plebea nella realizzazione” e portati alla conoscenza di tutti. Cosa intollerabile per quei tempi, ed è per questo plausibile il “gioco” cioè la finzione su cui operano i due autori: John Underwood pseudonimo di Gene Ayres noto sceneggiatore cinematografico (Universal Studios e Warner Brothers), che ha firmato questo libro, e il regista di successo Roland Emmerich (Indipendence Day, 2002 ecc.) che insieme a John Orloff è anche sceneggiatore del film. Il risultato è appunto quel “letteratura-teatro-cinema” che se da un lato ci regala un excursus dell’opera shakespeariana apprezzabile fino a un certo punto, dall’altro ci presenta uno Shakespeare impostore e truffaldino che si appropria dell’identità di qualcun altro, il cui stesso nome è inventato dall’autore delle opere. Quell’ “anonymous” appunto sul quale è costruito il thriller politico del film, che solo in parte, e relativamente all’argomento centrale dell’enigma Shakespeare, è ripreso dal libro di John Underwood. Due momenti diversi, quindi, entrambi godibili sotto l’aspetto del thriller, un po’ meno sotto l’aspetto storico, e tuttavia impegnativi: il libro per lo sviluppare ciò che gira attorno al mondo dei librai, con manoscritti enigmatici e falsari che manomettono la “verità” su cui il thriller si basa; il film per aver ricreato un’ambientazione “goticha” davvero speciale tutta giocata attraverso il frequente passaggio dal buio alla luce delle candele che rendono al meglio le incredibili (viscontee) scenografie di Sebastian T. Krawinkel, magnificate dalla straordinaria fotografia di Anna Foerster; e dalla ricercatezza, da sottolineare, dei costumi realizzati da Lisy Christl. Su tutto, autori e interpreti, personaggi “reali e irreali” del libro come del film dimostrano qui avere una grande passione per il teatro, per quel teatro che se da una parte si prende gioco della “realtà” per essere esso stesso finzione, da sempre ci regala emozioni e in qualche modo illumina la scena del mondo. E che, guai ad abbandonarlo, lasciandolo finire asservito ai giochi di potere della politica, o relegato alla sola mondanità. Quello stesso teatro che un tempo faceva opinione pubblica, come è appunto ben dimostrato nel film, che era e continua ad essere fonte di cultura, di civiltà sociale, di quell’umanità che in fondo è vita. E chi meglio di Vanessa Redgrave, straordinaria nella parte di Elisabetta I d’Inghilterra può dirlo, se alla sua età e dopo una lunga carriera cinematografica è tornata alle scene. Sorprendente è Rhys Ifans (Notting Hill, I Love Radio Rock ecc.) nelle vesti del protagonista, appunto l’autore “Anonymous” del titolo.
Dichiarazioni del regista riprese da “Sprint Web Magazine” – Anno XI n.112 Nov. 2011:
La biografia di Shakespeare non mi fa pensare a quella di un artista. Quest’uomo era un ragazzo di campagna. Se pensiamo a un autore bisogna subito risalire al contesto storico in cui viveva. Quando ci si trova di fronte al corpo delle sue opere viene subito da pensare a un uomo che ha viaggiato, parla molte lingue e conosce gli intrighi della corte elisabettiana. Questi elementi, messi tutti insieme, corrispondono più al profilo di Edward de Vere.
Sono venuto a conoscenza dell’argomento quando mi fu presentata la sceneggiatura. La questione è molto interessante perché il tema è supportato da forti basi emotive. La divisione più grande è tra artisti e accademici, dove gli artisti hanno difficoltà ad accettare che l’uomo di Stratford-upon-Avon abbia scritto le opere a lui attribuite. Mentre gli accademici insistono che tutti i lavori di Shakespeare siano immaginazione allo stato puro, il che è difficile da credere.
Inizialmente John Orloff mi fornì un soggetto di base ma si trattava essenzialmente di un triangolo di legami e di rivalità artistica tra il Conte di Oxford, William Shakespeare e Ben Jonson, in questo senso poteva ricordare il film “Amadeus” (con la rivalità tra Mozart e Salieri). Non c’era nessun accenno alle vicende di corte, non era contemplata la rivolta del Conte di Essex, così come tutto il contesto aggiuntivo che si vede nel film.
E allora dissi a John, “mi piacerebbe veramente sviluppare il progetto, ma manca di originalità!”. L’originalità si è creata in particolare con la trama che riguarda la penna segreta di Edward de Vere: in fin dei conti uno di corte poteva accedere a segreti e informazioni particolari che uno scrivano esterno come Shakespeare non avrebbe potuto ottenere.
Teniamo presente poi che molti dei soggetti delle opere di Shakespeare esistevano già in una forma o l’altra, ma che le aggiunte del bardo di Strattford-upon-Avon sono spesso molto particolari e intime. Prendiamo l’Amleto per esempio: come mai è presente questa forte ossessione nei confronto della madre? Forse perché vi potrebbe essere un elemento autobiografico riconducibile alla vita di De Vere. In tutte le opere di William ciò che è stato aggiunto è verosimilmente tratto dalla sua esperienza, e sembrerebbe riconducibile ad una vita di corte.
Curiosità:
In un periodo di conflitti intorno alla regina Elisabetta I, tra i Tudor e le altre famiglie nobiliari inglesi, si sviluppa una rete di cospirazioni. Edward de Vere, conte di Oxford, era un poeta e un drammaturgo affermato alla corte. Alcune teorie letterarie del XX secolo ritengono che sia lui in realtà l’autore dei lavori attribuiti a Shakespeare.
Tra coloro che nutrono molti dubbi sull’identità di Shakespeare vi sono nomi illustri quali Mark Twain, Orson Welles, Charlie Chaplin, Sigmund Freud e Jeremy Irons. Sulla questione sono stati pubblicati oltre 5000 libri che mettono in dubbio l’autorità di Shakespeare.
Nota d’autore: Inganno o no, tuttavia nessuno ha mai messo in discussione che l’opera di Shakespeare sia l’opera di un grande. E noi gliene siamo grati.
Id: 498 Data: 29/11/2011 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Rivista - Le Scienze S.p.A.
Aa. Vv. - Rivista - Le Scienze S.p.A.
Le Scienze: Il futuro delle Città
Numero 519/novembre 2011
Un numero davvero "speciale" che racconta come "la crescita inarrestabile delle grandi metropoli", influenza e condiziona le nostre scelte di vita. Un vademecum essenziale per affrontare le sfide della società e della vita comunitaria che oggi strangola le economie nazionali con il cercare di sfruttare al massimo il potenziale creativo ed economico, come ci dicono: "Per offrire soluzioni ai problemi globali di oggi e migliorare domani la vita di tutti noi", anche se non si comprende con quali risorse lo faranno. Il dialogo rimane aperto, ma con un interrogativo in più, che, pur nel rispetto dei diversi autori qui raccolti, deve farci pensare al peggio. La domanda è: "Con quali innovazioni e quali interventi potrebbero rendere più vivibili le nostre città, ridotte allo stremo?". La risposta potremmo dargliela noi, ognuno di noi, cliccando sul sito di Le Scienze e convogliando le nostre esperienze di vita, sociali, comunitarie e globalizzate, trasformandolo in un blog sul futuro, in cui spiegare a quanti, e sono moltissimi, pensano e scrivono di come si possono trovare soluzioni a problemi globali, mentre "l'umanità (tutta) si muove lungo una linea di confine tra l'anarchia della scelta e il mondo alla Disneyland", tanto per citare l'articolo contenuto nella rivista: "Vivere a Meta City". Un invito il mio rivolto a Voi tutti (lettori) e alla redazione de La Recherche affinché si faccia veicolo di problematiche sociali come ha già dimostrato in passato col sollecitare la "voce" di quanti hanno a cuore il futuro degli individui e della comunità poetica e letteraria che ospita.
Id: 495 Data: 15/11/2011 12:00:00
*
 Paolo Flores d’Arcais - Saggio - add Editore
Paolo Flores d’Arcais - Saggio - add Editore
Gesù. L’invenzione del Dio cristiano
La chiarezza, pur nella oscura tematica di cui tratta, è da sempre prerogativa di Paolo Flores d’Arcais che fin dal suo primo e illuminante “Etica senza fede” del 1992 che invito a rileggere, s’avvale di una scelta deliberante attorno alla figura di Gesù, in quanto centrale dell’ “invenzione del Dio cristiano”, trasfigurato nell’idealizzazione ecclesiale in “mito” di una religione millenaria che si regge su un qualcosa che – egli dice – non è storicamente accettabile. Relativamente alla storicità del Gesù in quanto messia, profeta ebreo, grande iniziato e quant’altro gli è attribuito, si possono concepire lacune dovute alla inconcludenza dei documenti in nostro possesso a partire dall’inizio dell’era cristiana che, seppure discordanti tra loro, oggi compongono una bibliografia sterminata. Si pensi alle testimonianze raccolte nei Vangeli canonici, a quelli così detti apocrifi, agli ultimi ritrovamenti papirologici di Qumran (Vangelo di Tommaso e altri), e di Nag Hammadi (Vangelo di Giuda), i quali, se da una parte attestano l’esistenza di una diatriba accesa quanto interminabile, dall’altra sono in vero la conferma di un’esistenza consumata che ha determinato il nascere di una religione. E qui l’utilizzo del termine “religione” va necessariamente interpretato nella accezione di “religare”, cioè “unire in una complessa relazione gli elementi emotivamente più significativi che nel mondo interno all’individuo hanno acquisito un significato sacrale” (*). Ora, stando alla determinazione di Flores d’Arcais di abbattere le false ideologie su cui la religione cristiana si basa, prendendosela una prima volta con Karol Wojtyła (Etica senza fede), questa volta con Joseph Ratzinger (Gesù) per la loro anti-storicità, tuttavia comprendiamo la portata di un’azione volta a restituire alla laicità il diritto dell’essere “aconfessionale”, come dire diamo a Cesare quel ch’è di Cesare – come infatti egli scrive: “di una democrazia cui si riconosca la nostra irredimibile finitezza”, lì dove nostra sta per la finitezza secolare dell’esistenza umana. Ciò non toglie al Gesù di cui parla l’autore di essere stato “umano fra gli umani”, credibile al suo tempo per la capacità dottrinale, la volontà di affermare la “visione apocalittica” ch’era già degli antichi profeti, di far parte di una schiera contestatrice all’interno della propria religione secolarizzata quale l’ebraismo, di essere l’iniziatore “iniziato” di una rivoluzione culturale/teologica di un “mistero”, quello della fede, che tutto differenzia e tutto unifica. Gesù non smette di essere chi è lo releghiamo tra noi in qualità di uomo che ha subito un supplizio ingiusto; la stessa Maria madre di Gesù non smette di essere in primis “madre” naturale o no di tutti i suoi figli, anzi tutt’altro, credo che entrambi sarebbero molto più apprezzati oggi se venissero smontati gli altari barocchi della verginità, della cristologia messianica e così via, per lasciare il posto alla vera sacralità della missione umana. Del resto la “verità” sulla nostra esistenza, che tutti da sempre andiamo cercando, si è fin qui dimostrata raggiungibile solo nell’utopia di quanti, studiosi e scienziati, semplici pensatori e umili sognatori, nella visione estatica, a dire più meravigliata che inorridita, dell’intima essenza umana. “La verità è accessibile all’uomo attraverso la religione intesa come iniziazione misterica, differenziata nella forma ma identica nella sostanza in tutti i paesi e in tutte le culture”(**). Una prospettiva questa che dovremmo far nostra, tenendo conto della necessità intima plurimillenaria, riscontrata nell’essere umano fin dall’origine, per far fronte alle sue paure ma anche alla sua estatica meraviglia davanti al creato di cui l’uomo è parte integrante, che se niente non è, almeno non possiamo attribuirlo all’uomo, che anzi l’uomo oggi va distruggendo, pur rendendosi conto di quello che fa. In questo siamo i veri continuatori della parola del Gesù cristiano, o almeno della sua visione apocalittica del mondo, messi al centro d’una religione millenaria che si può anche contestare, creando una diatriba politica sul soggiacere a una Chiesa imperante che s’impone sulla necessità laica di uno Stato sovrano, o di una nazione che si dice “democratica” e poi soggiace alle forzature di una religione stantia e polverosa. Ma questo non è tema da anteporre in sede filosofica, è piuttosto un problema sociale congenito di un sistema malato, difficile ma non “impossibile” da risanare. La denigrazione per anti-storicità di un Papa o di un altro, nulla toglie alla figura di un Cristo che si leva al di sopra delle parti tra i “grandi iniziati” di cui parlava Schuré: “che con i loro insegnamenti e la loro stessa vita hanno lasciato alla storia un messaggio eternamente valido e universalmente accettato”. Il resto è teologico, altra cosa è la fede. È quanto afferma lo stesso Flores d’Arcais: “Altra cosa è la fede, ovviamente, che orgogliosamente Paolo (pseudo apostolo) considerava follia e i cristiani dei primi secoli proclamavano altrettanto orgogliosamente nel “credo quia absurdum”. E cos’è la fede? – mi chiedo – se non un credere, per assurdo che possa sembrare, un “sogno” per definizione individuale che finisce per rivestire importanza decisiva nelle sorti di una comunità, apologia o esaltazione di un comune sentire che supera ogni valico della nostra misera, inaffidabile funzione della nostra mente.
L’impegno di Paolo Floris d’Arcais, pur nella sua eccellente qualità di saggista, non si stacca da quello che è il peso della sua responsabilità di uomo, dal dovere che lo tiene legato alla sua professione politica, al punto che il suo “credo” infine è “fede” che egli professa con la tenacia che gli va riconosciuta, e al quale dobbiamo comunque dire grazie per non aver lasciato cadere nel dimenticatoio una diatriba che si trascina da duemiladodici anni e forse più, che è bene sostenere, affinché nulla vada perduto e si arrivi un giorno a svelare quella “verità” che ci è tolta, per rinfrancarla con quell’umano sentire che appartiene a tutti noi, autore del libro incluso. D’Arcais, va qui ricordato, è direttore di “MicroMega” mensile di etica politica, comunicazione e altra cultura. Le sue pubblicazioni più importanti: “Esistenza e Libertà”, “A partire da Hannah Arendt”, “La rimozione permanente”, “Etica senza fede” e altre.
Id: 490 Data: 11/11/2011 11:11:11
*
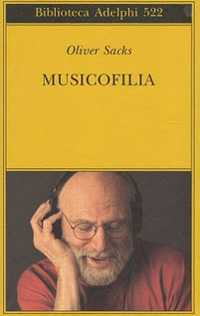 Oliver Sacks - Saggio - Adelphi
Oliver Sacks - Saggio - Adelphi
Musicofilia
“Le piace Brahms?” – fa chiedere François Sagan dalla bella arredatrice quarantenne al giovane amante. Ovviamente non ricordo la risposta – ammetto che è passato un certo tempo – tuttavia, personalmente, avrei risposto: “Forse sì, forse no!”, solo perché penso di essere io a non piacere al signor Brahms. Se invece la domanda mi fosse stata rivolta per Tchaicovski o Dvorak o qualcun altro avrei avuto una risposta decisa, come dire, più determinata: “Semplicemente sì!”. E questo, in qualche modo, fa la differenza, seppure ciò suoni alquanto strano a dirsi da parte di chiunque ami la musica in genere. A spiegarci i perché di questa discordanza di risposte ci ha pensato Oliver Sacks, neurologo e psichiatra, nel suo libro “Musicofilia” di recente ristampa, in cui la musica è trattata come patologia, lì dove essa rappresenta di fatto una disfunzione, o meglio una disorganizzazione nella normalità. Un libro di non facile lettura ma che riserva un’infinità di sorprese, o meglio, di possibilità sorprendenti per quanti fanno della musica una costante esperienza, così come nell’ascoltarla o riascoltarla, fanno un atto di rinnovata scoperta, per cui ogni momento “si mostra come se il passato può esistere senza essere ricordato” – come già vissuto – “e il futuro senza essere previsto” – quindi tutto da vivere e da godere. Questo ci permette di comprendere quanto di ciò che ascoltiamo in musica è propedeutico all’alimentazione del nostro apparato sensoriale che fin dalla pubertà si nutre di “suoni”, o meglio di “emissioni sonore” che elaborate a livello corporeo, sviluppano trasformazioni di diverso tipo, interessando altri organi sensitivi oltre che l’udito, come l’olfatto e la vista. “L’olfatto, la vista?” – viene da chiedersi. La risposta equivale a un “Sì!” affermativo ed ha anche un nome: “sinestesia”, per cui “non esiste una separazione netta, presente in ciascuno di noi, fra vista, udito, tatto e gusto. (..) Ogni parola o immagine che udiva o vedeva, ogni percezione, dava istantaneamente origine a un’esplosione di equivalenze sin estetiche – le quali erano tenute a mente con precisione, in modo indelebile e implacabile, per il resto della sua vita”. Il che, in ambito strettamente neurologico, può risultare una disfunzione cerebrale, tuttavia ciò non vuol dire che fungiamo da agenti “sinestetici”, o almeno non del tutto e non ancora. Qualche dubbio il neurologo Sacks ce lo crea, e scorrendo le molte pagine del libro qua e là è possibile che ci ritroviamo tutti in bella mostra con qualche patologia in più. Finanche quella di essere fruitori tormentati da sentimenti musicali, che so, essere piuttosto fan dei Beatles che dei Rolling Stones, degli U2 invece che dei Coldplay o viceversa, e di subire una musicofilia pregressa, quando non da allucinazioni musicali, o da epilessia musicogena – che orrore! Non è tutto, il libro, che non è di medicina e neppure di psichiatria, si limita ad esporre quelle che sono le patologie senza la pretesa di dare soluzioni curative. Molto più tranquillamente permette di addentrarci nelle diverse dimensioni della musicalità, in quello che è il paesaggio sonoro della nostra ragione, e che riguarda il sentimento, la memoria e l’identità, di uno stato emozionale affettivo che da sempre la musica regala a tutti noi, seppure nel diverso modo di sentire e apprezzarla. E che, al di là della seduzione o dell’indifferenza che talvolta ci coglie, alla malinconia che sembra creare intorno a noi, spesso risulta essere la cura che cercavamo.
Unico nel suo genere, il libro ha una sua valenza per gli aspetti inusitati e insospettabili che il lettore trova nelle pagine fitte di richiami etnico- musicologici, medicali e scientifici che appartengono a un panorama letterario di scarsa fruizione, in cui nomi illustri, operano nel silenzio della ricerca più ostica delle amnesie e amusie cocleari (l’imperfetta percezione dei suoni), e la musicoterapia applicata (morbo di Parkinson, demenza precoce, sindromi temporali e durature) e non solo. Bensì anche delle problematiche connesse al linguaggio così come si è sviluppato in tutti i suoi aspetti, che quasi c’è di conforto sapere che: “L’origine della musica umana è molto meno facile da comprendere”. Un libro utile per quanti: musicisti, appassionati di musica, neurologi, educatori, insegnanti di sostegno, linguisti, logopedisti, ricercatori, etnomusicologi che, possono trovare in esso le ragioni di quella conoscenza sconfinata che pure è parte rilevante della nostra crescita culturale. E che straordinariamente ricalca le parole di Darwin – che ne era al tempo stesso sconcertato – quando nel suo “L’origine dell’uomo” scrisse: “Giacché né il piacere legato alla produzione di note musicali, né la capacità (di produrle) sono facoltà che abbiano il benché minimo utile diretto per l’uomo … devono essere collocate fra le più misteriose di cui egli è dotato”.
E a voi, piace Brahms?
Oliver Sacks, vive a New York dove insegna neurologia e psichiatria alla Columbia University Artist. Medico e scrittore, è autore di dieci libri, fra i quali “L’uomo che scambiò la moglie per un cappello” e “Risvegli”, da cui è tratto il film che nel 1990 ebbe tre nomination agli Oscar.
Id: 480 Data: 11/10/2011 12:00:00
*
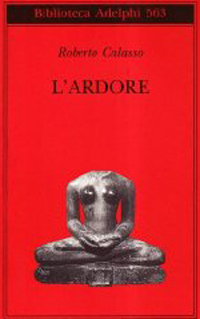 Roberto Calasso - Saggio - Adelphi
Roberto Calasso - Saggio - Adelphi
L’ardore
Sebbene non ci abitueremo mai a spingerci “oltre” la monotonia di tanta letteratura consumistica, sembra arrivato il momento di doverci impegnare in una lettura straordinariamente impegnativa, superando noi stessi. Dopo “La rovina di Kasch”, “Ka” e “K”: simultaneamente dall’India vedica a “l’innominabile attuale” di questo “L’Ardore”, con “la sottesa disponibilità a riconoscere un’immensità che tutto travolge e ovunque è avvertibile”, Roberto Calasso ci invita a una rilettura critica dei testi che compongono il Rgveda “come un mondo in sé compiuto”, oggi di assoluta attualità, quasi minimalista, per un ritorno all’espressività “filologica e filosofica” delle origini dell’umanità e dell’intero creato. Da subito, veniamo immersi in un Casting in stile Bollywood, dove con nostra grande sorpresa, tutto diventa possibile, anche l’impossibile. Allora: “la terra, lo spazio intermedio, il mondo celeste” sono la scena, lo sfondo sul quale si muovono i protagonisti: gli dèi e gli eroi dei miti ancestrali, mentre dietro le quinte s’agita tutto l’universo, il visibile, l’invisibile, l’ignoto delle nostre eterne paure, del nostro dramma, sempre attuale, legato alla nostra esistenza: “Un dramma autistico che, non aveva conosciuto requie né la consolazione di uno sguardo esterno, che potesse compatire o condannare – non importava –, ma comunque partecipare a ciò che avveniva. Né i prodigi né le disfatte si distinguevano dai miraggi. Eppure erano l’unica sostanza di cui Prajapati disponesse. Da essa doveva nascere, dopo lunga elaborazione, ciò che un giorno – ingenuamente – sarebbe stato chiamato realtà”.
Il linguaggio è indubbiamente quello aulico che conoscevamo già in “Le nozze di Cadmo e Armonia”, anche se qua e là l’autore (grandissimo) rimette la sua eloquenza al servizio del lettore, affinché possa addentrarsi nei labirinti dei nomi e delle corrispondenze, non facili da seguire per l’inesperto che vi si addentra, e che, tuttavia, vi scopre quell’universo mistico-contemplativo, in certo qual modo ancora “inesplorato” perché volutamente ignorato, entrato di recente nel pensiero occidentale. Ove l’ “ardore” sta a rappresentare il “fuoco” nelle sue più disparate e voluttuose accezioni; ma anche il trasporto, l’entusiasmo, la veemenza, e non in ultimo, la “tenacia creatrice della divinità”, controparte alienabile della “folgore distruttrice dell’umanità” che, non potendo raggiungerla in pieno, non può che cercare nell’ascesi, la spinta verso l’ “immanifesto” che si rivela, alla base dei rituali di tutte le religioni. Ovviamente c’è molto di più, di quello che ho potuto dire nello spazio angusto di una recensione parziale, di un lavoro enciclopedico (530 pagine), stracolmo di riferimenti e richiami letterari fino ai giorni nostri, e con i limiti ovviamente del modesto lettore qual io sono. Per cui la scelta di una lettura siffatta, diventa ragione arbitrale di un percorso conoscitivo che va appunto “oltre”, ove la libertà di scelta diventa “arbitrato” di una motivazione, per una predilezione che posso definire “elettiva”.
Id: 469 Data: 06/09/2011 12:00:00
*
 Camilleri Lucarelli Oggero Perazzoli Carlotto Monaldi e altri. - Rivista - Gruppo Editoriale l’Espresso
Camilleri Lucarelli Oggero Perazzoli Carlotto Monaldi e altri. - Rivista - Gruppo Editoriale l’Espresso
Micro Mega - Crimini d’establishment
“Crimini d’establishment” – MicroMega direttore: Paolo Flores d’Arcais 3/2011
Autori: Camilleri / Lucarelli / Vichi /Varesi / Oggero / Auriemma / Carlotto / Colaprico / Pulixi / Genna / Verasani / Pellizzetti / Macchiavelli / Monaldi & Sorti / Caldiron / De Lorenzis / Perazzoli.
Non ci siamo, o forse ci siamo eccome! La presunzione di Micro Mega questa volta ha peccato di falsa modestia sfoggiando sul mercato editoriale un eccezionale raccolta di nomi famosi (troppo famosi), con racconti di ottimo livello e davvero a buon mercato che si divorano tutti d’un fiato. In contrapposizione quindi i due sostantivi usati, cosa che non lo sono invece, i racconti contenuti all’interno, veloci, dinamici, realistici (più del vero), affatto ridicoli come li si vorrebbe, e che riscattano in qualche modo l’egida mussoliniana riportata in apertura: “Bisogna ridicolizzare i fautori o diffusori di romanzi gialli e talora giallissimi, parto di fantasie malate, bisognose di energiche cure”: (B. M.). Ce n’è voluto dico io, di tempo, prima che qualcuno si accorgesse di una scrittura: giallo, noire, fiction, burlesche, ecc. chiamatela pure come volete, che desse spazio a quella creatività tutta italiana che, a differenza dei molti titoli stranieri pubblicati, visti al Salone del Libro, occupano uno spazio davvero esiguo nelle nostre librerie. Come se non bastasse già il cinema a riempire tutti gli spazi nostrani. Come dice Guido Caldiron in Filo Rosso, facendo per noi un ripasso generale sul “giallo” in apertura del volume: “Perché scoprire il colpevole di un crimine letterario è un po’ come svelare ciò che non funziona nelle nostre società. L’indagine sociale, il racconto dello spazio urbano e la ricostruzione della memoria storica alla base del successo della letteratura poliziesca e ne spiegano la natura intrinsecamente politica e potenzialmente pericolosa per il potere”. Così detto, non ci serve di andare a cercare stereotipi all’estero che ne abbiamo in casa nostra a iosa. Scrittori italiani (meno famosi), fatevi sotto, dunque, magari in una prossima uscita di Micro Mega potrebbe toccare anche a voi di riempire le belle pagine che “finalmente” qualcuno ha pensato bene di mettere a disposizione! E siatene all’altezza. Questo vale anche per i poeti italiani che si dimenano in accorate e inespressive colpevolezze: tirate fuori il fiato, la vita quotidiana, il sociale, quello che viviamo, è sotto gli occhi di tutti, è possibile che se ne trovate la forza, le pagine di chissà quante altre riviste, come ha fatto Micro Mega, pubblicheranno le vostre grida: ma che siano alte! E forti per giunta! Nel merito del volume, tralascio volutamente di parlare di Camilleri e Lucarelli perché all’apice, sottolineo il bellissimo racconto “Povera Rosa” di Margherita Oggero, quello di Carlotto & com. “L’ultima ruota del carro” e duello di Grazia Verasani “Per quello che m’importa” che aprono una finestra su una realtà che facciamo finta di non conoscere; non in ultimo, quel “Secretum” di Monaldi & Sorti, che si svolge nel lontano 1700, breve ma davvero straordinario nella sua ordinata concretezza.
Id: 434 Data: 10/06/2011 12:00:00
*
 Cormac McCarthy - Romanzo - Einaudi
Cormac McCarthy - Romanzo - Einaudi
La Strada / The Road
«Ce la caveremo, vero, papà?»
«Sì. Ce la caveremo»
«E non ci succederà niente di male»
«Esatto»
«Perché noi portiamo il fuoco»
«Sì. Perché noi portiamo il fuoco»
Un libro questo del Premio Pulitzer, Cormac McCarthy, che pur nella sua esiguità letteraria, risulta fin troppo crudo, a tratti violento, eppure straordinario. Se davvero vogliamo formulare un giudizio, il romanzo “The Road”, tornato ad affacciarsi alla ribalta grazie alla trasposizione cinematografica (mera traduzione filmata diretta dall’australiano John Hillcoat che lo ha presentato in concorso all'ultima Mostra di Venezia,) che, se non altro, è valsa a testimoniare al più ampio pubblico, (certamente più ampio dei lettori che avranno letto il libro), l’altissimo messaggio d'amore tra padre-figlio, (di cui non si trova quasi traccia nella letteratura contemporanea). Una storia forse non nuova, ma di certo avvincente, “incentrata sui postumi di un Armageddon, in cui un padre e un figlio si trascinano attraverso scenari post-apocalittici, tra le rovine della civiltà, assediati da fame, disperazione e uomini regrediti che riscoprono gli istinti bestiali del cannibalismo”. Che è anche messaggio d’amore e di vita, per una consumata esistenza-sopravvivenza, che funge da trama portante in un mondo “di puro orrore” dove, il nuovo pericolo incombente della radioattività nucleare, ci presenta uno scenario che riprende le atmosfere metafisiche della fantascienza apocalittica, confermandole.
Un'opera (sia il libro che il film) che andrebbe portata a conoscenza di tutti, a incominciare dalla scuola, per il suo alto valore umanistico che infine ci riscatta dall’essere portatori di fame e distruzione, ma anche di nuova vita. Ciò a discapito delle critiche (più cinematografiche che letterarie) che comunque hanno rilevato una forte valenza escatologica del testo, in contrasto con il film che, “se da un lato appiattisce la poesia in una confezione tanto ineccepibile – paesaggi agonizzanti, fotografia sporca, musiche suggestive – quanto fredda; dall’altro, si pone il sospetto che si sia letto il romanzo solo per il suo contenuto, perdendone la scrittura. (..) Lo conferma ciò che vediamo nella didascalica ripetizione per immagini, cui manca imperdonabilmente l’anima" (Gianluca Arnone). E tuttavia senza nulla togliere all’ottima prova di Viggo Mortensen e del piccolo Kodi Smit-Mcphee, (padre e figlio) smunti, sporchi e amabilmente tragici nel loro “essere portatori del fuoco (della vita)”, restano pur sempre due protagonisti senza nome di un romanzo/film in cui il grigio incombe come “un lugubre sudario su tutta la natura che ha perso i suoi colori vitali”.
Ma se la pagina accendeva l'immaginazione del lettore, “il film, cupissimo, rigoroso, molto fedele al romanzo, è quasi insostenibile per lo spoglio realismo. Una metafora universale in tempi di guerra come questi, che però evita con classe le trappole e i ricatti del genere" (Fabio Ferzetti). Qui “ogni spettacolarità è bandita, se non la naturale meraviglia del nulla. Per mesi la distribuzione del film è stata in bilico. Potrebbe impressionare, questa palpabile caduta di ogni orizzonte dell'uomo... Vero come un pensiero onesto e ossessivo, e che per questo fa paura" (Silvio Danese). Non ci rimane che rilegge questo incredibile libro, per essere sicuri di ciò che la sconvolgente “realtà” dell’autore (quasi una profezia di quanto sta accadendo) ha portato alla ribalta in un momento come questo, in cui davvero serve tutta la nostra partecipata comprensione.
Id: 415 Data: 19/04/2011 12:00:00
*
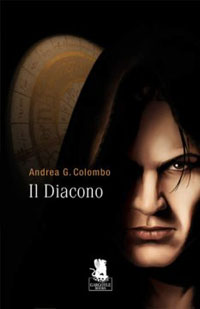 Andrea G. Colombo - Romanzo - Gargoyle Books
Andrea G. Colombo - Romanzo - Gargoyle Books
Il Diacono
In fil di penna, ma con l'inchiostro decisamente nero.
Non ci si aspettava di meglio che una buona scrittura, ricercata e doviziosa di particolari, per un certo verso addirittura elegante, ricca di passaggi agili, mai affannosa (di chi arranca), come si suol dire, esercitata “in fil di penna”. La stessa struttura è molto articolata, e la vediamo munirsi di contrafforti e piloni al pari di una architettura gotica, tuttavia senza gli orpelli del gotico fiorito, al contrario risulta piuttosto scarna, quasi minimalista. In cui il lettore è trascinato a forza, in una sorta di realtà sclerotizzata, in cui molti sono gli elementi chiamati a concorrere: l’esorcismo, il profetico, la malvagità, la diavoleria, l’apocalittica. Antropologicamente parlando segna un ritorno all’animismo, allo sciamanismo, all’etnopsichiatria e le conseguenti modifiche dell’ordine sociale, come causa di ritorno alle paure ancestrali che hanno condizionato il cammino dell’uomo. Da cui i disordini mentali (individuali), le turbe dell’inconscio (collettivo), modificate dalla religione e dalla società contemporanea, secondo l’impronta culturale (della razza, dell’ambiente naturale, della conoscenza) cui la storia fa riferimento (i giorni nostri). Scrive H. P. Lovecraft: “Gli uomini di più ampio intelletto sanno che non c’è netta distinzione tra il reale e l’irreale, che le cose appaiono come sembrano solo in virtù dei delicati strumenti fisici e mentali attraverso cui le percepiamo”, gli orpelli, appunto, del gotico fiorito cui sopra facevo riferimento. “Ma come predetto dalle profezie, l’equilibrio e' stato spezzato e qualcosa di estremamente pericoloso e' riuscito a passare. Qualcosa di cosi antico da non aver lasciato negli uomini neppure il ricordo di sé”. È dunque ancora la notte, il buio, le ombre, le capacità intuitive e paranoiche che differenziano la normalità dall’anomalia concettuale dei personaggi, qui straordinariamente codificati, al punto da farci sentire il loro fiato sul collo, avvertire i loro sguardi che si aggirano tra noi (lettori), alla ricerca di una qualche identità labile da penetrare, da sconvolgere e infine da uccidere: “sebbene siano tutti morti”. Una storia realistica nelle intenzioni così come nelle ipotesi estreme tirate a forza dentro la narrazione: “Chi sei?, chiese di nuovo la voce”, “il vecchio monaco fissò i quattro cavalieri (dell’apocalisse) che correvano verso le orde demoniache guidate da N’Tala Jeza, la divoratrice di anime”, “Pensavano di proteggere chi da cosa?”, “I traditori della Vera Fede erano stati puniti, e gli autori del complotto ai danni della Chiesa stavano per essere annientati. La punizione divina era stata terribile, non era stata dimostrata alcuna pietà per chi stava cercando di minare le fondamenta di Santa Romana Chiesa”. Ma questi sono soltanto alcuni passaggi di un thriller dell’orrore, impegnativo quanto sofisticato, fitto di colpi di scena da non lasciare spazio ad alcuna via di fuga … “da chi, da cosa?”, se i varchi (le porte spalancate attraverso cui il Male può irrompere e infettare la nostra realtà), “sono tenuti sotto controllo da una Volontà più alta e da un delicato controllo di forze”, “forse, la salvezza e' nelle mani di un monaco (il Diacono) senza memoria, senza nome, senza passato. Un uomo la cui vita e potere sono un enigma che deve essere risolto in fretta, prima che sia troppo tardi”. E una ragione forse c’è, basta ammetterlo con noi stessi … perché niente accade mai per caso.
Andrea G. Colombo non ci è nuovo, la sua “visione” dell’horror è stata un susseguirsi di assalti alle torri della nostra psiche, mettendoci ogni volta alla prova: da In fondo al nero (Mondadori), alle occasionali novelle e presentazioni. Ma non vi aspettate una Patricia Highsmith o un Stephen King, e neppure un altro Dan Brown, inattendibile perché infondato, impreciso e, soprattutto, mancante di quel sentore tra musica (hard rock) e poesia (maledetta) che fa dell’horror la quint’essenza della narrativa.
Id: 397 Data: 22/02/2011 12:00:00
*
 Umberto Eco - Narrativa - Bompiani
Umberto Eco - Narrativa - Bompiani
Il Cimitero di Praga
Id: 381 Data: 08/02/2011 12:00:00
*
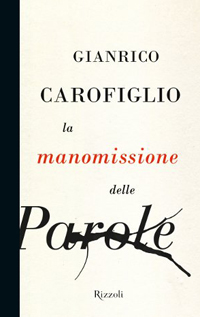 Gianrico Carofiglio - Saggio - Rizzoli
Gianrico Carofiglio - Saggio - Rizzoli
La manomissione delle parole
Id: 374 Data: 18/01/2011 12:00:00
*
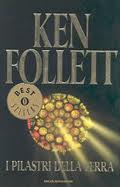 Ken Follett - Romanzo - Mondadori
Ken Follett - Romanzo - Mondadori
I pilastri della Terra
Id: 352 Data: 14/12/2010 12:00:00
*
 Emanuele Trevi - Romanzo - Rizzoli
Emanuele Trevi - Romanzo - Rizzoli
Il libro della gioia perpetua
Nota elettiva: un cammino difficile non sempre allontana dalla meta, talvolta un sentiero nascosto riconduce alla piena luce di uno spiazzo, e il cielo aperto è là ad attenderci per un altro viaggio della nostra “fantasia”. È allora che il racconto prende nuova forma, si dilata, si estende, assume linfa da tutto quanto avevamo abbandonato negli interstizi delle nostre connessioni mentali, che finisce per ricongiungersi con gli altri racconti che non abbiamo ancora scritto, e che pure danno forma al romanzo della nostra vita.
Nota critica: l’indagine interiore dello scrittore crea una cornice eccessivamente marcata in questa storia che mostra lo stupore e lo sgomento dell’infanzia, quasi un voler cercare se stesso in una realtà alla quale forse avrebbe voluto appartenere (?). Una fantasia terragna quella del Trevi scrittore di questo romanzo, che penetra negli interstizi grandi come crepe, dove costantemente, pagina dopo pagina, afferma la propria rigenerazione.
Passaggi: “Il passato non è solo ciò che perdiamo irrimediabilmente, ma anche qualcosa di oscuro e pericoloso, che con pazienza ci aspetta dietro l’angolo, sapendo che prima o poi finiremo col passare di lì”.
“Non so come esprimermi altrimenti: il Libro è privo di qualunque significato – ed è in questa purezza assoluta (simile a quella di certi folli) che risiede la sua forza. Ogni libro, in una certa misura, può essere frainteso. Ma per il solo fatto che è possibile fraintenderlo, un suo senso deve pure esistere!”
Accostamenti letterari: Elias Canetti di “Auto da fé”, Claudio Magris di “Microcosmi” e “L’infinito viaggiare”, Orhan Pamuch di “Istanbul”.
Id: 347 Data: 26/10/2010 12:00:00