chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Gian Piero Stefanoni
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
*
 Antonino Ficili - Poesia - Diana edizioni
Antonino Ficili - Poesia - Diana edizioni
Quando si diventa mare
Esordio all’insegna di una ricercata luce, di una lotta tra le chiusure e le contraddizioni del proprio mondo interiore e di una contemporaneità comunque ossessa, impenetrabile, respingente questo di Antonio Ficili, giovane universitario palermitano. Nell’insieme di poesie, soprattutto, prose, aforismi e pagine di diario il tentativo nella registrazione delle proprie scosse, delle proprie paure è quello di un progressivo e più mite abbandono, nella dimenticanza quasi di sé dai cortocircuiti della coscienza, a una natura benigna, illuminata e illuminante tra le pieghe delle sue quotidiane e creaturali epifanie. Così appare evidente nel corso della lettura come una spaccatura, un solco nelle diverse sezioni che vanno a comporre il testo, tra il rovello di un passato non concluso, di opere ancora al buio cui la parola tenendo dietro si perde e l’apparire di un presente più libero, serenamente gioioso negli spazi sorgivi di un incantamento sempre di rivelazione a un’anima purissima come quella che pian piano si viene a disegnare, in una versificazione anche, per questo, nella armonia di una cadenza legata all’umiltà di un qualcosa che ragazzo, fanciullo, non può controllare ma solo, a tratti francescanamente, accogliere. Si diventa mare lasciando che l’onda plasmi per noi l’involucro, la barca nell’assenso a una navigazione che può la vita là dove la vita stessa è accompagnata, nei suoi scogli e nei suoi contrasti, negli orizzonti delle sue aperture e delle sue correnti, e non subita. Ficili questo, nel diario di bordo delle sue uscite, lo apprende bene seppure come è naturale con sofferenza, con tentazioni certo di regressioni e respingimenti a volte, ma sempre nell’imprinting di una passione inviolabile, quella di una vitalità votata all’incontro perché riconosciuta nel disceso e più alto amore di cui è parte, e di cui la poesia non ne è che nostalgia nel presente del suo ricordo. Molto ha della metapoesia tra l’altro questa scrittura che però in questo spesso va a peccare non supportata ancora da quel necessario distacco che il dire abbisogna riflettendo sulla propria natura. Anche in questo caso, disancorata dagli ormeggi delle suggestioni e dei modelli che più che dire ne negano l’autenticità, questa poesia sa risolversi nella spoliazione, nello sguardo a quella rappresentata scena di mondi che dalle piante, dagli animali, dal mare stesso va a esemplificare ai suoi occhi quel paesaggio di risolta espressione- ed espansione-che viene come nei bambini nel dialogo di meraviglia e stupore col divino (“Dio? A Dio vorrei somigliare./ Come gli somiglia l’ombra, il profumo,/ la morte, il pane. E ritornare/: sabbia, sangue, acqua. Mare? Diventare./ E diventare mare, trasparente/ sentiero nei suoi occhi; e sollevare/ Dio, con la forza di una parola;/ e ritornare, e diventare./ Infine, essere”). Espressione allora che va a trovare compimento nel dire a due con l’amata Miriam, l’amore allora nell’indovinata unità della sua compiutezza. Amore cui la parola stessa si va a piegare maturando in Ficili in un percorso cui in conclusione auguriamo tutta la cura che merita in quel coraggio tanto evocato, tanto carezzato che viene dal restare bassi nella pazienza allora di se stessi, e del mondo imparando “a respirare l’invisibile”.
Id: 1329 Data: 28/01/2022 12:00:00
*
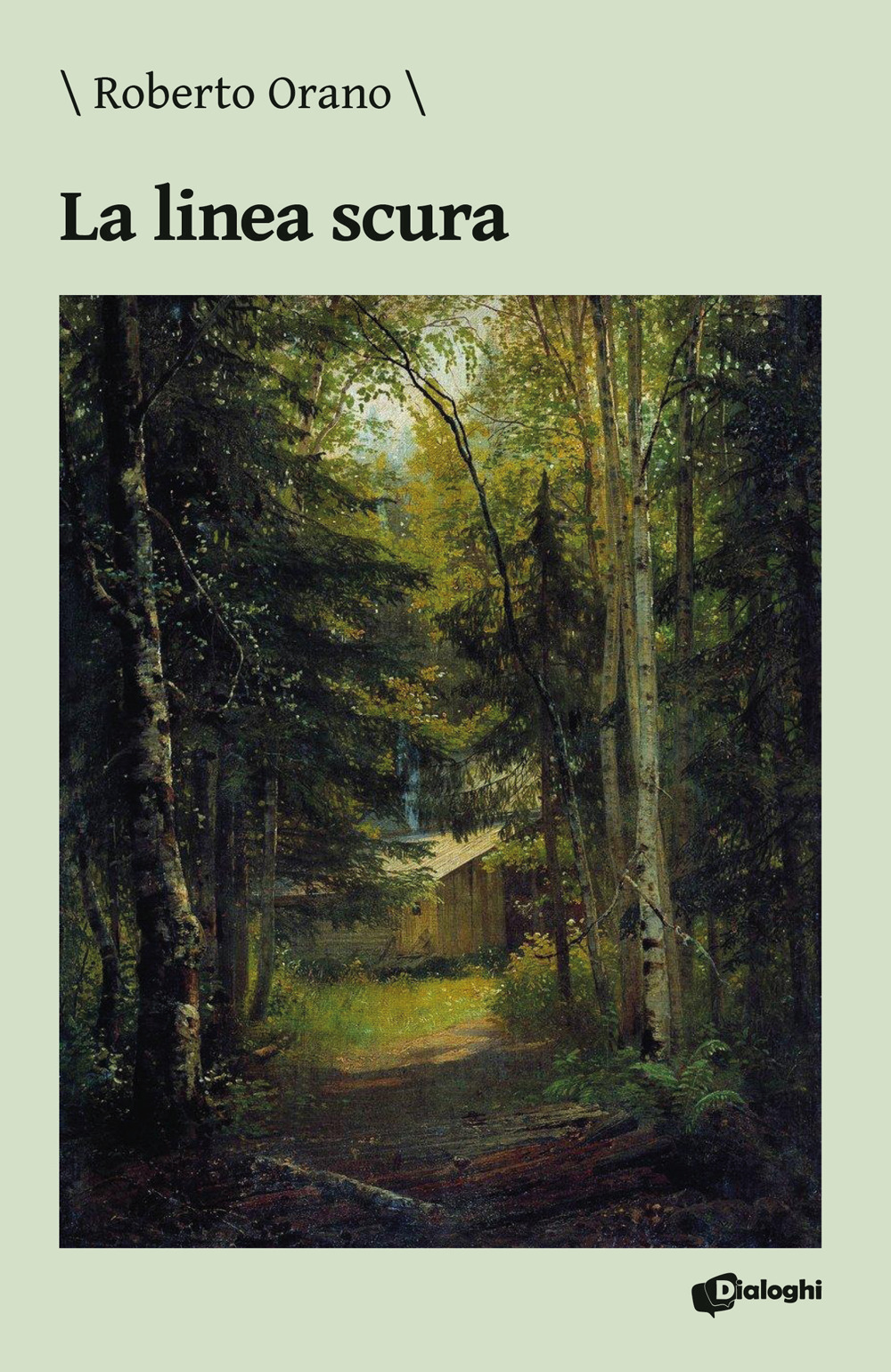 Roberto Orano - Poesia - Edizioni dialoghi
Roberto Orano - Poesia - Edizioni dialoghi
La linea scura
Libro d’esordio questo di Roberto Orano, trentenne mastro birraio veneto che tenta una risonanza d’accusa e di scossa, e dunque in qualche modo di liberazione a fronte di un mondo impositivo, socialmente e culturalmente alla prova di un sistema economico al risucchio di singoli e famiglie nella salvaguardia di pochi gruppi e di pochi uomini. Così ciò che da queste pagine risale è la corposità di una rabbia dapprima a implodere dentro sé, nell’amarezza di dinamiche di separazione e negazione ad annunciare della vita per lo più distrazioni e perturbanti stalli d’anima e poi nella tensione di strade, spazi, intimità di luoghi a riconoscersi e a riflettere nel medesimo angosciante e amaro sgomento il panorama di un millennio soffocato e al collasso. Non a caso, forse, il testo si va ad aprire con una immagine che tra le altre meglio può andare a descrivere tanta interrogazione, quella dei morti per mare, per migrazione, nell’assuefazione di chi dall’altra parte, la nostra, va smettendo anche di registrarselo nei nastri di un cuore sovente assopito e in sovrappeso. L’indice di Orano nell’avvertenza della introduzione rivolta a una globalizzazione divorante nelle sue unificazioni e nelle sue cancellazioni segue una riflessione come da sottolineatura che “sfuma dal materialismo anarchico a idee anticapitalistiche e rivoluzionarie”. Ciò che viene restituito in realtà in una versificazione spesso spezzata, quasi a singhiozzo, è un processo d’allarme cui l’io come accennato tende a comprimersi, a celarsi tra le pieghe di aspirazioni trattenute e non espresse se non in una dolente e a tratti paralizzante aggressività verbale, la stessa propositività negata nel segno stesso di un dettato, e di un’epoca, il più delle volte comunque subito (“Cadi piano,/ con grazia,/ nel silenzio/ dell’oblio”). A vincere allora è un odio senza misura contro i depredatori e “i distruttori della quiete”, di una impronta a seminare misconoscimenti reciproci tra gli esseri (“Tu non esisti” l’input a rompere relazionalità e sguardo, “Divide et impera”), a scavare nella testa vuoti a perdere la propria storia (“La vita, talvolta dura,/la morte, un debito”). L’amore ora altro luogo di inferno, e di inverno di dolore ora carnalità di una presenza a confermare, a rimisurare gradazioni e temperature in accensione di vita in quell’automazione dei sentimenti a premere da un potere psicologico che ha in un ordine più grande origine e controllo. Lo spiraglio in Orano che prova allora a risalire nell’accenno finale è in una riappropriata, non indotta, capacità del singolo di riprendere in mano la propria vita, in una unicità- una bellezza- che è nelle imperfezioni, nella infinita possibilità delle sue dilatazioni “perché c’è ancora una luce/ da prendere, / fino alla fine del mondo”. Da questa chiave, a proposito di luce, ci sembra poter provare a illuminare circa un dettato spesso più nel tentativo di una riflessione, nel sentimento di sé e del mondo, a darsi capacità di verso che di poesia stessa, saldamente ed efficacemente riuscita nella naturalità del suo esercizio. È infatti una scrittura non sempre forte nel potere e nella coscienza di una parola al rischio di una singolarità (che pure c’è) non espansa alla misura di effrazione che è- nell’incisività- d’ogni autentico dire poetico. Una scrittura a cui servirebbe forse maggiore cura e attenzione alle trappole delle proprie ingiunzioni, che viene certo anche dall’essere lettori prima che autori (in una regola che vale per tutti sia chiaro) e a cui a cui auguriamo anche per questo, alla forza e alla bontà delle sue urgenze, il miglior scioglimento dato.
Id: 1322 Data: 26/11/2021 12:00:00
*
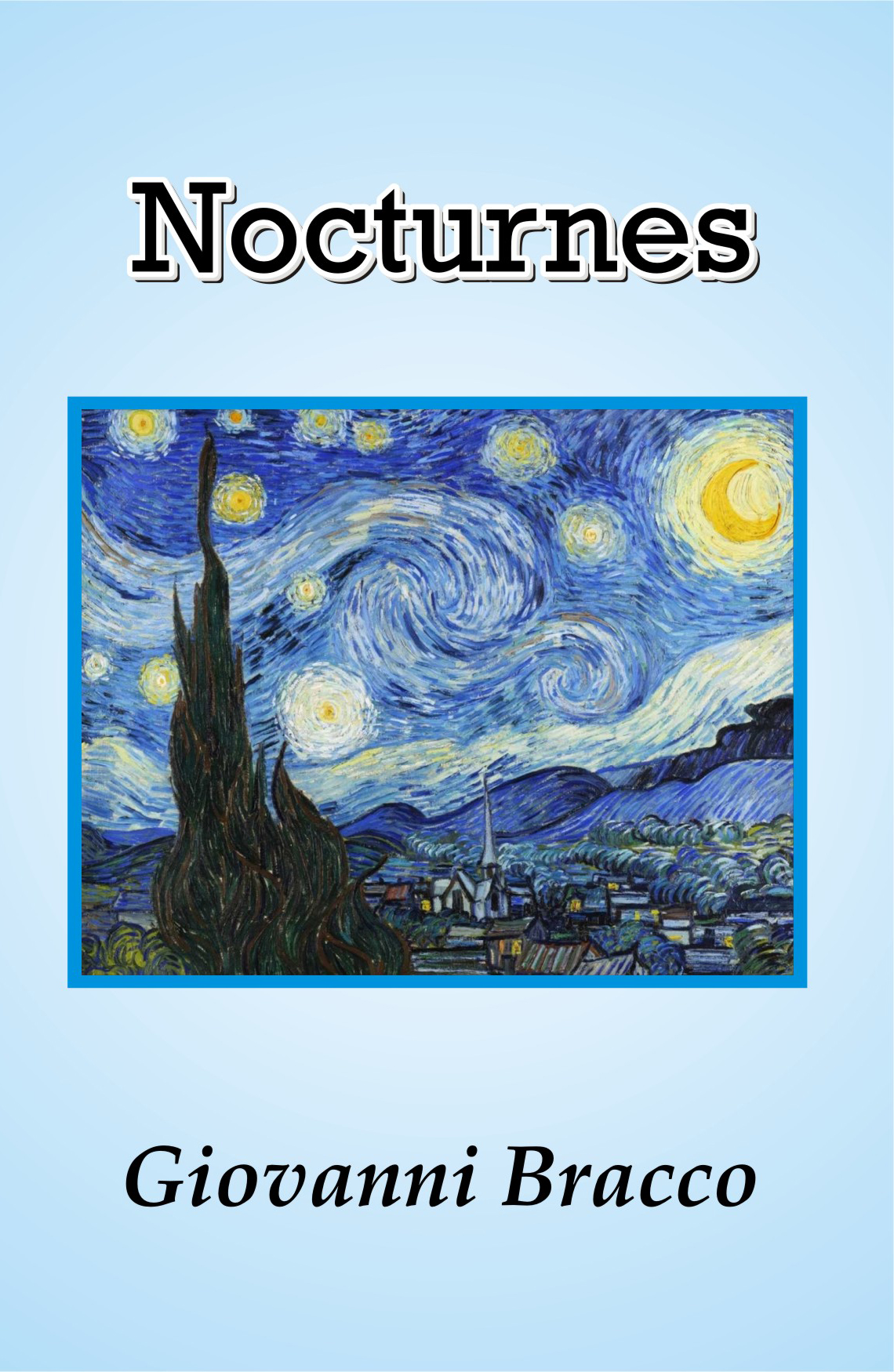 Giovanni Bracco - Poesia - Cyberwit.net
Giovanni Bracco - Poesia - Cyberwit.net
Nocturnes
Intenso testo, lucido, ben iscritto nel dettato di un moderno che confonde, stride, disperde tra le maglie delle sue illusioni e delle sue negazioni questa quarta prova poetica del giornalista Giovanni Bracco. E finalmente, diremmo tra tanta, troppa poesia aggrappata all’autoreferenzialità della sua lingua, entro una parola chiara, esatta, a tratti asciutta, ma sempre penetrante tra le aspirazioni e le spine di una realtà alla prova delle sue cronache, e delle sue demolizioni. Un notturno allora dal titolo a dire le oscurità ma anche le sospensioni di un umano provato, sofferto, avvinto tra desideri di respiro e piccole, quotidiane evocazioni tra cielo e terra, tra sé e il suo mistero più grande e sciagurate indifferenze, malie di rigetto a quell’altra parte battuta, vinta, respinta, apolide a se stessa e agli altri in quel sistema sociale, economico ma anche culturale in cui sempre gli ultimi restano gli ultimi. Così il testo è possibile dividerlo in due parti, la prima nelle due sezioni di “Souls at night” nell’evocazione nello sguardo al cielo, alle sue stelle, ai suoi rivoli di luce nel bagno quasi leopardiano, antico di nostalgica interrogazione, e di “Birds” nella familiarità di esseri cui è riservata tutta la prossimità di una condizione di finitudine, e di stallo e di “The dark night of the souls-Mediterranean, migrants” (dal libro precedente, “Il mare mi ha deposto dalla croce”), in cui Bracco immagina di dar voce “agli sventurati” di quella infinita tragedia che ha nome di Mediterraneo, nel cimitero immenso di chi cercando approdo per una vita migliore trova respingimento se non soventemente la morte. Notturno allora come anche la notte di una coscienza che si infinge da una parte e quella dall’altra di chi si prova, di chi non ha più dove andare o dove tornare in una distesa di separazione entro una vuota arca priva di alleanze perché priva di riconoscimenti, e di identità allora in quella carta di diritti, di partecipata umana e politica presenza, in cui ogni scrittura è atta se non nella sua negazione, e nella sua ipocrita, vile e addormentata, a proposito di notte, impotenza. Perché il discorso di Bracco, l’intelligenza del cronista riportata nella sapienza dell’autore, è iscritto all’interno di una identità più vasta la cui affermazione, di vita certo nei fattivi intrecci delle sue diversità e dei suoi orizzonti, vale l’affermazione di un umano tout court altrimenti scoperto alla propria mistificante incoscienza (priva di interrogazione), al blandire a perdersi dei suoi demoni. Un discorso allora riportato in tutta l’urgenza di uno specchio in cui ogni figura in quanto sovrapposta, confusa nello stordimento dell’uscita è figura dell’altro nel buio di un insieme il cui limite non è separabile nell’unità di una pronuncia che già nel dire, nel dirsi può avere in sé un’uscita. Non vogliamo suggerire di più pertanto lasciando al lettore il confronto con uomini cui Bracco non cadendo mai nel tranello della banalità e della retorica concede nello spazio di pochi versi il respiro primo e ultimo di una esistenza che dice anche noi nella misura di una creaturale volontà ad esserci e a rispondere che forse di qua si va dimenticando. Solo riportare dal cuore di una Roma ferita ma presente la sostanza di una incarnata corporeità di futuro espansa come da un piccolo, vivace laboratorio nello studio di un pediatra a Piazza Vittorio in tutti quei bambini provenienti dalle parti più disparate del mondo, “figli radici/che dicono le voglie di restare”. Di qui forse nell’aria di ritornanti e risonanti composizioni di uomini e di terre tutta la vitalità di una speranza “che unisce e non divide” e l’augurio di una scrittura che sa riportando vedere e rimettere alla appassionata coincidenza dei suoi incontri. Augurio che è anche il nostro nella bontà di un testo riportato anche nella versione inglese di Federica Giovannelli.
Id: 1319 Data: 12/11/2021 12:00:00
*
 Marcello Marciani - Poesia - Morettie&Vitali
Marcello Marciani - Poesia - Morettie&Vitali
Sottovuoto
Sempre una gioia poter leggere, perdersi, interrogarsi dentro la poesia di Marcello Marciani, autore fra i più interessanti e intelligenti della nostra scena poetica di cui in più di un’occasione abbiamo avuto modo di poter riportarne la scrittura sempre nel vivo di una lingua, anche nel dialetto della amata Lanciano, ora eversiva ora divertita ora soprattutto mai banale. In quest’ultimo libro il tema, doloroso, affrontato è quello del lutto, o per meglio dire di un’assenza, quello della propria donna scomparsa, che è fra i più cari e affrontati dalla poesia di ogni tempo. A proposito di assenza, allora, non può non venire in mente il pluricitato, famoso, perché terribilmente vero, verso di Attilio Bertolucci: “Assenza,/ più acuta presenza”. Verso che si sposa assai bene col ripercorrere e scrutare di Marciani all’insegna di un percorso, di uno spinoso ma anche insieme dolcissimo memoriale di giorni sedimentato negli anni e riportato nel lenimento cosciente della parola all’interno di una rotazione di cinquantadue sonetti con cui il testo si compone. Un anno, insomma, per dirli tutti certo, seppure in questo caso nel nodo di intreccio con quel tempo di pandemia che di lutti e di scomparse improvvise e in solitudine ha riempito cuori e immagini di un tempo d’oscura dissolvenza. Così, davvero, ci sembra ben indovinata, e magnificamente risolta, la scelta della struttura più nobile della nostra tradizione poetica a dire nella classicità dell’endecasillabo (nel dialogo a tratti dalle viscere con quel frentano lingua dell’anima) tutta l’impotenza di sempre, e del moderno nelle sue illusioni dominanti e giaculatorie, di fronte all’evento principe della condizione umana, la sua mortalità. Così ciò che ci viene restituito è un testo poeticamente ma soprattutto umanamente ricchissimo che la parola ha saputo raccogliere tra le maglie di un Orfeo che ha imparato nel suo doloroso gioco dell’oca a non voltarsi a guardar più se stesso o per meglio dire a guardarsi nuovo dal sé di prima finalmente, forse, proprio perché dalla sua Euridice, dalla sua bardascella deterso nella “spugna del lavacro” (scusandoci per il riferimento al mito ma questo è, questo risuona come da testo XLVIII). Non più la morte dell’altro per dirsi ma progressivamente dire dalla morte dell’altro quel sovvertimento che l’amore nel suo spazio, nel suo innesto ermafrodito, nella sua fragranza ancora incarna “trascendendo il deserto e il suo compianto”. Ma questo è di poi, prima, ancora, da una terra di cielo vedova, lo scompenso, la mancanza d’aria, rimestata cercata scavata da quel mare immenso, infinito di bracciate lontane, nel pieno della vita, dei suoi oggetti, delle sue tracce, animali elementi cose piante che la parola può solo inseguire, ricucire, scuotere nella forza di una struttura come accennato da Marciani rielevata dal cuore di una sapienza che in lui viene dal basso, uomo e artista che sa tutta la dolenza e la maestria di una condizione, di uno sgomento che viene dal limite, da quel vasto presepe dell’altrove che qui chiama e si incarna. Sapienza che non lo fa, non ci fa soli, dunque, in quella dimensione del racconto a dilatarsi e a risalire poi nei riferimenti ad una pandemia che è soprattutto prima dell’anima. Ché questo personalmente tra l’altro chi scrive ha sempre apprezzato in quest’ autore così raffinato, il non sfilare mai nel suo teatro ardente il personale dal collettivo, ma il ridirsi e il dirci ogni volta insieme perché come in questo caso dirci nell’assenza è il ridire ancora nell’evocazione tutto il senso del nostro essere a perdere e a interrogare nella dignità del possibile restare e riacquistare. Da questa considerazione, da questo presupposto allora preferendo non aggiungere nulla alla lettura libera cui caldamente invitiamo, e su cui ancora molto ci sarebbe ancora da dire, andiamo a fermarci augurando al caro Marciani e al testo stesso tutta l’attenzione che merita. Aggiungiamo soltanto la preziosità delle annotazioni metriche sonetto per sonetto di Francesco Paolo Memmo poste ad appendice, interessante e insolita guida ad una scrittura come dicevamo poco comune.
Id: 1317 Data: 22/10/2021 12:00:00
*
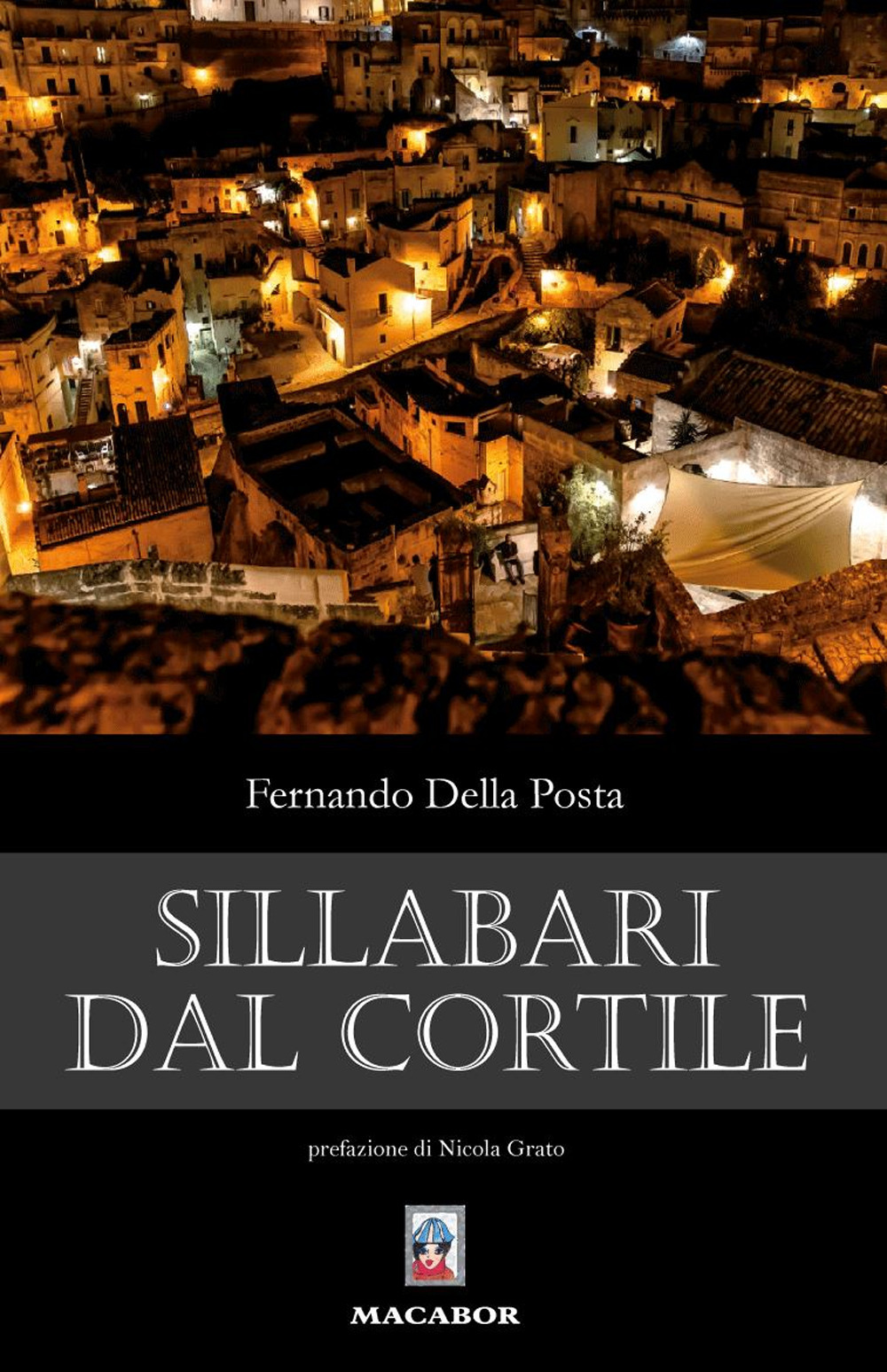 Fernando Della Posta - Poesia - Macabor
Fernando Della Posta - Poesia - Macabor
Sillabari dal cortile
Di Fernando Della Posta già avemmo a scrivere a proposito di “Sembianze della luce”, uscito nel 2020 per Ladolfi, nella distinzione di un’opera intimamente ferma e di lì attraversante nei frantumi di un mondo dolentemente piegato, e indifferente alle proprie logiche di rifiuto, di negazione. La forza di questa scrittura, che in quest’ultimo lavoro resta, più forte, pienamente confermata, non è però si badi bene in un aggressivo e cronachistico dettato nella superficie della sua denuncia ma come detto nella sapiente maestria con cui le cose, le figure, le città sembrano nella pronuncia stessa della parola, della loro esistenza riaffiorare ancora e riaffermarsi, seppure per un breve attimo prima di un inevitabile riaffondo nel buio. Così è in questa partecipata espansione in dissolvenza la verità di un autore che ha nel balbettio la registrazione della sua, della nostra umanità sofferente (e che nell’intelligenza del dialogo sa ben guardare alla storia alla presenza autoriale di chi lo ha preceduto, pensiamo in questo caso oltre al citato Zeichen a Caproni e allo stesso Pasolini). Alfabeto allora e sillabario nella consapevolezza di una ricostruzione, forse, che può muovere solo dal riapprendimento dal basso (di cortili certo nella simbologia dell’incontro e della prova), dal dire di un muovere per ombre alla luce di un sottomondo, dei tanti sottomondi (così avemmo a chiamarli) le cui fratture più che all’ascolto muovono alla luce. Sono spazi questi di Della Posta, autore versatile anche nell’attenzione critica dedicata alla altrui poesia, di spoliazione infatti, che nella sobrietà della parola e di ciò che resta dalle rovine ha nella povertà del possibile (intesa anche come essenzialità, denudata chiarezza) e dunque dell’amore come unica offerta. “Lievito madre”, seme e “fiore di filo spinato” che nella totalità delle sue accezioni tenta i propri naturali e dovuti riappropriamenti a partire da una identità che ha nella corporeità la sua istanza, il suo riconoscimento nella reciprocità del dettato. L’ordine, il “meccanismo” (nello scenario di una Roma che ha la sua dominante, anche se non mancano accenni ad altre metropoli), rotto e ricomposto dal sentirsi, dirsi nella pronuncia di un ritrovamento (del ritrovamento forse non a caso stavamo scrivendo) che vale per le cose, gli elementi e le figure tutte che care ci fanno e ci ricordano ad una terra altrimenti sola, desolata, saccheggiata allora sì. La vita nella sottolineatura non è tra altezze e perfezioni ma semplicemente nella sua naturalità (ed infatti tanti sono i riferimenti ai bambini), nella regalità della gioia e non del dominio ognuno non sfuggendo al rischio di non portare frutto (“non c’è altro modo per volervi/ bene, se non lasciarvi arbitri senza/ obblighi, con una pallida memoria/ di leggi lasciate lungo il cammino” è scritto in “Dono”). Così, a proposito di frutto, è dalla terra stessa che dovremmo riapprendere, da un’abilità che passa anche dall’abbandono per poter tornare in “coincidenza di veste e sostanza,/ fino al mallo della pietra,/ nuova creatura”. Terra che però può, ha abitazione solo nella consapevolezza di un processo che non ha esclusioni ci viene ricordato, non essendoci vera salvezza nella dimenticanza degli altri semmai il moltiplicarsi nella distanza della sensazione di un insensato appartenere, del far parte ancora- sempre,- di una tribù sbagliata, separata per questo e dunque persa perché non più umana. Sano allora nell’esodo da se stessi per Della Posta alimentarsi al dubbio, di un messa a fuoco della giustezza delle disposizioni, come quella del pudore ad esempio, a quali fonti se di salvezza o di dannazione possono muovere. Aggiungiamo infine andando a concludere che ciò che contraddistingue e fa cara questa scrittura è propria la rara capacità dell’autore di dire e dirsi entro una presenza che non si avverte, quasi anonima nell’incisione di un segno che proprio per questo resta imponendosi con più forza, il dettato una registrazione che risale dal reale, non un punto di vista dunque ma un espanso punto di sentire. E questo non è poco nel servizio anche a un dire poetico che si va smarrendo.
Id: 1313 Data: 10/09/2021 12:00:00
*
 Giorgia Deidda - Poesia - Place Book Publishing
Giorgia Deidda - Poesia - Place Book Publishing
Sillabario senza condono
Esordio importante, significativo, maturo questo di Giorgia Deidda, giovane universitaria pugliese. Entro una scrittura tagliente, incalzante che nulla scarta del suo doloroso interrogare, del suo laminato colpire e colpirsi in una malia dell’anima che ha nella paralisi il motivo del suo sfuggire, della sua mortificante disattesa, smuovono questi versi anche un doveroso riflettere sulla natura stessa della poesia, sulla sua terapeutica tensione nello scioglimento, o nell’alleggerimento di quelle distonie di separazione che finiscono coll’infingerci, coll’imprigionarci nei demoni, antichi, delle nostre negazioni. Infatti quello della Deidda è il racconto del corpo a corpo con se stessa, con le proprie irricomponibili fratture ad una mente, ad uno spirito che appare interrotto tra malattie e timori del mondo ed aspirazioni di cielo, di fecondità cui l’altro però appare non compreso, l’altro causa e vittima dei suoi sgomenti nell’eterna notte dei suoi scoperti fantasmi. Così questo sillabario (e certo non poteva esserci titolo migliore) ha la misura esatta di una perdita, di una mancanza (di se stessa, del mondo, degli altri come detto) che ha nella dinamica perfetta del suo osservarsi l’espressione di una lotta con cui forse, a volte, volendo, si può solo venire a patti, la parola racchiusa tra ininterrotto fluire di desideri, incisioni, allarmi e l’essenzialità di un versificare che nulla può e concede rispetto alle logiche delle proprie rimostranze. Uno sguardo il suo in disputa con una bellezza (negli intarsi degli spazi, nelle chiamate della volta) forse insufficiente perché mortale, perché come lei imperfetta (nella “anemia di un universo che non trova più il suo infinito”) e indifesa a quel continuo fluire cui solo l’amore a tratti può sostenere esposto com’è anch’esso al blocco dei suoi sgomenti. Ed è una scrittura molto femminile nella registrazioni dei suoi effetti, corpo e psiche nei sintomi di un’ombra cui non sfugge, nelle sue parole interrate e prive di sogno, nella spaccatura del “loro imprendibile avvertimento/che vaga nella mente come un confine/e non riunisce “. I riferimenti ci ricorda nella acuta postfazione Alberto Burina sono quelli dell’amata Rosselli, della Plath, della Sexton seppure la Deidda somigliando esclusivamente, autenticamente a se stessa in una metafisica della memoria, di “triste fossile”, della cui prigionia restando vittima non si libera in un dettato (in questo d’accordo con Burina) sovente claustrofobico, il lettore incalzato, risucchiato ma anche il più delle volte fortemente respinto entro un testo sulla cui natura, bisognerebbe interrogarsi e interrogare più approfonditamente. Una parola poetica infatti conosciuta, frequentata e restituita molto bene, e dunque ininterrottamente valida, che corre il solo rischio alla lunga però di parlare solo a se stessa nel sintomo del malessere che racchiude (in questo allora funzionalmente valida), in eccesso allora non sempre in quell’apertura di cui la poesia comunque è portatrice (la scrittura poetica, è vero parlando di se stessa ma una volta detta deve dirci). In questo caso, è bene sottolinearlo, però avvenendo solo in parte, la Deidda sulla scena con la verità di un’ autrice alla quale auguriamo tutta l’attenzione che merita e che andiamo infine a restituire nella consapevolezza di una luce che tenta nuovi battesimi: “C’è una vita dentro di me./ È l’assenza, non preghiera, delle cose lontane./ È il guardare la pellicola da vicino/ e toccarne gli arabeschi e le intarsiature,/è godere della bellezza nascosta/nelle cose dimenticate,/è guardare/ senza rimpianti i propri occhi, è guardare/ quelli degli altri senza più paura”.
Id: 1310 Data: 09/07/2021 12:00:00
*
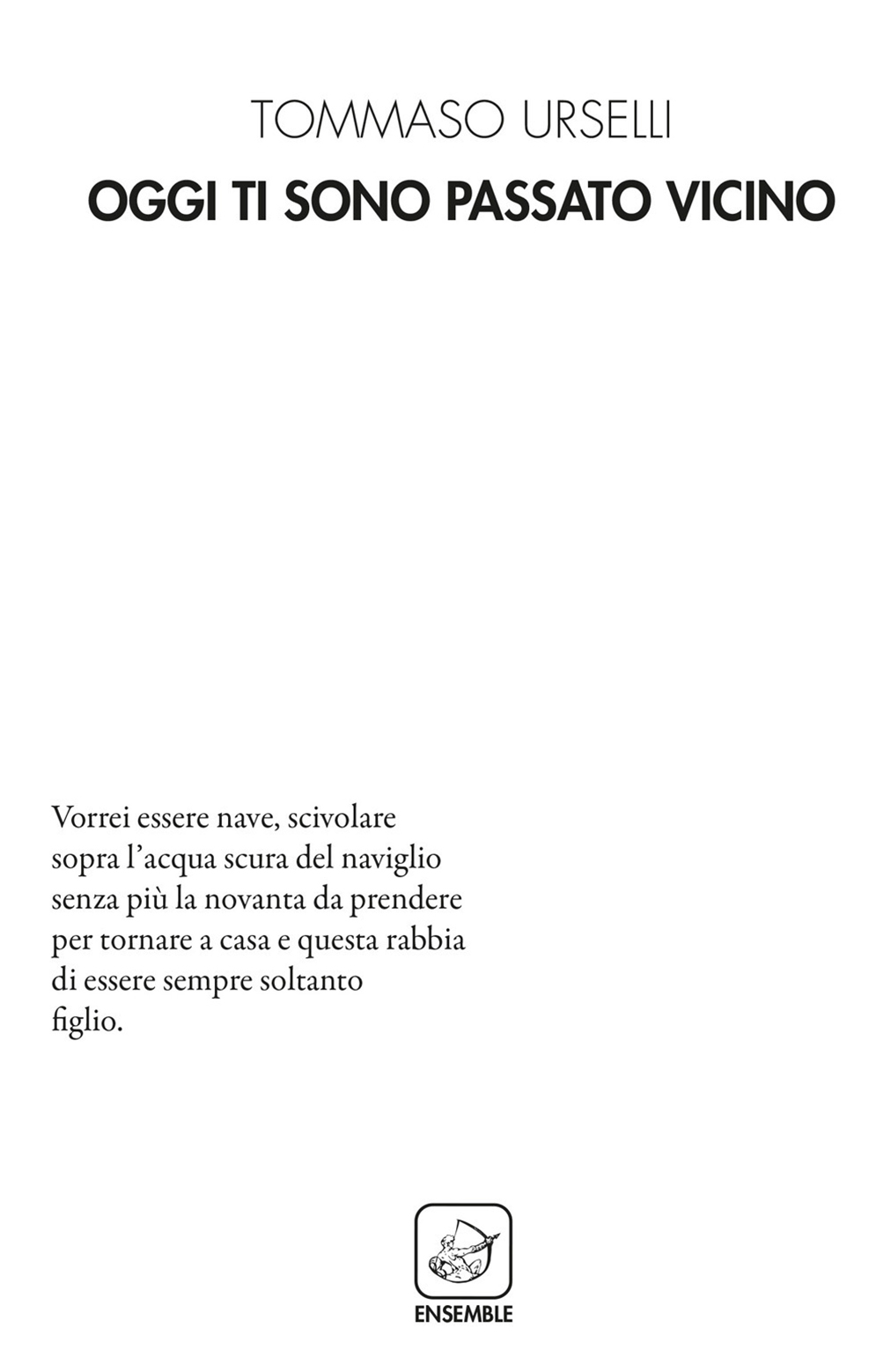 Tommaso Urselli - Poesia - Edizioni Ensemble
Tommaso Urselli - Poesia - Edizioni Ensemble
Oggi ti sono passato vicino
Opera prima di un autore attivo soprattutto nel teatro ha questa raccolta in cui si intrecciano periodi diversi di scrittura la nota riuscita di una parola che, come da impronta, sa mettersi in scena, viva allora nel richiamo della nominazione nella spinta a muoversi, ad agirsi. Non a caso la riflessione che si nutre nei riferimenti di spunti classici e tragici (dal mito di Teseo e il Minotauro, di Ipazia ed Eco e Narciso fino a Dedalo ed Icaro) ha della nostra presenza e della nostra riflessione nel mondo il sapore acceso di una condizione attiva della memoria, di voci elementi ritorni in grado di reinterrogarci in tutto ciò che ancora segna “lo scorrere del tempo, questo tempo che trascorriamo insieme in questo mondo che ci è dato di abitare” e di salvarci allora, a proposito del mito, dal labirinto delle nostre perdite e dei nostri misconoscimenti. Una parola per questo provocante nell’inquietudine di un presente raccontato allora per piccole presenze, piccole trasparenze del quotidiano, oggetti, luoghi figure a imprimersi nella dimensione dominante del silenzio in accompagnamento agli smarrimenti e alle foghe di un’epoca ferma ancora come negli occhi di Ipazia entro una terra reclamata da tutti ma in realtà di nessuno, sospesa adesso nello scarto paralizzante della pandemia. Il riaffiorare e il trasparire delle tensioni, delle sopite vocalità di uomini e spazi a (ri)dirci nella misura dei “versi e delle cose” di un inscindibile e originario appartenersi ha pertanto il senso di un confermato affidarsi nella ferma ingiunzione di un legame altrimenti minacciato, altrimenti offeso. Legame affidato da Urselli principalmente al dialogo col padre scomparso, dapprima nei testi composti durante il lavoro di raccolta proprio delle poesie paterne, nella cui voce è udibile tra un verso e l’altro ancora la vicinanza(ed infatti di qui il perché del titolo) nel comune tratto di un pensare lento e ingarbugliato sempre alla ricerca di uno spiraglio di luce (di una uscita, nel frenetico abbracciare del mondo), e poi con la figura del padre tout court nei rimandi anch’essi al mito dei testi successivi (vedi la sezione “In labirinto” nata da una lettura da Durrenmatt). Uno spazio però che è anche quello degli oggetti e delle cose che ci dicono, e ci diranno anche poi, nella conferma in noi- come soprattutto nel caso dei versi scritti proprio nel periodo del lockdown- del riflesso e sostanziato incarnare del tutto. Un modo questo di riportarci nella misura di cui accennavamo al senso del ricordare in cui è iscritto il senso stesso del nostro stare al mondo (e che proprio nella lingua delle cose e degli oggetti fa tornare alla mente certe disposizioni, certe modalità di Zagajewski) in cui le prime memorie, le prime geografie temporali nel carico delle stratificazioni sono iscritte nel corpo (corpo-città è la definizione di Urselli) e nella terra cui l’occhio tenta ancora nel piccolo il riconoscimento, e dunque il modello, di un più fermo e dilatato respiro. È il caso di una delle sezioni conclusive, “Parole alle formiche”, dove nell’accettata comprensione della natura in se stessa, di elementi e di cose senza attaccamenti di sé nella schiavitù dei ricordi ma riconosciute in se stesse, nelle proprie bellezze dal reciproco apprendimento degli sguardi, è iscritta quella remissiva smitizzante geologia di cui si accennava e di cui l’uomo ancora può e deve apprendere verso quella foce, quella “madre infinita” che non cessa di attenderci e di parlarci nella “spuma bianca” di pensieri che come foglie, inerpicandosi tra rami, “vogliono venire al giorno”. Figli tutti allora, come nel testo finale di un incantato sguardo, di un’incantata disposizione che viene dalla memoria dell’altro nell’affermarsi in noi degli spazi, del mondo stesso dunque nella fragilità del passaggio. La forza della poesia di Urselli (molti dei testi, tra l’altro, messi in scena) è tutta in questa testimonianza di fede, di uomini e donne affermativi laddove proprio la terra sembra mancare.
Id: 1308 Data: 25/06/2021 12:00:00
*
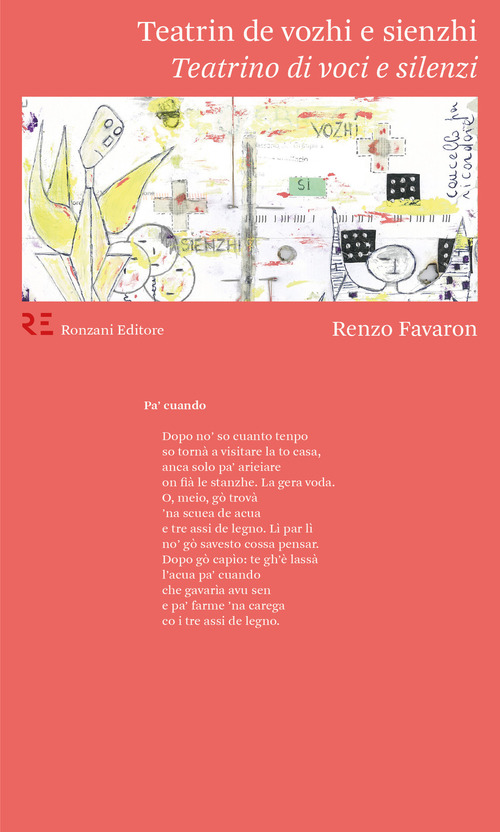 Renzo Favaron - Poesia - Ronzani Editore
Renzo Favaron - Poesia - Ronzani Editore
Teatrin de vozhi e sienzhi (Teatrino di voci e silenzi)
Classe 1958, poeta e narratore veneto bilingue, Renzo Favaron è da annoverarsi tra gli autori neodialettali più rilevanti e incisivi del nostro paese in una produzione oramai trentennale nell’uso di un veneziano sapientemente dosato nella coscienza di sé e del mondo secondo la cronistoria della sua scelta come espressione di una storia personale vissuta sofferta e pensata in dialetto , e nella consapevolezza allora dell’insufficienza dell’italiano stesso in quanto lingua già pronta, e dunque meno malleabile, a dire compiutamente ciò che si deve, ciò che è. Una lingua la sua “distillata e duttile perfettamente radicata nel territorio” come ebbe a rilevare la critica, ma appunto costruita nel tempo e per questo perfettamente salvaguardata nei riferimenti a morire delle antiche parlate in quel restare là dove quello scomparire significa anche lo scomparire stesso, antropologico, degli uomini. Questo appunto a riferire un continuo far di conti coi limiti di una condizione allargata e più universale di limite, di prova nel concreto dettato di un quotidiano svanire e un quotidiano incarnare, e dunque anche di un quotidiano perdersi, in questo intenso volume riportato alla dimensione luttuosa della definitiva assenza, e dunque allora, anche (nonostante i tentativi e forse gli infingimenti) al prossimo scacco della parola a dirlo, e a dirsi. La scomparsa, la mancanza al centro della narrazione è quella dell’amata madre ma non nella freschezza della perdita piuttosto in quella per certi versi più risonante perché ormai saldamente incorpata nell’anima del tempo lungo, dieci anni, e di un pensiero come già da primo testo che non sa rispondersi se non nell’immagine di una ferita ancora aperta. Il racconto allora è quello di un orientamento con la quale si cerca di venire a patti nella consapevolezza di un passato e di ciò che poi è seguito che non si può sciogliere. Così a seguire, nel partecipato e sofferto riconoscersi entro cui il lettore è come strattonato, è tutto un lottare con se stessi e con l’immagine dell’altro e di una figura che si vorrebbe per sempre, pur nell’assenza, nella struttura, nell’idea relazionale del tempo antico ed invece riportato a una dimensione di cui nulla sappiamo e dunque nella vanità adesso di una memoria i cui dialoghi nell’intento di trattenere finiscono col cedere piuttosto all’illusione di un soliloquio che rimanda sempre le stesse immagini, sempre gli stessi toni e una voce che non è altro quella dei nostri echi interni, delle nostre irredimibili paure (d’altronde il ricordo come gli ricorda la stessa madre è anche un’erba amara). Come è straziante allora questo avanzare e retrocedere nello stordimento sotto i colpi delle rassicurazioni e dei reclami circa le proprie abitudini di sempre dove a imporsi sovente è la forma reciproca della lettera in cui a dominare è la realtà di non sapere più chi si sta pensando, se è giusto come è giusto fermarsi al ricordo o lasciarlo andare, rinascere con esso col rinnovamento stesso dell’altro in quella dimensione di cui però non sapendo nulla non resta che il pungolo e lo sforzo della parola, nella sua accezione pienamente umana dell’imprimere e del dilatare cui forse solo il dire della poesia per sua natura potrebbe anche nell’abbandono dare meno condizionante accesso. Ed è allora in primis una parola che nell’attraversamento della carne, e non potrebbe essere altrimenti, affonda e ritorna nei luoghi e negli spazi di sempre, nei frammenti delle cose dove la vita quella vita che ancora ci parla appare ferma e ancora sospesa tra il dire e il rimettere, tra la pronuncia e il trasfigurato silenzio entro una insonnia che non è poi solo del corpo ma quello di un abbandono entro una quinta senza più copioni, attori soli adesso in una parte di cui non si sanno perché non si hanno più le battute e le controparti a cui riferire. Dunque è questo il teatrino di cui Favaron ci parla (“teatro de on scherzho infinìo/’ndove no’ resta che le parole/e ’na vozhe distante” “teatro/di uno scherzo infinito in cui non restano/che le parole e una voce distante”), in un cambio di scena di palchi separati, i cui protagonisti sembrano inseguirsi oltre il buio del velo nella non comprensione di lui dei suoi fantasmi. Allora è tutto un dire con noi a voce alta come a chiamarsi a liberarsi già nella condivisione molto classica e quasi terapeutica della propria passione, della mortalità non solo di una condizione ma soprattutto di legami. Voce voce voce, quella del figlio a spiegarsi a cercarsi e a cercarla, quella della madre ad acquietarlo e a rimandarlo nella direzione più sana dell’avanzare (“vivare male/ el to tenpo, xe vivare/male el tenpo passà/(...)/el sole cresse in avanti” - “vivere male il tempo/ presente, è vivere male/ il passato. (...)/il sole cresce sempre in avanti”), e quella del nostro essere uomini e donne alla ricerca di un senso in quella solitudine che più ci appartiene nel profondo e che non sappiamo portare, in quel silenzio a cui non sappiamo affidarci ma che potrebbe salvare nel nostro gioco di proiezioni. Così se la madre non può tornare, il figlio può ridurre le distanze buttando la parola dall’altra parte traendo a sé di nuovo come da rete ogni riflessa immagine in questa distesa di un’Ade sotto una luce che non cambia mai, di figure evanescenti ma non nella stessa consistenza e stabilità di relazione, la cui unica occupazione nel racconto della madre è il camminare continuamente in una direzione sola non conoscendo la meta nella visione di una fine (a partire da quella del marito Giovanni) che avviene per decomposizione (tra il gassoso e l’acquoso in cui è possibile scorgere fattezze e parte di una natura vegetale). Una seconda morte dunque (in una evocazione fortissima acutamente affidata nel legame di condivisione e potere proprio della scrittura alle parole di Thierry Metz, poeta che toltosi la vita alla morte prematura del figlio di là vaga alla sua ricerca) in una meditazione che in qualche modo non lo vince né può un’impossibile pacificazione in una quinta che resta ma pure lo rinsalda nella consapevolezza adesso di una memoria che sfronda, va a toglier via come nell’opera di uno scultore ciò che non serve, ciò che è inutile. Nel ritorno ancora, anche, di un eco paterno sul senso di una universalità di buio da cui tutto nasce, nel contrario della visione (noi di qua, noi di là, nelle nostre reciproche condizioni) dell’impossibilità di vedere nei nostri cuori, sempre che qualcosa da vedere ci sia: “cue’o che ghe xe de acessibie/xe inpensabie. E inaferabie” (“Quello che c’è di accessibile è impensabile. E inafferrabile”). L’eredità allora resta, deve restare, nella parola stessa nel suo fiorire, nel suo smentire del silenzio l’azzeramento passivo, nella misura allora sì di spazi di nuovo colmi laddove è possibile sempre ogni comprensione di ciò che è, di ciò che è stato. Questa è la nostra consacrazione, e questo anche è stato in questi versi nella carne e nella densità di una scrittura la cui forza, in questo veneziano (come da qualcuno sottolineato) di “coloritura occidentale”, è nel corpo di una materia incandescente nell’umile remissione di figlio - e di uomo - a fronte di un mistero più grande che quella stessa parola dalla terra trasfigura e, nella terra, raccogliendo, seminando supera.
Id: 1306 Data: 26/05/2021 16:18:00
*
 Gabriella Sica - Poesia - Interno poesia
Gabriella Sica - Poesia - Interno poesia
Tu io e Montale a cena
Di Gabriella Sica, docente universitaria, promotrice culturale e poetessa di lungo corso poco abbiamo da ricordare, la sua attività, il suo amore soprattutto per il dettato poetico nelle sue più diverse accezioni di incontro, domanda, investigazione nel corpo dell’umano presentandosi da soli. Come nel caso anche di Valentino Zeichen, l’autore di Fiume, o faremmo meglio a dire l’autore romano per l’adozione reciproca, o l’autore insieme di tutte le terre e di nessuna terra per lo scardinamento di un’appartenenza al mondo che insieme lo enuclea, nell’insieme, e insieme lo nega, lo riassetta nei frammenti delle sue infinite epifanie. È un libro questo, di una quarantina di poesie e due brevi testi in prosa, apparentemente semplice nella sua struttura ma difficilmente catalogabile, ed è un bene perché nel suo essere ora memoriale di una vita, di un’amicizia, di una poesia raccontata nella libertà anche da se stessi, dal proprio passato, dal proprio presente di risonanti assenze, cui continuamente, gioiosamente e dolorosamente chiama, ci investiga dal profondo e ci commuove, l’autrice spogliandosi di ogni ruolo e rivelando la donna, l’anima smarrita alla perdita dell’amico, Zeichen scomparso nel 2016. Così il lungo racconto di un rapporto antico nella consonanza e nell’affinità di un dire più che poetico umano, teneramente e drammaticamente umano nelle pieghe di una storia e di una contemporaneità sovente votata al rigetto, è il racconto di un uomo sì esule dalla propria patria, espropriato da se stesso e dalla propria lingua, che ha saputo riguadagnarsi e mostrarci la strada nella riappropriazione di tutto questo tramite la sua spoliazione, il suo servizio nella distanza ora monacale ora pienamente, provocatoriamente addentro nel duello col mondo, ma anche quella di un’amicizia, sul cui valore, il valore cui tutti noi diamo e viviamo questi versi invitano a riflettere. Per questo è un testo riuscito questo della Sica, perché sfonda, scarta ogni discorso critico (pure in una scrittura densissima, aerea e corposamente viva nel vagare tra figure e ricordi) strattonandoci nello spazio di quella corona cui ogni morte (come ben rilevò la Cvtaeva) si inanella a tutte quelle morti che in noi l’hanno preceduta fino alla prima morte la cui vita nella sua rivelazione ancora ci interroga. Tramite Zeichen infatti la Sica parla di se stessa, di una prossimità addestrata, carezzata, inseguita nella seduzione ora del poeta ora dell’uomo risaltando in questi testi una dolcezza e una intimità di sguardo forse solo alle donne possibile nello sgomento, nell’impotenza di fronte una storia, una figura cui riesce a dare il taglio del bambino, lei bambina con lui, bambina sempre, fuor di retorica sorella sempre, sorella piegata adesso, sì, ma riconoscente. È un racconto di Roma anche, di quel cuore ora metafisico ora per levità d’arte e di vita concretamente acceso tra la leggendaria “baracca”- residenza di Zeichen in Via Flaminia e cene, incontri, riapparizioni di nuvole in versi, di numi della cultura e della poesia italiana nella confidenza di uomini e donne colti nella spigolatura del sorriso, nella teatrale rappresentazione di un’epoca che ancora ci appartiene ma che non riconosciamo, dalla Sica espansa per non disperderne l’abbraccio, per non disperdersi lei, adesso, soprattutto. Ed è in questo smarrimento cui non è difficile aderire, ognuno di noi per personali debiti e per personali timori, la forza testimoniale di una apertura ancora al destino di incontro che è nel richiamo di ogni giorno, ogni giorno il dire poetico, la sua rivelazione più alta nella discesa a ricucire uomini e distanze, la vita mai vinta, come nell’immagine di quel glicine in fiore nel giardino del suo Valentino nel testo finale. Reciso dal male degli uomini, dal tronco spuntano foglie “più tremolanti del solito” ad annunciare “qualche altro bel fiore”. Fiori ancora di uomini e donne in poesia ancora, nella lezione anche di uno degli ultimi, pochi maestri (ne nascono ogni cent’anni, in questo aveva ragione Moravia), Zeichen infine riportato nell’esattezza di una verità, la sua verità di cui forse solo adesso, come spesso succede, con più nitidezza ne comprendiamo l’ardore. Spessore poetico e di uomo dalla Sica, dall’amata Gabriella forse tratteggiato come nessuno nel suo saper sopravvivere “a dispetto del male/ con poco nel poco per poco/come si vive vivo tra i vivi/dopo una gran catastrofe sonora/con tutto nel tutto per tutto” ed ora che non può tornare immaginandoselo vivo, lontano in un bar a Finisterre, “come migrante a bordo dell’Europa”, a fissare come “impenitente vedetta” “le macerie della storia”. Questa “spiga di grano” è l’omaggio a Valentino e a se stessa che la Sica ci lascia, il girasole che bramando la vita la vita in poesia riaccende, nell’invito a rileggere Zeichen dunque, anche, rileggendovi però insieme ogni amicizia, ogni incontro che l’esistenza pur nella dolenza degli addii che verranno per grazia ci offre. E allora grazie Gabriella.
Id: 1299 Data: 23/04/2021 12:00:00
*
 Sandro Sacco - Poesia - L’erudita
Sandro Sacco - Poesia - L’erudita
Poesie scritte camminando
Autore per il teatro, narratore, poeta qui alla sua seconda pubblicazione in poesia, Sandro Sacco ci regala in queste pagine un'apertura alla vita, e alla sua restituita forza e dignità di verso, scevra da intellettualistiche, pregiudiziali letture, come accade purtroppo ormai in buona parte della nostra poesia, pienamente affidata allora alla fede confidente in una favola che ci sa nuovi e unici sempre a partire dalle fenditure di stupore cui quotidianamente incontri, richiami nella fragilità delle figure e dei ricordi sanno in qualche modo evocare perché accolte nell'aderenza di luce che li rivela. Una poesia libera per questo anche da se stessa, dal suo autore in una sapienza di pronuncia che mentre si dice si annulla dilatando il lettore in una dimensione intima, dell'uomo e della donna raccontata nel sommovimento del cuore e del corpo, e insieme partecipante del mondo perché del mondo in ognuno, di ognuno ripetuto mistero e sostanza (sotto un Dio che "se ne sta seduto appena un po' più in alto"). Un naturalissimo, divertito eppure mai compiaciuto affabulatore potremmo definire Sacco, così innamorato di ogni esistenza, di ogni suo passaggio nell'aderenza carnalissima e sensuale dei suoi elementi, cui la parola si piega e si presta come nella cova in una nascita che moltiplica e riafferma la terra ("Stanno nei loro gusci/Le parole/Prima di nascere/Aspettano") nell'incontro tra i suoi ordinari e per questo così preziosi respiri e le infinite comprensioni di un qualcosa che nel superamento li trasfigura e colma. Terra attraversata nei testi davvero in lungo e in largo (dall'Africa al Giappone, dalle Americhe all'amata Parigi) e appresa nella forma della danza (più che camminando come da titolo) se nella danza movimenti e origini d'ognuno vanno a sciogliersi come in espanse gradazioni della lingua. Come nel caso del tango soprattutto nella dedica di più testi, dove l'inseguimento è dapprima spia e inseguimento dell'occhio prima che dei corpi, nel collante di passi cui ogni invito è una richiesta- e una sfida- nel sospeso riconoscimento delle anime. In realtà questo rituale corteggiamento delle forme, di uomini e donne, degli elementi come detto, ci sembra il motivo di spinta di un canto che sa attingere con originalità a lezioni diverse, sempre nella risonanza di un antico sguardo nella sua continua ricerca, quella della fede in un richiamo che non ci vuole soli nella detta incisione dei destini. Ragione per cui dunque accennavamo alla favola perché è nel favolistico intreccio di esistenze e approdi che anche una inceppata moderna visione di sé può esser sorgivamente ricomposta alle proprie formule di origine. Resta quella di Sacco infatti una parola che sa ricomporre fratture anche involontariamente nella semplice espressione delle tensioni. Per questo non ci sorprende apprendere del suo insegnamento a ex ragazzi soldato e a bambini di strada nella Repubblica democratica del Congo a teatralizzare le proprie strade, come anche le parole spese per lui da Elio Pecora nella prefazione a proposito di un "umano che si conosce e si esprime, si rappresenta come per una inattesa scoperta, che è insieme scoprimento e consegna". Ed è per questo, anche, che lo consigliamo e lo ringraziamo.
Id: 1292 Data: 05/03/2021 12:00:00
*
 Roberto Donati - Poesia - Transeuropa Edizioni
Roberto Donati - Poesia - Transeuropa Edizioni
Postmoderni
Forse non ha molto di critico riportare così la lettura di un testo ma ispira una naturale simpatia questo lavoro di Roberto Donati, quarantenne docente, scrittore e sceneggiatore, nel tono di una malinconica e distanziata presenza dal mondo se per mondo si intende, come ora è vissuto, bramato e subito l’esercizio disordinato e senza riferimenti del quotidiano e di se stessi. L’amore anche, ridotto a separati silenzi nella riuscita immagine già del testo d’apertura della passeggiata della coppia nell’abitudine di parole e incontri (“come da sole/ unità più unità/ mai somma//mai plurale”) cui allora, viceversa all’essere soli e non accompagnati segue piuttosto ora il desiderio di momenti ordinari e comodi come di sera tenue e piena di un ritorno a casa condiviso e familiare ora di consapevolezze di troppe nebbie ed ombre a parlargli, a parlarci dentro per volerlo davvero (nel diritto al proprio angolo di solitudine, al proprio inferno privato). Il racconto pertanto è quello di una sospensione ed insieme di un procedere tra ricordi e inquietudini come di tormenta, scelta certo, abbracciata e accompagnata ( giacché “è la bonaccia a uccidere”) nel solo possibile, nel solo che ci è dato. Per questo parlavamo di riconoscimento in tanto dissentire unita a una dolenza di fondo rovesciata in un dire di condivisa e a tratti irrisolvibile, ironica e autoironica impotenza. Per questo, dunque, forse postmoderni come da titolo aggrovigliati a tensioni personali e storiche che consentono solo ritagli, solo impressioni nella visione di interni e di figure che restano come per sogno come per memoria calde e certe e spazialità di continui affetti e appetiti nuovi (tra inviti per chat e l’esser il numero preferito di un cellulare) per poter capire quanto si è vivi e quanto si è morti in un tempo che ha il suo corso lungo superandoci sempre. La carnalità è allora a spingere dai versi, “in una notte di perpetua esistenza”, nell’inseguimento dello stesso mai raggiunto amore, nel nitore di videociviltà la ricerca di un porto d’approdo, di un punto di tenebra (“sia pure un buco di spaziale nero/sia pure una rorida fica”) dai ritorni di ghiaccio, dalle ferite del sonno. Perché, infatti, come in “Ecce homo”, testo tra i più riusciti e di impronta molto sabiana, nel rispecchiarsi nel dolore del suo uccellino per la morte della compagna il rigurgito, o il suo rischio, è quello di un risveglio senza nemmeno la malinconia del ricordo, persi “in un amareggiare ordinato di/ inutili/ abitudini:/più vuote”. La scrittura così non può che essere lapidaria: “Poesie, e poi più:/monologhi di morti”, prosa frammentata nell’affermazione di un senso non trovato seppure, in realtà, sovente offerto nel dettato in aperture liriche di riuscitissima, rivelatoria intensità (vedi l’ungarettiana “Lindoro”, o “L’argine” in cui allo straripare del fiume solo a sorridere nell’emergenza resta il neonato nel sogno de “l’acqua in cui ha nuotato/ la stessa acqua”). In conclusione allora forse questo il lascito, antico, più forte che permane, di là dai tempi, da ogni tempo e dunque anche di questo a saperlo vegliare; quello di un cuore viandante che sempre “dev’essere un miglio/avanti “ (la testa sapendo di tutto la scadenza) nello sguardo notturno di “un girasole” che seppure scettico, perplesso, tra l’oblio della mente e il Nulla, sa e continua a fingersi in poesia.
Id: 1289 Data: 12/02/2021 12:00:00
*
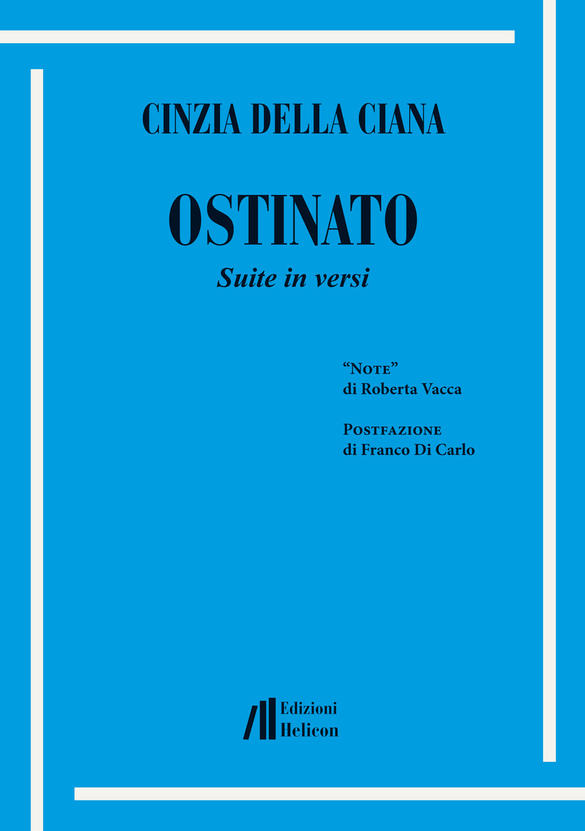 Cinzia Della Piana - Poesia - Edizioni Helicon
Cinzia Della Piana - Poesia - Edizioni Helicon
Ostinato
Un ostinato restare, avanzare, irretire e irretirsi nella capacità sinestetica di una parola aperta, felice, libera ma anche raggrumata ai colpi di un ritornare, di un sentire provato, a tratti vinto procedere dalle maglie di una realtà ora ostile ora seducente, ora lontana dalle sofferte, dolorose, urgenti richieste umane. Tutto questo ma non solo si leva nel canto di Cinzia Della Ciana, avvocato aretino, autrice alla sua terza prova poetica. Nell’algida geometria delle dinamiche, delle dissimulazioni, di un dire e un vivere stretto tra i denti, il canto allora, aperta la gola, ha il senso di mantenere aperta la vita, di rimandarla, di tenderla là dove nella storia, nel suo passare inciso che gli viene nel dialogo, umano, umanissimo tra costruzione e natura ha la sua eterna e rimessa possibilità, la sua risonanza della carne, dello spirito certo nel girotondo di un passo cui la parola come detto volentieri, ma soprattutto necessariamente si accompagna. Ed è così tutta una discesa tra limbi dell’animo e sue risalite, affondi nel mare dei nostri quotidiani e metafisici esercizi e di mari reali, di monti nella risonanza inquieta di memorie e ritorni strappati al loro rivelato esporsi a dire anche dai luoghi di un’Italia carezzata e bramata nell’archeologia di un popolo più che santo o navigatore vivo, meravigliosamente e drammaticamente vivo nell’espressione artistica, politica, sociale del proprio tormento. Il golfo ligure, la costa campana, Roma e il centro Italia nella malinconia dei suoi laghi ma pure ritratti di uomini e donne colti nella spigolosità del loro perenne movimento, di una storia lavata col sangue (“sindone/impelagata di morti”) cui fa sempre, ancora, da contrappunto nella passione il casto ma combattuto fiorire di una natura cui poter apprendere e guardare nel ritorno di un metro sorgivo perché melodia, ecco nella spinta di una passione tutta di donna, tutta carnalmente femminea, la direzione di una scrittura che non rinuncia nutrendosene delle sue più intense e pressanti consonanze. Che trovano luogo allora in un racconto che ha la veste innamorata della suite, della “composizione strumentale in più tempi, ciascuno dei quali costituito da un tipo di danza ora vivace ora allegra, ora solenne in una alternanza ritmica di particolare spigliatezza”, riportando da dizionario la definizione perché nel rischio della banalità e della caduta come spesso avviene la Della Ciana riesce piuttosto felicemente nella coinvolgente, ora ebbra e dolente ora sospesa ora penetrante provocatorietà del verso, di una struttura polimetrica, sovente breve, ricchissima di attorcigliamenti, risonanze interne e neologismi, di carezza liricità nella capacità della parola di sentire e spezzettare in piccole consonanti di riverbero e di suono l’immagine nella visione riuscita- e unita- dei sensi. Nominiamoli allora almeno alcuno di questi tempi, consigliandone caldamente la lettura: andante, adagio, allegretto, moderato, lento, eroico, fugato, marcia, narrante, mesto, fiorente, sospirato, barbaro, pastorale, grave, scherzo. Sono solo alcuni certo tra tanti ma potrebbero essere infiniti come infinite le accezioni del temperamento e dell’animo umano, la musica (cui dedica tra le altre quasi una intera sezione) dunque a dirigere una riflessione ma soprattutto uno scrutare, un tendere ostinatamente acceso appunto, ostinatamente in gioco e al sovvertimento- di sé principalmente- nella verità di uomini e donne o di un Dio che ci attende. Di donne ancora, soprattutto, nel paradigma del collante di figure che soprattutto nella parte finale trovano racconto. Santità non di immaginetta evidentemente ma di torsione, come la Cecilia della Basilica romana o della Maria del Della Robbia giovane ancella ancora ignara del peso che le cadrà addosso, pronte sempre al brulicare del seme perché libere nella eternità della scelta e non vinte, da una menzogna- tutta maschile evidentemente- di una mano chiusa che offende e colpisce in un modo o nell’altro in quel luogo e destino di “riservato piacere/ terra dovuta” (si veda il riuscitissimo testo dedicato a “La muta” presso il Palazzo Ducale di Urbino in cui la donna ritratta urla in chi la guarda il suo disconoscimento per ciò che di lei è stato dipinto: non moglie, non figlia ma “sdegnosamente la bella ribelle” a cui dalla Corte fu data prigione “da un qualsiasi Raffaello”). Andando a concludere, abbiamo qui riportato solo una più che parziale lettura di un dettato ricchissimo, fermo, lasciando ai lettori nel gusto l’accesa densità dei suoi simbolismi, dell’altrove in noi nelle sue risonanze giacché come è ben scritto non c’è niente “di laico/ in questo limitato spazio”.
Id: 1285 Data: 05/02/2021 12:00:00
*
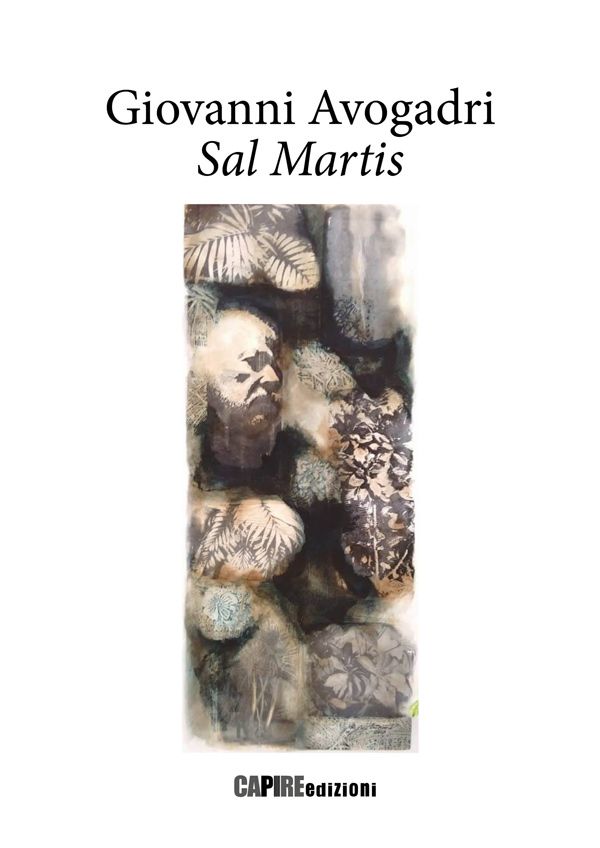 Giovanni Avogadri - Poesia - Capire Edizioni
Giovanni Avogadri - Poesia - Capire Edizioni
Sal Martis
Un versificare nel segno della luce, della gioiosa partecipazione a un viaggio di ritorno all’origine nella forma di un futuro che non è altro che “una provenienza dimenticata” e che nella navicella di una stirpe eternamente risonante delle figure e dei miti che l’hanno informata e incarnata non tenta scioglimenti ma i vibranti abbandoni di uomini e donne, di generazioni nel legame fiducioso del proprio esserci perché naturalmente interroganti, perché naturalmente rivestenti, quest’ultimo lavoro dell’insegnante livornese Giovanni Avogadri. Una parola allora, così semplicemente accompagnata, così con determinazione liberata nella maturità di una persistente e rinascente infanzia dell’uomo che sa delle ombre sì il risvolto di una Gorgone che mantiene fisso il suo sguardo ma anche nel viluppo della coscienza la melodia di un canto che sa ritornare come da un sogno dimenticato appunto a dire lo stampo e la visione di un altrove dove più alte “rinascono Parole che dicono nomi” che sanno “L’Amore,/ il Silenzio, l’Ascolto”, i segni e semi in ogni volto allora di un Tu sorgivo. E allora di questo Amore è la narrata quotidianità di un qualcosa di ineluttabile e di imminente di cui Avogadri avverte tutta la “necessità etica” che va a sciogliersi nella fantasia di vita- perché questo nell’espressione è del nucleo la creaturale espansione - di padri e madri, di ragazzini, di fratelli colti negli intrecci e negli accostamenti di una sacramentale e rimettente, reciproca incarnazione. La voce così è quella dei corpi dapprima, dei gesti cui nel mistero di un mondo che annunciandosi in frammenti, di qui lo vanno a compiere nell’ancestralità tra l’altro di immagini da Avogadri investigate come dicevamo nella logica del sogno o nel dialogo col sogno nella risonanza di quel solo e unico corpo di cui, come sa bene, ognuno è membra. La metafora stessa del viaggio che continuamente ritorna anche nelle sue più che concrete spazialità di strade e autostrade a questo apre, ci apre (la pianura “un tappeto smosso dal sole”) nella direzione di un rinascere in cui non c’è misura, perché infinita e senza morte se camminando nel deserto Qualcun’altro ci ha preceduto “dove già l’avevamo incontrato”. La vita è ricordo di questo, sempre, comunque il sogno di un altro e di altri nella dimensione onirica di un divino e di un umano che Avogadri sa ascoltare ed accogliere anche nel tentativo di investigazione ed elaborazione poetica di una serie di propri sogni in quel luogo centrale del testo che è la sezione non a caso dal titolo “Approdi” (lavoro che ha preso forma tra i materiali di preparazione con amici di un progetto su Michelangelo nel legame di integrazione di danza, movimento e parola). Approdo certo ma anche chiave di un interrogato disporsi, e attraversamento nel segno di un tempo il cui ponte “non interrompe ma asseconda la corrente del fiume”. La rivelazione è sempre all’insegna di “una mensa illuminata”, di un “evangelo laico” ancora nel sogno a partire dal corpo, in quella sostanza fisica che consente di entrare nel mare “al centro di una infinita navigazione” che muove vivendoci “da fuori da dentro/come un infinito risvegliarsi”. Qui nel cammino, nella bella immagine di “spiaggia e carovana/incontro nell’alba”, è però nell’incontro della “eterna dualità “dell’uomo e della donna, nella nudità di immersione “nella sorgente fisica della vita” l’icona di un indirizzo che propria della nostra condizione, sempre relativa e non-tutelata trova unificazione (“il battesimo dei nostri frammenti”, certo, nel caro riferimento a Luzi) nella visione dei mondi. Ed infatti quella di Avogadri, come da una corsia d’emergenza resta una poesia di nozze umane, entro “forme primordiali/ pietrificate/ che attendono- ancora necessariamente e costantemente aggiungiamo noi- una seconda creazione”, e che la parola va a celebrare nella sensualità di riferimenti che se nella donna hanno veicolo e movimento, pure trova costellazione e geometria visibile nell’astro risonante e divertito della figlia. È in questa intensità lirica allora di elementi colti nel loro naturale dispiegarsi, richiamarsi, giocarsi la forza di un dettato fedele alla capacità umana di ripensarsi e di rifondarsi dall’interno dei propri partecipati richiami, delle proprie partecipate istanze verso l’aperto splendore di una Promessa che nell’accensione ci nutre. Un grazie dunque ad Avogadri con l’invito a immergersi nella lettura in tanta aerea, concreta spazialità di trasformazione là “dove le radici/più forti si stringono alla terra”.
Id: 1281 Data: 15/01/2021 12:00:00
*
 Mattia Tarantino - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Mattia Tarantino - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Fiori estinti
Debbo dire che è sempre molto bello, e confortante, imbattersi nella poesia di un giovane capace, ricco di talento e senza infingimenti nella autenticità e nella forza della sua scrittura come nel caso di Mattia Tarantino. Non temiamo l’uso di tanti aggettivi perché densissimo di riferimenti e di istanze tra ribellioni e cancellazioni, tra provocazioni di sacralità e canzonatura della stessa sacralità l’humus da cui Mattia, quest’abile e a suo modo dolcissimo napoletano, si dibatte e tenta uno squarcio, un urlo a rompere un cielo troppo lontano e vasto perché qui possa rispondere. Va sottolineato subito, sia chiaro che tanto ardore non è la sola espressione di un assoluto giovanile nella radicalità di uno spirito che non ha rispondenza perché significherebbe limitarne la forza e la domanda. Tarantino infatti è già per buona parte autore concretamente maturo, pienamente conscio delle armi a sua disposizione, del suo versificare colto e riflessivo, dotato di una parola ora ben guidata nella traduzione delle sue ferite ora sapientemente espansa, libera nel dosaggio delle sue crepe e delle sue irrisioni. Figlio di un verbo che ama e tenta rifondarsi sulle macerie di una civiltà poggiata sul divoramento dell’individuo a cui prova il ricordo nell’origine e nel nome, il comune slancio da una terra che non cessa di attenderci (pensiamo a Rimbaud, certo, all’amato Dylan Thomas), questa poesia sa liberarsene, sa superarsi fino a non chiedere nuova terra o recisione di veli ma il dissolvimento stesso di un sé recluso perché vinto nell’inganno di un cielo le cui acque sono acque di imposizione e di dominio, irrisolvibili per una genesi la cui luce è squarcio di angeli ancora in lotta, nell’impostura di un richiamo che comunque nei suoi più disparati richiami non offre ma recide il respiro. Per questo è straziante e tenerissimo insieme nella lettura il sanguinamento e l’intreccio di stanze, profezie, boschi a risalire dalla carne di un sud antichissimo le cui nenie sono nenie di madre, di ninna nanne forse eccessive e disturbanti nella narrazione di un rigurgito, di un latte che si è fatto amaro, voce discosta di una umanità tradita da padri, terreni e celesti, impassibili e assenti. Bisogna esser grati ad autori come Tarantino perché nella sua disputa divina, tra compressioni di stelle che fraintendono il sogno, nell’intreccio di falli e di croci che ci e si ustionano al senso viene a ricordarci come da una memoria rimossa il primo sguardo, nello strappo l’esposizione della carne nella sua violazione, l’identità allora del bambino e dell’uomo divelto che all’uomo e al bambino chiede non assoluzione, perché non c’è colpa, ma affermazione, presa in carica del mondo, della parola allora, anche, nella sua capacità di rifondazione e nominazione. Poeta vero allora Mattia in un’epoca in questo di guide ed uomini dimentichi ed antico nel suo indovinare la morte, per remissione e per delega, per incapacità di chiedere e di chiedersi, soprattutto, nel senso di sé, di sapersi nell’unicità di un discrimine tra scivolare e prendersi cui nel veicolo di richiami e riferimenti classici, biblici, autoriali non teme fratture accettando unicamente di cadute ed allacci, di funi e preghiere le proprie dolorose ma- appunto perché proprie- meravigliose escatologie di fanciullo cui tra vesti insanguinate e cieli non più deturpabili dall’ombra di nessun Dio pare a tratti sentire un eco, ribaldo e intensissimo del pellegrino Campana. Anche se, è bene dirlo, nella distanza di oltre cento testi, forse il rischio in tanta rincorsa, di temi e rimandi nel groviglio continuo di simboli entro una rivolta infinita è quello dello smarrimento del lettore- oltre che di se stesso- in un coinvolgimento alla lunga che perde concretezza a dirlo, e a dirci nella ordinarietà e nella quotidianità della vita, là dove la vita nei suoi pericolosi ritagli ci tenta e può vincerci. Eppure ci direbbe forse, nella lama cui lui stesso sa ferirsi, l’ordinarietà e la quotidianità sono una scelta la cui qualità, la cui libertà è nella capacità personale di sapersi e potersi possedere, rimettere in gioco oltre il proprio (e non altrui) recinto. In conclusione autore vivissimo Mattia Tarantino negli strattonamenti delle sue dispute a cui, aspettandolo a nuove verifiche, auguriamo ogni bene alla sua trama di luce (“la parola/che ci salvi dall’inverno e faccia casa”).
Id: 1263 Data: 11/12/2020 12:00:00
*
 Domenico Cipriano - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Domenico Cipriano - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
La grazia dei frammenti
Personalmente è sempre un piacere poter parlare della poesia di Domenico Cipriano e della sua figura, sempre così ricca di grazia, attenzione e ascolto nei confronti del mondo. Carattere di uomo prima ancora che di autore che poi con determinazione e cura profonda ritroviamo compiutamente intatta nei suoi versi. Un’anima armonicamente musicale nello specchio a risalire anche dall’altro versante della sua espressione artistica, quello della musica appunto guidando nell’incontro con la poesia la formazione “e.Versi jazz-poetry”. Cinquantenne irpino con alle spalle oltre diverse pubblicazioni anche riconoscimenti importanti (come il “Lerici-Pea” per l’inedito nel 1999 o il “Camaiore” opera prima), si impone come una delle personalità, degli intellettuali più penetranti di quel meridione d’Italia sempre così attento nelle sue rivendicazioni e nelle sue interrogazioni a ricordare di uomini e territori le antiche istanze e le nuove urgenze, le passioni e i deragliamenti. In quest’ultimo volume, che raccoglie una sorte d’antologia della sua poesia è possibile allora fare i conti con un percorso in cui nella trasfigurazione accesa di uomini e mondi, la terra più concretamente si dilata e si avverte in un respiro in cui nulla si cancella ma tutto ritorna più alto, e aderentemente attivo nella rispondenza delle sue proposizioni e delle sue memorie. Più alto perché desideri e volti, incontri e passaggi vanno a levarsi in quella rete di circolarità che dice della carne l’ingiunzione, lo sforzo allora in quello spazio mai separato del paesaggio che fa di quelle montagne, da quegli affacci luogo e ritratto- autoritratto diremmo- di un reciproca corrispondenza, di un cercato e partecipato compendio. Di qui allora nasce e si sviluppa il canto nella consapevolezza di una narrazione in cui tutto ha presa nella resa di un continuo specchiarsi, di un amalgamarsi di riflessioni, forme, note di una innamorata e per certi versi contrastata incarnazione. La storia allora è quella- anche- di uno spazio segnato da obbligati abbandoni, di emigrazione soprattutto e di lontananze sapientemente riportate nella dilatata tensione non solo di chi forzatamente è dovuto partire ma soprattutto di chi dolentemente si è trovato a restare nella mutilazione delle spaccature. Eppure, ed è questo che ci rende particolarmente cara questa poesia, il tono mai severo mai eccessivamente grave è quello di una gioiosa partecipazione, di un incantato richiamo. Ancestrale e insieme eticamente e civilmente presente tra le maglie di una contemporaneità provata, la forza è nel dialogo tra le zolle di una reimpastata e non più remota fioritura di materne e paterne pronunce, di materni e paterni motivi e una modernità non dimentica nella complessità delle sue ascendenti strutture. Esemplare e classica insieme dunque la scrittura di Cipriano, forma di un versificare acceso a fronte delle cancellazioni e delle negazioni di un’epoca che non chiede, che non domanda, ha nella continuità della vita il suo più semplice e penetrante richiamo, in una cura, in una custodia mai lasciata sola perché non scontata. Così se nel libro d’esordio “Il continente perso” (Fermenti, 2000) il ritorno è quello di un territorio nella lunghezza dei suoi lunghi inverni in cui la natura cerca di ricomporre le sue desolazioni (come nella bellissima immagine dopo la neve della “piazza spopolata” in cui è possibile veder “rivivere morti/richiamati dal mitigante/suono dei passeri rinati”) - gli abitanti come sospesi in una esistenza “senza sogni, né speranza di cambiare”- nel successivo “Novembre” ( Transeuropa, 2010) l’attenzione a ciò che di illeso rischia di esser sottoposto alla maceria e all’incuria si fa doloroso recupero e memoria dell’evento cardine del terremoto tragico di parte della Campania e soprattutto della sua Irpinia del 1980. Nel resoconto lirico dell’opera (scritta esattamente a trent’anni di distanza) Cipriano ci offre nella testimonianza forte e concreta del sé bambino (all’epoca appena decenne) la cronaca oltre che di una tragedia che ebbe a colpire e mobilitare un intero paese (con la nascita stessa della protezione civile) quella di una incuria appunto e poca salvaguardia del territorio che poi a più riprese, dall’Abruzzo ed anche dopo la pubblicazione dello stesso libro avrebbe colpito ancora e altrove nei sisma seguenti (in ultimo l’Abruzzo, Amatrice). Come ebbi modo di scrivere all’uscita del libro in questo testo “ la sua voce di uomo, prima che di poeta, di bambino ha raccolto per quanto possibile la polvere, l’ha divisa da quanto rimane di vivo e di profondo nella radice che non si è spezzata provando a liberare finalmente quel respiro allora tanto desiderato (e che possiamo ritrovare nella stessa architettura del poemetto come a sigillo, nel sangue, di una comunità tragicamente ferita)”. Così nell’ascolto derivante dall’osservazione muta del poeta e del bambino insieme Cipriano ha saputo qui illuminare e dar nuova voce ai racconti a risalire dalle rovine delle case e delle anime sottolineandone dalle ferite le ragioni in una impronta etica e di scrittura che ha germe scoperto nel verso rivelatorio della sua metabolizzata strutturazione “.. e io ero la coperta di lana, i racconti cambiati e ripetuti..”. Il tutto ancora nel riconteggio degli uomini e delle cose, degli elementi di una terra cancellata a dire nella determinazione civile, ma anche nella dolcezza (“..il silenzio del palmo copre gli occhi ai morti”), la consapevolezza di una storia che va comunque affrontata(“..il confine è già segnato/ e nulla ti porta indietro”, “Questa sera ceniamo con la morte..) e perseguita a partire dal suo racconto. Soprattutto allora nella convinzione di una interrogazione, a cui ci richiama- e che ha nella forza civile del prologo il suo orizzonte- che rifugge dalla ineluttabilità degli eventi. Orizzonte e presenza che è poi al centro dei lavori successivi nel richiamo alla cerchia familiare degli affetti, delle nascite (la cara figlia Sofia), dei legami cari cui rinsaldare la terra e rinsaldarsi alla terra. Così ne “Il centro del mondo” (Transeuropa, 2014) in cui nella risonanza sovente anche metafisica (vedi tra le altre l’omonima sezione, “Irpinia metafisica”) tra luoghi e anime, tra presenze di una natura agli occhi luminosa nel ricordarci di esser sempre nuovo mondo e nuova esistenza nella rinominazione stessa della parola e pareti di intimità non più raggrumata nel sogno ma nel ritaglio di un confine non più cosi netto nelle sue divisioni, l’autore di Guardia dei Lombardi con serena determinazione sa rafforzare del presente l’edificio, il senso stesso d’esser comunità lasciando in piedi le fondamenta, rinnovandone i mattoni nella trasformazione dei passi in altri luoghi (di riflessione, di indagine, di intelligenza e d’amore anche) al mutare dei contorni. Così nella più che simbolica “La nostra casa sta cambiando” o in “Origine” (“L’arcolaio”, 2017) l’ultimo libro in cui la domanda dell’uomo a risalire dalla memoria del cosmo di cui è grazia e frammento investe la capacità stessa di sapersi tramandare in un “legame duraturo” nella tenerezza allora a cercare di compensare almeno se non di comprendere “l’angoscia/la distanza sconfinata delle stelle”. Un percorso in conclusione che più che vivamente consigliamo e che andiamo a ringraziare augurando il bene e la fortuna critica che merita.
Id: 1261 Data: 20/11/2020 12:00:00
*
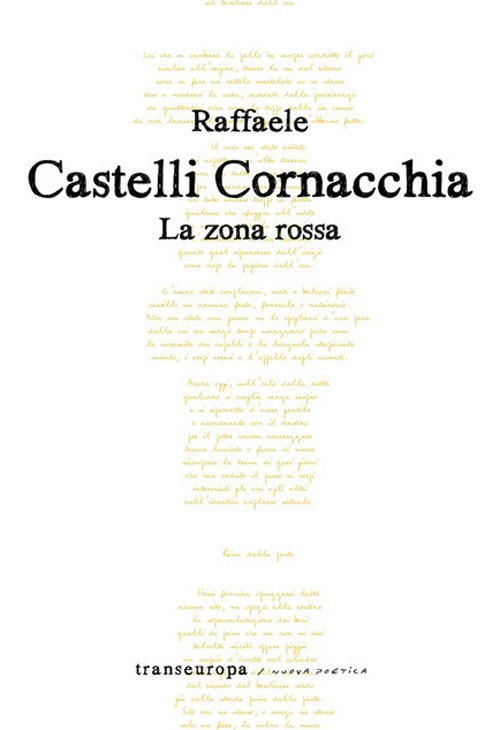 Raffaele Castelli Cornacchia - Poesia - Transeuropa Edizioni
Raffaele Castelli Cornacchia - Poesia - Transeuropa Edizioni
La zona rossa
Abbiamo già avuto modo di parlare della poesia di Raffaele Castelli Cornacchia, insegnante della provincia di Mantova (ma bresciano d'adozione), autore oltre che di poesia anche di libri per bambini e di monologhi per il teatro. Lo facemmo qualche anno fa (nel 2016) a proposito di Alfabeto della crisi nel quale si levava un atto di accusa assai potente, e dolente, contro un sistema economico in cui gli ultimi vanno a esser sempre più esclusi in un “tempo relegato a rango di merce”. Tanto ardore, tanta indignazione nel dire una civiltà e un senso che va allargando le maglie delle sue ferite le ritroviamo in questo ultimo Zona rossa, testo nato come suggerisce il titolo nel periodo più caldo della pandemia. Il dire però qui ha una sua partenza prettamente autobiografica, il contagio personale a cavallo del lookdown in seguito a precedenti accompagnamenti della madre in ospedale fino alla scomparsa di lei proprio a ridosso di quei giorni. Come ci avverte nella breve introduzione, la lotta col virus e le modalità d'uscita sono state accompagnate essenzialmente da una dinamica di ascolto di se stesso e del proprio corpo più che il coro di parole che sono andate a connotare quei giorni. Ed allora una dinamica di per sé già molto poetica nella radicalità del suo affondo, raccolta poi nei versi che seguono a dettare più che un diario una occasione di maggiore coscienza di sé e di un mondo nell'ipocrisia non più latente delle proprie suggestioni e dei propri divoramenti. La lotta dicevamo più che con il virus ci appare oltre che con un corpo nel riflesso dei suoi patimenti ma anche dei suoi invecchiamenti, o con un'emergenza di isolamento, soprattutto nella tensione esplosiva di una geografia di luoghi e di anime rovesciate, sommerse e poi riportate a galla come da una deriva dal fango del proprio quotidiano infettarsi da reciproche indifferenze, da reciproci egoismi. Non si fa illusioni Castelli Cornacchia, nella diversità di reazioni che sono andate a svelarci, insieme tragiche e farsesche nella figura di un sogno, o per meglio di un incubo il cui treno sempre pronto a muoversi in realtà non parte. La forza e la vitalità infatti non si improvvisano se la consapevolezza della storia, e della propria storia, e del mondo non è curata, non ha misura entro una cura, una riflessione e prossimità costante che vengono da lontano. Per questo lo sfondo appare dominato da non più oscure sagome manzoniane nella puntuale metafora del non toccarsi, “del non respirare./Non azzardarsi a sentire il dolore”. Questo eravamo e siamo, vivi e non vivi, nella equidistanza “tra Eden e Averno” entro un procedere dentro una Storia osservata nella sua memoria fatta anche, da sempre, di un rapporto con la vita e con la stessa morte nella logica del distanziamento e del potere, della disappartenenza, tra inganni ideologici o della fede con uno sguardo anche al venir meno di chi si è detto e si dice cristiano (“eppur privi di sguardo sul creato/per quel poco che basta a vedere/ciò che senza tempo è tramandare”). Questa allora è anche la “zona rossa” cui il testo fa riferimento da cui altre zone via via finiscono col vincerci e racchiuderci in contingenze sempre più senza respiro- come questa di adesso, nella nostra testa impensabile- nella palude allora di nulla di diverso dalla storia di sempre, a percorrere unicamente le strade delle recriminazioni vivendo al bordo di fasti, felici: “come dei contadini baraccati/ intorno l'anfiteatro romano/ perché questa è la nostra scienza”. Il tutto poi tra facili veloci dimenticati pentimenti e corruzioni- il tono del libro alzandosi più forte- nell'elemosinare “perle dai mendicanti di servizi/come dei raminghi senza diritti”. Metafore che ci strappano in un coinvolgimento cui non si può sfuggire come ne “Le parole appropriate” in cui il mondo e la vita sgozzata hanno il segno del maiale, della bestia (come dal sogno e dal ricordo di sé spettatore bambino) squartata, appesa crocifissa sull'aia; in cui tutte le figure richiamate vengono a chieder conto di idee e modalità di libertà e partecipazione. Così non a caso è in “26 aprile”, testo sulla Liberazione del nostro paese, il riferimento il cui corrispondere o meno alla sua espressione è nel suo post più che nell'evento stesso (la questione iniziando il giorno dopo); paradigma adesso nella ripresa della curva di una presenza e di una dinamica di comportamento cui vale e varrà il perché attivo della coscienza e della custodia reciproca, il nostro essere pienamente umani, uomini e donne di senso. Zona rossa però resta altamente consigliabile anche per uno sviscerarsi personale nel quale non è difficile confrontarsi e riconoscersi e scontrarsi anche all'interno di un periodo che ci ha divelti. Come il riconoscere, ad esempio, di aver avuto bisogno di abitudini (da lui mai amate) in una lotta per sopravvivere che richiede ordine nella consapevolezza crescente poi di dover imparare oltre che da se stessi anche dalla natura che “sbriciola selci, educa montagne”. Infatti: “il dolore del parto non addestra/pagine di libri non insegnano/non lo fanno il commiato dei vecchi/neppure il baccagliare dei pazzi/o il profetizzare dei sapienti/per non dire dei padri e le madri/gli esempi un avviso, neanche”. Bisogna farsi forti anche della rabbia. Perché nel tempo di radici da mettere “su lunghe gambe da amare” si accettano “soltanto pugni/ pugni di parole ben assestati”.
Id: 1257 Data: 30/10/2020 12:00:00
*
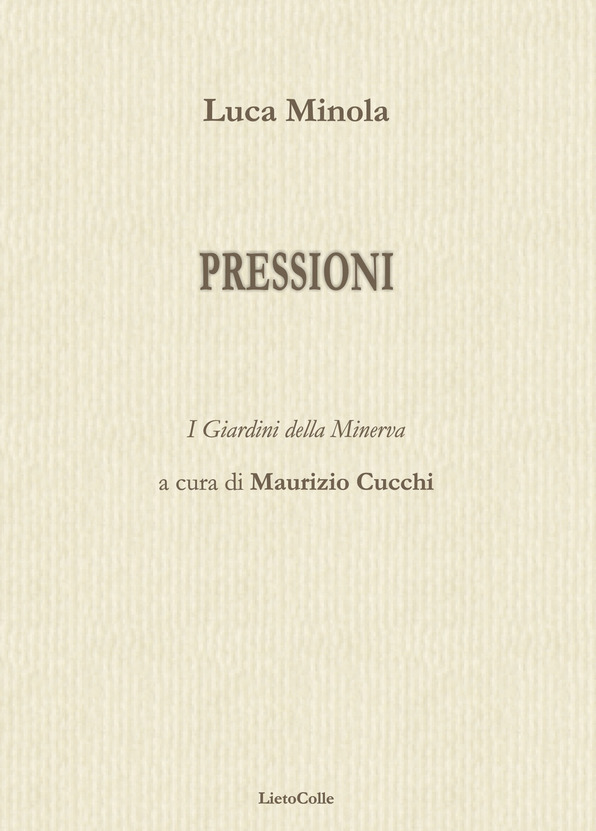 Luca Minola - Poesia - LietoColle
Luca Minola - Poesia - LietoColle
Pressioni
Interessante lavoro questo di Luca Minola, trentacinquenne autore di Bergamo all'opera di conferma dopo l'esordio del 2012 con Il sentimento dei vitelli col quale vinse l'anno seguente il premio Maconi Giovani. In un versificare esatto nella misura di una lingua ben distesa tra geometrie del pensiero e spazi di luce e di luoghi nel loro affaccio ora rivelatorio e interrogante ora sfuggente, ci offre la riflessione di un tempo nella consegna di un enigma cui l'uomo sembra poter partecipare solo nella sua disponibilità a farsi imprimere nella sua accettazione, umile e dolorosa insieme, nell'incontro e scontro con altre forme, pressioni appunto, di attese, di eventi, di parola. Di luogo- e di luoghi- soprattutto, come detto, spazio immanente dove l'uomo è annunciato ma al tempo stesso trasceso, superato tra sconcerti e limiti, tra un crepitare e un senso più alto sulla cui soglia, come ben rivelato da Maurizio Cucchi nella prefazione, questa poesia non può che fermarsi. Case, volti, strade, abiti ci appaiono allora pervasi da un modellare di luci e ombre nel cui tramite la parola si lascia guidare e accompagnare come a farsi modellare anch'essa nel restituirsi ad una modalità di prossimità che sola può dirci- e dire- tra spaccature e sconfessioni, accenni ed assensi. Così è un dire molto novecentesco questo di Minola che ben sembra aver assimilato e in modo originale la lezioni dei maestri, pensiamo a Montale evidentemente nei riferimenti presenti ma anche a Giorgio De Chirico nella restituzione di città riportate alla fonte di un orizzonte sospeso ma allo stesso tempo nuovo, libero facendosi dalle proprie ricuciture sistema e radiante di luce. Così, gli "occhi macchiati di giorni,/di precise intenzioni", nulla è separabile da noi, tutto ci appartiene e resta nella fedeltà a saper procedere anche nella nebbia dove non c'è varco se non il proprio seguire "un armonioso e strisciato buio". Se la trama è il motore il piano del reale allora si rivela nell'aerea concretezza di una tensione che chiama ad espanderci ed in cui "forse la scelta è solo conoscere e nient'altro" nel tutto che passa e che non è mai uguale, e a cui consegnarsi. La descrizione che ne deriva in un movimento che forse rappresenta la forza vera del testo, è ancora, sempre molto pittorica nell'intento di silenzi che si riaffermano nell'essenzialità del procedere (ci vengono in mente Hopper e Morandi tra gli altri) tra domesticità di radio e d'interni e reliquie notturne di strade e di palazzi che sembrano confuse nell'apparente collidere dei traguardi, spente da funzioni. Come gli uccelli che "cercano di migliorare il cielo/ sulla zona addormentata" anche noi, per quanto possibile possiamo dabbasso modellare destini e strade, restando tra zone che si dicono al di là di noi e grazie a noi. Cosi "le cicatrici dei punti" della poesia omonima sono quegli "spazi aperti nelle frasi" dove è possibile raggiungerci ed in cui l'amore non ne è che il verbale ("Sarei il sogno a te presente/l'azzurro spinto al massimo,/e saprei che l'anima è certa"). Di qui, a metà testo, in "Pressioni" la sezione che dà titolo al testo, è il corpo ad evocare nelle sue rappresentazioni impressioni e suggestioni di un inalterabile vitalità che nell'estensione della sua energia andrà poi via via, soprattutto nelle sezioni a seguire "Materia" e "Le ritmiche delle gradazioni", ad affrontare e a riportare effrazioni ed ombre di un'epoca rigidamente composta in funzioni e finzioni di negazione ed in cui se tutto sembra spingere da un sottofondo in realtà a vincere è la consapevolezza del restar fuori ("case private del loro fuoco"). Eppure proprio qui nella sapienza di chi non si scompone ma permane dove la sostanza è scossa ("Osservo: battaglie nei cieli,/misure di contatto, pressioni dell'aria"), Minola ci lascia nella determinazione delle forme con l'affermazione di quella voglia più dura che resta l'aderenza delle labbra, come nella conferma della- e nella- continuità degli elementi in un desiderio che giammai è stanco di ripetersi.
Id: 1256 Data: 09/10/2020 12:00:00
*
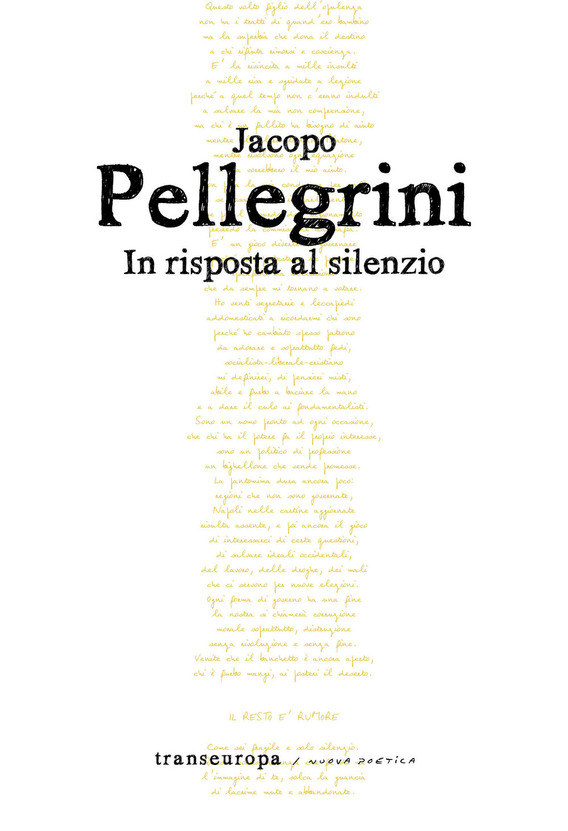 Jacopo Pellegrini - Poesia - Transeuropa Edizioni
Jacopo Pellegrini - Poesia - Transeuropa Edizioni
In risposta al silenzio
Un testo come pochi negli ultimi anni questo di Jacopo Pellegrini, quarantenne veneto alla sua seconda pubblicazione, per l'intima disposizione a quel senso dell'attesa cui si forma e si informa il bene dell'esistere inteso come partecipata domanda di mondo. Un' attesa ovviamente non ferma nella stabilità delle acquisizioni ma caparbiamente incisa nel quotidiano operare delle situazioni e degli uffici, fra uomini e donne, fra scarti e rovesci soprattutto di un'epoca spiritualmente ed economicamente nella frana di una voracità che non si tramuta in nulla se non appunto nella compravendita (così losca e fosca e tutta così normale volendola dire dalle sue parole)e non nell'ascolto di uomini e storie. Edificazione, ascolto, attesa tutte rimesse, con umiltà e ci sembra di poter dire con fervida mitezza, nello spazio del silenzio la sola dimensione riconosciuta del riconoscibile e dell'udibile necessario di un mondo, delle sue passioni, delle sue carnali istanze altrimenti misconosciute nella mortificazione dei clamori. Un' interrogazione allora che viene dal silenzio come costume, come modalità dell'agire nella presenza discreta di un esserci anche anonimo ma vivo nella grazia di una tensione che tenta e cerca prossimità proprio dove distanza. Che poi è il dire alto perché necessario di ogni sicura poesia che qui risale dalla discesa entro un dolore, il suo come di tutti, "divenuto tormento sordo" ed offerto come parola lieve a riempire d'amore e di vita. Un silenzio dicevamo nella sua accezione di specchio e per questo allora luogo non facile in una trattativa, in una lotta a spegnersi o dire il senso nel discrimine d'ogni giorno tra la libertà e l'essere davvero con se stessi e con gli altri. È così un discorso di autenticità e di onestà nella vena di una essenzialità che si dispiega principalmente nell'agire quello che via via ci interroga, e si interroga entro le tante figure colte nel proprio quid di rottura (dal sacerdote che depone la tonaca lontano dal gregge dove si è smarrito al suicida, dalla donna persa in una vuota ripetitività della carne al giovane per infermità mai in vita e vicino alla morte). Questa accesa volontà di resistere e di esserci tra esempi di cattiva politica e di una opulenza di chi " rifiuta rimorsi e coscienza" nell'indifferenza di "cellulari accesi e volti spenti" ha l'indice allora di un credere dalla radice stessa del suo imprimere, nel suo senso di avere fiducia, nella considerazione del vero. Soprattutto nella sacralità laica della voce è il tono di dilatata e garbata discrezione della scrittura, nella fisica di una parola e di una presenza che scrutando l'annuncio dalle fragilità si fa cosciente di un "senso/ del cammino insieme" che è nel "tragitto tentato/ nell'avvicinarsi,/ e non nella meta/ mancata". Ed è proprio in questo testo dedicato al padre da cui sono tratti i versi sopracitati uno dei passaggi, la "natura/ che si deve per dignità/ ammettere", in cui si rivela nella radice il dettato di Pellegrini e di cui, forse non a caso, è figura esemplare poi quella di Giuseppe, il padre putativo di Cristo cui è dedicata una intera sezione. Un ritratto quello che esce dell'uomo di Maria certo non da santino ma di un' anima nella forza di chi ha saputo ascoltarsi, e ascoltare nel silenzio, rovesciando nel perdurare del combattimento ritrosie in presenza, oscurità e dubbi in aperture di luce. Uomo paradigma allora (lui di cui non si ha nei Vangeli una pronuncia) proprio perché dal silenzio ha saputo volgere dall'altro il timore in fiducia fuoriuscendo da sé nell'orizzonte di una strada su cui anche questa poesia è volta, l'apprendere negli altri lo stesso patimento degli occhi (nella stessa intensità terrena di Giuseppe forse in cui chiunque anche se non nella carnalità del sangue ci appartiene). Nella lezione del silenzio, in questa corrispondenza di domande e risposte, l'acquisto è dunque nella spoliazione, nella perdita del nome nei nomi, nella grazia di un anonimato cui tutto risuonando si raccoglie e accoglie, e per questo libera (quanta poesia di qui viene in mente dalle pagine dei nostri più grandi autori, tra gli altri il caro Penna nella sua maestria di luoghi e figure ignote). C'è una fede in questo abbandonarsi che sentiamo prossima e che ci ricorda, e per questo ci commuove nella resa di una mente e di un'anima "presente/avendo appoggiato nel tragitto/ il peso del superfluo" e della poesia stessa là dove tutto non può riportare se non come noi dilatarsi e distendersi in quell'"ordine consegnato/ nei silenzi della quotidianità". Ed allora grazie a Pellegrini per questi versi che ci giungono in giorni difficili e per cui, anche per questo, per questa risposta dal silenzio a un silenzio evidentemente di tenebra in cui il tradimento alla vita ed il male si annida, caldeggiamo volentieri la lettura.
Id: 1225 Data: 24/04/2020 12:00:00
*
 Fernando Della Posta - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Fernando Della Posta - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Sembianze della luce
In quest'ultimo lavoro Fernando Della Posta si offre in un affondo mesto (ma alla sua radice pienamente accogliente e partecipativo) nel dolore basso e rimettente della terra. L'angolazione infatti è quella di una superficie, a dispetto almeno apparentemente del titolo, in bianco e nero, di voce e di richiesta dimessa da parte di un mondo colpito e fermo nelle sue ferite, nei suoi inascoltati domini, di uomini e donne sole nella vacazione di città e di interni demistificati e smarriti nei circuiti di un tempo la cui produzione, soprattutto, non contempla appelli nel ritorno delle sue cancellazioni. Ed allora lo spazio su cui va come in deriva il verso di Della Posta ci appare nella sostanza quello- per i più forse il solo possibile- di un sottomondo, offeso ed anche come detto a tratti battuto, ma come tale, come tutte le dimensioni che sfuggono aperto e comunque libero alla trasmissione di una umanità ancora viva perché presente nella risultanza di una compassione che cerca e muove ascolto, se non amore ("una piuma data toglie una pietra"). Qui la luce, dalle crepe di un dire fermo tra instabilità delle sottrazioni ed ospitalità dei legami, prova e sa trovare un varco, quel varco di sufficienza di vita che a più lieve esserci rammenta nella reciprocità di identità confuse (di essenzialità a dirla nelle sottolineature di Luca Benassi e Giulio Greco in accompagnatura al testo). Un'essenzialità dalle cui premesse e promesse ritrovare accordo e comprensione dalle fondamenta, dal basso da un edificio, il nostro, che forse sta per sgretolarsi. Così è ben calzante il cadenzare nella sembianza questo esercizio del riaffiorare tra sterilità della perdita e incarnata evocazione, l'uomo nella sacralità e nella dignità di un riconoscimento non solo spirituale e morale ma anche politico. Questa la veste che dal buio tenta il suo tenero e rabbioso scardinamento tra densità di figure senza gloria ("morfemi senza suono") e piccoli e grandi monarca a mutare in topi la morfologia degli esseri e su cui come in Fortini non può che cadere lo strale:"Dite a quelli/ che cavalcano sicuri in superficie/che sotto di loro/ c'è sempre stato/ tutto un mondo sommerso/e che soprattutto il tempo/ sostituisce fatti a testimoni oculari.//Odiarvi odiarvi/quando a pancia piena/ scartate come fosse superflua/ogni visione ulteriore" ("Dite a quelli"). Ed allora il richiamo è a quello scarto in più rappresentato dagli outsiders, da quegli ultimi in noi, di chi stando in basso "grida più forte" deviando dalle strade battute con inerte tranquillità dagli altri ma- restando con gli altri- imparando a proposito di topi dal loro osservarli nel labirinto ("progresso è sfatare il bosco malevolo/ampliare lo spazio su cui sentirsi protetti"). Quel che fa caro il testo è a proposito di questo il tono con cui Della Posta accompagna la scrittura, impotente, dolente, a tratti desolato pur nella stizza del dettato; eppure a ragione avvolto nel carico, nella mortificazione quasi del non poter dire, del non poter altrimenti pronunciare, nella costanza però sempre del bruco a tentar di estrarre vita- e gruppo- nella luce. L'isolamento sociale, la pompa nei cui fortilizi ci si nasconde ("l'ognun per sé e Dio per tutti") non cancella infatti la morte e questi giorni di covid stanno qui a ricordarcelo come allora la letteratura, e la poesia (a proposito di outsiders) restano per raccontare (certo non nella bontà) che "tutti siamo ospiti a questo mondo/ e tutti l'un l'altro ci abitiamo" ogni gesto avendo un effetto che si propaga nel mondo ("Effetto farfalla"). "Emanciparsi dalle ancore/che nei tratti tempestosi/abbiamo gettato per metterci al riparo": da qui giocoforza è necessario ripartire sembra dirci in chiusura Fernando nella condivisione di un timore a cui non si è sottratto. Motivo altro dunque per dirgli grazie.
Id: 1224 Data: 22/05/2020 12:00:00
*
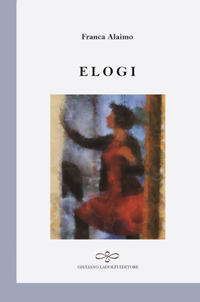 Franca Alaimo - Poesia - Giuliano Ladolfi
Franca Alaimo - Poesia - Giuliano Ladolfi
Elogi
Esemplare oltre che di una poetica, di un costume dell'abitare che investe il senso stesso della reciproca appartenenza, familiare, umana, in questi giorni così duramente messa alla prova e chiamata radicalmente a ripensarsi, questa sorta di lunario, di calendario dell'anima e dei giorni che la cara Alaimo ci consegna in un quaderno di testi che racchiude una produzione di circa vent'anni. Curioso a nostro dire, dopo una ripetuta lettura, come in realtà sia la prima parte soprattutto a farsi centro e cuore del libro, la restante pur dolorosa, viscerale, incalzante a dettare la biografia di una vita segnata da ripetuti abbandoni e mancanze e assenze essenzialmente esplicativa, propedeutica a ritroso di tanto interrogante e rimettente canto di vita nel mondo, del mondo nell'elogio della gratuità della terra- e della nostra presenza in essa- che viene solo da una progressiva spoliazione di se stessi. Il percorso però proviene dal buio, da una lotta non ad armi pari con un'anima in cerca di consegna ed un immanente tragico per l'uomo transitare nel tempo di cui è preda nella sua "brutale inumazione", ogni cosa ma soprattutto l' uomo un' isola priva di approdi "dissolta la rete dei simboli". Così gradualmente avviene il passaggio da questa non ricomponibile ferita, che non può ricomporci ma che è possibile solo cantare ad un affondo, ad una partecipazione in quella lirica degli elementi finalmente piena perché deprivata dello sguardo, soprattutto nella notte dove "solo la luna/che fiorisce e sfiorisce nel cielo/raccoglie insieme/il tempo dell'infanzia e della morte" tra lo spazio immenso della volta e una terra sostenuta da "piccolissime cose da nulla" ("i fili dell'erba, le ali degli uccelli,/le nuvole e le mani dei bambini") . La dimensione è quella della "leggerissima felicità del niente" cui Franca tesse l'elogio, non a caso il primo all'interno delle quattro sezioni del libro (gli altri sono incentrati sul tutto, sul tempo, sull'amore) di cui l'uomo però non può che scontarne il processo, l'aspirazione in un'atmosfera che ha un che di trakliano in un sole che muore facendosi "lampada luttuosa degli Inferi" e sciami di stelle "lucenti come umide agnelline" (come sacrificate o come imploranti a compararsi alle immagini dei nostri sogni). Eppure è proprio in questo odore di rose che non si vedono, in questo improvviso apparire e scomparire di abitare di angeli (dove forse "è morto/per sempre il peccato") l'affermazione nella remissione di una natura già redenta, e che sembra attenderci in quell'affido del respiro che trova in "quei piccoli passeri affamati" che "scrivono la lingua crocifissa del nulla" una delle sue più alte immagini. Poesia di rilkiana ascendenza più che orfica a suggerire comunque dell'uomo il suo altrimenti sostare sulla soglia dove nell'annullamento di cielo e terra"tutto quel che avviene poco dopo era./Tutto quel che avvenne dopo un poco è" in un canto a cui nulla manca perché non c'è caduta e dove, per noi, solo senso è vivere nella propria figura "di vento e canna", sola sponda il dubitare e oscillare essendo "vento per il respiro della canna/canna per il soffio del vento". Approdo umile e dolcissimo di una scrittura che sapendo "il dolore della conoscenza" nella docilità dell'animale e del bambino dagli animali e dai bambini procede essenzialmente nella semenza di una vita felice perché semplicemente viva, nella bellezza di un mondo negli occhi degli altri, che esplode e va a moltiplicarsi "come a primavera i fiori/ubbidendo alla vocazione/di ogni cosa nel farsi perfettamente" e dove è straordinario anche il dolore e lo svanire, la morte stessa un tramite per liberare dal bozzolo l'anima farfalla. È un discorso d'amore allora quello a cui l'Alaimo richiama, in una moltiplicazione che viene dal dimenticarsi entro una offerta di qualcosa che sempre dalla natura accoglie e ritorna e proprio da bambina, già da bambina misteriosamente compreso e accolto entro una storia come accennato difficile, non comune, l'amore stesso figlio di una coniugazione mutila, a tratti entro una negazione penitente, densa di oscurità e colpa. La vicenda autobiografica prende allora campo (come già nello splendido "Sempre di te amorosa" a cui volentieri rimandiamo) in cui dall'interno di un parlare ancora acceso scorre la visione di una ragazzina, di una giovane, di un' adulta poi ora recisa ora accudita, ora desiderata ora tradita eppure mai vinta e impressa nell'accensione di uno sguardo che fu di angelo sempre cadendo "nell'ombra delle crepe,/nel fondo dell'Amore". Angelo abbiamo detto, sì, una figura che spesso ricorre e riportata esattamente nella densità del suo significante provenendo dal sogno, al centro di un pulsare che ha alla fine ancora e sempre l'ardore di una sensualità che è il sì della terra nella comunione delle forme nell'appello che risale come da un cielo rovesciato, e nella figura allora come d'usignolo ("La promessa") al flauto dolce della gola perché "il linguaggio delle piante,/degli angeli e degli animali è quello dell'Uno". Quell'Uno che l'ha accudita prima e salvata poi nella forma delle rivelazioni che sa offrirci, "di sangue, di carne, di ossa", a dire appunto "che più della morte/può il canto". Ed è questo appunto il senso di questi elogi nel tempo di una povertà riportata al dono di una creaturalità salvifica, nella precarietà sapendo che non solo "è sempre giusto vivere" ma più dolce esserci là dove nell'amore qualcosa di aperto ogni giorno attende. Parlare di Franca Alaimo così, in conclusione, è come rammentarci. E questo nel solipsismo di un'epoca che teme l'ascolto si può davvero dire di pochissimi.
Id: 1220 Data: 10/04/2020 12:00:00
*
 M. de Freitas - F. Gullotta - Poesia - Edb Edizioni
M. de Freitas - F. Gullotta - Poesia - Edb Edizioni
Manuel de Freitas - Federica Gullotta
È una bella operazione questa della Edb Edizioni che nella collana “Poesia di ricerca” presenta e fa incontrare autori diversi ma in qualche modo uniti da un riferimento di interrogazioni che qui in questo smilzo ma densissimo libricino ha nella presa di distanza da un’epoca che sembra procedere per cancellazioni il suo intreccio doloroso e sapiente. I nomi infatti appartengono a generazioni diverse, a lingue e paesi diversi. De Freitas, portoghese, è del 1972, la faentina Gullotta del 1991. Stesso l’affondo della parola, qui accompagnato da alcune opere inedite di Davide Mansueto Raggio (l’artista rappresentante dell’Outsider Art scomparso nel 2002) e dalle appassionate traduzioni per quanto riguarda de Freitas di Roberto Maggiani. La poesia di de Freitas, tagliente, rivelatoria, oscura nel suo sguardo ferito e di rimostranza sul mondo, va a dilatarsi tra le pieghe di spazi cui la parola può solo gli accaniti e desolati rimontaggi di una realtà illusoria a dire la mortalità di una condizione sempre più fagocitata dalle cancellazioni della sua economia. Così questo sguardo continuo sulla morte e sulla doppiezza evanescente della figura umana, tra presenza e ombra, tra desolazione e annichilimenti da accensione, ci restituiscono un autore nella piena di un’avanguardia soprattutto pienamente e nobilmente lusitana per il tono ora romanticamente disperso ora consapevolmente al termine ma sempre fermo nella disputa delle sue coscienze. La poesia, nel suo viaggio nel moderno non può nulla, come il moderno può condurre a una fine prematura- almeno del pensiero- così il dire poetico nel raffreddamento delle sue metafore può solo accompagnare questa infinita rinascita di continue morti, nell’epitaffio di una conoscenza vicina però- almeno!- a chi non ha contorni di bellezza (“servire da rosa triste a coloro/ che cantano affatto, per delicatezza”). Così in questo abile rimando di una realtà nel tono medio e asettico del suo progressivo e inarrestabile- e ormai familiare- sfacelo (in cui il mondo stesso accade nonostante il dolore- ed in cui la cosa strana è sopravvivere a tanto) il dialogo coi morti su cui la riflessione va a insistere ha il sapore di un’acre rivelazione intorno a noi stessi, ad una presenza, la nostra, per gli altri per certi versi infernale e che nulla- e nessuno- nonostante le illusioni, può salvare. Resta l’incisione, la cruna di una stizza meravigliosamente e inutilmente umana che de Freitas (a cui non saremo mai grati abbastanza per aver unito in un sol verso Smiths e Joy Division) sa restituire nella sanguigna intelligenza di “uno stile espresso nella poderosa dinamica delle sue strofe larghe e cadenzate e in una eleganza del dettato estenuante”, come ha ben rivelato Di Spigno nella introduzione. La poesia della Gullotta, a sua volta, muove anch’essa dal registro di una realtà asfittica cui sa rispondere però con le aperture e chiusure di un’età- e di una ragione- ancora libera di pensarsi e di negarsi all’interno della violenza di un mondo predeterminato e privo di logica. Eppure- ed è qui la splendido arrotolamento di una poesia già terribilmente matura- è nella coscienza del non potersi muovere il bordo su cui il suo dire si accende tra dogmatismi e strutture di divisioni di spazi e stagioni, di ruoli ed una natura stessa-così tanto amata- che pure va a smentirci nella mortalità dei suoi isolamenti, come una illusione a fronte di una terra in cui non c’è più nulla di invisibile ma solo un male che si distingue e “grida forte”. La lotta è allora è con le immagini, per le immagini, nella loro salvaguardia di reminiscenza e di origine, di contenuto allora nel loro frutto d’amore e di pietà adesso nel vuoto a perdere di un tempo che come i suoi angeli sembra lasciarsi decomporre (scadere al chiuso dei suoi frigoriferi verrebbe da aggiungere come dalle immagini più forti che Federica ci regala). Così il morto che in sogno va a salvare “dai festeggiamenti”, che teme, ama, asseconda è anche figura di un mondo che nel pensiero dei suoi uomini e delle sue donne si vorrebbe immortale e forse per questo terminale nella neutralità e nell’indifferenza del suo possedersi. In conclusione, dunque, un volumetto che volentieri andiamo a consigliare, seppure domandandoci se possiamo cantare ancora solo dolore e tramonto, se la poesia d’occidente può solo condividere l’imbrunire da cui nasce e non aprire piuttosto squarci, luci nella gioia di esserci perché vivi così come ci viene suggerito da altri orizzonti, più poveri forse, ma nell’insieme. In sostanza, giocando proprio da de Freitas: possiamo solo continuare a morire, dire la morte?
Id: 1198 Data: 25/10/2019 12:00:00
*
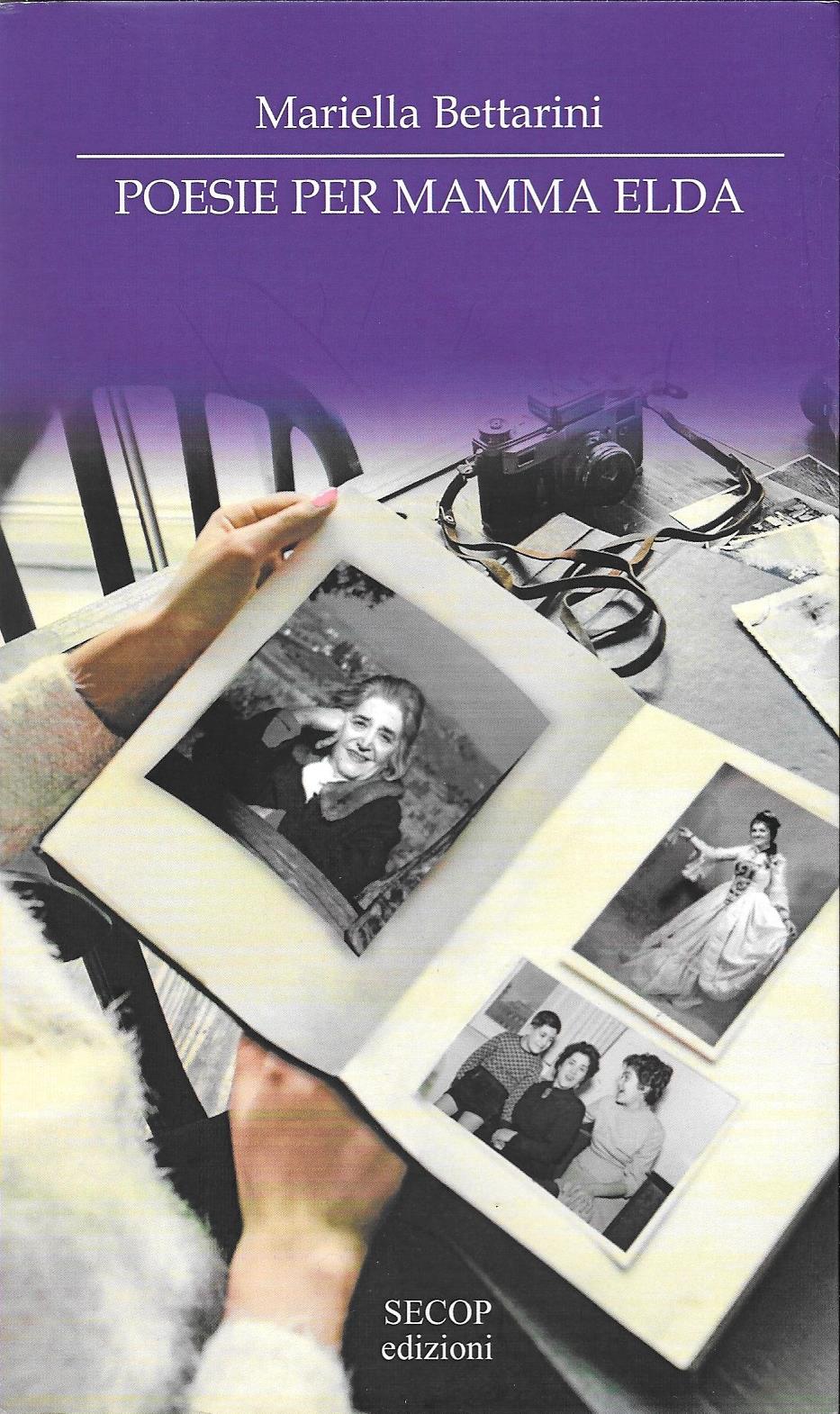 Mariella Bettarini - Poesia - Secop Edizioni
Mariella Bettarini - Poesia - Secop Edizioni
Poesie per Mamma Elda
Non è nuova Mariella Bettarini (che non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei nostri più importanti poeti) al racconto di figure amate, di cari ricordati e celebrati entro una esistenza che anche di questi volti, di questi affetti si è nutrita nella formazione della propria identità. Infatti già in "Zia Vera- Infanzia" nel 1996 si era misurata in tal senso. Il caso di queste poesie (per buona parte già uscite come ebook nel 2010 proprio per i tipi de LaRecherche) però è diverso giacché vanno a registrare un'assenza a tratti irraccontabile ma di cui è necessario fermare la forma, il suo costante bussare all'interno di una perdita cui tentare di colmarne il vuoto nel dire della parola insieme sofferenza e memoria, luogo del travaglio e incisione viva della figura materna nella "testimonianza (così povera, imperfetta) della sua serena, umile dolorosa Persona" generosa, non appariscente. e per questo viva. Il dire del lutto è sempre un dire dell'apertura in quello spazio di chiamata ad un procedere nuovo, spesso ingombrante in cui in "uno vanno tanti volti" (come ben iscrive Giovanni Stefano Savino nella poesia dedicata ad Elda nel giorno del suo funerale) a sgranare il rosario delle morti cui apparteniamo, andando ad aggiornare ogni volta il nostro personale rapporto con la morte cosicché il parlarne è, ovviamente, un parlare dapprima di se stessi. Pure è bene ricordare, ed in questo ci aiuta Angela De Leo nella postfazione, che la perdita della madre in quanto tale "priva di sé", mutila e sovverte l'identità cui la parola non può sopravvivere che per inciampo alla prova di un latente e ostinato pensiero, di una presenza che passa per sbalzi non cessando dunque, in realtà, di esistere. La scansione allora dei "lacerti di esistenza, di memoria, di doloroso amore" cui provare a "ritrovare minuzzoli di vita" è data giocoforza per controcanto e incastri di parole e immagini brevi, quasi a singhiozzo, ora a confermarsi ora a smentirsi all'interno dell'anima sola (in una indagine secca della scrittura di cui la Bettarini, il cui percorso ha abbracciato ed abbraccia cinquant'anni di interrogazione, è forse unica). Eppure già il testo d'apertura, nel ricordo della madre sul letto di morte sa cogliere esattamente il senso di un compimento di una vita che passa rilkianamente per la propria morte risolvendosi la donna così come è vissuta: "pacifica- paziente- illuminata" e "nel grembo delle cose". La lotta allora va a sciogliersi come in un antico procedimento, certo non conscio, in un tener dietro alla madre (come sole nella sua ineguagliabile luce) risolto poco a poco in una presenza viva proprio perché non pensata ma sospesa come "se nulla fosse passato", lei di là nelle consuete e care stanze adiacente a regnare nei suoi territori familiari, ubliqua nella sua "limpida storia lineare" entro una capacità d'amare espressa in vita con discrezione e devozione, capace di disfare dolore "amore alzando- diffondendolo fuori". Così soprattutto nella prima sezione la scrittura e l'anima finiscono con l'intrecciarsi nella dimensione di una chiarezza liberata proprio nell'agile disciplina di un Lume vivo perché iscritto nella sua esatta trasfigurazione- e maestria- di cielo e terra. Il verso risulta limpidissimo, toccando vertici cari alla nostra più grande tradizione lirica (vali tra gli altri questo piccolo passaggio:" se di te riprendo a ragionare/con te ragiono/senza te- e ancòra/delle tue belle stelle m'incorono"). Perché ciò che resta nel "destino della dimenticanza", e dunque indimenticabile, è la lezione e l'educazione all'Amore ("grande Anima e grande Cuore") che ha allora nella sezione seguente una breve ma significativo appendice nel susseguirsi caro di ricordi (toccante nello sprigionare dai ninnoli di una scatola un'alta e "sapiente povertà"), di vecchie storie familiari, calamità, pudori, sogni e "favolelle" vivissime seppur nella lontananza dei tempi e dei racconti familiari, Elda (cantante lirica fino all'incontro col suo marito, e Maestro, Luciano Bettarini) scomparsa nel 2003. Il lascito è quello di un credo, di una fede a non render vana quella più alta Volontà della vita per cui il canto di riconoscimento finale si scioglie: "sei la matrice-/il corpo lo devo a te-/sei la Matrice del mistero-/lo devo a te-/sei la matrice-se vivo/lo devo a te/sei tu/la Mediatrice e il Nulla/e me- il Tutto e me-/ sei la matrice-/colei che ha dato corpo a un Soffio/che vagava/che ha dato fiato/ a un corpo che (non volente) doveva/poi essere//sei l'orma del Mistero-/sei la Matrice". Un testo allora vivo, prossimo per la sua insanata ma carezzata, illuminata dolenza nella quale il lettore può riconoscersi e ricordarsi tra le pieghe di giorni e figure che mai disattendono e che ancora ci formano- e informano. Andando a concludere è bene sottolineare anche la raffinatezza dell'edizione corredata da alcune fotografie della cara Elda, una delle quali nel costume del suo debutto come soprano nell'opera "Il matrimonio segreto" di Domenico Cimarosa; e poi dalle poesie per lei di Gabriella Maleti, di Angela De Leo e come accennato di Giovanni Stefano Savino.
Leggi le poesie proposte in Poesia della settimana
Id: 1188 Data: 12/07/2019 12:00:00
*
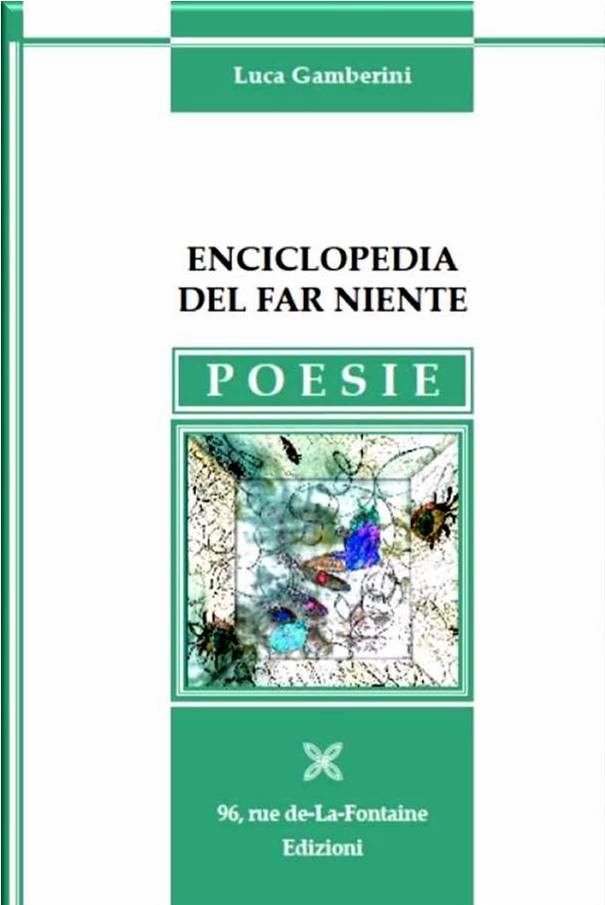 Luca Gamberini - Poesia - 96, Rue de-La-Fontaine Edizioni
Luca Gamberini - Poesia - 96, Rue de-La-Fontaine Edizioni
Enciclopedia del far niente
Proviene da uno spazio di resa ai margini, di magnifica resa alle dimensioni non ricattatorie, non espugnanti dell'esistenza la poesia di Luca Gamberini e in amore e descrizioni di luoghi e interiorità umane in dissolvenza colte nell'istante del loro piccolo sfacelo o della piccola grazia entro una scrittura a tratti debordante, tra lirica e prosa poetica, cui nello scetticismo di una vita cui non crede se non per brevi e pieghevoli tratti rende onore nella sospensione di una presenza, quella della morte, sempre sottesa e forse quasi bramata. E non è facile scioglierne criticamente il dettato, e forse non ne ha bisogno, non è giusto perché lo infinge e viene da sé nella non banalità di un trauma, di un dolore cui ora acceso ora radicalmente vinto si espone nella provocazione e nella dissacrazione delle infette dinamiche del mondo. Si è parlato a proposito del "male di vivere montaliano" ma questo non dice nulla, ne limita il discorso perché l'angoscia di Gamberini, se di angoscia poi si può parlare, è una condizione sua propria nella forma di una persecuzione che lo informa da dentro scavando ed estorcendo sottordini e splendidi quadri di negazione a fronte di una pratica attiva e di un quotidiano che non gli appartiene. Il suo è un cielo buio, di stagione fredda, ma non ossessivo, non pesante, quasi risolutivo e sollevante nel suo odore premonitorio, di penultima fine, cui solo gli animali e i bambini, con gli ultimi sanno esporsi senza patire "l'amore dei gesti", nella pazienza di un respiro che li sa, li crede eterni. Come la notte, che priva della luce, conforta perché non ascolta, non cede al pensiero e cancella il lamento perché non umana, non nostra. Ciò che tocchiamo infatti è un umano disgiungere, svellere, come l'amore qui nel contrasto di copioni in quanto tali mai risolutivi o come la poesia nei poeti stessi- e in chi ne scrive- casta sprecata "nel trasformare il bambino/ in un giorno di pioggia". Ma non millanta crediti Luca nel seno di uomini e avi per una storia suicida, non gli interessa (anche perché la poesia non fa tornare bambini, "da una poesia si nasce già vecchi") sapendo distendere nell'assenza- e nella deriva- del senso il senso la forza di una scrittura che non fa sconti e il cui paesaggio è anche nella dolcezza di disappartenenze senza metafisiche, che non trascendono (nella consapevolezza che il solo Dio che esiste è in chi non l'ha) il cui bene, forse, è nella consapevolezza di una solitudine che si combatte con la solitudine, nella ferita non sanata ma esposta nel sangue che deraglia. Un po' troppo nero? Non sappiamo dire, qualche dubbio su di noi lo ha lasciato. Grazie.
Id: 1186 Data: 06/09/2019 12:00:00
*
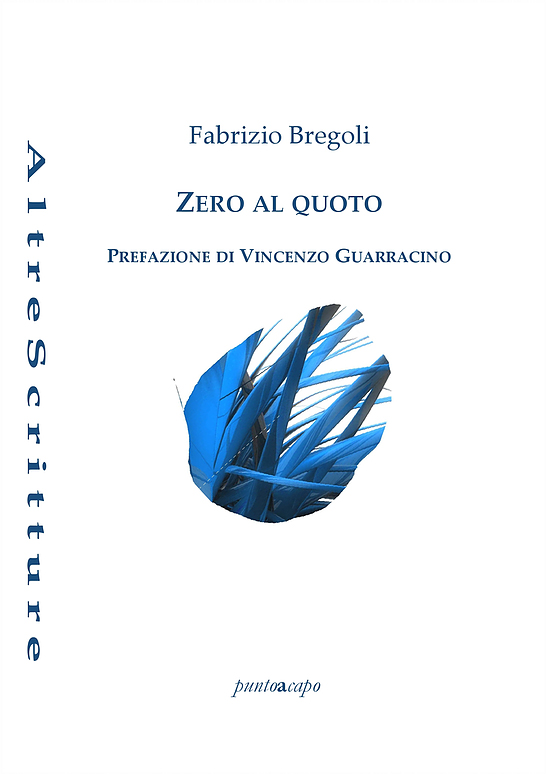 Fabrizio Bregoli - Poesia - Puntoacapo Editrice
Fabrizio Bregoli - Poesia - Puntoacapo Editrice
Zero al quoto
A venirci in aiuto nella spiegazione del titolo dell'ultimo lavoro di Fabrizio Bregoli, autore tra i più interessanti e penetranti delle ultime stagioni, è direttamente nell'introduzione Vincenzo Guarracino: "Espressione con cui in gergo matematico s'intende una operazione che ha come resto zero e che trasferita dall'ambito suo proprio allude ad una ricerca di senso che approda allo zero, ossia al niente". Zero al quoto allora, nella narrazione di una parabola tra il dover restare- e dire- e il suo scetticismo ci conferma, anche per i dialoghi intessuti con parte della nostra tradizione poetica, che il novecento non è finito. Che il secolo breve è ancora lungo, sono ancora lunghe le sue distonie, le sue macerie che ancora bruciano, le sue grazie anche. Si badi però Bregoli non è epigono, ma autore si diceva originalissimo, per spirito e caparbietà, per rigore e analisi di un reale riportato in tutta la sua compressa, dissonante, complessità. Rigore che nella scansione delle sue sei sezioni (in una settantina di testi) accompagnato da una certa dose di amara ironia e persistenza nel cercare di dividere e recuperare, cavillare un tempo che non ama strumenti critici, richiama spesso volontariamente alla mente certe lezioni di Montale, di Caproni, ad una linea soprattutto lombarda (lui della bassa bresciana) nei nomi di Sereni (che infatti risuonerà più forte nella parte finale), Fortini, Giudici e il caro, carissimo Nelo Risi. Eppure, e di questo da subito Fabrizio ci fa consapevoli nel suo viaggiare tra metapoetica e fratture del mondo, la conoscenza non salva (per dirla ora con la Bachmann), la poesia stessa non dice se non un imparare a morire oltre la consuetudine dell'ora e del non detto, "nella disequazione di parole e senso". "Un'ora d'aria" breve, secca ma per questo teneramente, tragicamente umana nel dare terra a un passo da troppa gravità tentato. Un racconto dal margine così come di rosa che può crescere e dare lode solo dall'asfalto (come in uno dei testi finali) e a cui Bregoli non abdica seppure nella spina di una intraducibilità del reale entro una poesia (sulla cui possibilità tanto finirà coll'interrogarsi nella parte conclusiva) della terza persona, di uomini e luoghi colti tra finitudine e scarto, tra vacuità del vuoto e tentazioni di prossimità, entro una natura e case e spazi che gradualmente più non ci acconsentono, piuttosto si preservano sottraendoci, e sottraendosi. Così il suo è un discorso di piccole luci, di una didattica della vita espressa nella cura quotidiana del minimo, nello strappo di una disciplina capace di "raccogliere/ per sprazzi l'imprendibile, ed includere/ quel senso che svapòra, che recrimina". Una disciplina, ed un' etica della presenza, che nell'esitare, nell'attendere e palpitare dell'ingranaggio vale l'accoglienza di quel nulla che dà principio alla vita, nella cura e nella custodia scontornati dal riflesso dell'altro ("La vita è il nulla che le dà principio/l'assurdo che si intrude nel possibile"). E che due testi, tra gli altri sanno raccontare bene, "Ostello degli inguaribili" in cui una fine improvvisa non interrompe del protagonista la sapienza, "il catechismo/paziente della terra" (giacché nei fatti è la risposta) e "Pietà Rondanini" (nella sezione dedicata alle risonanze ad ut pictura poesis a dire l'iconoclastia di questi giorni) in cui la lotta dello spirito che nella carne cerca il suo profilo è colta a Milano da figure protese "a un bivacco di cartoni". Un'etica, ancora, che si lega gioco forza alla memoria e che ha qui luogo centrale nelle sezioni, in "Memorie (da un futuro)"- appunto- e "Diversa densità degli infiniti" in cui se nella prima la meditazione sulla storia ruota attorno al discrimine tra costruzione e sua menzogna (esemplare in tal senso il testo dedicato alla "Frau Goebbels"), nella seconda l'accento è sui riflessi ordinari dei nostri movimenti che della storia fanno il discorso nella reciprocità delle incidenze ed in cui non si può che registrarne, ora, la mancanza di direzione, le morti scomposte in un tempo in cui ci si può forse salvare solo remando a margine, montalianamente rimanendo a terra (agli occhi andando a perdere: giacché "tutto vale/tanto più se è vile"). C'è un verso allora a dire la sintesi di tanta passione, di tanto cucire e ricucire, sminuzzare, tentare, perdersi di Bregoli anche, a volte, nell'eccesso della parola e cioè questo chiedersi- e chiederci- ora sotteso ora quasi rabbioso se è "amore tutto questo/o solo un suo resistere". Nella consegna di questo interrogativo o nella sua impronta di senso già prossimo, è la sostanza di un percorso in cui ci riconosciamo e che caldamente spingiamo alla lettura. Ce ne fossero.
Id: 1185 Data: 28/06/2019 12:00:00
*
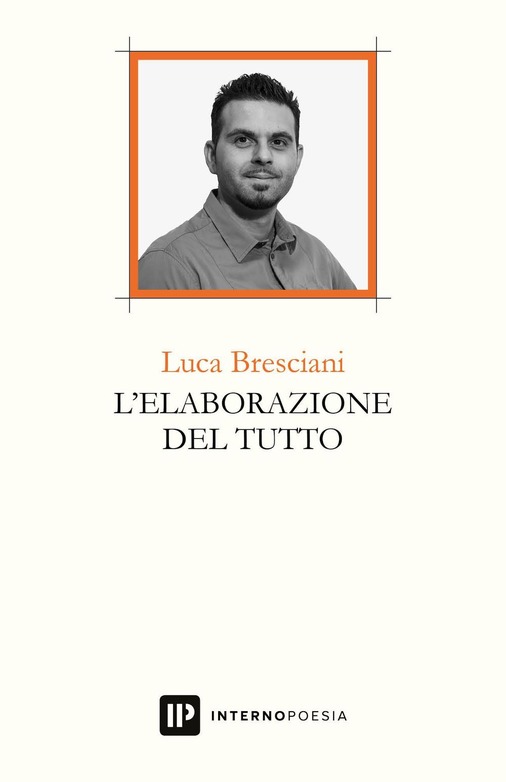 Luca Bresciani - Poesia - Interno Poesia Editore
Luca Bresciani - Poesia - Interno Poesia Editore
L’elaborazione del tutto
Necessario è il primo termine che ci viene in mente al termine della lettura di questo nuovo libro di Luca Bresciani, quarantenne promotore culturale toscano. Necessario perché nella diagonale di un tempo vilipeso e offeso nelle sue ansie di separazione ci ricorda entro una parola esperta (ed esatta nel suo essere "asciutta e provocante" così come ben definita da Davide Rondoni nella prefazione) quel rischio di morte sotteso là dove il dolore nella sconnessione del corpo racconta del mondo, e dei mondi, il confino, della vita, a partire dall'anima il suo isolamento e, dunque, la sua negazione. La frattura sociale in questa "guerra inodore" che "varca senza bussare" si accompagna allora, in un gioco macabro di reciprochi tagli, alla costellazione silente delle tante implosioni personali e collettive, di solitudini ammassate, di inaccessibili ripiegamenti nel timore. Ed allora non è poi così banale come forse a un occhio semplicistico potrebbe apparire il richiamo immediato nei primi testi alle morti per mare perché esemplificative tra le altre di un appello a sorreggere la coscienza dal crollo dei contorni, se per contorni s'intende quella terra che nel suo comprenderci sa pure quale falla può aprirsi dal vizio di vivere soli col proprio strazio. Al proposito, così, mi vengono in mente queste parole tratte da "Cecità morale" di Zygmunt Bauman e Leonidas Donskis:" Quando il dolore morale perde la salutare funzione di avvertimento, di allarme e di spinta ad aiutare il nostro simile, inizia il tempo della cecità morale". Perché è qui che Bresciani mette il dito in una poesia per forza di cose molto corporea, il corpo veicolo di un riconoscimento che passa da se stessi all'altro nella direzione della rottura, della prossimità dunque che viene dal medesimo infangamento, dalla medesima secca. Un corpo a cui dedica testi e sezioni come un piccolo chirurgo, perché un bisturi la parola a ricucire, separare dal male una carne arroccata, compressa, a tratti disumana perdendosi l'indignazione nell'abitudine a qualunque tipo di morte, muta la pietà al dramma dell'altro. Ma è pure un corpo a suo modo immortale, "più antico del dolore" e delle sue muraglie ("dove l'amore precipita a valle"), quello cui il verso fa appello, il diritto alla disperazione riservato solo " a chi è innamorato del futuro". Per questo lo sguardo resta fisso a coloro che sporcandosi provano a "sradicare le lusinghe del buio" nel coraggio di comprendere di non essere solo l'inizio e il termine di se stessi ma chiave di una congiunzione nella quale anche il dolore se adottato e liberato dal rancore può "farci riportare vicino/il nostro io più lontano"nel diritto di sentirsi uniti "a se stessi e agli altri". Ed è per questa pena che il dettato che finisce per procedere per imperativi si batte o all'inverso contro la sua desolazione, la sua ricacciata all'inferno dell'infingimento si oppone. Perché di questo, per sua natura, infatti la poesia sa esser cura, e spina dorsale addestrata dal dubbio, nella china, " a seminare il cuore della terra". Terra, in quel girotondo in cui sono sempre gli stessi a cadere, per la cui uscita alla luce necessita una compartecipazione come detto, l'altro il gesto reciproco del nostro ripeterci all'infinito. Perché se il male "nasce dal buio/ di chi non sceglie", l'apertura accade nel compimento del rischio proprio dove il destino non è chiaro, obbligando "i sogni/a fare passi avanti". Nel segno di questa pietas, riportata nel suo valore riconoscitivo e fondante, il libro così va a chiudersi entro una interrogazione oggi non più eludibile. Ed è per questo, nonostante a tratti un eccesso della parola a dire il peso, che lo consigliamo nella sua necessità.
Id: 1183 Data: 14/06/2019 12:00:00
*
 Federico Corrado Camporeale - Poesia - Italic
Federico Corrado Camporeale - Poesia - Italic
Dimenticanze
Opera prima, questa del cinquantenne milanese Camporeale, solida, ben scritta, assai stimolante nella ricchezza di echi di una formazione di non indifferente livello che si dimostra meditata e rielaborata entro una riflessione originale e personale che sa passare agilmente da un registro crepuscolare e quasi demodè a un timbro grottesco, ora salace ora impudente. A guidarlo una visione di bellezza sfigurata, di un mondo di piccola provincia o di periferia urbana, raccolto attorno a piccoli quadri di sogni smarriti o appena intravisti negli occhi di una giovinezza o di una infanzia ricucita in una età adulta forse compressa ma ben presente nella lucida malinconia della sua veglia. Che è quella della nostalgia, allora, della inarrivabilità come destino di cose non avute ma in quanto vagheggiate comunque conosciute, felicità di barlumi intravista per oratori, nei cortili, nei piccoli e grandi abbracci di fiere e stazioni, meraviglia di giovani donne ma soprattutto di campi descritti magistralmente con l'occhio di chi sa la compiutezza appartenere ad altri animali, agli animali sì e agli uccelli soprattutto. Così è un viaggio questo, come da titolo, tra dimenticanze, di aggraziate e crude mortalità condivise, di grida perse nell'indifferenza del tempo e del mito, restituite nella condizione di un amara confidenza che si fa arte nella tenacia presenza del suo distacco. E del suo dipingersi, perché Camporeale prima fa vedere e poi risuona dietro gli accenti di un raccogliersi che nel perdersi però poi ci dilata e dunque pur nell'ombra ci fa eterni. Un discorso dall'ombra come da lezione di autentica poesia, dettata come accennato dai banchi di autori che hanno informato e formato tanto nostro grande novecento, da Gozzano evidentemente ed amici, ma anche Cardarelli, Montale (per alcuni giri di affabile perplessità del reale), di Saba, Carderelli, Penna finanche nel fulmineo richiamo dell'icona. Ma pure da tanto esercizio transalpino, luogo caro e inseguito con l'ironia colta del piccolo scalpellino che guarda a se stessi e agli altri con affettuoso disincanto, con disincarnata ma viva pazienza che è poi quella del tenersi stretti "quel poco che il destino avanza/per la nostra sete di assoluti" nel mistero di una natura in cui si è sospesi. Non a caso l'immagine cara al pensiero, nella tensione del dialogo, è quella della neve col suo "potere d'attutire/i colpi dolorosi" cui nella consapevolezza della zolla provare l'attesa del filo d'erba, l'ora pronta dal solco a involarsi stella, a farsi canto per quel vuoto d'amore cui sangue non potrà bastare. Dimensione questa che è la vera misura di un dettato che non scantona, teneramente, ironicamente anche, vivo: vero.
Id: 1178 Data: 24/05/2019 12:00:00
*
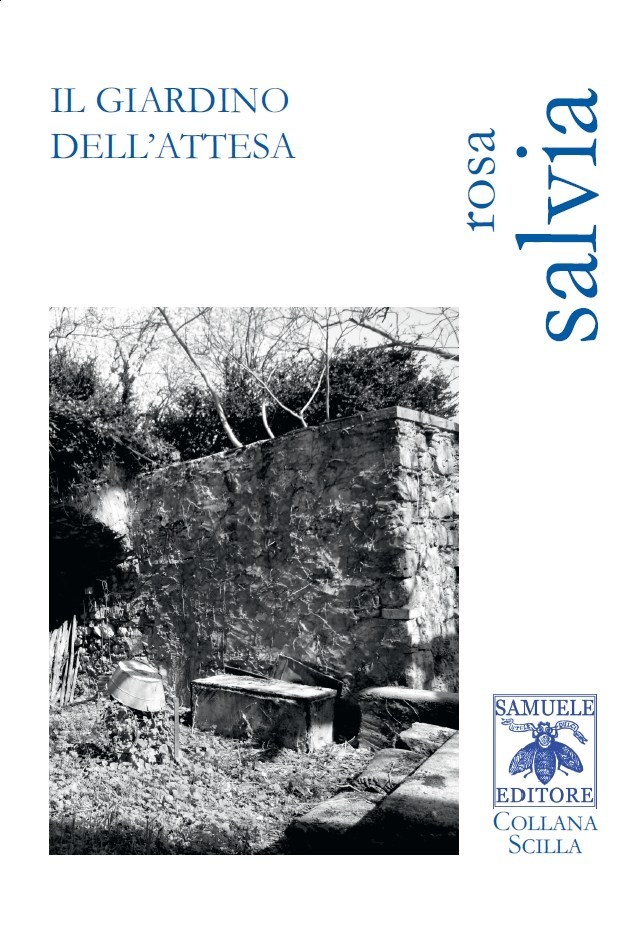 Rosa Salvia - Poesia - Samuele Editore
Rosa Salvia - Poesia - Samuele Editore
Il giardino dell’attesa
Quest'ultimo libro di Rosa Salvia, autrice lucana da tempo di stanza a Roma dove insegna storia e filosofia nei licei, ha il merito e il coraggio, dunque, di riportare al centro della riflessione poetica il suo luogo centrale, e cioè l'abitare la terra. Dico riportare perché nell'andamento ora della preghiera, ora della veglia, sa raccontare nel riferimento, non solo metaforico e simbolico, del giardino la tensione vitale di una creazione cui l'uomo stesso nell'inscindibilità degli elementi è chiamato a rimemorarsi, a concorrerne al corpo, mistico certo perché nell'unità di un legame che non gli viene da sé e di cui è responsabile nel carattere profondamente- e teneramente- umano e dunque fallibile della sua costruzione. Così il giardino da subito, dal primo testo, senza divaganti astrazioni, senza equivoci, si mostra, ci chiama a ciò che è, luogo del seme e dello "spazio che accoglie/quel seme". Occuparsi del seme allora è il primo movimento, che viene da un setacciare consapevole e partecipante della terra, di un'erba falciata con la lingua nella splendida definizione di un insieme che non esclude ma ricuce nel dire stesso le diverse aspirazioni del suo procedere. Un procedere che ha nell'altro l'osso, il cardine di un'impalcatura di cui ognuno è scheletro e albero, ancora, ed in cui la misericordia, l'attenzione e la partecipazione al dolore dice nella semplicità della complessità la speranza e quindi la comunità nella ricucitura della ferita. Giacché è evidente quello della Salvia è un discorso sulla comunità umana riportata nel microcosmo della comunità lucana d'origine e che ha nella seconda parte del libro il suo sviluppo più stringente. Non a caso il termine di radice in cui la fioritura si raccoglie ha la risonanza esatta in uno dei testi iniziali del rintocco vigile del campanile nella rispondenza che dall'ombra la afferma sigillandone il cerchio. Ma il senso, ci avverte, è tutto, nella seconda parola, essenziale e complementare al giardino, l'attesa, ecco, nella fatica ascendente e discendente dell' esserci "là dove agisce la gravità" e la nascita ha la provenienza oscura e umida del freddo. L'attesa infatti è un agire sì procedente ma anche rimettente ci viene costantemente ricordato, educazione alla fedeltà e alla pazienza che viene appunto dal concorrere entro una pratica d'orizzonte che tutto investe ma che anche ognuno, ogni cosa supera, trasfigura e rimonta. La parola deve, non può che accompagnare quest'agire, farne memoria a partire dagli uomini e dalle donne (soprattutto, in rappresentazioni in queste pagine esemplari), dagli animali, dagli elementi di una natura sovente fatta di fatica, di dolore (ed anche di morte là dove per nostra incuria "aspetta e riposa") in uno scorrere che ha il suo sviluppo, denso e piano, proprio accanto ed entro la rosa di spina, eletta qui a figura del senso. La parte finale del volume allora va a connotare l'esistente come esercizio e fisiologia del respiro nella sua tensione con la forma, di un'assenza diremmo che nell'accoglienza possa dire del mondo- e di noi- più che un' oscura bellezza il suo certo tornare ("innocente come una pala d'altare") e restare "ove con il vino spartiremo il pane,/il pane, la memoria e la casa" (si legga al proposito "Medusa", uno dei testi più esemplari). Questa lezione sacra e al contempo etica e civile altissima (essere "lingua ove le lingue/ cessano") in un tempo che non ammette tempo (nella sua tendenza a fare della coscienza un incidente) va al merito di un'autrice che ha saputo coltivarsi- e richiamare- alla luce di una verità possibile.
Id: 1174 Data: 19/04/2019 12:00:00
*
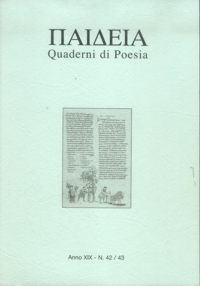 Aa. Vv. - Rivista - Centro culturale Paideia
Aa. Vv. - Rivista - Centro culturale Paideia
Paideia, numero 42-43
Anche in questo numero la rivista Paideia (giunta ormai al ventiduesimo anno) si conferma tra le più complete e attente e magistralmente dirette del panorama nazionale. Merito è dell'instancabile Francesco De Napoli acuto cucitore di memorie e di orizzonti che sa ben intrecciare analisi critiche, testimonianze ricordi di autori e critici valenti. Come nel caso di Emerico Giachery, ad esempio, col quale il numero si apre nella preziosa interrogazione sulla capacità di trasmettere adeguatamente nella lettura vocale il modo di sentire un testo. Richiamando dapprima l'attenzione sulla importanza fondamentale del significante, dei valori fonici e ritmici lo studioso romano invita a riflettere su una "previa consapevolezza critica" del testo nella "interpretazione-esecuzione anche vocale di un testo poetico". Testo che innanzi tutto bisogna amare lasciandosi anche guidare nella lettura dall'emozione ma senza farsi sopraffare affidandoci a "quella trasmissione silenziosa che assomiglia alla cosiddetta o alla telepatia". Lezione altissima cui nelle pagine seguenti Francesco De Napoli dedicherà valenti analisi a proposito de Passione e sintonia. Saggi e ricordi di un italianista (Carocci Editore, 2015) in cui Giachery stesso si definisce, più che critico, interprete nel conferire al testo "vita attuale e presenza". Segue l'analisi della raccolta di Pasquale Maffeo Nostra sposa la vita. Tutte le poesie (Caramanica Editore, 2010) in cui De Napoli inserisce la figura del grande anglista nella linea della grande tradizione poetica e letteraria meridionale di ogni tempo (dalla Morra a Quasimodo passando per Di Giacomo, Eduardo, Gatto, Sinisgalli, Fallacara, Viviani, tanto per fare dei nomi) analizzandone la poetica e ricollegandola a quell' origine orfica della poesia tanto radicata nella Magna Grecia e bilanciata in due distinti livelli, la condivisione immediata di fermenti e sollecitazioni da una parte e dall'altra "una consapevole posizione d'attesa sulla soglia della percezione oggettiva e sensibile". Il quadro che ne esce allora è quello di un intellettuale ben vivo "tra riserbo e impegno, tra senso della misura e prodiga militanza" in cui la vita abbracciata e intesa nella sua tensione all'unione- vedi di qui il titolo del volume- di fatto si trasforma in questi versi, nel canto, in condivisione di sofferenza e insieme di luce e libertà nell'intima familiarità di un mistero più alto. È la volta poi di Maria Lenti la cui attenzione alla poesia di Giarmando Dimarti riporta alla luce la singolarità di una scrittura "sulla scia di autori italiani i quali, almeno dalla fine del secolo passato, sperimentali o meno, hanno tenuto come punto fermo di lasciare al passato i leopardismi (ma non il Leopardi della Ginestra) e pascolismi e hanno indicato una strada di sovvertimento, di conferma della necessità di una scrittura per tempi nuovi, di sconferma dunque del lirismo". Dimarti, secondo la Lenti, arriva allora a scavalcare l'amata lezione di Luzi- a proposito "della sfaldatura della coscienza civile"- ripartendo al giro del millennio proprio dalla "insistenza espressionistica della sfilettatura di quella coscienza" per l'acquisizione di nuovi valori da acquisire. Nel consueto omaggio ad autori che ci hanno lasciati particolarmente sentito è invece il ricordo di Adam Vaccaro di Mario Lunetta e Francesco Leonetti. Partendo da memorie personali Vaccaro tratteggia caratteri e incisi dei due autori rimarcandoli nella presenza autorevole di intellettuali solidi, vivi proprio all'interno della crisi di questo ruolo all'interno di un contesto, sopratutto quello degli anni novanta, mutato dal punto di vista economico e sociale e nella percezione "delle pratiche di ricerca letteraria e artistica e saggistica". Ma è la lettura di Tommaso Di Brango del celebre sonetto "Guido, i' vorrei che tu e Lapo" ad imprimere una traccia diversa alle pagine nell'intento di "evidenziare i principali nodi problematici del testo dantesco per riformularli in chiave divulgativa". La prima parte- come da avvertenza- si concentra"sul rapporto tra questo componimento e i generi letterari del suo tempo", nella seconda e terza parte sulle "asperità" di quartine e terzine. Sono pagine che vivamente consigliamo prima di dedicarci all'analisi di De Napoli di due saggi di Rocco Salerno sulla poesia e la figura di Dario Bellezza (L'emblema casto del passato. In memoria di Dario Bellezza, Edizioni Confronti, Fondi 2017, e Utopia della speranza nella poesia di Dario Bellezza, Edizioni del Giano, 1994) in cui il poeta calabrese a Roma dal periodo della sua conoscenza con Bellezza ha innalzato negli anni una memoria critica e di vita importante dell'amico. Poeta ricorda De Napoli "dilaniato dalla fascinosa, impari sfida lanciata all'assurdo naturale, al male di vivere, alla natura matrigna" entro però quelle rivoluzionare armi del linguaggio come sottolineato da Salerno, al contempo "strumenti- di difesa e d'offesa"ed "epici, niente affatto innocui". Passando all'edizione del premio De Libero 2017 ancora De Napoli soffermandosi su La luce di assai buon'ora di Gerardo Vacana, l'opera vincitrice, ricorda del poeta di Gallinaro il carattere "metafisico" di poesia criptata ma incisiva e piena entro quel carattere che da ragazzo lo colpì (e poi pienamente confermato) entro "un andamento sì levigato e scarno, dolente e risentito ma pacato, dove lo smarrimento e il disincanto- incapaci di precipitare nell'irritazione e nello sdegno- si palesavano in forma di carezza e di pietas umana". A proposito di omaggi è Antonio Risi a dare voce a quello di Amerigo Iannacone, poeta ed editore molisano tragicamente scomparso nel 2017 di cui si rammentano (partendo proprio dal volume di ricordi Iannacone stesso C'ero anch'io- Un'autobiografia o quasi , 2017) le Edizioni Eva, "La Flugfolio", rivista di informazione letteraria fondata e diretta per più di trent'anni, i numerosi riconoscimenti conseguiti ma soprattutto il concetto della cultura come bellezza partecipazione e memoria sempre perseguita con instancabile e ammirevole fermezza. A chiudere quindi l'attenzione critica è il direttore stesso che nella sezione "Il libro ritrovato" ci introduce a Le betulle nane di Evgenij A.Evtusenko (libro del 1974 che uscì in Italia per la Mondadori con l'introduzione di Pier Paolo Pasolini). De Napoli, che ebbe la ventura di conoscere e frequentare il poeta russo, celebra la figura e la poesia di Evtusenko in un'analisi dettagliatissima delineando il ritratto di un artista che "capace di metafore sottili e pregnanti- non soltanto di quel realismo franco e aperto che tutti gli riconoscono-, ribadì in svariate occasioni la sua ansia di abbattere qualsiasi steccato od ostacolo, sia materiale che ideologico". La rivista avvicinandosi al termine ci presenta le tre poesie finaliste della Biennale di Poesia "Succisa Virescit" organizzata dalla rivista e in attesa del risultato definitivo. Sono di Tommaso Lisi, Evelina Pascucci, a cui va la nostra preferenza, e Giovanni Tavcar. Infine prima della rubrica "La pagina di Rocco Scotellaro" (con la poesia: "Che fiato mai avrò ancora") e della segnalazione di altre riviste, ecco la nutrita schiera di recensioni tra le quali si sottolineano quella di Antonio Risi a Salmi metropolitani di Michele Brancale (Edizioni del leone, 2019) e quella di Francesco De Napoli a Canti della tartaruga di Daniele Giancane (Edizioni Eva, 2016).
Id: 1172 Data: 22/03/2019 12:00:00
*
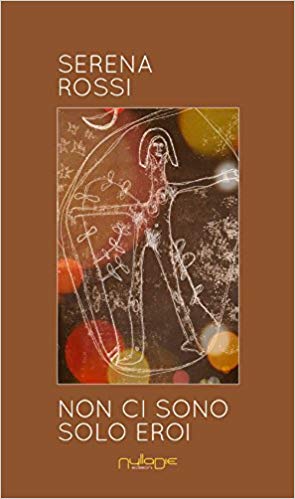 Serena Rossi - Poesia - Nulla die
Serena Rossi - Poesia - Nulla die
Non ci sono solo eroi
È un libro che fa innamorare di sé un po' alla volta e al quale dire grazie questa terza pubblicazione in versi di Serena Rossi, quarantenne milanese attiva anche nelle arti visive (tra l'altro formatasi alla Fondazione Pomodoro di Milano). Un libro che va a vincere alcune resistenze che ogni tanto per evanescenza di immagine, e di parola, rischiano di frenarne il dettato e di conseguenza la lettura. Eppure, è proprio qui, collateralmente, all'interno di un contemporaneo narrato nella mestizia di un divenire irraggiungibile che certa fragilità si impone, si fa funzionale nelle sue incrinature, a un discorso sull'essere che ha base su una condizione non solo personale ma diremmo sociale, culturale, esistenziale di disagio. Ed è un ritratto intenso, doloroso, ferito ma splendidamente, creativamente libero quello che la Rossi ci offre. Femminilmente libero, evidentemente, coscienza e carico del peso risalendo e sciogliendosi per il tramite di nudità non nascoste nella loro ansia di luce ma esposte e dunque condivise. La lotta è tra un'espressione piena e partecipata del mondo e i traumi, le frizioni che risalendo come detto da oscure camere vanno a inficiare un presente già carico e sospeso nei suoi rifiuti entro una geografia di luoghi e di anime forse non vinte ma certo colpite, battute, derise. La risposta, nello stordimento, in un procedere a inciampi e a perdite in cui nessuno è escluso, è in un fermo, muscolare richiamo a restare come detto, a prestarsi nel capovolgimento delle declinazioni, e nella singolarità delle identità violate, a un ritrovamento al plurale di noi stessi. Nella forma del "siamo " infatti, la Rossi scioglie il suo interminabile appello, nella figura degli ultimi, dagli esclusi ai bambini e alle donne, rammentando una sacralità, un destino d'orizzonte sovente in progressiva e reciproca cancellazione- quasi castrata, dimentica (se non in abbandono come nel destino dei tanti animali qui ricordati) Investe infatti tutta la dimensione allargata del suo mistero il discorso sull'uomo cui questa scrittura ci riporta tra gli umori e le sostanze di una terra che chiede sostanza e accoglienza soprattutto dal basso, da quelle secche e da quegli umori entro cui con forza questa poesia (altro non potendo) vuole restare. Ed è proprio tanta tenacia, tanto insistito dichiarato attaccamento a una vita aggredita nei propri sogni, alle proprie ontologiche promesse- e premesse- a cui solo l'amore, seppur spoglio, seppur spesso nella sterilità della solitudine, può ricordare e dare degna bellezza a imporsi come moto propulsore del testo incidendosi in tutta la sua interrogante lacerazione. Ed è proprio ancora tanto naturale procedere in versi pur a tratti zoppicanti a convincere sciogliendosi forse anche al di là delle intenzioni in una piccola lezione consigliandosi da sé allora alla lettura. Brava, coraggiosa autrice dunque cui va il nostro plauso per lo sforzo del continuo ricordo: "non siamo soglia" ma anima già eterna, e casa.
Id: 1166 Data: 08/03/2019 12:00:00
*
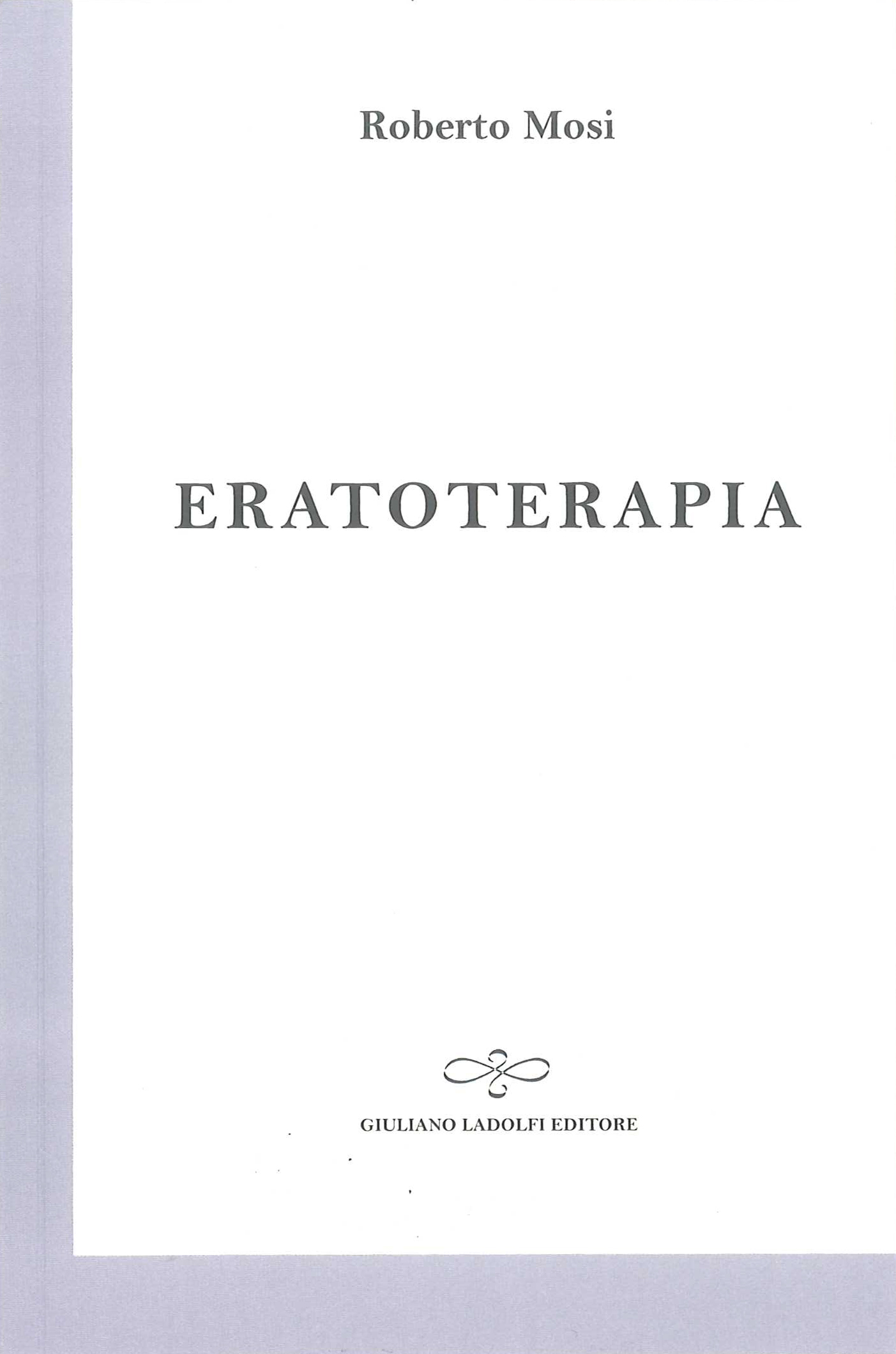 Roberto Mosi - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Roberto Mosi - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Eratoterapia
Ci eravamo lasciati dopo la lettura de La vita fa rumore (gennaio 2019) parlando a proposito della poesia di Roberto Mosi di una scrittura fortemente caratterizzata da un' incisione critica ed etica del reale, da un racconto bruciante nelle dolenze e nelle rivendicazioni del presente. Ed è ciò che a distanza di tre anni ritroviamo in queste pagine, il dettato adesso arricchito però da una grazia prima appena sottesa, appena evocata, a dimostrazione allora di una scrittura mai arenata in se stessa. Una grazia data nell'espressione di un verso che trae forza da sé, nella fiducia che risale dall'apprendere, dal saper osservare- e ascoltare- nella rimessa in moto dei mondi entro una attualizzazione sempre nuova della bellezza ora per partecipata storia ora per edificata memoria. Siamo pertanto d'accordo con Ladolfi quando nella prefazione, a proposito di un andare a riscoprire i luoghi in cui si è vissuti (Firenze) dal fondo delle sue radici e delle sue sofferenze, Mosi compie un'operazione che va a sottrarre "al tempo la sua azione devastante" ricucendone piuttosto nella contemplazione e nello stupore prossimità e risonanze. L'occasione come sempre però è data dalla vita stessa, dal suo procedere per rinascite tra le maglie delle sue direzioni, delle sue annunciazioni, qui nel volto di nozze della figlia o della amata nipotina Marta.. È come se, nel passaggio e nel nutrimento di vita che queste occasioni consentono, la poesia lo consegnasse entro uno sguardo e uno spazio finalmente sollevato e perciò grato in quel ritorno di sostanza che viene dall'amore. La gratitudine dunque è il primo frutto di questi versi a conferma di quel risanamento cui la poesia comunque conduce (e a spiegare insieme il perché del titolo, Erato secondo la mitologia classica la Musa del canto orale e della poesia amorosa) nell'andamento chiaro- e caldo- di una parola sempre accogliente, sempre funzionalmente aperta. E dunque condivisa nella consapevolezza di una identità nell'intreccio con la vita degli altri, letizia e pesi mai scissi da un costruire comune. Ecco allora nelle risonanze i richiami obbligati non solo a una storia personale o a una Storia come detto che viene dall'alto (la città dei Medici, lo splendore di un'arte e di un pensiero che ancora ci interrogano) ma anche alle cadute e alle mancanze di chi della storia non riesce a tenere il passo. Ed è questo certamente uno dei punti di forza del suo dettato nella costanza del mantener "fermo il timone/ sul mare aperto". Timone che ha il suo senso nel saggiare così la consistenza del presente e che nel finale si fa monito nella lettera cui proverà sciogliere alla piccola Marta motivi e incanti del dire poetico. La poesia infatti, ribadisce, ha autenticità nel timbro se sa guardare al vero della vita, "ai tempi prossimi che stanno per arrivare" facendosi strumento contro l'opacità dell'epoca. Una affettuosa- e sapiente- lezione questa che riguarda tutti noi.
Id: 1163 Data: 01/03/2019 12:00:00
*
 Emiliano D’Angelo - Poesia - Puntoacapo
Emiliano D’Angelo - Poesia - Puntoacapo
Trilogia delle ore
Quarantenne avvocato campano legato alla critica d'arte e a collaborazioni con Musei e centri d'arte visiva, si offre Emiliano D'Angelo in questo agile volumetto ad un convincente esordio poetico dopo alcune pubblicazioni di racconti su diverse riviste (ed una pièce teatrale per gli allievi del Teatro Stabile di Torino). Autore raffinato per una formazione culturale che per naturalezza qui esce fuori tutta (al contrario di molta esposizione che dietro al modello cerca di infingere il proprio vuoto di interrogazione e di senso) accompagnando nella meditazione sul tempo la sua malinconica ma divertita- per stizza, per invisa finitudine- riflessione sulla mortalità e le sue bellezze, i suoi dissapori. Nella struttura delle tre sezioni con cui il libro ci accompagna come a seguirci dal sorgere del giorno alla sua conclusione, i richiami, gli omaggi ai tanti scrittori, pittori, e musicisti soprattutto, non sono infatti che un compendio- struggente, bello nell'intensità delle sue fughe e delle sue rivalse- ad un sentire umano che si sa vinto in quel suo sogno di vita appena dilatabile e che solo l'amore- forse- e l'arte- certo- allora possono provare a cantarne l'illusione. Così la figura del risveglio con cui si apre il testo che ci fa preda ancora di fantasmi e della luce di un dio che incombe nella sua collera resta insieme figura di un ossessione e di un abbaglio che non cessa nell'instabile destino che ci ospita ma che pure non nega a una bellezza che proprio da questo limite, da questo continuo morire si fa sublime. Perché a suo modo, è un canto che abbassandolo fa più caro il cielo questo procedere per piccole evasioni, per giri inversi entro una terra che si offre nella sua povertà come in "Meditazione su un tema di Grünewald" dove chi tende la mano più che chiedere salvezza la offre. E come accennavamo non c'è però soffocamento in questo dettato che ama piuttosto un dirsi e un dire ora nella sottigliezza della piccola provocazione, e dello scherzo quasi, ora nella leggerezza di una consapevolezza che sa della bellezza stessa la necessaria fragilità del suo stadio nel passaggio (e paesaggio- di "agave protesa" e "lucertola in amore") verso l'esilio. Lo sguardo al mito e alla nudità degli animali (si veda nella meraviglia l'indovinatissimo ritratto del gatto nero, "Charlot etilico e lunare") a fronte di una annunciata e catodica digitale e apocalissi occidentale (che scaccia una morte che però continua a depositare la sua polvere) è una consolazione per se stesso forse più che per gli altri eppure è, resta segnale di un segreto, di una possibilità di mondo che si annuncia dal buio (come l'istrice nella sua "danza di guerra e di paura"o le ragazze che vanno a scomparire in "Hanging Rock" tra "musica e stupore./E uno stridore, lontanissimo, di insetti"). Ma non è una poesia della fuga questa di D'Angelo, no, ma di una presenza forte all'interno dei chiaroscuri di una esistenza che sfugge, che non si dice e non ci dice- se non per scarti che possono però anche essere preziosi- nella malia di un irraggiungibile culmine. Per tale motivo questo dettato ci è caro perché prossimo e riconoscibile nelle sue consonanze e vivo proprio in quel "linguaggio scarno ma ricco di suggestioni" ricordato da Anna Bertini in una delle due postfazioni (l'altra è di Emanuele Spano) grazie al quale bene sa incarnare evocazioni e ritorni di una anima affaticata, dolente ma malinconicamente mai vinta. Un testo dunque ricco, intenso e mai banale che si segnala anche per l'accuratezza di una edizione corredata nelle inserzioni grafiche all'interno di acquetinte su disegni di Stefano Di Stasio.
Id: 1159 Data: 08/02/2019 12:00:00
*
 Gian Luca Guillaume - Poesia - Nulla Die Edizioni
Gian Luca Guillaume - Poesia - Nulla Die Edizioni
L’oscurità tra le foglie
Ci resta poco al termine della lettura di quest'opera prima del giovane torinese Gian Luca Guillaume. Poco, davvero, oltre la stucchevole ripetizione di modelli fuori tempo tra le pieghe di un compiaciuta esistenza coatta e perciò maledetta. Intendiamoci, più che nobile il grido- e auspicabile diremmo- che viene dal rifiuto di una modernità divorante, di un richiamo dai margini a valori di solidarietà e presenza a fronte delle uniformità delle cancellazioni. Ma qui il racconto, in forma di fuga da una perdita dell'innocenza quasi dovuta alle dinamiche familiari e sociali, non ha altra direzione se non la poco originale strada della melensa mitologia personale che nulla ha da illuminare su quel mondo personale e umano (battuto, disprezzato e insieme, nel rovescio, escludente e al tramonto) per cui tanto strepita. La scelta (se di scelta si può parlare per mancanza di coscienza critica) è così quella della scrittura di un sé ultimo, bandito dalla strada e dagli uomini (persi ahi loro nella grassezza dello stomaco e del coito) e alla ricerca nelle evocazioni del cammino e degli incontri di quell'ispirazione del tempo che lo possa in qualche modo comprendere nella sua bellezza. Il tutto entro un armamentario, di situazione e di lessico che ha poco di proprio pugno (nella vera illeggibilità di buona parte del testo) per provenienza da autori amati, letti ma non metabolizzati; padri fermi nella sterilità di un dettato evanescente perché innamorato della propria adolescenza. Su tutti i cari Baudelaire, Verlaine nella sensualità esotica della carne e dell'alcool, Rimbaud (a proposito di illuminazioni)tra lode dei paria e degli schiavi ma soprattutto Campana, il buon Campana in queste pagine saccheggiato- e colpito- a più riprese. Potremmo fermarci qua per il basso servizio offerto al bene di una voce- quello della poesia- che abbisogna principalmente di umiltà e di onestà dunque nella domanda del proprio senso, e per una risonanza non solo privata. Invece preferiamo concludere, nel bisogno di incontro a cui il verso chiama, da alcune piccole tracce che pure Guillaume sa versare nel suo percorso. Ci riferiamo a malinconie e silenzi di dolore vero, di piccole richieste di ascolto che dal basso di una solitudine lontana risalgono da un cuore impaurito. Provare a tentarsi finalmente alla luce di una condivisa spoliazione, di una parola accettata potrebbe essere questa allora la strada tramite la quale sorprendersi, e sorprenderci, da quel seme che attende.
Id: 1156 Data: 18/01/2019 12:00:00
*
 Mauro Di Fabrizio - Poesia - MEF - L’Autore Libri Firenze
Mauro Di Fabrizio - Poesia - MEF - L’Autore Libri Firenze
La mia Gloria
Poesia della fede, nella creazione di luce iscritta nella naturale declinazione della famiglia e dell'amore, è questo il dettato in cui gioiosamente si iscrive l'esordio di Mauro Di Fabrizio, quarantenne autore della provincia di Roma. Così il canto che è sempre un canto di vita in costruzione- e partecipazione- del mondo non può che avere nella figura della sposa che ha scelto di condividere con lui il cammino fulcro e centro della sua irradiazione. E c'è qualcosa di autenticamente candido in questi versi a sorreggere il bene del tempo infinito delle generazioni che non si disperde ma si rinnova nel passaggio dei suoi valori. Un candore che viene dalla forza di un' interrogazione che non si piega all' azione oscura del dolore,"nella paura di mangiare il buio", e che dunque sa rinascere nella gioia di un accompagnamento dato nell'umiltà della passione e del servizio. La letizia è infatti la consonanza in cui Di Fabrizio consegna la sua scrittura nella lode della donna da cui avuto pienezza, chiamati insieme a una fecondità che se ha la sua incarnazione nei figli ha pure nella sua quotidiana presenza voce di una naturale e chiamata espansione. Ecco allora i tanti richiami ai colori, ai fiori, alle stesse montagne d'Abruzzo delle origini, nella radice di una promessa che si va mantenendo (vedi i riferimenti al padre, ai cari dei diversi affetti) nella perseveranza faticosa del seme . Pure così ha tratti del genere cavalleresco questa tensione che ha nella casa, nella protezione della donna e dei figli il cuore dei suoi motivi. Ed è, ripetiamo, proprio questo sapersi parte di un orizzonte in cui si è chiamati il bene di un testo che però per lunghi tratti rischia di rivelarsi fragile. Infatti la tensione da sola non basta a sorreggere un dettato la cui sostanza spesso si svuota entro una parola irretita nella cadenza di immagini prive di forza perché retoriche e in un armamentario abusato e dunque oggi niente più che lezioso. Ma non sempre è così, per fortuna, e per questo il termine autentico ancora vale se Di Fabrizio riuscisse a coltivare movimenti e giri di senso che ha pure in sé e gli appartengono. Ci riferiamo a un risolversi secco della voce entro risonanze che bene sanno riportare nell'interrogazione di vita da cui muovono lo spazio di un compimento che viene dal riconoscimento dell'ombra ("quello che hai visto passare nel silenzio"), di una mancanza dalla cui frattura passa il riconoscimento dell'altro. A conferma di un lavoro dunque che ha bisogno di soffermarsi meglio sul proprio materiale espressivo nel legame con il suo dettato- che c'è e preme con forza- per imporsi e restare. Con un caro augurio, in conclusione, riportiamo un passaggio riferito all'amata che ha un che di orientale, particolarmente felice:" "Anima lieve./Sereno nella casa del padre".
Id: 1153 Data: 04/01/2019 12:00:00
*
 Francesca Anselmi - Poesia - Gazebo Libri
Francesca Anselmi - Poesia - Gazebo Libri
Il tempo delle parole
Esordio poetico questo della quarantenne fiorentina Francesca Anselmi per la cura della Gazebo di Mariella Bettarini, da sempre preziosa officina di vita e scrittura. Ed è una prima opera come da titolo all'insegna del dialogo col tempo entro un verso che cerca di ricucire nelle maglie di una memoria ora distante ora più vicina il presente di una coscienza e di un dolore non disperso ma riportato al credo del suo vivere. C'è un'ansia infatti, uno scollamento che cerca ascolto a cui la parola presta servizio nella registrazione di un sé divaricato, tragicamente diviso ma anche in qualche modo, per questo, teneramente carezzato, cullato a tratti in quelle parti che non convergono tra l'io e sua incompiuta ma desiderata possibilità. Così è anche un percorso di consapevolezza quello che la mano nel suo scorrere "libera/su carta bianca" testimonia partendo dalla registrazione del corpo nei segnali del respiro, metro di un mutare e transmutare dentro un enigma cui solo l'accompagnare è dato. Umile spettatrice di un insegnamento che viene dalla virtù dell'abbandono, dal sapersi spingere in avanti ("come sappiamo,/come possiamo") la Anselmi procede così nella sospensione di piccoli segnali, di piccole aperture nel tentativo di confidenza di un disagio che affidato alla sua scansione possa in qualche modo sciogliere o almeno lenire l'inconciliabilità del proprio difficile equilibrio. Ed è la sapienza del verso allora entro le brevità strofiche e del metro a sostenerne l'eco, il riflesso in cui il silenzio nell'apparire delle sue feritoie sa reindirizzare nelle tracce acquietandone nel distacco le interrogazioni. Sorretto da una fede nella nominazione il cui bene è già nell'esplicazione del dire il dettato si nutre di osservazioni, di passaggi tra "Corpo e anima,/ sostanza e spirito" nella cui nudità di "pesantezza e leggerezza", nel cui abisso l'io- seppure nella perdita, seppure, nel dolore- prova a rifondarsi nell'accettazione trasfigurante di una realtà per sua natura irraggiungibile. Il pensiero dunque è lascito contro "quel potere disgregante del presente" di cui ci informa Antonella Pierangeli nella prefazione; la poesia nel dolore come affermazione e informazione di vita nella richiesta di dignità da cui risale. Ed in cui si salva nell'oscuro avanzare della sua tensione, nella possibilità sempre attuale- e partecipe della sua rincorsa. Qui la maturità di questa prima prova si fa più evidente risolvendo via via in contemplazione lirica quegli spazi in cui la parola, dimorando e riposando (secondo una felicissima espressione) sa liberare nel silenzio dei motivi il senso di un partecipe e comprehensivo vuoto. Eppure proprio quando il gioco della scrittura sembra salvare dalle dispersioni osserviamo come l'autrice non riesce a tener dietro smorzandone gradualmente la forza, ingolfando il discorso in un eccesso di testi che ne abbassano il tono. Ciò però non cancella la bontà di una meditazione e di un percorso sulla via della maturità e a cui auguriamo quel coraggio a cui tanto aspira.
Id: 1150 Data: 30/11/2018 12:00:00
*
 Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
Versi senza titolo
Abbiamo avuto già la grazia di addentrarci nella scrittura di Savino, nella forza di una poesia inseguita e raccolta nel crinale di giorni lunghissimi dalla collina di Fiesole dove quest'autore quasi centenario (classe 1920) scioglie il suo canto sospeso tra una fine sempre più prossima e la luce di spazi (della memoria, degli incantamenti) che lo investono. Questo tredicesimo titolo per la cura della Gazebo (a cui va il merito della scoperta) ci restituisce un sentimento della vita in cui seppure tutto apparendo ormai lontano nel tempo che va a concludersi sa risolvere il suo bel verso ("per sempre lasciato/ non finito") nel contare i passi tra le stanze accompagnando ed entrando con l'uomo nell'ignoto. È infatti un esercizio dell'abbandono, un diario di consegna questo dettato altissimo che proviene da una terra (il proprio sé nel proprio confondersi) respirata nella sua florida consunzione nella conca che a valle quotidianamente lo distende e lo risplende. L'alternanza come tra veglia e sonno è tra una parola allora che cerca di lasciare "segni di passati risvegli" ed una che lo imprima entro un "aspro grido" nel quieto andare di un dire che si ferma perduto. A distinguerlo dai precedenti si segnala in quest'ultimo volume un eccesso di dolenza e di stanchezza cui il battito sulla coscia nella conta delle sillabe non infinge ("ignoto il passo, ignota la preghiera", tutto perso- anche "il volto degli amici"). Il ritorno all'immagine della cara madre (il cui sorriso basta "come pezzo di pane") sembra sospeso con quello della buca di Trespiano (che lo attende per l'ultimo riposo) all'apparire e scomparire dell'Arno nel suo scorrere come figura del tempo. Diversamente però ora più forte è il peso nella consapevolezza che tutto è tardi, che non si può tornare indietro a ricucire le dimenticanze ("non giocai mai con mio fratello") e che il tempo della vita (sentendolo anche dagli altri) sta finendo ma che- soprattutto- ancora non finisce: ancora non lo coglie. Ecco qui nella testimonianza di una chiamata e insieme di una permanenza è- nella fatica certo, nel buio di uno spazio per noi lontano di chi si cerca e trova un volto sconosciuto- il procedere di un uomo che dalla penna come dalle tasche fa cadere piccoli versi, piccoli segnali di un sonno, di un metro che non è più "sbaglio ripetuto" ma già preghiera a entrare anche con noi nel dire finale di una "lontana voce nuda" che forse già ci sa ancora e per sempre natali. Resta- e probabilmente resterà- una figura insolita quella di Savino. Autore e uomo schivo nella luce di un infinito finire. Per questo paziente e poeta sempre.
Id: 1145 Data: 26/10/2018 12:00:00
*
 Giancarlo Baroni - Poesia - Grafiche STEP editrice
Giancarlo Baroni - Poesia - Grafiche STEP editrice
I merli del giardino di San Paolo e altri uccelli
L'ispirazione che viene dagli uccelli, l'attenzione suscitata dalla loro presenza e da un dono quello del volo a noi negato è da sempre, dalle osservazioni dei primi, nelle risonanze dei poeti in quel canto sovente segnato da una perseguita malinconia nell'inclinazione alle parabole, agli inseguimenti non raggiungibili tra cielo e terra. Anche la poesia del nostro novecento non ne è stata immune pensando così, tra i tanti, a Montale, Saba, Ungaretti (e appena prima a D'Annunzio e al Pascoli), al Cardarelli con quella struggente, intensissima "Gabbiani" che non smette mai di stupirci. E però ci vuole amore, consonanza vera e coraggio in questo percorso tra ornitologia e misura dell'anima, nella disciplina di un apprendimento che viene dapprima da una progressiva coscienza del peso e poi per sapienza dell'occhio. Giancarlo Baroni, parmense di navigata versificazione, ce lo ricorda nella scrupolosità di un accento sempre vivo perché fermo nella dilatazione di un riconoscimento che non si illude, che non confonde, a riprova dunque di quanto già sottolineato da Pier Luigi Bacchini nella prefazione a dire tra i viventi solo il possibile raggiungimento di un "combattuto equilibrio" nella "delineata separazione tra le specie". Un lavoro che viene da lontano e che Baroni ha voluto rivisitare essendo il libro un completamento di una prima edizione (2009) raccolta nella prima parte a cui nella seconda seguono testi nuovi o precedentemente esclusi nel compendio delle belle illustrazioni di Vania Bellosi e Alberto Zannoni. L'alzarsi in volo della prima omonima sezione segna allora più la spinta di uno sguardo umano nella curiosità della tensione che non il librarsi stesso dei pennuti, scrutati, immaginati e rincorsi nel racconto di un mondo descrivibile, come tutto ciò a noi sconosciuto, con parole e riferimenti umani appunto in quella trasparenza di rumori e tocchi e voci nascoste che di noi non si curano, osservandoci dall'alto quasi ad avvertire però di non essere coinvolti in ciò che non sanno, di non cercare di indovinare nei loro voli il futuro, "il progetto di chi ci sovrasta". Così seppure nati prima di tutti, prima degli eroi e della terra, e messaggeri di un mondo a cui noi aspiriamo con la preghiera (la loro città di aeree frontiere è comunque tra gli uomini e gli dei) sono tratteggiati nei versi da una terrestre equità di cornicioni, pozzanghere e salti, di lotte e spole tra rami resi nella nobiltà e nell'orgoglio della figura, nell'arabesco dei colori. Davvero Baroni ci restituisce un campionario ricchissimo di piumaggi, danze, nutrimenti nello sfilare dei falchi e pavoni, colibrì e aironi, storni, anatre, aquile, tarabusini, quaglie e pettirossi (solo per citarne alcuni). Il tono bello è quello divertito, serio come di studioso ma per sé, per il proprio spazio di mistero a cui allargarsi nella interrogazione di un mondo, di una vita che non riusciamo più a percepire nella malattia e nella morte che va a corrodere ("Quali uccelli verranno/dopo di noi? e quali piante?"). Ecco allora al centro del quadro i merli, cuore di una geografia- e storia- personale in una investitura di riferimenti e motivi che non stupisce: la cara Parma e l'assedio del 1248 nella ferocia degli uomini ma anche nell'intelligenza delle donne, nella bellezza della sua arte. Nell'ex Convento di San Paolo (luogo come ricordato ricco di natura cultura " a cominciare dalla splendida Camera affrescata dal Correggio") queste piccole creature, protette dai rapaci e dai pericoli del mondo in un luogo ospitale anche nella rigidità del giorno, sembrano echeggiare, beffeggiare con allegria il tempo tra disputazioni sul trattato di ornitologia e falconeria scritto dall'imperatore (quel "De arte venandi cum avibus" conservato lì dalla Badessa Giovanna e di cui loro si sono eletti custodi) e la simpatia coi putti dipinti dall'Allegri sul soffitto nella somiglianza di vita sulle nuvole. Nella concessione solo di brevi migrazioni all'orto botanico, alla fortezza farnesiana d'estate, sembrano ricordare quell'esistenza parallela e serena che la storia non contempla ma che l'arte suggerisce nelle ispirazioni di un bene possibile forse solo nel ricordo e qui riportato tra le pagine più riuscite di un testo sempre esatto. E che si conferma nella seconda parte, relativa come detto a testi aggiunti (e accompagnati dalla bella prefazione di Fabrizio Azzali), negli inseguimenti e nelle fughe con cui, in "Una geografia celeste", nel disegno di un viaggio infinito andava a chiudere il discorso precedente ("Non un labirinto/ma una geometria di scarti/ di gallerie sbocciate su radure/di crocevia e di fughe./ La morte qui non saprà scovarti"). Qui il tono si chiarifica nel rigore di una coscienza che sa vedere nelle migrazioni non un'astratta libertà di terra ma la necessità e la fame di chi, innumerevoli, sa per quale sopravvivenza muove. Seppure poi Baroni mai abdicando al gioco scherzoso degli umori in cui i suoi favoriti continuano a sorprendere nelle loro apparizioni inaspettate, nelle multiformi griglie delle loro esplorazioni, delle loro incandescenze (in una teatralità di suggestioni che li porta ad incuriosirsi della natura dei poeti). Maestri della presa di distanza dalle cose e da un mondo che implora impazzito una uscita, dalla finestra uno spazio, una rimessa in ordine:"non oltre gli uccelli/né sotto agli uomini,/ amando questi /quanto più si è capaci di afferrare/ i segreti dei primi". In conclusione un libro questo di Baroni che conforta nella sapienza di una scrittura, di un verso- robusto- entro l' antichità di un dettato riflesso in questo canto nella misura del nido ("Intrecciato di piume e vegetali/poi murato col fango") dove "una coppa accoglie//come un uovo la Terra". E che resta a nostro dire come uno dei più bei testi di poesia degli ultimi anni a dimostrazione di quel brevissimo frammento di Holderlin: "e davanti ai/ Migliori passano gli uccelli".
Id: 1125 Data: 14/09/2018 12:00:00
*
 Manuel Paolino - Poesia - Il seme bianco
Manuel Paolino - Poesia - Il seme bianco
L’idromele
In questa raccolta il quarantenne triestino Manuel Paolino raccoglie la produzione di un quindicennio di poesia a raccontare come in un diario, nell'avvertenza della introduzione, il suo apprendistato d'amore e di uomo, di poeta nella passione di una parola che sappia nelle sue incisioni infiammare e informare. Così in un centinaio di testi possiamo perderci negli scioglimenti di un percorso in formazione che, tra riferimenti al simbolismo di un verso tra sensualità e oscurità di un sentire mai sazio (Rimbaud, Mallarmè, gli amati Baudelaire, Poe, Lorca) e desideri di mitologie e disincarnazioni fuggiasche ed epiche così care a tanta poesia latino-americana (ma anche orientale nelle evocazioni e nelle suggestioni del Tempo), si risolve in una meditazione sulla figura del poeta come iniziato, come indagatore (continuo è lo sguardo, il dialogo col Corpus Hermeticum del Trismegisto) a cui però non è data conoscenza (che brucia) ma servizio (come prolungamento "della luce del Sole" o come coperta "quando si fa notte"). Ed allora questo canto nella gioventù del suo prestito non può che scorgersi nella reverenza di una terra che reclama attenzione- e aderenza- nella fragilità del frutto ("cosa vi è di più esposto?"), cui dare riflesso- e voce- nella cadenze del giorno. La declinazione è quella della istanza, inseguita, bramata, perseguita entro le tracce di un desiderio che ha nello smarrimento, nel suo rischio, l'indice di una umanità ancor viva (come l'orchidea dell'omonima poesia) pur nelle secche degli sradicamenti. Ed è poesia di creaturalità nella carnalità di una libertà vezzeggiata e carezzata grazie anche a un uso ricco e attento di una parola piena, densa per riconoscimento e prossimità con gli uomini e le cose a dire dunque di un dettato autentico, di una scrittura che sa attendere e catturare come da un girasole (da uno "sconfinato nulla/fatto sui muri di storie") nella sua conta di vita. Il verso infatti non fa, non sa che accompagnare questo gioco di luci e penombre (avendo senso in questo) nelle visitazioni quotidiane e notturne, nella misura di un percorso o per meglio dire di un pellegrinaggio a cui comunque preparare il ritorno. Per questo forte è l'aderenza alla natura (nel suo ricordo di "cos'è il respiro/ che rinasce dal passato"), al paesaggio nelle dinamiche di risonanze dei corpi e degli spiriti, di presagi e di remissioni che il canto si sforza di catturare ("Terra sui poeti tra i grandi seni./Non dormono ma ascoltano/Un verso sempre lo stesso"). Eppure è proprio qui il discrimine della perfetta riuscita (se mai possibile), della resa al lettore di una visione che sappia dirlo nel medesimo riconoscimento, nell'interrogazione del comune mistero che è nei giorni. Infatti Paolino indugiando nel dialogo coi maestri, negli ammiccamenti di genere tra figure e rimandi di poesia nera (tra dannazione e perdita) rischia sovente di inficiare l'originarietà di una voce che pure esiste, resta ed è certa nelle corde di una liricità sempre viva che lo salva consegnandolo a una commozione, a un riconoscimento che di quegli stessi modelli, appresa la lezione, evidentemente sa far meno. Pensiamo tra gli altri a testi come "Libète", "I larici di ghiaccio", "Versi antichi" o a "Prima del crepuscolo", soprattutto, esempio di una ispirazione e di una aspirazione d'assenza che cerca nei varchi di "felicità/interrotte" luce e pace dai propri enigmi, dalle proprie irrisolte e fuggevoli distanze ("Scorgo/ la mia vita/ tra quelle montagne/ disegnare con le loro curve/ sul tiepido abbaglio/ in discesa/ di un sole/ a metà// Prepotente ora/ dal cielo emerge/ e mi vince/ in un abbraccio di luce"), di un movimento dunque che ove non cede alle suggestioni dell'ebbrezza sa finalmente sciogliersi e trovarsi, come nella sinestetica "Colori", entro una vita ed una notte "negra grande buona". Ed osservarsi nella direzione di una "poetica/ come la vita che smonto sempre/per ripartir dai luoghi/ degli eterni pezzi": l'amore, la famiglia, la casa nel "sogno puro/indagatore di purezza"; da quell'angolo da cui però infine lo sguardo continua a perdersi: "Lassù/quegli uccelli/come pesci negli abissi".
Id: 1121 Data: 12/10/2018 12:00:00
*
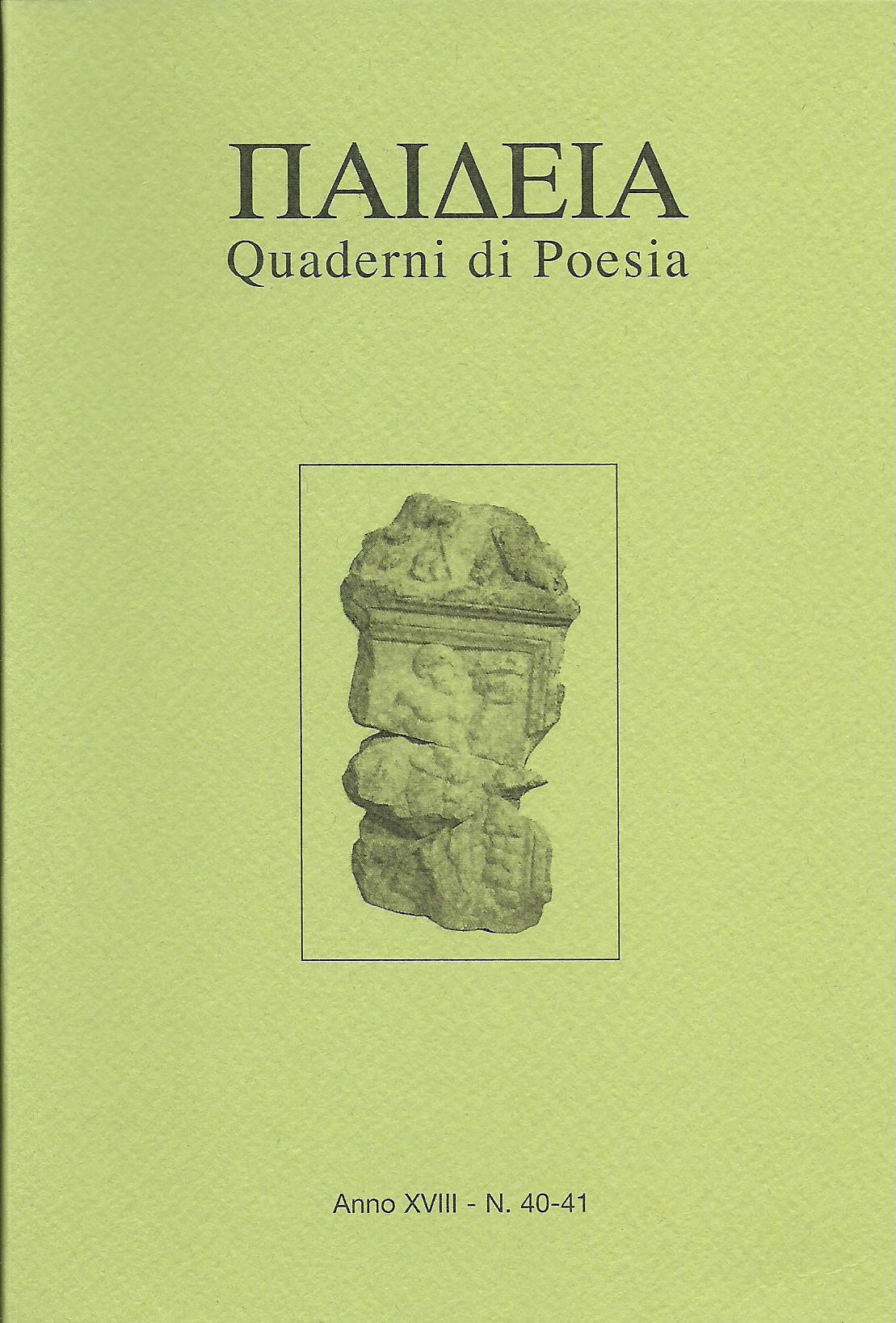 Aa. Vv. - Rivista - Centro Culturale Paideia e.f.c.
Aa. Vv. - Rivista - Centro Culturale Paideia e.f.c.
Paideia n. 40-41
Più che ricco e interessante, come sempre, anche quest'ultimo numero di Paideia, rivista, o come sottolineato, quaderno di poesia diretto con sapienza e rigore da Francesco De Napoli ormai da quasi vent'anni. Numerosi gli omaggi e letture critiche a figure e testi autorevoli riportati alla luce dell'arco di un'intera produzione. Apre l'attenzione dello stesso De Napoli all'antologia A parole- in immagini (Edizioni Gazebo, 2008) in cui è raccolto il percorso letterario di Mariella Bettarini. Oltre ad analizzarne l'evoluzione e il racconto testo per testo, dagli esordi de Il pudore all'effondersi al Trialogo con la cara Maleti e Giovanni Savino e gli ultimi inediti, De Napoli si preoccupa di ricordarne la fortuna critica (Dario Bellezza, Mario Luzi, Franco Fortini, Roberto Roversi fra gli altri) e la singolare posizione di autrice sempre entro una "poliedricità di scrittura e di temi- della storia, dal basso", mai banale nel dissidio "tra l'inefficacia- forse, l'impotenza- del discorso poetico da una parte e l'omologazione culturale e socio-antropologica" (che ebbe non a caso ad avvicinarla nei riferimenti delle interrogazioni a Pasolini) e secondo "una ricerca stilistica e concettuale incessante ma ben misurata- per quanto scossa dal rovello del dubbio filosofico-, appassionata e totale". A seguire l'appassionante e intenso saggio di Giuseppe Panella "Letteratura come memoria. La tecnica dello svelamento" in cui viene ricordato il compito della letteratura nel trasformare in sogni il bene della memoria (facendola così durare nelle sue isole in ciò che resterà) "come la forma indispensabile della nostra vita". L'analisi allora parte dalla Toscana del trecento nel magistero di testi quali La Divina Commedia, il Canzoniere, il Decameron nel loro porsi a"straordinari esercizi filosofici di memoria". La grande opera di Dante è il riuscito tentativo "di ricordare in unico viaggio simbolico la storia, la struttura e il pensiero dell'umanità- passata, presente e futura" (restando la memoria però argomento principe di tutta la produzione dantesca); anche il Canzoniere del Petrarca è un libro della memoria (di Laura, del passato, della poesia) ma a dispetto della filosofia dantesca del ritorno senza "istanza di salvazione" rappresentando il liber memoriae della poesia lirica italiana tentando "di trasformare in scrittura poetica la filosofia di Sant'Agostino", lo "scavo interiore come scelta prospettica esistenziale " nella "ricerca di una soluzione ai problemi della soggettività umana"; per quanto riguarda Boccaccio, infine, Panella parla di teatro della memoria che "si fa filosofia della vita e dei rapporti sociali " basata sulla lezione del passato per una giusta condotta nel presente. Nella seconda parte invece viene ricordato della scrittura il carattere di strumento per "scoprire che cosa rappresenta in realtà il mondo che in un'opera letteraria viene messo in scena, qual è il segreto che nasconde, quale verità essa veicola e pro-duce" sottolineando inoltre come "lo svelamento della natura della realtà raccontata è, a sua volta, il segreto rivelato della volontà di chi scrive" giacché "scrivere significa cercare di rivelare un mistero, che è poi lo scoprire la dimensione stessa della soggettività di chi scrive" (come nei casi qui ricordati di Joyce, Proust, Musil Kafka, Pirandello e Svevo). Suggestivi a seguire sono i ricordi di Evgenij Evtusenko e Valentino Zeichen poeti recentemente scomparsi, soprattutto quello di Valerio Magrelli dell'autore fiumano di cui ribadisce oltre al "tema barocco dell'eccellenza, del Tempo distruttore", il carattere spiccatamente argomentativo dello stile. Interessante è anche l'intervento di Tommaso Di Branga su Opera sull'acqua e altre poesie di Erri De Luca (Einaudi, 2002) in cui la poesia si manifesta nell'autore napoletano come esigenza di rinnovare il proprio strumentario linguistico e letterario, come azzardo nel mare aperto di una storia che va narrata per poterla comprendere e ove necessario fermare ("una presa di posizione motivata contro l'incipiente globalizzazione neoliberista"- sono i giorni tra l'altro del G8 di Genova). Nel carattere miscellaneo del testo echi biblici si intrecciano a temi civili (il Vajont, le tragedie dei migranti) e poesia d'amore in cui la stessa dimensione religiosa si fa in lui (pur ateo) "pietà creaturale di ascendenza francescana"volta a dare ad ogni creatura importanza. Ricco è soprattutto però il lavoro di De Napoli che nell'attenzione critica a saggi e testi poetici diversi ha modo di rincorrersi in appassionate illuminazioni su percorsi autoriali e storie letterarie meritevoli di diverse e forse nuove valutazioni. Come nel caso di Gerardo Vacana di cui a proposito de Il verbo infedele. El verbo infiel (Traduccion de Carlos Vitale. Emboscal, Tordera, 2016) evidenzia il sapiente procedere nella forza del dubbio, nella "relatività del sapere" che consente la prevalenza nella scrittura di "saggia accettazione" e al contempo di "curiosità ironica" aggiunta a "connotazioni umane, psicologiche ed esistenziali di alta filosofia". Oppure, senza dimenticare la lettura della preziosa testimonianza sulla visita a Cosenza nel 1957 di Betocchi ("con tutti i risvolti socio-antropologici e letterari che ne conseguono") nel saggio di Carlo Cipparone (Betocchi. Il vetturale di Cosenza e i poeti calabresi, Edizioni Orizzonti Meridionali, Biblioteca di Capoverso, 2015), le puntigliose considerazioni dal libro di Leone D'Ambrosio Museo, la poesia ceneraria di Libero De Libero (Edizioni Ensemble, 2016). Qui soffermandosi sulla profondità delle trentanove poesie del finora sconosciuto, e inedito, Museo rivelato da D'Ambrosio e sulla non risolta "individuazione e/o delimitazione dei territori che costituirono (..) la fonte primaria ed essenziale nel percorso di formazione e iniziazione" della sua poesia (e che per D'Ambrosio è la nella Ciociaria nella terra che si estende dalla Valle del Sacco e del Liri fino al Golfo di Gaeta e al promontorio del Circeo) evince fin dalla prima età un destino di "forestiero errante", "carico di conseguenze inesplicabili" pur nel legame ben radicato con la propria terra. "Dentro la terra", nello sprazzo di vena surrealista che tra le altre misure lo avvince e avvicinano ai grandi nomi della poesia europea a lui coeva (attento alla lezione che veniva da Rimbaud e Mallarmè) ed incentrata comunque e anche nell'impegno in letteratura. Così lodando i meriti di D'Ambrosio nell'aver bene sintetizzato "i differenti- ma non divergenti o antitetici- elementi costitutivi" nei termini di "poesia evocativa, analogica, irrazionale, immediata e potente", De Napoli sostiene De Libero, nel possesso della "più ampia varietà di schemi e di cifre contenutistiche e formali", come il poeta italiano " più eclettico e complesso del suo tempo". Il rigore e la passione critica è al centro ancora dell'attenzione che De Napoli riversa a proposito del libro di Tommaso Lisi Nuovi colloqui col padre e con la madre (Luigi Pellegrini Editore, 2016) nel tema del dialogo coi cari scomparsi in cui il poeta di Coreno Ausonio ricuce l'esercizio della memoria ad esercizio di presenza e "comunione e confronto con il contesto umano e sociale di origine e appartenenza". Così aldilà di ogni "insorgenza divinatoria", De Napoli rivela di questa operazione la coscienza di un legame salvaguardato nella messa in pratica di quei valori cui va dato onore per non interromperne il filo e che in Lisi è dato allora nella pratica a lui più congeniale, la poesia appunto nella resa di una severa costruzione del verso e come (nell'osservazione di Alfonso Cardamone riportata dalla prefazione) "rivelazione dell'uomo all'uomo, dell'uomo a se stesso". Altro bell'intervento poi nella rete di interrogazioni che il numero suggerisce è quello di Maria Lenti che partendo da I poveri sono matti illumina con alta intensità critica meccanismi e dinamiche dei personaggi cari a Zavattini sciogliendo il nodo della follia entro una fantasia che non si presenta "come valvola per uscire dal compianto della vita né come straniamento dal piano della realtà, ma come piano di bilanciamento corporale", come capacità di rimettersi "in contatto con le parti profonde del sé". Ed ancora: "come opposto del riscatto impossibile con le proprie forze o come annullamento del risarcimento inutile e della valenza temporanea" consentendo dunque di slegarsi dalla prigionia dei ruoli "colmando la distanza (..) tra soglia percettiva e soglia intellettiva". Una follia allora che riscattando "dalla convenzionalità" ha il significato del recupero "alla coscienza, a quella presenza mai messa in forse". Infine oltre le consuete rubriche "Pagine di poesia" con testi di Lisi, Vacana, Evtusenko e "Lingua e diritto" (a cura di Pasquale Benedice), vanno a chiudere il numero le recensioni di libri di De Napoli con Di Brango (tra i quali volumi di Ferruccio Brugnaro, Domenico Adriano, Imperia Tognacci) e le notizie sulla XII ° Biennale internazionale di poesia Succisa Virescit (ideata e curata dalla rivista stessa) vinta da Giorgio Bárberi Squarotti.
Id: 1118 Data: 15/06/2018 12:00:00
*
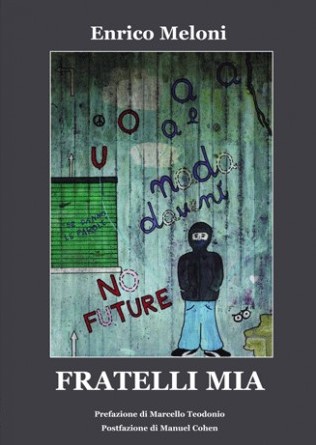 Enrico Meloni - Poesia - Edizioni Progetto Cultura
Enrico Meloni - Poesia - Edizioni Progetto Cultura
Fratelli mia
Questo lavoro di Enrico Meloni, autore in prosa e poesia nonché insegnante e storico, va a dimostrare appieno quanto il dialetto possa soddisfare interamente nella sua funzione letteraria "tutti i bisogni intellettuali" (come ebbe a sostenere già Vito Moretti). E che dunque, ancora e fortunatamente, nell'incisione di una scrittura quotidiana attenta alle istanze e alle bruciature di una Storia non solo personale possa la sua voce essere foriera di accenti e interrogazioni anche più radicali, per profondità, per prossimità, di quelli in lingua. Così il romanesco della prima parte in cui la consegna civile del dettato è però abilmente affidata anche al gioco delle contaminazioni di lingua (l'inglese, lo spagnolo) e di genere (il rap ad esempio) nell'espressione ricca degli aspetti- nei suoi volti, nelle sue contraddizioni- del presente. Se il riferimento illustre del Belli è nelle tracce, un altro nome nel richiamo si fa visibile ed è quello di Mauro Marè, autore al quale Meloni si richiama e maestro di una lingua, come ricorda Marcello Teodonio nella prefazione, "capace di esprimere disperazione e amore, violenza e gentilezza". Tutti caratteri più che presenti nei versi di una poesia civile, "poesia ciovile", cui il racconto dei giorni si raccoglie nel Giano bifronte di una memoria sempre inseguita e perseguita da Meloni entro il rimbalzo di un tessuto sociale oggi lacerato, ferito, senza i necessari anticorpi a fronte delle cancellazioni e delle rovine di inizio millennio. Ha allora il duplice valore del recupero e della rifondazione, almeno nell'intento, questa pioggia di parole carpiate, rovistate, smozzicate e nel tono alto di una intelligenza che muove dal basso, dalla precarietà della sua fiumana, dai suoi tanti Pasquini che vanno a formare diligentemente il "Corettaccio" di una contemporaneità impazzita e ingabbiata in se stessa. Ecco allora sulla scena alternarsi tra fandonie e magagne, speranze e disgrazie e poi gli intrighi di corte e i ricordi struggenti di morti dimenticate come quella di Francesco Pinna ad esempio, studente lavoratore caduto sul lavoro nella preparazione di un concerto e che si fa occasione del rimarco di sproporzione del guadagno nel rapporto manager-operai. O quelle dei bombardamenti di San Lorenzo a Roma nel luglio del '43 e di Pasolini cui è dedicato un intensissimo e bellissimo compianto intrecciato al Pianto della Madonna di Jacopone da Todi. L'indifferenza dei potenti e dei "sudditi supini" tra qualunquismi e moralismi conformisti oltre che confermare le profezie dell'intellettuale emiliano vanno a legarsi dunque ai troppi ultimi che salgono al Calvario qui nel volto rovente dei migranti, dei giovani precari, dei lavoratori e della scuola, offesa nella sua professionalità e nei suoi tagli. La risposta allora agli impuniti cannibalismi, ai fascismi di ogni genere che non si spengono entro un'economia che cancella anime e prospettive è nella vigilanza di un'etica che ha il suo caposaldo nella Costituzione, pianta da coltivare con cura se vogliamo che in noi crescano ancora i suoi frutti "fra nobbili parole e la 'ngrata ranfosa realtà". L'invito allora è a non cedere a rancori e ad amarezze nel rovescio di valori in cui il crimine si confonde all'innocenza ma a imprimersi e a spendersi nel districo difficile della parola e di se stessi. Direzione questa nel senso di una concretezza sciolta negli esiti significativi della seconda parte, "Risanate acque", dove i testi al contrario sono in lingua. La spinta civile qui si rafforza anche nello sguardo ad esempi di figure illustri, ancora della letteratura e della poesia come nel caso di Leopardi ( nella mancanza di senso quando anche un solo singolo soffre per incuria, solitudine, emarginazione, reclusione qualsiasi nella riproduzione delle marginalità) ed Elsa Morante e Primo Levi, e dunque anche della storia come nel giovane partigiano Armando Ottaviano ucciso alle Fosse Ardeatine che gli dà lo spunto per parlare ai ragazzi di oggi sottolineando il valore della libertà possibile anche grazie all'agire di uomini proprio come Ottaviano. L'attenzione infatti è al "peccato di rinuncia" là dove al rischio della reciproca predazione è necessario opporre un"pensiero solidale,/nel valico di esclusivo recinzioni", una visione nuova. Potremmo definire così questa poetica sul bordo del polisenso di un mondo, di una polis che esonda, di una umanità "all'oscuro del nulla/o dannata nel dimenticarlo" cui Meloni segue convertendone il ritmo in illuminanti bagliori dati anche qui sovente per forza di commistioni, di pensieri che s'abbarbicano entro una lingua insieme umile e colta. Coscienza altissima di una poesia intesa "come militanza" (ancora Teodonio) e " nel carico di incombenza critica e di utopia libertaria tra le crepe del sistema dominante" (come tra gli altri ha avuto modo di sottolineare Francesco Muzzioli) e di cui volentieri caldeggiamo la lettura certi della sostanza e dell'originalità della voce. Ne è conferma la parte finale, di nuovo in romanesco nella traduzione da Khayyam.
Id: 1112 Data: 04/05/2018 12:00:00
*
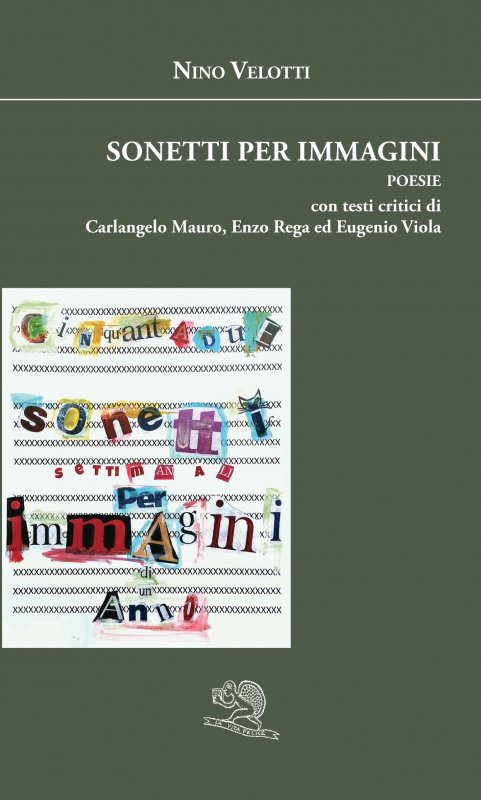 Nino Velotti - Poesia - La Vita Felice
Nino Velotti - Poesia - La Vita Felice
Sonetti per immagini
Attività artistica nel segno di un'impronta, di un segno- o sogno- sinestetico quello di Nino Velotti, docente napoletano che ama spaziare dalla scrittura in versi a quella in musica (fa parte del duo pop-sperimentale Hueco) e che in questa sua terza opera fa accompagnare in un rimando di interrogazioni e di sguardi i testi oltre che da propri lavori fotografici e digitali anche da foto e dipinti di altri artisti (tra gli altri ricordiamo Novella Parigini e una bella opera di Veronica Vecchione). Lo sguardo dicevamo è quello su un mondo che appare in separazione e che solo la presenza degli animali, gli amati "bimbi ancestrali", può guidare, far convergere ancora l'uomo a un dubbio fra una pratica abitativa della terra- e pertanto di se stesso- connotata dall' abuso ad una conforme alla misura del cuore e dell'occhio (per dirla con Elitis) e dunque di custodia nella cova di luce che crepita "sotto il mare del mondo". C'è infatti in questa poesia la sottesa vitalità di un'esistenza sotterranea, per certi versi estranea alle sorti stesse del mondo eppure proprio del mondo a suo modo fulcro nell'espressione piena che viene dal piccolo, dal minuto rintanato "tra pieghe d'atomi" e che forse proprio per questo nelle sue aperture tanto ci spaura e confonde. Esistenza che come questa poesia, come la poesia, non dà risposte ma provoca leopardianamente domande nel rimbalzo di un cosmo, di un cielo che sovrasta là dove la Terra brilla "di luce/ propria, anche in notti senza luna e stelle" ed al cui giro l'uomo non può che opporre "ad ogni morte la forza contraria". Quello di Velotti allora è un dettato estremamente fisico dominato nell'alternanza diaristica ma soprattutto mentale delle stagioni, in quel contrasto d'anime sospinto tra le pieghe di estati ed inverni che andiamo a subire tra promesse inevase- ed ormai lontane- di luce e gelo di respiri senza più nido. Casa la terra di un veleno che viene dalla disappartenenza di una contro-natura che ha figura nel rifiuto, in quel bruciare di diossina in cui s'incendia nell'ammasso il nostro non pensarci finiti (nel nostro assuefarci "alle assenze dopo i drammi"). Così "armi di indifferenza e di delitto", a suffragare l'assunto di un'età dell'oro che non era, non è nell'inizio dell'età; semmai, nella forza del richiamo, "idillio c'è forse laddove/ non muore un uovo", nel macello pasquale la metafora e la contraddizione di un precipizio in cui la vita non cede a rinascite. Nella osservazione del cielo cui ritorna nella passione di una terra disattesa, il panico di spazio, l'ansia nel Dio che "spiana spume, che smista aria nera", rivela nel disegno delle galassie, tra fobie e amnesie, "in un che di familiare e alienante" i tratti di un feto gigante (vedi "Il bambino astrale") sollevando la riflessione se non sia proprio un bambino capriccioso invece a giocare"combinando/ gli universi vibranti il bene e il male". A proposito dell'infanzia nella costanza di un tema mai slegato da quello animale (di cui i carissimi gatti sono i maestri) in quell'essenza purissima che li fa "custodi d'assoluto" la ferma possibilità di poter scrutare forse nelle "curve aghiformi dei sempreverdi", nel "bel caso superiore" delle nuvole, il "fiore/mai uguale" dell'anello che presiede e tiene tra "granelli di luce e frante sfere", tra le crepe e i suoni delle spighe. Intanto però, nella dissonanza, lo sforzo nell'amore espanso è restare insieme proprio a partire dalla comprensione del proprio male, delle proprie endemiche crepe, trasparendo come il papavero dell'omonima poesia (probabilmente la più riuscita del libro) che "contento e in disparte e senza lutto" sa il proprio "breve fiorire bello a maggio" nella "fessura/ del cemento". Per quanto riguarda l'aspetto metrico-prosodico non possiamo infine che convenire con Carlangelo Mauro che nella postfazione ricorda come Velotti sappia ravvivare "la struttura stereotipata del sonetto classico con una buona varietà di ritmi scanditi da poche pause in un continuum musicale di sinalefi e sineresi anche in deroghe a norme classiche". Musicalità aggiungiamo noi accompagnata da una gioiosa dolenza che si rivela come uno dei punti cardine di una poetica tagliente, di una scrittura sempre viva forse "per gioco e per donare amore".
Id: 1100 Data: 13/04/2018 12:00:00
*
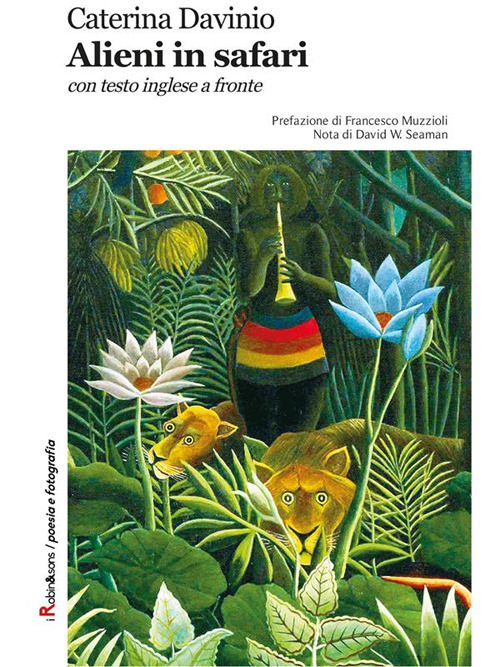 Caterina Davinio - Poesia - Robin Edizioni
Caterina Davinio - Poesia - Robin Edizioni
Alieni in safari
L'ultimo libro di Caterina Davinio, autrice multisemica di cui più volte abbiamo avuto modo di scrivere, raccoglie testi (con versione inglese a fronte di David W. Seaman) ispirati da diversi viaggi in Africa, Sud America e Asia, India soprattutto. La lente, ora ravvicinata nei piccoli e grandi grumi di una umanità sofferente ma disperatamente e gioiosamente viva ora nella dilatazione come dallo spazio nello sguardo che la trascende, ci restituisce nella sua partecipata e interrogata prossimità di attraversamento tutta la coscienza di una cultura, la nostra, sovente ferma, incapace di risolversi nello scarto di domanda di un'alterità non bloccata, non chiusa nel possesso e nel giudizio del tempo. Gli incontri, le immagini (corredate tra l'altro all'interno da bellissime foto della stessa autrice) insieme statiche e velocissime di distese e di interni, come da ipnosi, con tutte le commistioni di ferinità e di festoso brulichio di lacerazioni e sensi che si accorpano quasi in abbaglio al viaggiatore, rivelano allora nella visione una dimensione dimenticata, non contemplata, soprattutto (come giustamente la definisce Francesco Muzzioli nella prefazione) non determinata, non antropocentrica del mondo. L'apprendimento dunque a cui si guida e ci guida è quello della donna, e del poeta, nel riflesso della propria stessa alterità, del proprio essere alieno e straniero che il luogo, il cuore altro ci rivela nello spaesamento e nel "safari", intendendo la Davinio con questo la disposizione a cogliere e a esser colti dalle "tangibilità sfuggenti", dagli scatti illuminanti di una boscaglia, di regioni inesplorate che ci osservano appunto "da una pericolosa prossimità, diffondendo la loro vastità luminosa, sfolgorante, e oscuri segnali". Un testo tra gli altri ce lo conferma e annuncia , muovendo non a caso dal mondo animale, in quel piccione "padrone del rasoterra" , creatura sorella che ruspando nel "sudicio selciato grigio" scruta le anime degli altri per incontrare le proprie. Qui, nell'India, nella sacralità delle forme che si fondono e passano nel defluire quasi divertito delle ombre e degli ultimi - dove la stessa morte nella pulizia e nel sacramento ha simbologia nell'onnipotenza del fiume che scorrendo sussurra risvegli- l'anima bianca ("quell'animella/ da niente/ desiderosa di stare al mondo,/ di rallegrarsi al senso/ di una lunghissima fine") è colpita, sembra perdersi, scossa nel tramestio del suo moltiplicarsi in un precario equilibrio. Trance dunque nella muta "evanescenza/ rarefazione", "nella sapienza ermetica del nulla" che chiama alla scoperta e che in Africa di contro smuove dall'immobilità di una capanna (come dal ventre di "un gigantesco insetto") a sentirsi finalmente Terra ("il nostro/pianeta/festoso") nella scaglia d'oro della corrente, nella direzione di tutti gli orizzonti. Nel continente nero, "luogo profondo/ di labirinto e di fiumi/ e radici annodate", nel rosso della terra come sola traccia certa, sono così i profili nobili di visioni veloci e aleggiate più che concrete nell'aria e nel caldo (di ghepardi, di elefantesse,) a interrogare sullo stato dell'essere, a dire (nella vicinanza e nella condivisione di un "dio/ carezzevole/e spossato/nei tramonti") una possanza e una contemplazione preistorica come di iguana che si offre nella dolcezza di un frutto che assommando tutti i tempi li riporta indietro, incurante "diamante/sull'anello del cosmo". "Uragano segreto" ancora di un tempo nella linea dell'equatore "racchiuso tutto nell'istante" a cui il poeta (molecola che non sa l'universo) nella coscienza in formazione andrà chiedendo pietà di parola nel pianto, nella dignità di vita, nella malattia di felicità da cui è preso di contro all'illegittimo sfrecciare nella terra degli altri, in quel click di caccia di un invasamento che non si risparmia. Luce e non inferno dunque, che si leva piuttosto nella seconda sezione in cui attraversando in più punti il nostro paese (il Salento degli avi, Monza nel suo autodromo, Roma, Lecco) ci restituisce la cartolina in fiamme di una penisola nella simbologia di una terra che vista dall'alto piuttosto appare quieta, senza divisioni (i precari, i disagiati, gli ultimi, piccoli, semplici "punti verdi nel blu"). Italia allora a cui rivolgersi augurando nell'intensa lettera in occasione del "Centocinquantesimo Anno dell'Unità", di imparare come dallo spazio a distinguere, a non ammalare "la speranza/col ghigno" (sull'esempio tra gli altri del giudice Antonino Caponetto ricordato poco prima). Considerazioni queste che si accostano a quelle dell'astronauta de "Il Pianeta" che avanzando verso il "nero stellato" dell'ignoto si strugge pensando alla bellezza per l'incapacità dell'uomo, "batterio tenace" che ammala e distrugge. Nei testi finali tra il Brasile e l'India il viaggio però riprende, insaziato, nella consegna della conferma della vita proprio come movimento, come semina d'abbondanza che viene dallo scorrere, "segno dell'amore universale" nella "parvenza del sereno nulla", illuminazione del valico nel niente ormai del bisogno che trova finalmente nell'Om la sua formula e suono: "danza di atomi/o prima variazione di luce/tu hai nome di molti dei,/fine del racconto/ e delle visioni,/ del viaggio, / gioioso silenzio".
Id: 1095 Data: 23/03/2018 12:00:00
*
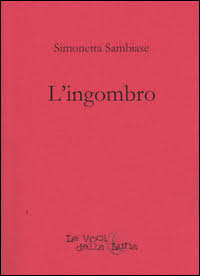 Simonetta Sambiase - Poesia - Le Voci della Luna
Simonetta Sambiase - Poesia - Le Voci della Luna
L’ingombro
Subìta e portata in un carico che va perdendo di senso, la vita un ingombro o noi un ingombro alla vita alla vita più non rispondendo? Nella piena di questa interrogazione tutta la riflessione critica di donna prima che di autrice di Simonetta Sambiase, operatrice culturale di Reggio Emilia al suo quinto libro di versi (vincitore del Premio Renato Giorgi de "Le Voci della Luna" che così l'ha editato). C'è una spina infatti negli uomini e nelle donne che fuoriescono da queste pagine, dalle piazze e dai margini di campi e stanze, che sembra interromperne il tempo nella consegna delle crepe, nel "ghiaccio sottile" di città e periferie anonime, di cuori fermi in una disintegrazione (come giustamente la definisce Maria Luisa Vezzali nella prefazione) che nell'assenza di un racconto e di una politica adeguata si fagocita nel rancore. Ecco allora in una temperie di reticenze -e di ipocrite indifferenze- l'alimento del timore tra residenze difficili e nuove provenienze, la violenza (maschile evidentemente) che si ripropone tra le generazioni in una sopraffazione che non fa differenza tra corpi delle donne e paesi. Ecco, soprattutto, la lotta contro una morte che si affaccia spesso a ricordarci quanto invecchiamo male, a partire come detto dalle comunità, dai luoghi urbani, nell'ingombro appunto di dinamiche e sentimenti che non si spiegano se non nella velocità delle cancellazioni, di identità trascorse e senza lingua, di solitudini allora nell'inganno dei trucchi e degli incontri in cui il sacro stesso rischia di perdersi nel sapore di una rassegnata rabbia ("Riposaci in pace nei tuoi miseri,/o dolce Signora"). E allora la parola che ancora può dirsi si risolve nel riflesso spezzato di una lirica che si attorciglia nelle immagini delle proprie evocazioni, delle continue ora accoglienti ora respingenti personali risonanze (secondo una prolissità come "correlativo linguistico dell'ingombro"come direbbe ancora la Vezzali), nel sospiro, nel sorso sovente amaro di versi che tentano nel corpo a corpo d'andamento prosastico che li guida quella dicitura che li rompa e con noi, con lei ci liberi da quell'impasse di malia che non ci spiega se non nel vacuo sopravvivere di mortificate passioni. Così non può non assumere un che di etico per la spinta morale che la incalza questa scrittura profondamente incarnata nelle figure di una meditazione ogni giorno alla prova di un mondo che la supera non muovendosi più su domande e dinamiche consuete. Nel disconoscimento, tutti "sperduti con la qualità della stessa fame", resta aggrappata alla terra, a dirla anche "in dialetto/ così da ricordare dove siamo", a spiegarla al figlio (o almeno a provarci) nella macchina di male "che gli si muove attorno" spesso nascosto dietro chi dovrebbe proteggerci. Perché in realtà (si veda il bellissimo testo dedicato al poeta palestinese Ashraff Fayadh) gli ultimi, i martiri, noi stessi nell'ottundimento dei nostri stessi demoni sono "la noia di questa cultura" e solo tagliarsi negli altri, può renderci, rendere onore nell'amore all'unico corpo cui siamo chiamati. Eppure, a proposito di demoni e d'amore, è nel rovello di un presente nel passato che non cancella i suoi fantasmi, che li ripropone entro nuove e insopprimibili vesti il graffo invisibile di un ingombro che va a dispiegare un secondo tempo del libro per scrittura forse anche più suggestivo perché più personale. Il riflettore infatti volgendo su se stessa riporta tutta la fatica di una donna "spaziente e stanca", seppure come da carattere nell'indice di una prossimità viva, "madre della compassione e dell'insoddisfazione" nel privato di un amore e di una casa come terra d'esilio, pronta a mordere la verità di un amore affannato ("Ho peccato di te/ che chiami casa questa patria d'ombre"). Di qui la riflessione, che si allarga a un femminile violato nelle sue aspirazioni (il matrimonio anche come fonte di sofferenza nell'atrocità dei silenzi), che si impone nel solco di una fioritura che si può rivelare piuttosto un abbassarsi di fronde di terra che reclama la sua acqua ("forse sono le mie catene che si preparano alla guerra"). Nel dubbio che ritorna nel conto del passato si impongono allora, in un discorso che probabilmente però vale per tutti, le immagini degli errori che stampandosi addosso ci accompagnano riflettendosi nelle stanze e ovunque, al di fuori, nelle strade e nelle piazze. E che nella Sambiase un occhio ancora ben vivo va a scuotere nella posa di giovani donne e giovani uomini nei naturali riti di incontri, di passioni pronte a dirsi nella freschezza di sensi ed anima ma che pure non risarcisce se è vero che nella colpa, e nella mancanza di perdono, il cuore nella sua trappola rischia la secca, o quantomeno l'insonnia così presente in questa poesia dentro notti dense di spiriti e voci dal pozzo di favole che più non sono. Nell' ironia e nell'attaccamento a un'esistenza che non fa sconti il tempo appare dunque sospeso tra un desiderio di vincersi verso i "verbi nuovi" che affacciandosi agli occhi chiamano a rompere ancora nel bene dell' amore l'ambiguità delle ripetizioni ( e "gli occhi chiamano spesso a voce alta") e la tentazione contraria nel "millennio di inutili anni" (in una vita che più non è la stessa nel vuoto del ciclone che ogni giorno ci attraversa) della consegna per sopravvivenza al "fracasso/ai difetti" di un moderno che più non ci contempla. La coscienza ci appare dunque, in conclusione, l'ingombro, la guida vera di questo dettato coinvolgente, senza infingimenti e nel pieno sempre di un'interrogazione che non affretta i passi ben salda nella consapevolezza che solo nel dar luce al proprio ascolto l'uomo può sollevare se stesso.
Id: 1089 Data: 09/03/2018 12:00:00
*
 Nisida Bortone Frainetti - Poesia - Youcanprint
Nisida Bortone Frainetti - Poesia - Youcanprint
Ancora una volta
Intensa e coinvolgente per prossimità e partecipazione alle disunità del mondo nelle ferite delle sue solitudini e delle sue scelte questa seconda prova poetica della Bortone Frainetti, insegnante d'inglese di Terracina. La crepa, il punto d'osservazione nel bene primario della famiglia, nucleo nel quale l'orizzonte personale a seconda del modello e dell'impronta può compiersi e manifestarsi al di fuori o cadere. Così nella struttura delle tre sezioni nelle quali è diviso il testo, la narrazione prende spunto dalla memoria dei propri nonni e genitori nella costruzione di un amore provato da fatiche e guerre, attese e pudori, nella ritualità di incontri vegliati, custoditi, sovente testati dalla storia. Ed allora l'apprendimento quotidiano dello stare insieme e del parteciparsi nell'educazione al rispetto e allo sguardo insieme stretto all'essenziale al buon vivere e allargato alla sua condivisione (ché nessuno è solo, nessuna famiglia è- o dovrebbe essere- mai sola) diventa luce di una sacralità incarnata da perseguire e moltiplicare nell'offerta di una terra che nessun seme vuole perdere ("ogni chicco merita attenzione e cura" ci dice; se cade a terra può esser schiacciato e cedere alla malia del sangue). Ed allora più che un omaggio alla propria famiglia questo bel libro ci appare, nello specchio che attraversa il secolo scorso fino ai riflessi e alle incrinature dei nostri giorni, l'appello a un tempo nelle sue radici a illuminare ancora nel mistero, senza disperdersi, "l'argine della strada". Lo strumento, gli strumenti come detto sono entro un'esistenza di coinvolgimento e di presenze a dirsi nell'affermazione dell'altro, dove la stessa infanzia nel calore e nella semplicità degli interni evocati viene colta nella crescita entro un "amare senza chiedere pegno", allevata ad uno sguardo di misericordia (anche verso se stessi) nella pazienza di un'esistenza che non manca di chiedere prove (e di cui l'uomo saggio sa le misure- "a volte dobbiamo dimenticare per vivere"). La comunità riunita nella letizia e negli affanni, sempre nell'intreccio con amici, vicini e figure care è dunque il lascito affidato ad una parola (là appresa) che proprio dalla memoria sa attingere nelle sue evocazioni per dare carne "al desiderio/ di dare alla storia un corso nuovo,/ fatto di comprensione, fatto di dialogo,/offrire alla pace un'opportunità concreta". Parole queste che non a caso prendiamo a prestito da un testo dedicato allo sbarco sulla luna, la terra piuttosto- la nostra terra- sempre presente nei suoi occhi come il suolo più difficile da raggiungere e ben perseguire. Naturale dunque nel proseguo, in età adulta, da educatrice e da donna che si lascia coinvolgere, l'attenzione estrema all'altro nell'esplosione di quei piccoli e grandi mondi che sovente proprio nelle distorsioni della famiglia trovano motivo e perdita- questo infatti restando, e non potrebbe essere diversamente, il punto d'osservazione. Ecco allora tutta questa schiera di ragazzi dolenti, di uomini e donne sole nel margine terminale di se stessi tra rifiuti e abbandoni, nel silenzio di un'esistenza- e di un indifferenza- che volta le spalle e che la Bortone Frainetti sa ben riportare nella spina di una ferita, quella propria di ognuno, che dall'intimo della carne reclama quantomeno cittadinanza, il riscatto del ricordo. Il tutto nella tecnica cui si affida l'autrice, o così almeno ci pare nella ricchezza dei riferimenti, grazie alla grande lezione di tanta poesia inglese - e irlandese (su tutti l'amato Patrick Kavanagh)- dando luce nella trasfigurazione anche da un piccolo ritaglio a quel luogo dell'abisso cui ognuno nella cattività del suo demone rischia di volgere. Echi allora dalla Bibbia e da antiche leggende si fondono alle urgenze di un'era che va affondando, ancora e sempre tra l'avidità di mammona e la cieca violenza di un mondo che non ha altro modo per riproporsi, le donne sempre le prime a cadere ma sempre le prime con gli ultimi (e qui ce ne sono tanti) ad abbracciarlo e a sostenerlo però a fronte di una società e di una politica che procede per separazioni. Una parola quindi che si risolve nella fedeltà all'imprinting da cui nasce, la famiglia, per volgere allo splendore dell'unicità cui rammenta nell'essenzialità del dettato lo sforzo necessario, il dovere nel reciproco sostegno (e che i versi dello stesso Kavanagh in esergo puntualizzano: "Dobbiamo registrare il mistero dell'amore senza parole inutili,/Sottrarre le passioni al tempo prima che sia troppo tardi"). Perché è un discorso sulla bellezza questo lungo discorso su noi stessi, nel suo bisogno di cura e costante attenzione nella consapevolezza comunque di come ogni volta si debba ripartire dai giovani, dalle loro aspettative come anche dai loro pericoli (non dimentichiamo che è un'insegnante). In conclusione un testo riuscito che non ha cedimenti ma che anzi nutrendosi continuamente di se stesso continuamente si ripropone nel circuito di interrogazioni cui il lettore è costretto. Una cosa sola aggiungeremmo a proposito dell'edizione. È bene sempre mettere qualche riga di riferimento biobibliografico, e al libro, in aiuto al lettore. Non ha grande senso, non è necessaria inoltre in copertina la dicitura "poesia narrativa". Si tratta semplicemente di poesia con andamento prosastico, tra l'altro ben compiuta.
Id: 1086 Data: 02/02/2018 12:00:00
*
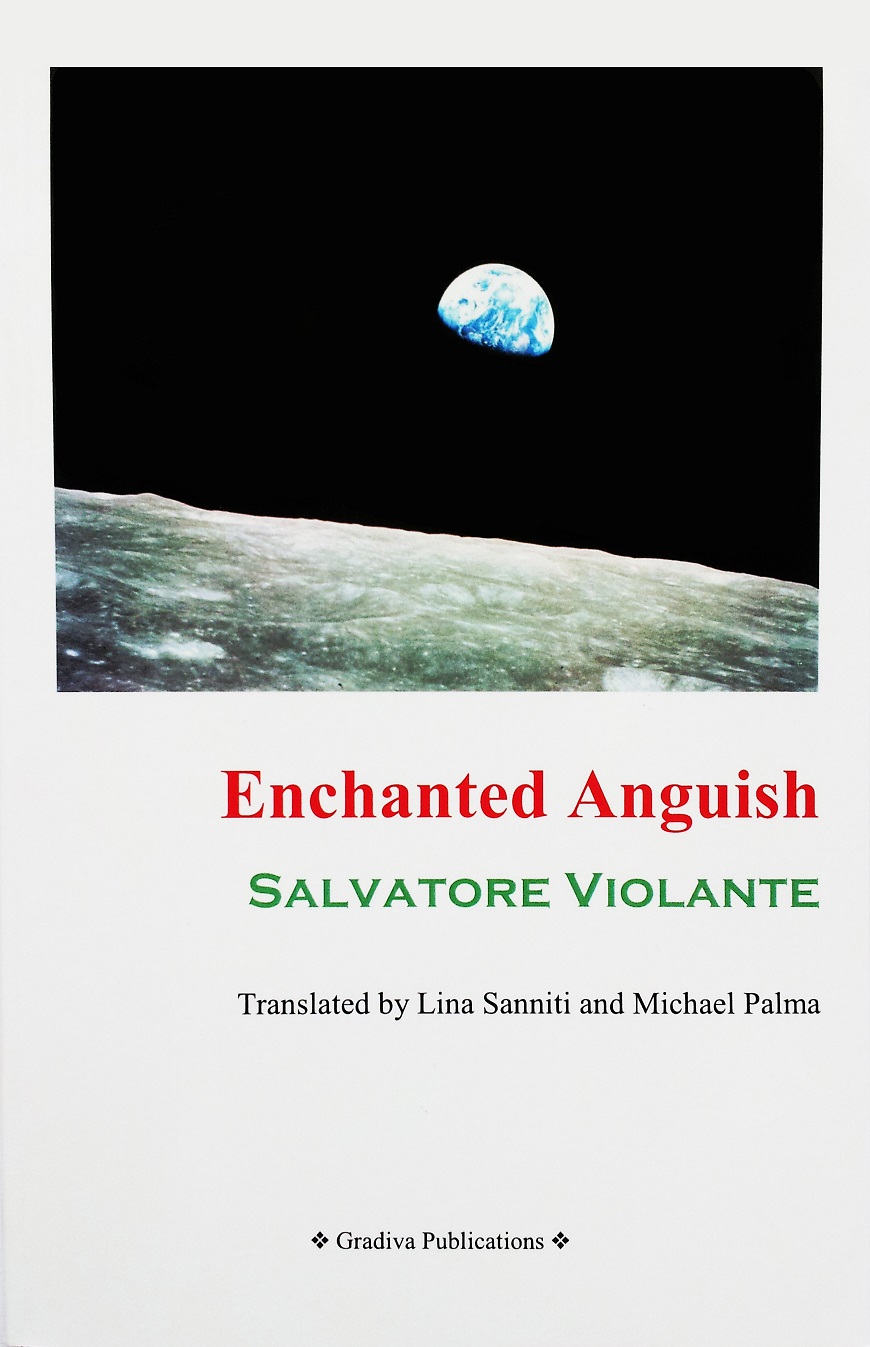 Salvatore Violante - Poesia - Gradiva Publications
Salvatore Violante - Poesia - Gradiva Publications
Enchanted Anguish
"Noi che vivi siamo, lo siamo per la morte": in quest'assunto è racchiuso il dettato d'occasione e di rabbia dell'ultimo lavoro di Salvatore Violante, autore alla sesta pubblicazione in versi (nella veste bilingue italo-inglese della Gradiva Publications per la traduzione di Lina Sanniti e Michael Palma). Nel tono offeso di una parola che procede per cantabilità irridenti e amare ecco infatti tutta la dolenza di una terra nella gramigna di un umano nel male che lo oscura, di un mondo che sembra avanzare per estinzioni nel Nulla di un universo, di un creato nei tempi diversi dei suoi elementi. È un dolore allora di un orizzonte perso, di una vecchiaia in cui l'uomo vive come per sorte nel rimando di un fuoco che poco riscalda; di una sacralità ferita per cui si reclama perdono e "che rende più soli chi solo è da sempre" (vedi "Natale sporco"), come i migranti sputati dal mare o le prostituzioni di "occhi lontani, di lontani stenti". Eppure proprio nell'affanno della rincorsa, nella consapevolezza del colpo a perdere come da schianto, ecco la fede che è anche della parola in quel "bene riposto/nel fondo d'un'eco" che dice di noi, della vita stessa nello "spazio supposto" la pienezza e la dignità della sua trasmissione. Nella nobiltà di una lingua che vuole imprimere un perseverante restare si spiega allora forse l'evocazione suscitata dal titolo, Angoscia In-canto, a promuovere più che il pianto, strozzato in gola il grido del pudore, il coraggio di aprirsi al mondo pur "con i suoi raggiri", della cura entro dimensioni e dinamiche di una bellezza comunque quotidianamente data (e come in un giardino verrebbe da dire da omonimo testo). Così convenendo con Wanda Marasco che in una delle note introduttive (l'altra è di Marcello Carlino) parla di "poesia di emergenza e di rovesciamento" come laboratorio "per contrastare il morire e l'esclusione", è bene nell'apertura ricordare anche come accennato quella trama cantabile già sottolineata proprio da Carlino in cui nel gioco sovente delle rime baciate e delle ripetute assonanze Violante celebra la vita tra ricordi di amici e di affetti antichi, di sensualità divertita che danno tra tanta oscurità un getto di azzurra luminosità a rammentare, contro la parola "sorda e cieca" che "nella notte affonda", quel "limite di-verso" che per vicinanza è proprio della scrittura poetica. Memoria allora di saper andare, come i poeti, controcorrente tra le ombre che disorientano il cammino perché si può solo per intercessione, muovendosi e adoperandosi per il mondo. Riattualizzazione continua dunque a non recedere dall'amore nel richiamo di un autore e di un testo di provato valore.
Id: 1083 Data: 19/01/2018 12:00:00
*
 Cinzia Marulli - Poesia - La Vita Felice
Cinzia Marulli - Poesia - La Vita Felice
Percorsi
Instancabile promotrice culturale e autrice di lunga data, si offre la romana Cinzia Marulli in questa sua terza prova nella tensione accesa di un io naturalmente, umanamente inquieto tra scioglimenti di ferite e perdite e insaziati, forse insaziabili desideri d'amore e di vita. Il senso allora è in un percorso come da titolo, nella frammentazione infinita dei percorsi, che sappia rinucleare le l'identità entro quella più vasta unità d'origine che ci trasforma e trascende, accompagnarla allora sulla via di un ritorno a cui siamo indirizzati e chiamati. Così sapientemente chiara la parola nella sua evocazione in un intento da subito svelato, giacché è proprio nel rimemorare il ritorno l'orizzonte scritto della poesia (nell'andare è tutto un tornare cantava Campana) e matericamente viva nell'attraversamento arido dei deserti nella desolazione corporale e d'anima di un tempo che si pensa- si sa nelle sue finzioni- fermo. Ed allora ha un che di orientale questa disposizione dei movimenti, questa continua dilatazione di metamorfosi a vincere le insane staticità delle febbri, questa narrazione di elementi che si sciolgono e si cercano in quel germoglio paziente della terra che dal basso sapendosi piegare svela del cielo il senso obliquo, il tempo nel suo primo giorno ancora intatto. Il piccolo sembra sorreggere il mondo in questa poesia (si legga non a caso "Non sono questi alberi immensi a cui tende il pensiero"), riportarlo alla sua fertilità di spiga da suolo finalmente umido e gravido per attesa e cura, per custodia. Un mondo di cui pertanto la Marulli sa illuminare le fratture partendo dalle separazioni e le solitudini di un femminile sempre in equidistanza tra l'amore e l'offesa degli esseri, quasi a tenere stretto a ricucire quel filo, quell'erba che rompe, vive tra le crepe. Ed allora non sorprende il timbro etico e civile di un dettato che non sottrae alla memoria cancellazioni passate e presenti (la shoah, Gaza, la terribile pratica dell'infibulazione) a dire una storia cui ognuno è chiamato nell'azione a pronunciarsi. Infatti la fede che muove il percorso è nella gioia e nella fatica della condivisione dell'amore, dentro "l'amore a doppio senso, l'amore in ogni senso", a vincere la distanza tra spazi di dolore e indifferenze, il margine del tempo aldilà d'ogni retorica come luogo dell'abbraccio ("il peso del mondo/l'assurdo peso di tanta pietra" gravando "solo su una poverissima corona di spine"). Conveniamo con Jean Portante allora che nella sua bella prefazione parla di poesia esistenziale (e non esistenzialista) nel movimento duplice di ascensione al cielo e di radice nella terra, ed in cui il morire stesso è iscritto nella sacrificale rinascita. E proprio sul tema della morte, unito a quello dell'oscurità, sono incentrati i testi della terza e ultima sezione, Il riflesso della luce, nell'interrogazione di un mistero che è nella stessa fine, nel folle pensiero di una luce che "avanza come l'esercito di terracotta- nel tempo", di là finalmente detersa l'anima con parole che si faranno e la faranno preghiera- e germoglio nell'erba come nella poesia finale dedicata al padre. In conclusione, a nostro dire, una tappa non banale di un autrice col senso prezioso dell'esistere cui difetta- ma solo in parte- certa dispersione del dettato in un eccesso prosastico del verso che toglie forza ad una parola che necessita e chiede peso.
Id: 1078 Data: 29/12/2017 12:00:00
*
 AaVV - Rivista - Edizioni del Laboratorio
AaVV - Rivista - Edizioni del Laboratorio
Steve n. 47
Rivista de "Il laboratorio di poesia", Associazione Culturale di promozione sociale modenese che dal 1979 "opera, senza fini di lucro, per la produzione e la conoscenza della poesia ", anche in questo numero Steve si offre nella nutrita corposità della propria ricerca che già dall'editoriale del direttore Carlo Alberto Sitta si conferma nell'attenzione ai segnali, o per meglio dire al mancato annunciarsi all'interno della scena poetica degli ultimi decenni del secolo scorso di segnali che in qualche modo concretamente annunciassero , introducessero al nuovo in arrivo. Nella scrupolosa analisi Sitta, a fronte di uno stillicidio di autori alla prova dei fatti mancanti nelle promesse alte dei rimandi e dei propositi (e purtroppo poi facenti scuola), impone a un presupposto anti-storico la cancellazione di ogni alterità di scrittura. "Viene da pensare- scrive- che non sia esistito, a chiusura, del Novecento, il male del secolo. Come se l'arte e la poesia avessero pattuito un armistizio con il dolore, individuale e collettivo" (incarnato piuttosto da diversi autori che proprio su Steve negli anni sono stati ricordati- tra gli altri Pasolini, Emilio Villa, Amelia Rosselli, Antonio Delfini). Gli anni ottanta e novanta si denotano allora a suo dire senza aperture a rinnovamenti formali nel mentre di un orizzonte che si preannuncia entro una sostanziale "omogeneità trasversale delle parlate tra l'Italia, l'Europa e i continenti" (ed in cui le stesse voci provenienti da aree lontane vengono "assimilate, fatte in casa e non escono dalla monocultura universale"). Nel perché dell'editoriale dunque è necessario dare un'altra lettura di quegli anni cercando di esprimere più che nomi il timbro, "l'aura" di quell'epoca, anche se poi Sitta un nome, in alcuni titoli esemplari lo dà ed è quello di Giorgio Caproni: i libri Il franco cacciatore e Il conte di Kevenhuller, considerando (a parte qualche plauso di prammatica) ancora oggi le poche sottolineature meritate. Che sono soprattutto nella partitura musicale delle composizioni unite alle centralità delle domande nella "solitudine dell'uomo di fronte a se stesso e al mondo, il vuoto di senso metafisico, il Dio che si assenta sotto gli occhi di chi lo cerca". Andando a concludere Sitta invita ad affrontare seriamente le dinamiche poetiche di quel periodo anche perché "una fine di secolo è tale quando informa il nuovo prima ancora che arrivi". Riflettendo sulla questione nell'intervento a seguire Elio Grasso, dopo aver fatto i nomi dello stesso Sitta e di Alberto Cappi e Nanni Cagnone riguardo i libri su cui il futuro allora sembrava poggiarsi, vede il difetto in certo asettico minimalismo di fronte alla complessità del mondo, in un dettato trascurato e senza interrogazioni quindi e privo di un dialogo con una tradizione poco conosciuta- senza contare tra l'altro anche la mancata crescita di nuove figure critiche di rilievo. Molto interessanti appaiono poi le pagine successive dedicate alla figura dello scrittore e politico croato Vlado Gotovac in occasione dell'uscita nel 2015 nel nostro paese, per le stesse Edizioni del laboratorio, del volume di aforismi Peste stellare/Poetica dell'anima (per la cura di Mladen Machiedo) in cui sono raccolti e antologizzati frammenti poetici di oltre quarant'anni. Un autore e una figura (perseguitata e incarcerata sotto Tito e- seppur riabilitata poi- accusata di tradimento dalla stessa Zagabria) ancora non conosciuta a dovere in ambito europeo e che Tonko Maroevic (richiamando ed evidenziando i caratteri di autorevolezza di autore e uomo "nell'apologia della libertà e nell'affermazione dell'unicità e particolarità dell'esistente") e Chiara Martinoli invece aiutano a comprendere meglio. Il quadro che ci viene presentato è quello del "valore autenticamente europeo" del suo messaggio -nel riavvicinamento nel divario tra est ed ovest europeo anche (lui nato in Croazia e morto a Roma)- entro un'opera che in realtà non parla solo della propria vicenda personale ma va a racchiudere " nel suo mondo di parole e pensieri l'intero arco di un cinquantennio di storia" ed in cui il mito del pensatore recluso, insieme vittima politica ed eroe di un mito sovrannazionale, lo avvicina a figure molto simili alle nostre come Pelllico e Gramsci (la Martinoli). Maroevic inoltre sottolineando nell'opera di traduzione di Machiedo la gratitudine verso Gotovac per l' attivismo etico e civile (il "coraggio nel subire la violenza del potere", la "tolleranza e comprensione indispensabili nel periodo del dopoguerra") evidenzia di Gotovac il caso stesso all'interno degli scrittori dell'est europeo condannati alla reclusione. La poca conoscenza internazionale del suo lavoro sta infatti anche nel limite autoimposto del frammento, del motto, della sentenza di contro alle analisi metodiche del terrore statale o testimonianze del martirio di altri. Esatto compendio è anche l'intervento di Alessandra Paganardi sul testo nella relazione con il lavoro d'aforismi di Cesare Viviani rilevando una certa vicinanza- seppur nelle distanze non solo geografiche che li dividono- nel senso del limite. Che in loro si incontra "nel comune confronto con l'irriducibile" ed in cui una sostanziale rinuncia a sé, nel viaggio, può dar senso al viaggio stesso in un esperienza della poesia allora come esperienza della parola salvata nel cruna e nel racconto di questo limite. Seguono nelle altre sezioni della rivista una nota di lettura di Fosca Massucco al libro di versi di Angelo Maugeri Prove di impaginazione (Nuova Editrice Magenta, 2015) e del direttore una cronistoria, a partire dalla formazione, di Gian Pio Torricelli con l'aggiunta di alcune fotografie e tre testi poetici dell'artista e poeta modenese (membro del gruppo 63). Ricca poi, soprattutto, la serie di poesie presentate con brani di Mario Moroni, Miria Baccolini, Fosca Massucco, Laura Accerboni, della stessa Alessandra Paganardi e soprattutto, curiosamente, restando alla stretta attualità, di due autori catalani, Ramon Farrés e Cinta Massip (entrambi nella traduzione dal catalano di Antonello Borra). Del primo ricordiamo l'andamento sensuale e corposo del timbro, della seconda soprattutto la fulminante brevità di testi nella tensione degli avvicinamenti ("M'ancoro nei tuoi occhi/ e m'abbarbico, solo voce,/nel cerchio preciso/ del tuo sguardo"). Ed ancora- in versione d'autore- di Antonello Borra, di Mario Morone, di Giorgio Terrone e del croato Ante Stamac (nella traduzione di Mladen Machiedo) con scelte dall'intenso ciclo Tardiva stagione, sussurro di foglie cadute in cui la musicalità del verso ben si sposa con le materiche dissolvenze del pensiero. Quattro invece sono le recensioni ad opera di Sitta. Lacerti (GuaraldiLb 2015) di Miria Baccolini, Frammenti sparsi (Giuliano Ladolfi editore 2015) di Giusto Truglia, Al buio dei nodi anfratti (Book editore 2015) di Nina Nasilli e dell'attivissimo Borra Alphabetiere-alfabestiario (Ken Verlag 2015), versione bilingue italo-tedesca del "bestiario" uscito nel 2009 per Lietocolle (nel lavoro a doppie mani con la moglie Adriana Hosle) in cui sfilano animali più disparati tra ricchezza di simbologie culturali e loro presa di parola. Nel mezzo intanto un ricco scritto in inglese di Sitta dedicato alla rivista canadese Gronk corredato da numerose e interessanti foto di Alessandro Fornilli ("Carta straccia: l'epopea al ciclostile di Gronk"). Ed infine la sezione "Cronaca" che va a chiudere il numero con notizie sugli autori presentati.
Id: 1073 Data: 08/12/2017 12:00:00
*
 Cristina Sparagana - Poesia - L’ArgoLibro
Cristina Sparagana - Poesia - L’ArgoLibro
L’oscura controdanza
È un piacere poter scrivere di Cristina Sparagana e della sua poesia materica, corposa sempre rivelatoria e prossima nel nutrimento delle sue implorazioni. Autrice di rilievo altissimo, studiosa e traduttrice dallo spagnolo (ha insegnato per parecchi anni in Cile Letteratura italiana presso l'Università Cattolica di Valparaiso) la ritroviamo intatta nel canto in questi versi da un'alba ossessivamente evocata- e a tratti subita tra le insonnie e le malie della notte- e le spirali, le interruzioni del giorno nelle maglie di un male, un'interruzione diremmo ancora presente. C'è un dissidio infatti, una spina che non consente aderenza se non quella appunto di una oscura contraddanza, un movimento inverso entro una terra che ci sa sotto i colpi di una sterilità di luoghi e anime inferme. Il richiamo allora, l'evocazione a rompere l' oscurità ("tremenda moscacieca che colpisce alle spalle") ci pare allora sospeso fra gli spazi di una memoria di cari- così preziosi e ancora vivi nello scavo di una parola e di una corporeità ancora imprimente- e una quotidianità cantata nelle figure di una sotterranea mancanza, di una difficile e a tratti poco afferrabile genesi. La poesia allora diventa riappropriazione di luoghi e anima nel legame inquieto con una natura- ora non rispondente ora sensualmente orfica- cui non si chiede scioglimento ma rimessa e partecipata scrittura. Che è liturgia poi di uomini e donne, di madri soprattutto nella polvere e nella stasi di un tempo smosso da dimenticate angosce, da sentori di irricucibili distanze. Nell'umiltà di una disposizione ferita l'autrice si risolve nella dilatazione stessa del mistero, denso di annunci, di intagli,di soglie di smarrimento e liberazione, di incamminati abbandoni (ed infatti quanta meraviglia, quanta frattura nei testi dedicati alla figlia). E in particolare nella coralità degli spiriti -e delle pagine- indocili, è nell'elemento animale (uccelli ma anche cani, volpi, diciture di rettili) insieme a quello dei bambini (composti entrambi "di groviglio e di tenebra, gentili") l'illuminato eternarsi di un crepuscolo che nel suo ritorno- non nell'affondo- sa sacralmente vincersi mostrando all'uomo (come di tartaruga nel suo continuo entrare e uscire dal guscio) il bene di una continua"nuova unione/con la terra remota". ("La bambola impastata di farina/ ha spinto nell'abisso i vostri morti" dice ancora in un potentissimo verso). Così è proprio nel partecipato dissidio delle paralisi il rovesciamento stesso delle ombre, l'apertura dilatante di una notte, di una tenebra come "la grande,/la paziente nutrice" (in un dettato che via via assume nei suoi contorni anche quelli dell'incantesimo- o della sua rottura- del vago esorcismo). Il tutto poi nel supporto di una lingua forte, coraggiosamente salda a se stessa e di cui a ragione Paolo Carlucci nella puntualità dell'introduzione ricorda il "cromatismo verbale, visionario e profondo, d'altri tempi, archetipo d'alba pre-logica, densa, poematica, voce di natura abrasa e poetante". E di cui oltre alle chiare ascendenze rilkiane e pastosità latino americane tra le altre (Plinio Perilli al proposito ha sottolineato movimenti cari a Montale) ci pare anche di scorgere riferimenti, passaggi vicini ai crepuscolari in una singolarissima rivisitazione ( si veda ad esempio, tra campane all'alba e frinire di croci, quell'intensissima definizione della Domenica come "grande/ Messaggera dei morti"). Così, dicevamo, come il gheppio anche lei nella "immensa partitura del giubilo", ferma e in piedi come tutti i poeti , "alza la sua preghiera": giacché morte vera è dove non è veglia, dove non custodia. Ed è questa proprietà, infine, questa definizione stessa della vita il valore di un libro e di un'autrice a noi sempre cara.
Id: 1070 Data: 27/10/2017 12:00:00
*
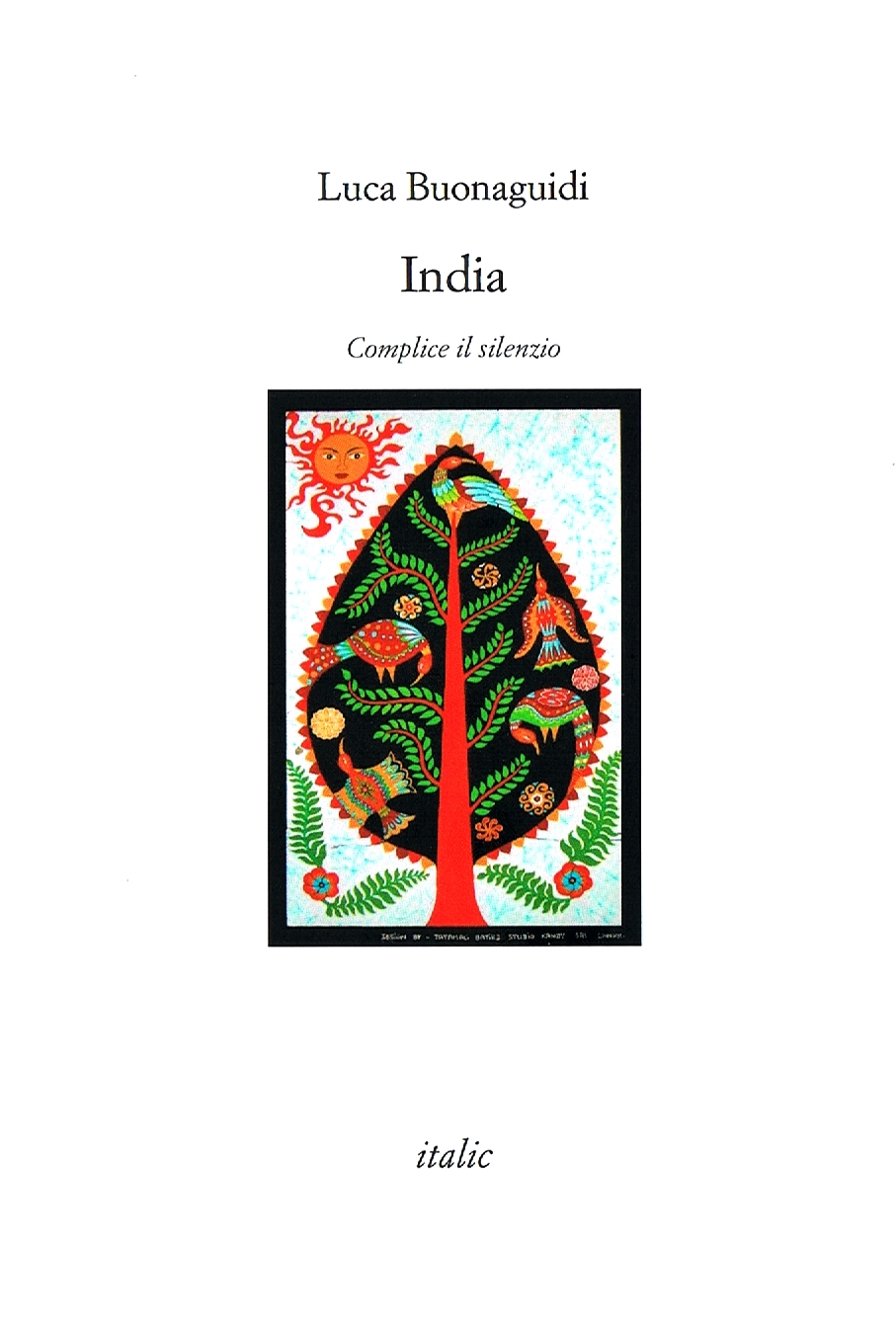 Luca Buonaguidi - Poesia - Italic
Luca Buonaguidi - Poesia - Italic
India
Curioso e a suo modo prezioso questo libricino di Luca Buonaguidi poliedrico trentenne toscano al suo terzo volume di versi (scrive anche di letteratura, musica e cinema). Frutto di un percorso durato cinque mesi attraverso India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Tibet e Kashmire ci appare come un diario di viaggio in cui l'esperienza che ne deriva, nella trasformazione della persona e della poetica, ha il valore di una testimonianza spirituale come Bonaguidi stesso ricorda nell'introduzione nel riferimento a Moravia proprio a proposito dell'India. Corredato da foto personali (profondamente liriche e pertinenti per la comprensione del senso come nella lettera a fine testo son definite da Giulia Niccolai) e accompagnato nella scansione dell'itinerario, che ovviamente non è solo meramente fisico, da diverse citazioni- alcune delle quali anche da testi sacri indù- ha in sé l'iscrizione di un sentirsi e sapersi scorrere nel sospetto di una irraggiungibilità che sempre muove e spinge altrove, di un vento (elemento base della propria dialettica) in cui il Dio che si annuncia- lo annuncia- e svanisce sembra procedere con lui tra le smentite e le baluginanti- forse illusorie?- pronunce del giorno. Tra staticità e movimento infatti, nella liricità di istanti ora nel riflesso di un silente silenzio ora rivelatori, l'apprendimento è, nel pensarsi, nella graduale distanza da sé, nel sorridente gioco di una poesia che si costruisce e cancella da sola grazie proprio al Dio senza il quale "non ha voce" per cui "oscilla, depone". L'India allora nel contrasto della sua fame e della sua povertà con l'India suggestiva e morbida dei suoi colori e dei suoi odori è occasione per "guardarsi da vicino"- nella sincerità di una tensione lontana da ogni debordante curiosità occidentale- e nella scoperta di un sé, nel passaggio, portato a morire ("Mi sento a casa/ e mi sento appena,/trovo pace in quest'assenza"). La mutazione è nel cambio di prospettiva, nella consapevolezza di un interrogazione "sul valore/ dell'azione e della rinuncia" che non ha risposta, l'apertura ad un'attesa che si lascia vivere dall'ombra là dove ha cuore la forma e il canto devozionale di uno spostamento che onorando l'abisso (nella complicità di un silenzio ora inteso come "distacco interno da tutte le cose", ora un risveglio "da questo sogno di separatezza" nei riferimenti a San Giovanni della Croce e alle Upanisad dell'introduzione) sappia suscitare nell'avvicinamento il saluto e il respiro dell'anima. Nella significativa immagine di salire sopra un treno in corsa e sedere (nel riflesso della citazione dall'Isa Upanisad: "Il Sé pare si muova, ma è sempre fermo") pare raccogliersi allora tutto lo slancio di un anima appunto nella costruzione del mandala, verrebbe da dire, nel richiamo in se stessa- "dove l'appoggio è sicuro" per il placare della sete. Nei passi che noi mettiamo a caso e "di cui Dio sa tutto"- lui il padre della poesia, nella poesia il suo ritorno nel soffio dei passaggi: "Ci rivedremo/ancora,/altrove"- la consapevolezza di una fiamma che deve imparare a tenere a mente la propria casa, il "campo sacro" che fisso è, ci attende (secondo la lezione da Hilde Domin) per parteciparci a uno sbocciare che non termina di compiersi. La lezione di questi versi ci appare quindi nella consegna, in un tutto di "dolore e dolcezza", nella mistica di una fanghiglia che ci accoglie non desti e incompleti nel fiorire di un continuo e instancabile mattino. Versi che si sciolgono come preziosi strumenti (oltre che belli ) secondo l'auspicio dell'autore, e per questo netti, essenziali:"Potrei aggiungere altri dettagli/ma la felicità sta nel toglierli".
Id: 1068 Data: 13/10/2017 12:00:00
*
 Fabrizio Bregoli - Poesia - Puntoacapo
Fabrizio Bregoli - Poesia - Puntoacapo
Il senso della neve
Non è nuova alla nostra attenzione la figura di Fabrizio Bregoli, quarantenne ingegnere della bassa bresciana, vincitore quest'anno per la sezione poesia inedita del premio "Il giardino di Babuk- Proust en Italie" (si legga sul sito al proposito l'intervista a lui dedicata). Opera prima riconosciuta dallo stesso autore dopo un paio di piccoli testi, "Il senso della neve" raccoglie in sé la forza di una poetica stretta tra "tradizione ed esigenze delle modernità" perfettamente riconoscibile nelle sue intenzioni nel racconto di un contemporaneo evanescente e ferito tra le insufficienze sociali, politiche e umane cui non la fede (certo non quella farisaicamente devozionale), non gli indirizzi della scienza sembrano sollevare. La poesia allora, entro uno sguardo sofferto e caustico, come contraltare al conformismo e all'arrendevolezza; la poesia (ai cui riferimenti espliciti ed evidenti di Fortini e Sereni ci sembra di poter aggiungere quello di Nelo Risi nell'ascrizione ad una lirica mai disgiunta da una interrogazione civile assai forte) come chiave di scasso nella rappresentazione delle "contraddizioni del presente". Il risultato, nella scansione delle sue cinque sezioni, è potentissimo e dolentissimo per sdegno, attraversamento e perdita entro valori di comunicazione, unità e direzione disgreganti e disgregati. I luoghi, asettici e respingenti, sono quelli dei nostri cuori e delle nostre menti nell'esplicazione quotidiana delle incombenze e degli incontri: uffici, raccordi, corridoi e interni di case annegate alla luce della ferita e del certo, che si negano all'ombra, al circolare della vita. Giacché questo è il tempo della scelta Bregoli ci ricorda ("lasciare illeso il gesso/(..)/o ripulirne il tratto"), tempo d'inverno cui l'indugio del pensiero (quello scrutare di là dalla finestra il mondo) richiede una "liturgia dell'assenso" che sappia ripartire proprio dalle disappartenenze non spezzando, non scorporando la vita ma riorientandola "sulla scala del minuscolo" (al contrario di un economia che non lo contempla). L'analogia è quella della scrittura poetica, di un equilibrio dato da un elemento minimo su cui "regge l'equilibrio di una frase", la punteggiatura d'anima nella "esatta curva del restare" e del "viverci". Eppure l'opera è per sfrondamento, non va giù facile, leggero, Fabrizio nella misura discorsiva del suo endecasillabo , nella sua pulizia come di stoviglia a rompere la balbuzie. Nell'abilità di una lingua che "nel quotidiano mappale dello smarrirsi", nel garbuglio di tecnicismi e fonosmembramenti non afferma conclusioni solo processi, ciò che permane aldilà di certo criptico oscuro sentore è il chiaro incidere di una parola che non s'affranca, di "distanza che si varca" nella grazia di un tempo ancora intero ("d'un pugno striminzito di farina/ che lievita nel buio, si fa pane") almeno nella ragione di un "integro vivere" ("Forse di rondine/quel palpitare a sprazzi fra le fronde/come annerito seme di superstite"). Ed allora quel senso di preservazione ("Scoprire/la chiave del durare in ciò che è breve/ lo spazio dove resta illeso il bianco/ allo svanire certo della neve") nell'istanza civile che lo guida si fa crinale tra un "inventario/ dello svanire" e il necessario sdipanamento della forza che preme dal basso, sfarinatura di quel "nucleo d'unità che ci affratella" a riprova di una sapienza di scrittura che sa decifrare il mondo nella sua struttura "secondo un codice linguistico nuovo, in grado di fissare la realtà scomponendola, quasi geometricamente, nelle sue fratture" (come acutamente evidenziato da Ivan Fedeli nella prefazione). E che riesce a nostro dire, nell'apprendimento libero della sua misura in riferimento ai suo più nobili modelli (dal realismo dantesco fino all'ironia cara a Montale ricordate sempre da Fedeli) a imporsi con originalità (anche per l'irato e ironico incedere del temperamento tra personali e collettive dolenze) tra le voci più interessanti dell'ultima scena poetica trovando il testo dignità più alta nella costanza dell'invito, soprattutto, a resistere alla luce esatta del sole, noi non esatti ("pane spezzato sull'aceto/ cilicio interminabile ed attesa"), l'amore, l'altro a restituirci reciproca "ragione, unità" là dove il male si annida nel dolore di un vuoto "che mai prende corpo/peso, identico a se stesso" e che ognuno nella ripetizione dell'apprendimento si trova a portare entro una "indifferenza ora voluta ora subita".
Id: 1063 Data: 08/09/2017 12:00:00
*
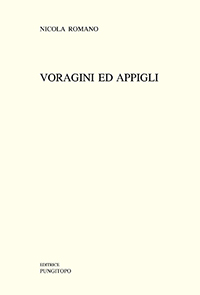 Nicola Romano - Poesia - Editrice Pungitopo
Nicola Romano - Poesia - Editrice Pungitopo
Voragini ed appigli
Autore autorevole, giornalista, con alle spalle un'esperienza pluridecennale in poesia (con alle spalle una dozzina circa di titoli dal lontano 1983) Nicola Romano in quest'ultimo lavoro cerca appunto un appiglio, perdonateci il gioco di parole ma è dovuto, tra le voragini e i vuoti di una contemporaneità cui la stessa poesia sconta una separatezza ormai definitiva entro una realtà senza appelli, senza voci e suoni che ancora potrebbero dirla, inciderla in un dialogo a ricucirne in qualche modo possibilità ed incontri. Eppure derive e infingimenti, istanze e logiche di cabotaggio e sentimenti vengono qui nella prova dello scioglimento interrogate alla luce aurorale, sempre, e autorevole di autori più o meno illustri della tradizione poetica italiana (dal novecento ad oggi) dalle cui citazioni in esergo in ogni brano Romano prende spunto (servendosene nell'impianto del discorso) nel gioco dei rimandi. Nella densità del dettato la scelta stilistica, riuscita, è nell'uso di un settenario agile, secco, funzionale nel saper "radunare al meglio le parole", nel loro ascolto nella consapevolezza dello spiazzamento di fronte al male del mondo. Il tono, "a metà tra il calligrafismo e la didascalia stilizzata" (come ricorda Giorgio Linguaglossa nella prefazione) va a rivelare verso dopo verso una dolenza di memorie nella deriva, di nostalgie e malinconie cui si tenta un qualche impossibile distacco- e rinascita forse- se non come ramo annodato e rimpattato al fusto "ed i suoi bracci in fiore" entro una via non prevedibile (e per questo destinata all'esclusione). Nella consapevolezza di una cronaca "ruffiana e ammiccante" che più che dire confonde la verità del tempo, di gioventù offesa, di aghi e polvere che restano sul volto e di una poesia ridotta a mero idolo di se stessa ("E i poeti non hanno più canti/ non un messaggio di gioia", nel riporto da Padre Turoldo) seguire i guadi, gli appunti e le tracce sembra la sola strada per non sviare e rimettere in chiaro ( nel mistero che "dal cielo bucato/(..)/ sgronda") "quella sequenza d'occhi/ smarrita fra le scale". L'arma, però nel rovesciamento è anche quella di una ironia come "strategia di sopravvivenza" verso il "reale" (ancora Linguaglossa soccorrendoci), come per venirne a patti nella distinzione delle distanze. E allo stesso tempo, aggiungiamo noi, per meglio illuminare nelle certezze ( la famiglia , l'eros, la casa stessa nelle sue memorie - seppure nel pericolo di una suggestione che può chiudere al mondo) le figure, i soloni "carichi di dottrina" di una realtà che appunto non più incarnando nega allo sguardo storie e dolori sottaciuti ("sicuri che sia il nostro/ cervello in esilio"). Il coraggio più grande è, resta la fedeltà a se stessi nelle lusinghe del quotidiano giacché ad altra libertà ci chiama l'anima "per godere in pace/il dono dei risvegli" nel solo tempo di una natura e di una Parola che unica "patisce e cede come/Elica quando cede il gelsomino" ("La ginestra alle scarpate"). Intanto però quel tempo e quella parola va custodita e per quanto dato raccontata nella cronaca di giorni che devastano e così ecco nel dire fulminante dell'Haikù i quaranta movimenti della seconda sezione ("Dimmi se hai Kuore- cronachette ferali") gli eventi grandi e piccoli, personali e della storia, riportati nel segno di una violenza, di una solitudine e di una indifferenza che non risparmia e dove l'andamento surreale e quasi canzonato assume il sapore indistinto dell'azzeramento. Nella raffinata ricchezza di una lingua e di una radice forte nel suo stare nel transito come "morto a galla" il lascito è dunque nella rimemorazione di un'offerta non più così ovvia:" "Diventa ricco/ di gesti e di parole/le tue monete", Romano forse rispondendo dapprima a se stesso nell'imperativo a quella interrogazione inseguita nel testo: "Ma quando torneremo/ al centro delle cose/ dentro quel solco antico/che luce diede al mondo?".
Id: 1054 Data: 18/08/2017 12:00:00
*
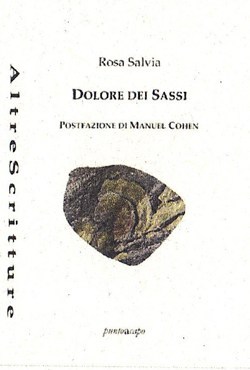 Rosa Salvia - Poesia - Puntoacapo
Rosa Salvia - Poesia - Puntoacapo
Dolore dei sassi
Dolore dei sassi come dolore della terra e della pietra, degli interni in cui affondiamo e di una natura della quale pur in sofferte aperture di condivisione avvertiamo, scontiamo una qualche- crescente- separazione. Questo ci sembra il cardine attorno a cui ruota l'intenso testo della Salvia, insegnante di storia e filosofia nel licei ed autrice ormai d'esperto cabotaggio. La coscienza arcaica della mortalità, di una condizione che non può sopravvivere alle sue stesse costruzioni, spirituali e morali, di abitazioni e chiese, ha l'eco nelle origini di una terra, quella lucana (anche se ormai la Salvia da tanti anni romana d'adozione) disseminante nelle sue tracce un apprendimento e uno sguardo tra le opacità e le zone d'ombra di un mistero entro cui è possibile procedere solo per interrogante affidamento. Questa dignità dell'umano è la lezione e il dono allora di una scrittura quotidianamente sottesa al filo di un incedere materno diremmo, nell'orfanità di una mancanza avvertita ora nel richiamo pungente di una voce e di una etica di una nascita (o ri-nascita) comune ora negli spegnimenti di riferimenti che ci rigettano. Sofferenze e ferite che di qui competono narrate secondo una diaristica di cammino che ha il suo incipit nel testo che dà titolo al libro, "Dolore dei sassi" appunto, che ha proprio nella morte di una bambina il grido alto di uno scalciare e di un mondo inascoltato nel suo bussare. Ed allora tutta la sequenza nell'incedere e nella posa della sepoltura, in cui le "stesse bianche costruzioni di pietra" delle strade appaiono come "strani oggetti/che non hanno causa" perché prive di noi, sembrano levarsi a metafora di un'impossibilità magistralmente così descritta in uno dei passaggi seguenti:" "zolla secca/che l'aratro rivoltò quando il raccolto/ fu seminato". Ed ancora, "meteore cadute" che nel contatto, nella sua rimemorazione di vuoto d'aria (di spirito e soffio allora) in apertura di tutto ciò che scorre, sanno però il punto e la bellezza da cui ripartire come in un "moto perpetuo di acque, di stelle, di radici" comunque a dirsi sotto un cielo "dove ogni cosa è più forte dell'uomo". Esemplare in tale senso è il brano "Eguale segno sempre" (vera dichiarazione di poetica) in cui nella direzione di un "Abitare tra il sale e la parola" è in questo trasalire la possibilità d'orientamento (nella tenerezza quasi d'animale- di gatto- però diremmo secondo la risonanza da un altro testo nella capacità di "coscienza delle soglie e degli spazi", di respirarne il silenzio sentendo tutto vivo). Intanto però è tutto uno scontare, un peregrinare di strade e di spazi, di uomini e donne nel tentativo di dirsi che hanno nella carnalità di una poesia intrisa di terra e calore, di tentazione, il luogo sospeso tra "un tempo paziente e muto/e un sapore di noce viva/fuori dal guscio" e quello di un buio, di una fine imminente nell'annuncio di un mondo che resterà solo. Ecco allora i riferimenti alla Plath e alla Stampa, all'amatissimo cugino-poeta Beppe Salvia e al Basento dell'infanzia, ad una Roma di rivelazioni e negazioni, ad un Italia soprattutto come "ape inglobata/in una pietra" e in promesse che ignare finiscono nell'incuria "di un luogo non luogo" nella "assidua contiguità della morte". Così ad un'età in cui "la notte non crede più nell'alba", che non riconosce, non vede nell'altro la medesima ombra, la Salvia finisce col contrapporre una sacralità dello sguardo proprio "là dove è il cammino dell'acqua/ e il tempo di pietra", nella domanda stessa all'uomo della croce sul come dare apertura di speranza e di sorriso prima dei lupi e del sangue. La risposta forse è allora nel farsi toccare nel rischio della perdita, nel trapassare come stella "di forma in forma" nel dono di "una parola frutto di scoglio" che possiede, ferisce, illumina. Di una parola in conclusione che sa però anche sospendersi- e scommettersi- nell'ambiguità dei silenzi.
Id: 1051 Data: 29/09/2017 12:00:00
*
 Giuseppe Vetromile - Poesia - Marcus Edizioni
Giuseppe Vetromile - Poesia - Marcus Edizioni
Percorsi alternativi
Intellettuale raffinato e attento, promotore culturale da lungo tempo, quella di Giuseppe Vetromile è una figura a suo modo preziosa ed esemplificativa di un percorso che ha fatto di Napoli negli ultimi decenni uno dei centri di maggiore interesse poetico per la forza e l'originalità delle sue interrogazioni. Pensiamo con lui alle esperienze di riviste quali "Secondo tempo" e "Risvolti" o ai nomi di Pasquale Della Ragione, Alessandro Carandante, Giorgio Moio (così almeno nei primi che ci tornano alla mente). Scuola questa, se così possiamo dirla, nella distinzione di una ricerca che ha nelle frizioni del linguaggio, nel cortocircuito di una parola sovente condotta nella cazzottatura dei significanti, l'estetica di un contemporaneo scioglibile solo nella vitalità e possibilità del dubbio. Ed è questa parola, nell'architrave di un sospetto che colpisce anche se stessa e di un affidamento però totale nell'urgenza delle istanze, a guidarlo nella risonanza di un tempo, o per meglio dire con lui, di uno spaziotempo- che è quello della vita e della condizione umana- di compressione, di sfiancamento e disillusione che ha infine poi nella morte la sua destinazione certa. Lo stesso Carandente nella sua breve presentazione sottolineandone al proposito le urgenze biologiche e la "forza di rimozione" con cui si scioglie da tentazioni nichilistiche ci aiuta a comprendere il percorso con cui Vetromile fonda un'impossibile sopravvivenza composta da dinamiche che hanno nella mente (nel dialogo però mai interrotto con quel veicolo di finitudine che è il corpo) le tappe di un viaggio ora parallelo ora deviato (per contemporanee e laterali investimenti di fuga) tra i confini e le parzialità di una vita che ci supera trascendendo aspettative e sogni. L'efficacia secondo noi, giacché è un testo che si piega al cuore, è nella cucitura del rigore della lingua (nella severità dei suoi passaggi tra visioni date ora per sensoriaretà ora per ritorno di memoria nell'espansione del tempo) entro un lirismo di fondo raccolto entro dolenze e malinconiche strette che ci hanno fatto molto amare (per riconoscimento, per dettame) alcune circolarità dei suoi passaggi. Nel "cammino perenne verso il caso" proprio nulla resta di ciò che ci è dato? Nello strappo alla luce e al buio di ogni giorno, tra le case e i viluppi di cielo e terra che ci inghiottono proprio nel momento in cui ci comunicano, questa sembra essere allora la domanda di direzione e di senso che lo muove oltre le metafisiche e gli abbracci di fede (che pur tra illimitate sconnessioni permangono). I titoli delle sezioni e dei testi (soprattutto delle prime tra stazioni, Percorsi alternativi e fermate obbligatorie, Sequenze del contrario andare, Transiti provvisori in una Geometria dell'orizzonte caduco- tanto per citarne alcuni) già dicono molto peraltro andando a confermare nei dettami la strenuità di uno sforzo al lettore chiaro dalle dichiarazioni stesse dell'introduzione in cui Vetromile nell'impossibilità umana della sosta nel "punto di accumulazione di se stessi" indica nel procedere alternativo del suo percorso la ricerca "di possibili strade d'essere nella speranza che l'ultima stazione non ci sia, o che rimanga così asintoticamente lontana da essere praticamente irraggiungibile". La risposta secondo noi è nelle corde stesse di una poesia che sulle tracce della sua stessa insufficienza (in quanto, seppur alta, comunque espressione di una comunicazione umana) affondando la fragilità della voce nel sommovimento che dice della creaturalità l'essere afferma proprio oltre la parzialità di se stessa (e del proprio assenso) quella stessa logica che poi la cancella. Filosofia oltre la filosofia e poesia oltre se stessa l'agone in cui accerchiato Vetromile si costringe e a cui confidando nella bontà delle interpretazioni riconosciamo soprattutto (ripetiamo) entro la necessaria complessità delle strutture la tensione di un uomo (nella dolcezza dei riferimenti continui all'amata) che non si arrende all'evidenza di una esistenza che non concede altro oltre una condizione a termine. Così nella speranza di avere poi tutti "il nostro tesoro" come quell'ombra di "figura che risale il greto e si rifugge nella pineta" (nella bella immagine delle arcaicità delle forme nel loro sogno di redenzione catturate dal sole per strati d'aria) invitiamo alla lettura di un testo per inquietudine e amore coinvolgente, stimolante, grato alla vita e allo sguardo.
Id: 1046 Data: 23/06/2017 12:00:00
*
 Lorena Turri - Poesia - Kairós Edizioni
Lorena Turri - Poesia - Kairós Edizioni
Leggi una donna
Quanta vita, quanto dolore e quanta luce noi uomini non vediamo delle donne che ci stanno accanto? A quanta direzione, quanto mondo in realtà non partecipiamo nel parallelo di rincorse che non scorgiamo forse assuefatti (se mai possibile) o indifferenti all'amore? Questo, e molto altro ancora, viene da chiederci dopo la lettura del bel libro di Lorena Turri entro un esordio intenso, interrogante, disarmante nel reclamo di una storia offesa nel circuito della sua progressiva cancellazione. Leggere una donna, ci richiama in faccia la Turri, significa fare i conti con una scrittura composta quotidianamente anche dalle indifferenze, dalle piccole e distratte disappartenenze maschili (vuoi per superficialità, vuoi per egoismo) ma anche (e non solo giacché altrimenti resteremmo appunto nella logica di una visione esclusivamente maschile) da spazi ed orizzonti di una pienezza vissuta nell'intreccio ora fecondo ora ristretto di una terra sempre desiderata e abbracciata. La scansione con cui allora Lorena si racconta è in qualche modo quella diaristica nella struttura di sei sezioni ognuna accompagnata da una breve frase introduttiva. E sono quelle della prima parte, sicuramente la più sanguinante, ad aiutarci nel tentativo di meglio riportare una lingua che nell'acme delle umiliazioni e delle distanze sa bene sempre, non smarrisce, il fiore bello dell'acqua e della nascita cui dare- per amore di sé e della vita stessa- cura. "La donna è come un libro che gli uomini, molto spesso, leggono per metà" oppure "Ti accorgi che la solitudine è veramente brutta quando, dopo aver stirato le lenzuola, non hai nessuno che ti aiuti a piegarle. E' in quel momento che devi farti forza e allungare le tue braccia più che puoi". E da queste braccia, nella simbologia forte di una mutilazione da sé e dai propri sogni di condivisione a cui non si vuole cedere, da questo corpo e da quest'anima dimenticata nella rivelazione della propria sconfessata identità (di compagna e donna nella pienezza dell'unione) è l'immagine della casa a farsi teatro di una intimità ora messa in scena in dinamiche prettamente d'assenza (la donna sola nelle proprie quinte d'amore) ora tutta raccolta all'interno di uno spirito, seppur sgomento , mai domo nelle proprie attese. Nel riferimento continuo della casa (che è dapprima nel cuore e nella testa), nel suo tema ricorrente, infatti la Turri ci racconta la storia di una fedeltà non a un'idea ma alla realtà profonda della propria natura di donna che, nella scelta, si sa nell'altro . Così nelle pieghe della rovina (perché di rovina si tratta, della coppia e del singolo, nello spazio d'orizzonte ormai reciso) "la casa d'amore è un sogno eroso", amarezza di un "nido che si è perso" nell'ossimoro di un rifugio che non smette di seminare chiodi nelle stanze. Infatti nella totale lontananza dell'uomo, che è tra le cose che più colpisce, la donna ci appare, nella ricerca di un difficile equilibrio che possa nutrire ancora l'insieme, compressa tra la custodia di un bene che chiede ancora vita ("Io- piccolo seme/accovacciato nel calore/che incoraggia la terra-/ascolto e mi nutro//aspettando un disgelo/che mi mostrerà fiore/sbucato dagli asfalti") e sua infecondità nella screpolatura che non cessa (così nell'indovinato accostamento di sé a un vecchio ulivo dimenticato da chi dovrebbe averne cura e che per questo può morire). Queste ombre, queste luci piegate a ridisegnare nei tratti l'affanno e la tenerezza d'amore e di desiderio (che la Turri sferza per mortificazione con rabbia:"Da sempre con le cosce spalancate/ ad un inderogabile dovere,/non so niente, più niente del piacere") sono la scrittura, nella sostanza, cui l'autrice reclama appunto dignità di lettura. Eppure nell'incapacità dell'uomo a farlo, e a spogliarla dunque della solitudine cui la condanna, ancora la forza della fedeltà a sé le permette di non cedere al giogo della promessa ma di rinsaldare piuttosto quella promessa nel cuore di un mondo che la chiama fuori, nello sguardo di reciproco incontro con la terra nella memoria del tempo antico e unico che è quello campestre del paese, quello della partecipazione collettiva e familiare. Si guardi con attenzione allora la quarta sezione, Natura, dove in modalità care al Pascoli (non a caso, forse, la Turri essendo toscana di Garfagnana) l'osservazione del mondo, l'apprendimento nel "senso della mela" che offre "i succhi buoni/come una madre nel suo ventre dolce" sono nel segno di un fiorire tutto in un infinito tessere d'insieme che l'uomo ha in parte dimenticato offrendole al tempo stesso l'opportunità di comprendere come nelle rose rampicanti di maggio dell'omonima poesia in cui "nessun petalo trema di paura/nel buio della notte" così nel dialogo l'uomo nella consegna al Cielo delle sue meraviglie. A proposito del Pascoli, poi, e di poesia dunque ("Qualcosa come un sogno/ma più reale,//come la vita ma più immortale , // come l'amore ma più corale " ) per un pane che " sembra misera pretesa" (giacché "il grano della vita più non trebbia"), dedica un'intera, omonima sezione, nella rivelazione di una scoperta (quella poetica appunto) cui è pervenuta tardi ma che l'ha aiutata nello scioglimento trovando nella quieta ispirazione delle cose il "cantico d'essenza" (nella consapevole sapienza di un dono che dà condimento alla terra nella condivisione piena della vita- "Soffro a cercare il Tutto e il Nulla dire./Di Tutto e Nulla riesco anche a patire") grazie anche a una parola in lei sempre esatta, sempre circolare nel dosaggio di forme e strutture, di risonanze ed evocazioni. Il miracolo allora si fa carico, la voce di Lorena si fa eco dei silenzi e delle negazioni di molte donne racchiuse nel coro unico di una disperazione e di una solitudine sovente senza appello e questo, aldilà dei meriti artistici comunque ragguardevoli, è il nocciolo di un testo più che degno.
Id: 1044 Data: 12/05/2017 12:00:00
*
 Lucia Longo - Poesia - Falco Editore
Lucia Longo - Poesia - Falco Editore
Rendez-vous oltre la riga
Esordio poetico nel segno di una scrittura d'amore, sull'amore questo di Lucia Longo insegnante calabrese con alle spalle una intensa attività d'artista nel segno della multidisciplinarità (non a caso il testo è corredato all'interno di foto raffiguranti installazioni di poesia visiva). Potremmo allora, oltre l'abuso ormai consolidato del termine, parlare a buon ragione di piccolo Canzoniere nel taglio però si badi bene di una interrogazione e registrazione di eventi, seppur minimi anche, legati soprattutto ad una interiorità femminile che ha nell'amore, nell'espressione piena dell'amore e della sensualità che la lega la pronuncia più profonda. L'amato infatti di cui, della vita è accordato strumento, per custodia, per cura si affaccia in queste pagine come nota, come oggetto di un canto che è dapprima interrogazione e rimemorazione continua di sé e poi, come si conviene, sollecita lode, invito, convegno a spezzare ben oltre la riga e la pagina, nell' indicazione dunque di una fecondità sovversiva della passione, un'orizzontalità di intenti che nulla, nemmeno la scrittura può credere di racchiudere e fermare per sempre. L'altro infatti non è che un appuntamento con se stessi nella conferma, a saperla riconoscere e cogliere, di un esistenza data in apertura, di una fecondità che è tale solo nell'incarnazione dell'altro. Di qui dunque nel riconoscimento quella sapienza che viene dal senso, che precedendo prepara e guida, alleggerisce sempre, intuisce in una frammentarietà di spazi che dei due sa, già dice l'unione. "Ho lasciato l'anima/ a stringerti la carne.//E ora sono rondine/ a cui risponde l'eco", ecco, in una versificazione breve, secca, un piccolo esempio di quanto detto a cui la Longo affida verso per verso a proposito di eco una moltiplicata risonanza di desideri, voli, contaminazioni. Così nell'intreccio di una medesima grammatica d'anime e corpi il sapersi viva come pianta che incontra l'elemento che le dà nutrimento (senza il quale il mondo stesso appunto rischia di farsi siderale) ha nella formula dell'abbraccio il senso del gheriglio (come da poesia omonima), di un amore dunque nel suo verde allappante colto dalle mani, di un amore altrove invocato secondo un'efficace espansione: "Come incredulo frutto/ nasci in fretta / lentamente . // Oh.. / se potessi essere ramo/ t'accoglierei fra le mie foglie". La poesia allora che nasce tra i tempi della separazione e del contatto erge a sua portavoce principe il bacio, sì, cui la Longo dedica versi intensissimi non solo come necessità della carne (ossigeno senza il quale come fiamma ci si spegne) ma come presenza e conferma di un'anima che teme lo smarrimento in una solitudine senza pelle (che piuttosto oltre la logica e le verità del cuore suda le sue verità). Non a caso, infatti, è proprio una poesia sul bacio ad aprire il libro, nello specifico su quelli mancati come ad annunciare (da titolo) una "Nuova primavera""Anche le rose/ spezzate sanno/ sbocciare e/ i baci mancati/ trovare bocche dove/ navigare". Così il fremito di cui ci racconta ha sovente l'accezione dell'accento che sovverte e guida la rotta, a cui può anche non servire la bocca per ricucire e tenere insieme le distanze nella "pienezza di un frutto/ dove posso saziare la sete", nella virtù che sa dell'amore la pazienza "di cruna/ dell'ago/ quando il filo/ è sfrangiato/ e le mani/ sono spesse" e la spazialità policentrica dei sensi ("Baciami...//Ma non lasciare che/ siano solo le nostre/ bocche a provare/piacere"). Nell'intelligenza di un cuore di donna mossa per fatiche e prove pure nella coscienza di un' interdipendenza che passa per sentieri intricati (che vissuti "senza/ il pregiudizio/ della colpa/ e del peccato" aiuta a toccare l'intimità di se stessi) sa bene che l'amore per essere saputo ha comunque bisogno di essere detto, che a nulla serve se ciò che si porta nel cuore nel cuore resta. Anche questo allora il senso del suo cantare in un sogno come stupore di se stessi. Nell'uso esplicito dei simboli lo stesso Ferdinando Battaglia nella prefazione si diverte a enumerarli e noi con lui li ricordiamo. Sono le figure della Fenice (capace di rinascere sempre), quella di Pinocchio (nel slancio verso promesse che non si manterranno) e quella della Sirena (nell'incompiutezza che lascia nella malinconia della parte divisa). Il tutto come lo stesso Battaglia sottolinea nel desiderio di ripristinare "nella consapevolezza l'integrità dell'amore" e che nell'accento del canto ma soprattutto nell'ostinazione dell'amante e dell'amata in parte già realizza (considerando in realtà che il vero rendez-vous come detto è oltre la riga) e che compiutamente così riesce a esprimere: "Sei/il mio gioco delle linee/parallele./Ti incontro nel punto/di un infinito che ricorre". Un volume dunque corposo e coinvolgente del quale però si è sofferto un eccesso nel numero dei testi (che in parte avremmo tolto non aggiungendo nulla a nostro dire al dettato semmai inficiato dal rischio di stancanti ripetizioni) e dall' uso di un verso breve nel singhiozzo di spezzettature a frenarne sovente lo slancio.
Id: 1038 Data: 14/04/2017 12:00:00
*
 Beda - Poesia - Eretica edizioni
Beda - Poesia - Eretica edizioni
La passeggiata di una farfalla ferita
Non sappiamo nulla di Beda se non il celarsi dietro lo pseudonimo di un giovane autore veneto alla sua seconda prova. Ma non importa perché quello che ci preme sottolineare è la fuoriuscita di un'identità poetica molto forte, strettamente intrecciata- volente o nolente- al destino di una civiltà in declino senza più spirito di interrogazione e dunque di direzione, di un mondo ormai ben dentro al crepuscolo cui questo stizzoso reclamatore di luce contrappone uno strattonamento inverso entro le lande e gli antri di coscienze e città e boschi nella disgregazione di panni che più non calzano. Ciò che più affascina è il reclamo naturale che si leva da questi versi che via via, nell'evocazione del ritmo giusto dei mondi (per dirla alla Holderlin), vanno a indicare la possibilità ancora viva di un'etica di ricomposizione (e non di freno ormai) dopo la caduta. Abbiamo citato Holderlin ma dovremmo, e non a caso allora,fare piuttosto il nome di Trakl nel tempo della povertà così ben presente in questa poesia che procede per accellerazioni e divagazioni del pensiero e del corpo ma anche per scandalose indolenze nell'accidia di un'anima non sommabile ai conti. Ed è qui allora, nella malinconia di una disappartenenza ora subita ora fieramente inseguita, l'impronta comune di un'epoca che ci rispecchia rendendo cara una scrittura cui per questo vien facile perdonare gli eccessi di sovrabbondanza e la debolezza di alcuni esiti linguistici. Tanto più che ogni procedere, ogni disavanzo vien messo in conto nella cura di un orizzonte di spoliazione e consegna. La farfalla è ferita perché tale, perché nella virtù di una compiuta e definita luce che si rovescia nella disarmonia degli squilibri, che tende al nero nell'oscurità degli spazi compressi. Eppure, è nell'alzata di spalle, nella grazia stessa della ferita che viene anche da un uso strumentale della fede, da una devozione ipocrita che rigettando la terra rigetta il cielo, la coscienza di un peso rimesso alla logica di una parola che sa nella mancanza l'unità, la risonanza affettiva delle origini. La direzione è quella di una bellezza non storpiata tra reclami di carezze e prese (sapendone i tagli, sapendone l'alfa) ma partecipata in un divenire entro l'utero infecondo di un'acqua che non alleva , là dove è impossibile rinascere , là perché impossibile rinascere. Di qui l'ostinato guardare in avanti della testa e del sangue, di qui il canto e l'affidamento - mai orfico però, mai utopico- alla notte in cui sfiorito come le gerbere, come le cose, rifiorire nel sonno che tace il nostro tempo. La scrittura stessa che appare nei toni sfuggente e lontana, a tratti infastidita e sfacciatamente distaccata da un umano senza più vita (incapace e finito al termine della propria storia) in realtà conferma un'aderenza dell'uomo prima che del poeta ad una natura che non mirando a procedere con noi pure sembra mostrarci nella veglia delle sue mutazioni la possibilità finalmente di vincerci entro una bellezza che si trascende e supera perché finita. Questa è la strada che Beda insegue nell'accettazione della mortalità di un destino (nel carico di pena comunque iscritta in ognuno) e a cui richiama nel segno di una vita, nella sua rinascita, che va dunque letta prima di essere scritta. Una fuga all'indietro allora, un respiro delle origini connotato però non solo da un oscuro giudizio (che è sempre dell'uomo mai della terra) ma anche da una luminosa offerta, quella del ragazzo fatto pellegrino. In conclusione dunque un testo che si consiglia (pur nelle accennate fragilità) e del quale volutamente non abbiamo riportato alcuna citazione lasciando alla lettura d'ognuno, nel pungolo, gli affondi e le separazioni che ci riguardano.
Id: 1033 Data: 17/03/2017 12:00:00
*
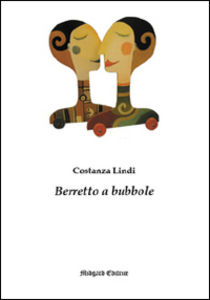 Costanza Lindi - Poesia - Midgard Editrice
Costanza Lindi - Poesia - Midgard Editrice
Berretto a bubbole
Divertente, arguta, a tratti irrispettosa per le provocazioni e le debordanze linguistiche delle sue interrogazioni, delle sue irriverenze rispetto a un quotidiano e a un mondo ostinatamente chiuso nelle proprie irriflessioni e nelle proprie irate inconcludenze questa terza prova (oltre a una raccolta scritta a quattro mani) della trentenne umbra Costanza Lindi. I riferimenti, i padri o i fratelli nobili che negli echi o nelle risonanze esplicite si accavallano sono quelli già dal titolo di Pirandello, quello di Marinetti e poi di certi richiami alle avanguardie del secolo scorso, a Palazzeschi ci pare soprattutto nonché alla cantautorialità degli anni settanta. E poi, eppure, nelle rivisitazioni di cui si fregia- nel divertissement mai banale del cimento- ecco i richiami anche al mito greco, nell'appassionata controfigurazione di Dei e uomini (Pandora, Narciso, Elena, Eco, Icaro), e lo scioglimento dalle carte della storia letteraria (Don Chisciotte, Cyrano, Mercutio, Achab) di una simbologia umana colta sempre in quel surplus di connotazione fatta di aspirazione e rovescio nell'incalzare della menzogna e della morte in cui solo Romeo, sapendo ascoltare le proprie bugie, può dire benedetta la propria follia. La maschera così va a connotare nella stasi delle paure il rammento di un bisogno e di un mondo che è nel minuto, nel frammento che lo copre e lo può svelare ("Tutto quello che voglio sapere/è in un granello di sabbia"). L' arlecchinata della prima e omonima sezione ma soprattutto la narrazione della seguente "Pseudobardi", entro una scrittura che come uno svuotatasche raccoglie il tutto- necessario, ordinario, frivolo- della vita, svelano uno spazio che nel riflesso poetico della Lindi si industria comunque a procedere senza di noi avendolo smarrito nel basso di una terra che non sa più la sua meraviglia ("Forse è meglio così./Sono giochi da grandi" subito però aggiungendo nel sarcasmo della dolenza). ll percorso, la cattura di nuovo del sentiero passa dal fingersi ciechi, dal restare dietro agli altri nella fantasia e nella provocazione delle mani in tasca, dal vivere distesi come camaleonti "sulla corolla di un papavero,/sposando la luce/ come capro espiatorio". In una realtà deformata e deformante, in un mondo in cui ogni cosa ha il nome sbagliato , l'ordine è dato dal "rendere leggibile l'essenziale", da uno "scrivere sull'acqua" reso nell'urto dei contrasti dal cortocircuito delle forme continuamente richiamate e impresse in giochi di parole che ne infingono la lingua illuminandola o mettendola alla prova nella capacità evocativa di suscitare prospettive e feritoie diverse come negli esercizi di "Gingilli" la sezione finale e in "Lilliput" dove in brevissimi versi i testi scherzano con gli elementi del mondo (dagli animali agli oggetti) in scomposizioni diremmo cubiste comunicando l' alternativa perfezione- e profondità- delle svagate dislessie che ci compongono (il mare che si mangia le parole nella spuma, le ali a mostrare la parte più bella delle giraffe). Pertanto è bene accompagnarla nel procedimento togliendo alle sue disposizioni il nome di maschera perché nell'effetto riuscito il volto che ci mostra è quello di un tempo rimestato e smorzato per misericordia al fuoco di una disperante urgenza che è in quel perdono di noi stessi che viene a strattonarci fino al tramonto nel riconoscimento di una medesima desolazione. La gioiosità sottesa, la vivacità della luce, la curiosità della vita e dell'amore ("Quello che vorrei capire/è perché le cose stanno così/finché stanno così,/e perché cambiano/per stare così/finché stanno così") è ciò che resta e che in conclusione guida oltre l' interrogazione metapoetica di una scrittura che sa sciogliere (e non "per finta") nel gioco delle frizioni e delle condivisioni il proprio soffrire, piangere e prendere la pioggia. Un autrice dunque nella solidità di un cammino a cui manca solo maggiore vigilanza rispetto a qualche eccesso che scema in dissonante ripetitività ma sempre nella chiarezza della partitura:"Che io possa essere estremamente breve/nell'estrema brevità del mio poter essere./Che l'estremo possa essere breve dentro di me/vantando con brevità l'estremismo del mio vivere".
Id: 1031 Data: 31/03/2017 12:00:00
*
 Adua Biagioli Spadi - Poesia - La Vita Felice
Adua Biagioli Spadi - Poesia - La Vita Felice
L’alba dei papaveri
C'è un'intensità di sguardi e di affondi nella vita sospesa delle cose e di sé, in un reciproco dirsi, in un reciproco svelarsi che rende particolarmente caro questo esordio della Biagioli Spadi, quarantenne operatrice culturale toscana. Diremmo una sensualità del sentire che tende all'apertura come è naturale ma che pure come è altrettanto naturale, nella tensione dell' incontro, vive di ritrosie ed ombre, di sottoesposizioni, di piccole ferite che la luce più che guarire può ulteriormente allargare o tutt'al più, nel bene di una scrittura che non ammette infingimenti, dar voce. Cosa sono allora tutti questi petali che traboccano desiderio, questa richiesta negli elementi del sole, di un respiro chiaro, non offuscato , della terra al cielo cui nel riconoscimento o nella proiezione verso cui nel fremito delle congiunzioni teneramente ogni piccolo verso sospinge, se non il fremito delle fecondità possibili, dell'amore dunque nell'identità dovuta? La suggestione di questa poesia così è tutta in un pudore di interrogazione che ha dapprima in sé nella direzione dell'uscita la freschezza di uno spirito verso una terra che non la invalga, di una grazia raccolta e preservata nella fragilità della propria, personale bellezza e di qui poi sprigionata entro quel giallo del sogno e della speranza finalmente liberate da quel centro nero cui ogni vita nel suo essere rosa sa nel destino la spina. Abbiamo usato di proposito questa immagine da "Speranza" poiché la più esemplificativa in tal senso del dettato profondo di una visione fortemente intrisa dallo scandaglio di un cuore che sa di sé, rimestato ancora da un passato che come in ognuno si riaffaccia e tenta, la gemma di una zolla che non ha altro destino se non nel taglio delle resistenze e dunque nell'abbraccio. L'animo, o l'anima, che la muove è di una imprudente, meravigliata coraggiosa tenerezza che fino alla fine ci confonde, tra timori e appelli di germoglio, tra lucidi rischi del pensiero e suoi smarrimenti, nell'orizzonte di una dischiusa femminilità che proprio in questo già si compie consegnata e unita al mistero d'ogni creaturalità nel grido delle proprie affermate aspirazioni. Non altrimenti, è un percorso doloroso, certo, nel respiro di un amore ("l'inizio di tutto") forte a partire dalle assenze, nella veglia delle distese promesse e inseguite anche qui sullo sfondo di una partecipata attrazione delle cose e degli esseri che si cercano, di un paesaggio e di una condizione quindi nel dialogo di personali e reciproche risonanze (si veda ad esempio quello con la notte per cui "è difficile essere donna,/difficile essere madre,/immenso bacino di vita"). L'altro, l'amato, così non può che divenire canto al sole che nasce, pronta alla sequela e alla semina di donna scrostata e rinverdita nella fedeltà ad un sentire in cui, a differenza degli angeli, "Tutto è nell'ora dell'esistere qui". Un canto dell'esistenza piena che ha nell'uso finalmente prorompente del colore il tratto dominante (non a caso la Biagioli Spadi è anche pittrice), il rosso soprattutto ("pietra che brilla nascosta/ splende nell'organo di vita pulsante/non sa di un gelo che stermina/ i fiori e li spezza") mischiato al chiaroscuro del desiderio e della memoria, grimaldello privilegiato di ricomposizioni e scardinamenti, luogo del perdono a saperla ascoltare la terra traboccando ed assolvendo alle radici. Di qui dunque quella spinta, quel demone gentile che insorge continuamente alla naturalità della vita e che ha nel silenzio la conversione perfetta, il ritorno originario di linfa, di più pur nel trapasso il suo "celeste assorto ammirare" (come di Maria, ne "La Pietà", il figlio tra le ginocchia deposto). L'oro, che sa di noi e nell'incertezza del tempo non sappiamo scorgere, è allora nel "fondale addormentato" di sé dimenticati, di uno spirito che risalendo dal basso sa muovere all'incontro senza perdersi tra i rimpianti e gli inciampi delle proprie ombre. Oro che giocando sull'assunto di un suo verso è proprio nel mondo davvero dato, ancora, solo nel non tradimento del giorno che viene dall'amore, il suo sapore tutto nel tocco di lui, "scintilla infinita", "albero di me aperto nella notte" a saturare "l'aria ovunque" ma in cui pure, appunto, voltati gli occhi "tutto naufraga/e tutto è riscommesso". Fedele a un'idea di poesia come canto di memorie e di insonnie di questo si nutre nella suggestione delle evocazioni e delle assenze entro una parola non privata a scioglierla finalmente, "infinita/sull'infinito senso del sentire", nell'ora dello sbocciare e del sorridere. Qui però a ben dire non sempre l'efficacia del verso accompagna degnamente l'intenzione, ripagando con stonature il dettato (non sappiamo se per mancanza di controllo o di strumenti) in un difetto di costanza che sovente abbiamo riscontrato in più autori (anche se nel caso della Biagioli Spada non incide più di tanto nella sostanza di una base forte nell'essenzialità dello spirito). In conclusione un testo ma soprattutto un'autrice ricca di grazia e a cui auguriamo l'agognato sposalizio, quell'alba della memoria e del frutto, allora, in piena liberazione.
Id: 1025 Data: 17/02/2017 12:00:00
*
 Bachi Dardani - Poesia - Edizioni Melangolo
Bachi Dardani - Poesia - Edizioni Melangolo
Un segreto ancora
L'esistenza come luogo di smarrimento e perdita, nella sensazione di sentirsi superati tra le dinamiche di un presente imposto (dunque non nostro) e mancanze di un mondo che affonda nella ordinarietà di giorni sempre uguali perché senza orizzonti, è questa la linea dove si muove la poesia di Bachi Dardani, trentenne genovese che vive ormai da tempo a Milano. Eppure, e non potrebbe essere diversamente per le dinamiche interne che la agitano, è una poesia ascrivibile alla luce nel filtro di uno sguardo e di un anima proteso comunque ad una riconoscibilità di orme e di forme a dire delle cose e degli esseri la reciproca unità. Poesia allora non della solitudine ma della condizione , di un temperamento che dipartendo da uno stato di trattenimento fa della propria oscurità ("Lo so che non ha senso disperare,/che è certo") scandaglio, motivo e luogo di una presenza a preservare in qualche modo "quel poco di vero, d'umano" ("dinosauro ruvido e ferito/ che all'alba estingue" e che alla sera nemmeno più reagisce) in noi ancora identificabile. L'affondo allora è nel buio, nella monotonia di giornate come detto connotate dall'odio e dal rancore cieco di città e civiltà in rovina, da teste piegate nel fango di un notte che sempre sopravanza (in cui il cielo è solo possibile sfiorarlo), di un lavoro dominato da dinamiche che non ci contemplano se non nei circuiti di procedimenti che azzerano, di schermi che divorano ogni legame- senza il tempo nemmeno per domandarsi se tutto ciò nella nausea che "umilia e morde" non sia "un miraggio" alla propria morte (tra scadenze e propositi, tra massificazioni e idolatrie lo spreco della vita).Il rischio di cui Dardani è ben consapevole é, nella consuetudine ed oscenità dei desideri, il rifiuto che porta allo spegnimento , dunque al gioco riuscito del demone cui tenta la contrapposizione di una dignità vigilata, ostinatamente nell'esercizio del dolore perseguita, nel segreto che ancora chiama a viverlo pur nella resistenza di sillabe stentate nell'incubo che tutto possa finire. E che lo spinge oltre la finestra, oltre lo sguardo sulla città visto dall'alto e di "andare là fuori nel mondo". Qui tocchiamo le ascendenze poetiche di Dardani che a noi paiono quella di una certa linea ligure che procede ben al di là dei natali; parliamo di un Montale ( il cui "Mediterraneo" in parte ritroviamo in "Risacca") e della sua vita al cinque per cento e di Sbarbaro soprattutto nei motivi e negli andamenti quasi ovattati nel giro del pensiero, stordito a tratti tra notti e forme informi entro un sonno che non sa se vincersi nella speranza del sogno. Così è un dialogo antico quello di Dardani, per certi versi (ma non sempre) vicino ad un novecentismo che lo libera nel canto (in particolar modo nella sezione d'apertura I miei segreti) e poi nei testi a seguire, entro una difficoltà di parola segnata appunto da uno sforzo etico di resistenza al magma che proprio all'inespressione volge (l'alternanza è infatti tutta in un versificare tra lirismo puro e andamento prosastico del dettato), da una memoria, ancora, che si fa forte delle generazioni che ci hanno preceduto (dei genitori e quelle della guerra ad esempio nei racconti dei nonni) e dell'amore ragione e spinta di vita (lui "nato solo/per il solo destino d'uomo solo") a rinfervorare e a indicare "in fiori come splendono le notti". Nella sostanza però non potendo uscire da un tempo che "non corrisponde più niente al suo niente", nel pantano di un'abitudine a vivere "segregati in aiuole/ di plastica, involucri in vetro" (in cui tutto pare già perso e lui non esserci comunque nel disgusto di sfide che si tramutano nella metafora di una fine che uno ad uno prende tutti nelle sue gole), pure qualcosa può aprirsi, un'aria fresca che viene forse da lontane dimenticanze che ci raggiungono, nella custodia e nella cura che viene da un 'educazione che ognuno dovrebbe avere alla cultura e all'arte, a illuminare il cuore e dare un nuovo suono al mondo coperto dalle croste di un silenzio rabbioso. Il giorno può vincersi a un nuovo senso che non sia solo nella spenta conclusione di chi con vanità esercita il potere, o nella compassione come da corsia dove tutto finisce ma compiersi anche come nel lontano esistere del mare che fonde e rifonde i propri frammenti, le cose, gli oggetti, le creature che si caricano e si mischiano, a uscire nell'aroma e polpa dovuta ("Estate"); nell'assentire insomma al valore di una vita che sempre riprende nel giro "che tutto ci muta e ci passa" ("I fiori"). In questo invito, sull'esempio di una scogliera che tenacemente resiste agli assalti, nell'esortazione finale a non perdersi nella "inquietante solitudine d'intorno" per cercare di ricucire dai "tratti/turbati" una "storia/stenta infranta", si conclude un libro ancora nella piena del proprio tormento ma orgogliosamente libero nelle consapevolezze delle proprie ferite. In questo il suo autore allora già esattamente uomo.
Id: 1014 Data: 27/01/2017 12:00:00
*
 Luigi Finucci - Poesia - Eretica Edizioni
Luigi Finucci - Poesia - Eretica Edizioni
Le prime volte non c’era stanchezza
Tenerezza, dolcezza, grazia nella custodia del bene caro di un'infanzia intesa nell'equilibrio stabile e ordinato di forma e mondo, di sé e mondo all'interno di un sistema familiare e di terra, di forze esattamente risonanti e riportate nell'unico paradigma possibile, quello della perdita. Discorso questo, di Luigi Finucci (trentenne marchigiano alla sua seconda prova poetica oltre a un testo di versi giustappunto per bambini) che tra l'altro ci riporta alla cronaca di paesi, culture, cerniere del nostro paese così duramente colpite dal sisma di questi giorni, di questi mesi. Diciamo subito che per buona parte della lettura ci è sembrato di avere tra le mani un piccolo gioiello, un'opera di poesia vera per semplicità e umiltà antica davvero sorprendente e che pareva smarrita tra scaffali di versi nei fatti chiusi al mondo per logiche di autoreferenzialità sentimentali e politiche. La stessa ingenuità che da più parti va a segnare e accompagnare le pagine ci riporta ad esempio ad una malizia, ad una corposità di vesti che piuttosto che coprire non liberano, ci sconfessano dimenticati a noi stessi e agli altri nei recinti di solitudini e impossibilità progettuali. E non rabbia, non accuse, non parole accese nel timbro ma la desolazione dell'occhio che sa la luce nel buio che spegne. Timidamente, fieramente, solo rammentare (come da primo testo) "il diritto/ di essere deboli" in una meditazione sul tempo in cui, come rileva nell'introduzione Alessandra Piccoli, in un paesaggio che "acquista piacevoli caratteristiche umane" il ricordo nel sollievo prova a sovvertire il trauma. Interiorità umana e interiorità circostante sembrano dunque continuamente cercarsi, circolarmente pensarsi in una compenetrazione di generazioni e distese. Tra promesse e perdite, nella domanda se é possibile ancora "ascoltare ciò/che il tempo ha perso per strada", la risposta è in quella malinconia di uomo e Creatore che insieme fondendosi ridanno, sostenendosi, speranza. Bellezza di cruna che nel piccolo si compie e che al piccolo, così, naturalmente ridireziona (le poesie sull'Africa- in un cielo senza rovina perché sempre nuovo- a mostrarcelo, a confermarcelo) e che ha nel sogno la sapiente compiutezza del gioco, il mondo trovando nello sguardo a sé del bambino ( non più sull'altare dei demoni ) la chiave della disputa col tempo nell'ordine riunito della casa e dell'albero (del letto e del legno come una volta dalle spalle la visione del regno giusto del padre). Esemplare allora di questo sguardo di comunione (a scongiurare quella perseveranza all'errore che porta a morire due volte- a "vedere/negli uccelli/un volo mancato") è il brano "Nel fiume ho trovato un sasso" in cui il tema caro del tempo è strettamente collegato all'amore. Così come nello scorrere dove "tutto cambia e si logora" e sembra dimenticarsi dei sassi l'acqua stessa comunque va a modellare la pietra, infatti l'amore con noi compiendo e fiorendo pur nell'aggressività degli eventi- le care cose (le botteghe, il pane, l'odore del melograno) nella consuetudine e nel racconto di uno spazio ("I sensi si sono riposati") in loro stesse rasserenato. Eppure, nel procedere, qualcosa in questa scrittura- quasi sorprendentemente- a un certo punto va in cortocircuito. La corsa del fanciullo, non più lievito, si fa affanno come se nel ricordo ("Tutto il resto l'ho dimenticato") quella quiete che da bambino fu turbata dalle ansie dei grandi fuori dalla stanza non fosse più ricomponibile ("tutto il resto è finito/ nel gioco delle prime volte") ed esemplare restasse nella possibilità solo il passato ("solo in quel villaggio/le abitudini erano madri,/e gli orologi erano del colore/ del giorno e della notte"- "Il villaggio dei mulini"). Nella morte del sogno che si fa inutile chimera "con mani piene/ di falci e clessidre" il libro va a chiudersi in un'oscurità a cui segue una parola incostante e a tratti debole che va a scemare il dettato stesso in inconcludenze che non ci spieghiamo, l'orizzonte comunque così tanto carezzato nelle sue intenzioni un inciampo. Ciò non toglie però ricchezza a una disposizione e a un naturale talento che ci ha emozionato, certi che il caro Finucci non si smarrirà nel suo gioco.
Id: 1010 Data: 11/11/2016 12:00:00
*
 Marco G. Maggi - Poesia - Puntoacapo Editrice
Marco G. Maggi - Poesia - Puntoacapo Editrice
Punto di fuga
Un cielo senza Dio quello di Maggi (quarantenne piemontese all'esordio, dopo prove sparse tra riviste e premi), un cielo senza direzioni (in cui altro non si è che " materia che brucia/su pire d'infinito") ma a cui comunque artigliarsi in aperture montaliane di varchi a rompere nell'urlo il respiro che non si può trattenere "prima che il buio avvolga". Nelle stonature dello sguardo degli altri, con gli altri, nell'impossibilità di riconoscerne il pensiero (pur nell'intreccio d'amore che insegnando toglie "senso a ogni vertigine" come dimostrano i testi dedicati a migranti del 3 ottobre e ai martiri di Sant' Anna di Stazzema) la condanna alla fuga, appunto, o per meglio dire a un volgere il capo a una natura che ci comprenda, che possa rispondere nelle rimemorazioni di consueti connubi. Ed infatti sono questi i testi che maggiormente ci convincono di una scrittura e di un dettato a tratti altalenante entro una lingua ora avvolgente, calda e sensualmente risonante ora debole, a smarrirsi facilmente in sforzi di secca. Una natura, dicevamo, a cui però l'uomo non sembra più appartenere, in una terra che non sa, o piuttosto, vuole più assorbire. Resta,come nella suggestiva "Promontorio", una preghiera cara per i morti nell'oscurità che nasconde il mare. Resta nel setaccio di ritorni di amore il naufragio in avanzare della propria giornata od imparare (mentre "ognuno biascica per proprio conto") forse allora dal figlio che pari all'onda che crea se stessa cerca d'imporsi tra "i marosi di una nuova speranza". La poesia non può che raccontare questo reclamo tra le intemperie del tempo e degli abbracci, nel panico stesso che la penna e il foglio, pur nella lotta, possono accogliere giacché da autore sincero Maggi sa riporre nel canto quello "strazio che più non sa fingere" cercando (per quanto conscio che nel rigirare la vita sovente resta il silenzio attorno) di dare altra misura che non sia la perdita al sorriso nell'uomo. Perché comunque in una vita che come panni stesi sulla sua corda ora arride alla luce ora "più spesso ci sbatte" e abbandona "su un sasso", "volare è scegliere/ tenere il fiato o respirare" pur nella perfezione sterile e nell'agguato dello spillo che non perdona nella bella analogia con le farfalle. Ed allora ci appare questa poesia come un tentativo di resistere ai timbri stessi dell'autore, ai suoi contrasti, alle sue contraddizioni nell'intelligenza delle interrogazioni, negli affetti di spiriti e cose (i vecchi armadi, la borraccia dei pastori) sulla soglia come ne "L'ultima foglia che cade" della figura che sa consegnarsi all' inverno, nel dubbio incalzante poi dato il sonno della ragione che la "Terra/-così speciale-/sia il frammento mitocondriale/ di una cellula di Dio". Così allora inizia a possedere senso forse nell'espressione del desiderio "frenare le scie al pensiero" per ritrovarsi finalmente entro un "firmamento più denso" dove è possibile raccontare "e sfogliare la vita"- non più trattenuta dalle incrostazioni e sentita come un' eccezione nel "tremito feroce che dilata vene/ e tornanti di arterie". Su questa soglia dunque, in una malinconia di avvicinamento che non lascia il suo autore, ci fermiamo augurando a Maggi maggiore attenzione nella scelta di testi e a cadute di tono che possono inficiarne forza e motivi.
Id: 1007 Data: 27/10/2016 12:00:00
*
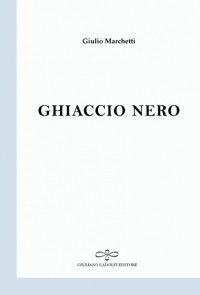 Giulio Marchetti - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Giulio Marchetti - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Ghiaccio nero
Nel luglio del 2015 scrivemmo a proposito di Apologia del sublime, la precedente raccolta di Giulio Marchetti, di incolmabilità di distanze tra spazi di incarnazione e definizione di sé e, dunque, di conseguente mancanza- o prigionia- di una forma e di un senso nell'orizzontalità dell'amore e del quotidiano sovente respinte in uno smarrimento del respiro. E più nera, come da titolo, troviamo adesso nella sua naturale evoluzione una scrittura però in ogni verso drasticamente chiara (secondo il paradosso lucido di una coscienza sempre impietosamente vigile), composta nel bianco d'allarme di un'esattezza di negazione che davvero non può che indovinarsi nel ghiaccio dello scioglimento prima o poi certo di tutte le proprie (sempre) illusorie impostazioni. Questa infatti è una poesia dell'inappartenza, di uno stato che non consente di compiersi nell'impossibilità stessa di pensarsi concreti. Nel percorso delle tre sezioni ("Cercandomi", "Cercandoti", "Meraviglioso fallimento") il deserto è il solo paesaggio consentito in un freddo dato più per assenza di calore che per rigidità (come nella notte di tutti gli inferni); oscurità, ancora, mai negli effetti "zona di passaggio" ma "luogo di nascita" di un silenzio ogni volta subito per richiesta di luce a un qualcosa- un altro da sé, un mondo, un' ipotesi- senza risonanza per inconsistenza (un "niente" dunque). Si badi bene però mai banale anche nell'accento della lacerazione- che non è lamento, risentimento semmai di una condizione universalmente coatta- questa voce sovente tesa al delirio, come disturbata da un eco di paralisi, di contemplazione dell'altro come fosse abisso- la sua bellezza pari alla propria pena. D'altronde se quella scia d' immenso (vedi l'omonima poesia) che piega l'orizzonte non è che "coda del destino/tra le gambe", allora nulla può proteggere dalla caduta, della vita la mimica sfaldandosi "nell'attesa di una carezza agognata". Il giorno, evanescente già al suo apparire di sconfitta, chiama ad artigliarsi al soffio che può dar respiro (inscenare la danza), l'altro solo, forse- ancora, sempre, comunque- "ponte tra vita e morte", conferma della propria presenza, veglia, e pur nella medesima labilità, custodia oltre la visione toccata della tenebra (vedi tra le altre la coraggiosa "Ipomea blu"dove gli occhi amati nel germoglio rispecchiano la luna). Eppure, forse dicevamo, giacché Marchetti non può che procedere nella consapevolezza di illusioni che ora per sopravvivenza si infligge ora rifugge. Così quest'amore così tenacemente carezzato , nuovamente ogni volta , come la vita essendone figura, sembra chiudersi all'esito inevitabile dell'impossibilità e della polvere (già accolta poi da una pelle che l'attende morta- "Bellezza"), il cielo angusto in tutto il respiro dato nel volo per arrivare all'amato ("Cuore"). Fuggire però da un paesaggio dove la somma continua della neve non consente fioriture, e la solitudine si impone nel solo "spazio/concesso all'oscurità", appare vano. Resta, nell'inutilità di un tempo che ha il suo ricatto nell'oblio, la parola come forza di resistenza d'una visione che tenta il divincolo dal buio; ogni giorno una registrazione, ogni giorno nella libertà del sogno in un "alfabeto del silenzio" che sa della terra l'accordo col sole nel poco nutrimento, di "goccia nel deserto che non vuole morire". Di conseguenza il cuore pur perso, nella sua scrittura, reclamandosi ancora dalla terra riesce ogni tanto a battere ancora nell'attesa di "una pioggia di stelle/ a vene aperte". Lirica allora, in conclusione, la risposta più umana di una disposizione a tratti cieca per oppressione. Ed è questa è la direzione in cui più ci riconosciamo.
Id: 1005 Data: 11/10/2016 12:00:00
*
 Edoardo Ferri - Poesia - Edizioni Il Labirinto
Edoardo Ferri - Poesia - Edizioni Il Labirinto
Linea di fondo
Felice, evocativo, pungolante l'esordio di questo cinquantenne romano per le raffinate Edizioni Il Labirinto. Il tema, subito chiaro dal titolo e dal disegno di copertina, è quello calcistico il quale, seppur non particolarmente frequentato in letteratura (e tanto meno in poesia) ha dei precedenti più o meno illustri come ricordato da Fabio Ciriachi nel commento finale. Dei nomi citati di Pasolini (che nell'ulteriore sottolineatura oltre a praticarlo ne riconobbe lo statuto di vero e proprio linguaggio), Camus, Handke e ancora per l'Italia di Saba (con le sue famose cinque poesie), certo è bene ricordare quello di Fernando Acitelli che con "La solitudine dell'ala destra" ci ha consegnato, rompendo come si disse allora un tabù, nel 1998 per Einaudi uno dei testi sicuramente più intensi e pregnanti su una passione, un gioco, una misura che pur nel favore planetario paga ancora in parte una sua irraccontabilità di fondo (in questo anche nel cinema ad esempio o in musica, alla memoria riportando "Ultimo minuto" di Avati o la classica "Leva calcistica del 68" di De Gregori, ovviamente). A questi nomi è bene aggiungere però ancora quelli di Osvaldo Soriano e di Eduardo Galeano che in "Splendori e miserie del gioco del calcio" ha tentato felicemente un resoconto particolareggiato di questo sport e per restare da noi di Elio Filippo Accrocca ( “L’arbitro” ad esempio, in "Videogrammi della prolunga", come metafora sulla propria coscienza durante i festeggiamenti del secondo scudetto della Roma nel 1983). Ferri non stona tra questi nomi, assolutamente, dimostrando una conoscenza specifica che viene dalla pratica in una resa connotata di grazia per dolenza di carne, e di spirito, nell'irraggiungibilità di una condizione che nella figura dei suoi interpreti è di un'umanità tutta nel gesto che solo, per bagliore, si illude nella riuscita di poter essere e impetrarsi. Ed infatti il segreto che fa cari questi versi è l'ordinario anonimato dei protagonisti a cui in qualche modo ci accomuna nel suo piccolo discorso sul mondo. Resterebbe deluso dunque chi tra queste pagine cercasse nomi noti di fuoriclasse o aloni di compagini passate alla storia (il solo riconoscimento, che viene dalla data, è quello relativo alla vittoria del mondiale spagnolo a dire nella nota personale di prima giovinezza quel "grido all'alba/in cui il sentire sembrava il mondo"). In realtà, "col suo lessico e la sua sintassi come metafora dell'esistenza e di occasione per parlare di noi" (così come evidenziato nella risvolto di copertina), questi versi ci restituiscono in un rettangolo di gioco che è dapprima un luogo della mente un intreccio sospeso di anime tra tempi (che sono quelli ordinari, o straordinari del gioco secondo gli esiti) e spazi (nella dilatazione infinita del terreno tra luoghi deputati dalle linee appunto e le improvvise folgorazioni delle zolle) dei propri riconoscimenti o misconoscimenti, come il più delle volte in effetti malinconicamente- e più o meno teatralmente- avviene nella ricerca quasi anarchica di un dettaglio insieme rigenerante e salvifico. Ecco allora tra gli altri, un campionario vastissimo di centromediani, di terzini dai polmoni inarrestabili ma sfortunati o distratti, di portieri che proteggendo "lo spazio comodo ai sogni" non sono imperatori ma "maglia come gli altri", di centravanti smarriti alla rete (o, come in uno specchio, di bomber a cui manca solo il suggello del gol nel minuto che non esiste- "settantasettesimo sessanta secondi"- per la consacrazione dell'eterno e dunque, per questo, anch'essi restando incompiuti), di panchinari e di sognatori come nella vita sempre per azzardo fuori gioco, di esordienti senza futuro e di giocatori all'addio. Eppure, si badi bene, non si tratta quella di Ferri di una facile epica di antieroi ma di partecipata cronaca d'uomini semplicemente ritratti, fermati tra l'istante di un gesto e suo compimento, nella riflessione breve- e a tratti metafisica- dell'interprete dove la possibilità dell'impresa vale l'impresa, o è già l'impresa nel mentre di stagioni cui la storia, piccola e personale, collettiva e di bandiera, può determinarsi in un mentre di appassionate ed agognate rincorse, il fallimento, lo sproposito sovente aleggiando su destini e classifiche. Ed allora se, come in "Minuti di recupero", l'inizio di un tempo nuovo in "un pallone non più vivo" può incrociare il sogno, la meta, così è nella scrittura del corpo, nelle intuizioni delle sue recuperate e poi addomesticate intelligenze (colpi di tacco, pallonetti, diagonali e tiri dai sedici metri ), il dettato di un prodigio che si sa vicino nella meraviglia di una punteggiatura inseguita, a spezzare, a "colmare" quel vuoto che viene dall'attesa compiendola (si legga al proposito "Gol vivo"); i lanci,i tiri meteore sovente a tagliare riflessi lunari , parendo sempre di esser visti dal cielo . Di contro, però, è nell'errore anche la misura di protagonisti cui proprio per fallibilità è facile per noi e per Ferri stesso (cui proprio non riesce la simpatia per gli abatini) appartenere ( vedi "Autogol" dove nell'impossibile previsione "il pallone diventa/ordigno di effetto e malinconia", il giocatore nella corsa come se non avesse "più coscienza della struttura del vento"). Tracce queste che tentano di sciogliersi tutte proprio nel motivo della linea di fondo come misura del respiro entro una corsa che si vorrebbe senza fine come a vincerne il limite, spostandolo nella non accettazione e nel "desiderio improvviso di un solo istante/ in cui cogliere tutto/ il senso di una vita". Dolenza di una salvezza che però si sa, improbabile, "in quel punto tracciato oltre il terreno" ed a cui il gioco come la poesia si affida in un altrettanto improbabile ammaestramento. Nella leggenda della posizione eretta guadagnata dall'uomo "tentando di calciare/ una palla di rettili" , del gol come prima parola pronunciata "dinanzi a un tramonto di dinosauri", Ferri infatti vorrebbe costruire "un pallone ideale/quello che tutti saprebbero colpire/con traiettorie romantiche". Così nell'analogia tra gioco del calcio e procedere e pensare poetico, tra il tempo e lo spazio di una "corsa a vuoto," sembra poter iscrivere un "ultimo momento in cui cogliere/gli angoli acuti di una vita", a superare, a vincere quell'occhio irridente del giudizio che rischia di smarrire nel rimarco stesso delle sottolineature quella essenza stessa dell'esistenza- che in sé è già poesia- ad accettarsi e a compiersi senza "indugi/ sull'inciampare di una sillaba" ("Se i calciatori fossero poeti"- ci dice infatti a concludere- le traiettorie sarebbero parole/i gol sillabe veloci" (..) "ché campo del poeta è l'orizzonte/la prima strofa calciare", tutto per "un mondo di suoni per esultare/con versi del pubblico in metrica"). Intanto, a rappresentarlo e a rappresentarci, resta nella consegna la malinconica, bellissima, figura di Laszlo, atleta colto nella nostalgia di tutte le inarrivabili mancanze, impenetrabile nell'enigma ("il fermo desiderio di non aggiungere/altra tristezza agli occhi"), mai nell'indugio dell'esultanza al gol (che è sempre "la fine di un racconto") e che in qualche modo, seppur nell'illusione, sembra acquietarci con lui nella memoria a "quegli attimi luminosi interminabili/ come ad un verso dimenticato/ che attraversa il tempo incide i giorni/malgrado tutto sia abitudine".
Id: 1000 Data: 30/09/2016 12:00:00
*
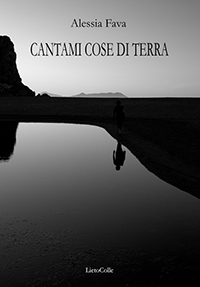 Alessia Fava - Poesia - LietoColle
Alessia Fava - Poesia - LietoColle
Cantami cose di terra
Alla sua seconda prova poetica Alessia Fava, quarantenne giornalista e traduttrice romana, ci offre nel canto di vita per il figlio appena nato il segno di una maternità innamorata, gioiosa (come non dovrebbe essere diversamente...) e al tempo stesso naturalmente tesa, nel senso di tensione e accompagnamento della nuova creatura nei cui riflessi la donna e la madre si vede crescere e morire ogni giorno. La scansione dunque, nella struttura delle tre sezioni di cui il libro si compone, è quella diaristica andando a definirsi in quella forma che a buon ragione Silvio Raffo nell'introduzione definisce Canzoniere, sottolineandone nel caso la singolarità storicamente il genere prestandosi a lodi di innamorati e d'amanti o, seppur con minore frequenza, di rivolgimenti di figli alle madri. Così qui la scrittura persegue nel dirsi il racconto di un rovesciamento, o per essere esatti, di più rovesciamenti. Infatti il movimento non è verso l'unione come tra individui che si cercano ma verso il distacco nella ridefinizione che segue del legame stesso; in questo, di più, nella rotazione mutati gli ordini, essendo ora lei ("Costellazione girovaga per esserti cielo sicuro") a girare attorno al figlio ("Piegata sul tuo orizzonte"). Nell'intima continuità dei riflessi ( "Dedizione tremula questo fulgido sapore") lo stesso dolcissimo sussurro "tu hai aperto gli occhi/ nelle mie mani" racchiude allora insieme anche l'esatta consapevolezza del suo opposto: giacché mi hai aperto gli occhi nelle tue mani, aggiungiamo noi, pare sentire nella conferma dei versi che verranno. Per il gioco dei sensi e del tatto passa allora una nuova, reciproca aderenza, una relazione nella terra- e con la terra- in un confine che seppure incerto incalza al più eretto desiderio di vita nella fertilità di anime che combaciano, carne ognuna della storia dell'altra. Ma se il riferimento alla terra è esplicito fin dal titolo, il dialogo in realtà procede in direzione del cielo, essendo il cielo- nel senso di passo e di giorno, di giorni verso cui procedere, di latitudini che volgeranno a separazioni, a scenari non più condivisi- il teatro di uno sgomento e di una meravigliata grazia che volge a uno stentato equilibrio ("grembo al margine / della tua lingua per sempre") . Nel sentore che nulla lo tratterrà, sulla soglia " della bocca eterna dalle braccia spalancate", l'apprendimento nell'apprendimento comune è connesso al reinventarsi al tempo, in una vicinanza che nella preghiera si fa invito a restarle cucito ai giorni, a caderle "ancora più dentro" giacché é "dal volto alle dita il senso rotondo, il viaggio", "eretto in questa mia stanza d'ambra". Ogni giorno appare dunque come una nuova nascita, una nuova gravidanza in una veglia continua di accompagnamento e comprensione (come a ricordare ancora la prima attesa:"non sei ancora qui nell'ovale di braccia/ tra le mani congiunte in capovolta preghiera,/(...)//ma la finestra azzurra dice il tuo nome; arriverai col verbo delle camelie"). Ed è proprio qui che il canto si fa più rarefatto e insieme più concreto giungendo ad esiti altissimi tra interrogazioni su quanto possa esser suo il corpo che guarda, le mani nel contatto a mantenere la purezza e la favola: "le ginocchia in preghiera/ saziano il fiato fin sopra la lingua/ così non avrai più paura// carne di giglio fiorisce carne:/ meta di te, specchio d'ali". Nei limiti di "traiettorie inesatte" nel "moto necessario", nella dolente coscienza di una diga destinata alla resa "pei cieli che non ci appartengono" entro un orientamento che sembra mancare, ecco però fiorire la forza che viene dal sapere della sua presenza comunque, nella certezza nel cuore di un posto in cui attingere: "una casa senza/ porte dove il pane fumante/ scrive piccole salvezze/ incarna sorrisi sulle ossa". Sì una presenza in lei come ricreazione costante anche per l'orizzonte eterno del tempo a venire che nei versi dei testi finali scorre nel segno dell'acqua, primo elemento di vita e simbolo dello scorrere e del restare anche nel corpo e nella sua memoria "a ricercare/ il punto fermo, il parto necessario/un giusto esilio in forme silenziose/ che lascino, infine, la traccia delle nuvole" in un mutamento, in un passaggio a dire del corpo stesso l'estrema, nuda fedeltà. Non dobbiamo aggiungere di più su una poesia che si compie per evocazioni, dove i paesaggi (del cuore e degli occhi) sovente convergono; semplicemente lo raccomandiamo vivamente nella benedizione di uno dei passaggi centrali, nella custodia e nella riconoscenza di vite che si amano: "Piena di nutrimento, mi hai lavato via il buio/ viaggiandoci dentro, terrena nelle gambe/ la notte si sfrangia: io ho ora le mie luci".
Id: 993 Data: 15/07/2016 12:00:00
*
 Caterina Davinio - Poesia - ArteMuse
Caterina Davinio - Poesia - ArteMuse
Fatti deprecabili
Ci siamo già occupati della scrittura di Caterina Davinio a proposito de "Il libro dell'oppio", testo recuperato da un diario all'epoca per gran parte inedito ed ora in toto pubblicato da ArteMuse in questo "Fatti deprecabili" nella struttura cronologica di cinque testi che vanno a raccontare un periodo lunghissimo della vita dell'autrice andando dal 1971 al 1996. Così immergersi nella Davinio, leggerla, scontrarsi ed incontrarsi con la sua poesia è anche occasione di riflettere su se stessi e su dinamiche di realtà sociali e culturali e personali strettamente connesse ad un'epoca o per meglio dire più epoche, nell'intreccio di destini e ricordi qui raccontati, sul bordo dell'esplosione e del rigetto incandescente di sé e di un mondo subìto e avvertito come concluso, malato, violento nella sua autoreferenzialità di dominio. L'itinerario allora è presto detto dai sommovimenti e le esplosive inquietudini degli anni settanta fino al contrappunto al silenzio del riflusso e le sclerotiche, noiose indifferenze di derive- e poetiche- evanescenti. La composizione del libro infatti è già racconto: Il libro dei sogni (1971-1976), Il libro del disordine (1977-86), Libro mistico (1987-89), Libro del caos e del risveglio (1990-1993), Fuori testo (1994-96). Ma quello che più preme sottolineare adesso è l'arco di un'anima nella lotta e nell'abbraccio con se stessa fino alla spinta omicida e suicida dei propri slanci, dei propri rivolgimenti, delle proprie istanze di visione. Piccola Caterina nella meraviglia e nella protezione orgogliosa dello scoprirsi e dell'inventarsi nel rifiuto che questa ed ogni bellezza sia un delitto, già nel suo primo libro (che ricordiamo è quello dei sogni) alla ricerca di un Dio di qualche specie, adolescente curiosa e ribelle nella corporeità libera di se stessa. Storia che diparte da una precocissima dote di appartenenza al reale e di sua osservazione, nella sua oscillazione tra calore e tensione, tra riconoscimento familiare e refrattarietà, di natura e città nelle disarmonie connesse e disarticolate a uno spirito in formazione cui per temperamento e per età una certa angoscia e solitudine di scarto, di un sentirsi sempre fuori posto , inizia ad affacciarsi nel suo ringhio feroce. La reazione allora è nell' orgoglio di una parola seppur acerba che nel comporsi si rimonta nelle autoriflessioni di una coscienza che intuisce, sa, ha nella scommessa dell'amicizia e dell'amore la sua riscrittura e la sua partecipazione feconda. In una lingua da subito valida nei suoi presentimenti ed anche degli inganni del cuore ("Il mio amore è senza pensieri/ bello come una bambola/di cartapesta/ dai colori delicati./ Sorride, non pensa mai/ è una tenda a fiori/ non un prato") ecco la sua ricerca e il suo coraggio "perché seguirò tutti i miei sogni fino in fondo", nella consapevolezza del rischio di perdersi nella necessità del viaggio, l'eroina iniziando a mordere tra notte di concerti e albe, tra primi sentori d'artista. Orizzonte, presenza, morte poi che sono al centro de Il libro del disordine nella distesa di giorni orgogliosamente abbracciati tra facoltà occupate e riti studenteschi, tra marginalità e contestazioni, peregrinazioni collettive e rurali tentativi di vita sempre però nel segno appunto di una idealità gioiosamente e drammaticamente in comune ("E si può anche amare la solitudine/ ma essere soli è quasi sempre essere vili"). L'anno del discrimine, all'albore del punk, il 1977, "l'anno della rivoluzione lasciata a metà", delle frequentazioni dell'autonomia operaia e della morte di Giorgiana Masi, e delle ore perse a cercare fantasmi tra paura della quotidianità che uccide e il rigetto dei cari in canto di desideri e sazietà di richiamo. Ed ancora in un periodo dove i ricordi si affastellano nell'intensità di un lunghissimo pericoloso e solidale istante la seduzione dei pusher, la marginalità di tutti i confini tra discoteche e trasporto di armi (nel rischio di "mille anni di morte,/il carcere,/la vita,/di piccolo uccello che vuole volare") ma anche il pianto sui gradini di una immensa Roma dei meandri nella notte coatta ("Vorrei dire che oltre le nostre/ povere vite c'era un destino, /una rabbia segnata,/una piccola speranza di folli"). Tutto questo in una scrittura densa, corposa, lucidamente viva nell'abisso di una bellezza di riparo, di sconfinamento sempre nella fedeltà ai propri patti di salvaguardia e riconoscimento. Che sembrano non salvare però se già nella figura del suicida a conclusione di testo la Davinio pare proiettare una parte di sé nella propria solitudine "di bestia ferita a tradimento" e se soprattutto nell'opera che segue, Libro mistico (che copre il periodo 1987-89), è il racconto della follia a farsi fulcro di una scrittura testimone del rischio di una disintegrazione definitiva a cui sembra non bastare più uno sguardo di compenetrazione fuori da se stessa,di una natura che pure ripete i suoi piccoli miracoli di creazione. Sulla via iniziale di interrogazioni sulla famiglia e sulle figure dei non nati che sembrano farsi amaro paradigma della condizione umana ("non saranno/ seme doloroso della terra,/ non saranno messe") i brani tendono ad un'essenzialità di pochi versi all'ombra di una consapevolezza di qualcosa che manca, di irraggiungibile forse perché "solo il corpo si lascia narrare", il corpo il veicolo del pensiero, dal corpo la luce cercata, non liberata ("mi spaventò/come l'apparire di Dio/ e mi fece svanire,/ ardere nel fuoco , / me, impuro simbolo / di purezza " ). Qui dicevamo la follia, e gli strumenti di una liberazione operata anche per la via dei farmaci dalla "violenza mostrata dell'infinito", insieme ad uno scontro ed un incontro con un Dio a cui cedere "nella fede/come un uccello ferito" dopo averne tentato un'entrata di distruzione seppure, con slanci e parole audacissime, nella visione della propria morte sembra consegnarci per un attimo la visione della morte stessa di Dio. Che però resta presente e vicino (anche se a tratti sogghignante- e nell'affondo delle unghie) restituendole nella lotta col male ("la mente dispersa e spaventata,/la mia generazione corrotta,/contaminata,/degenerata") la consapevolezza che "tra il creatore/ e la creatura/ il legame è fitto,/l'intreccio/infinito,/lo sposalizio inestinguibile" anche in un randagismo che nel Libro seguente- del caos e del risveglio- il quarto (che dunque va dal 1990 fino al 1993)- di nuovo prenderà il sopravvento. Qui tra nuovi flash di metropoli che vanno cambiando e una realtà che appare sempre più indefinibile se non incomprensibile nel suo sospetto di inconsistenza il racconto non può che può esser nel tramite di una lingua che si fa più irriverente, giocosa e divertita come per reazione, annodata e poi snodata da se stessa nel tentativo di liberarsi e viversi finalmente da una polimorfia priva di senso. A dire il vero qui il risultato non sempre come in passato riesce a coinvolgere, almeno non pienamente per un eccesso appunto di ricerca linguistica e intellettualità del dettato che più di una volta ne frena la spinta- pur forte, pur incalzante- rendendola al cuore, e all'orecchio, meno naturale in un montaggio e smontaggio però mai banale secondo un' incisione vicino a modalità di nuovi media (molti di questi testi non a caso nascono per svilupparsi in "performances multimediali e poemi più lunghi recitati in letture pubbliche e in teatri " ) . Chiudono infine a segnare questo lunghissimo percorso pochi brani dell'ultimo libro, come detto dal titolo, Fuori testo e che coprono il periodo a seguire di due anni, dal 1994 al 1996. In conclusione "Libro dei propri fiori del male degli errori, del disordine, dell'impossibilità del menestrello di essere normale", come l'autrice stessa (della quale ricordiamo la poliedricità tra poesia e multimedialità con attività espositiva, convegnistica e curatoriale in diverse parti del mondo) ricorda nella presentazione, ma per questo nella "deprecabilità" di fatti, "di gesti liberi e profondamente umani" (rifacendoci alle parole di Ivano Mugnaini nella postfazione) libro per certi versi necessario, naturalmente non solo all'autrice, nella direzione di un'esistenza mai di scarto, mai passiva alla ricerca di quel senso di pienezza e d'abbandono che le spetta e anticamente, nella chiarezza che è dei bambini, intravista e poi deturpata, rubata, svilita non solo da se stessi. E della cui limpidezza ha voluto e vuole farsi cantrice, mai del suo sfregio - nell' asservimento- complice.
Id: 991 Data: 09/09/2016 12:00:00
*
 Laura Sagliocco - Poesia - Campanotto Editore
Laura Sagliocco - Poesia - Campanotto Editore
Sensi e sentimento dei sogni
Lode della poesia, sfrenata ed appassionata fedeltà al suo potere altro di squarciare mondi e tempi illuminando il cammino dell'uomo restituendogli orizzonti e identità perdute. Questo è l'humus in cui affonda il libro d'esordio di Laura Sagliocco, quarantenne romana attiva soprattutto come attrice con alle spalle un progetto di poesia in musica trasformato in album indie-rock. Nell'introduzione in cui raccontandosi tra riferimenti a Shiller, Boccadoro e Rimbaud , è nella direzione dell'eterno femmino la ricucitura della sua scrittura (che è tutt'uno evidentemente con la vita come ci ricorda Natale Rossi nella presentazione "poiché volta a trasformare la poesia in amore (...), in quotidiana esperienza estetica") per la riconnessione- in un ritorno di dialogante e reciproca vivificazione- alle segrete, creatrici sonorità del mondo. Dunque ridonandoci nel "privilegio di fonderci ai sensi e al sentimento dei sogni" l'essere sotteso che privo di respiro boccheggia dentro di noi. Questo nelle intenzioni e nello spirito acceso con cui il sentire è rincorso (e non abbiamo dubbi). Eppure, e particolarmente nella prima parte ("Premeditazione"), il dettato sovente non si accende nell'eccesso di lessico e immagini dato, a nostro dire, secondo un inseguire non troppo personale dei modelli, tra compiacimenti ed ire sul destino infausto dei poeti e l'inferno cui in eterno si è votato. Ed ancora, il modulo con cui nei respiri agresti o nella magnificenza di antichi luoghi (come qui in "Tempio antico" a Bolsena o più avanti a Stonehenge e nei luoghi della Grecia classica) in cui altre vite ed altre epoche si riaffacciano sembra escluderci in un presente che non ci parla, non potendolo per l'evanescenza delle rimemorazioni. Questa poesia così vezzeggiata, così amata, così chiamata alla cura allora funziona meglio, è sinceramente e più fortemente coinvolgente quando non procede per caricature ma per moti e significazioni riportati nella dignità e nella sostanza della loro umile forma (l'io a lato- non davanti- fedele servitore). Pensiamo ad esempio a cadenze come queste: "Adoro il canto affannato di fine estate,/ calda che brucia ,/l'odore di erba scolorita/ abbattuta dal sole " ("Fine estate") o "Perché la tua carne è bagnata / di lacrime leggere , / come un Cristo troppo giovane al suo cammino" ("Lo spaventapasseri") giacché l'autrice , sempre debordante, possiede un temperamento poetico autentico che però, come spesso succede, da solo può non bastare. Ma non renderemmo merito a quanto c'é di buono in questi versi limitandolo a queste poche notazioni. Infatti è nei testi dedicati agli amici e alle amiche, alle figure care di amanti, che lo spirito guida della Sagliocco si leva nel suo canto migliore ed è l'amore, appunto, riportato all'alogicità e alla carnalità delle sue regole dimostrato nella straziante offerta e impagabilità dei suoi ritorni e nella cui forma, data dal confondersi e dal custodirsi dei corpi, risiede la stessa forma del tempo. Sempre nella fascinazione e negli incanti ciò che in queste pagine intenerisce è la gridata e ricordata e preservata consapevolezza di un incontro che ha nel dare alla luce lo splendore di vita dell'altro già nello sguardo quell'annullamento delle distanze, almeno nella sua più tragica e incessante delle illusioni, che la accomuna alla poesia appunto. Qui dunque lo scioglimento riesce, e non annoia, questa è della poesia sostanza (non come nell'omonimo testo quell'orfismo di ritorno tra cori iniziatici di ancelle). Ancora, è anche nell'orgoglioso ritrarre i misteri e le fascinazioni del femminile nel lineamento dei caratteri , sempre sollevato nei suoi sforzi e nelle sue malie e sempre innocente a dispetto delle violenze del mondo (tra tante citiamo "In mare aperto"), il potere di una versificazione che riesce a procedere a dispetto di intralci e chiusure nella convinzione di poter illuminare ed essere illuminati in quella unione di terrestre e di divino che rompe i mondi e li trasforma. Di qui nel percorso, dopo l'attraversamento della parte centrale del libro dei testi della sezione "Il viaggio: convalescenza e tenerezza", la convinzione finale che fuoriesce dai versi di "Conversione", la terza e ultima parte del libro, per cui mai la vita conosciuta ci abbandona ma cresce "in perenne intesa/di sorgere ancora" nella coscienza tra l'altro di una poesia "non strumento contingente di dominio" ma di veglia, nel calore e nella sensualità predisposta al richiamo , come in mancanza dell'amato da cui prendere e dare vita . Non a caso in questi ultimi brani la carnalità si fa più bruciante soprattutto nel dolore dell'assenza chiamando e trattenendo l'altro come per amplesso già avvenuto : "Scava sempre accanto alle mie mani/e schiudi i tuoi spasmi /allo specchio della bellezza" ("Un solo giorno") ed ancora: "E ti amo sempre,/ti amo nell'estraneità che pasce/ il dolore dei santi" ("Reliquie", testo esemplare per alternanza di indovinate evocazioni come questa e irrefrenabili cadute di tono). Un libro allora che ha in questo la sua forza e la sua fascinazione vera, il suo motivo di lettura seppure nell'ingolfamento di pagine di cui poco ricordiamo.
Id: 987 Data: 05/07/2016 12:00:00
*
 AaVv - Rivista - Iuppiter Edizioni
AaVv - Rivista - Iuppiter Edizioni
Levania, n. 3/12 2014
Nell'editoriale d'apertura il direttore Lucrezi nell' introduzione al tema del numero, partendo dal presupposto che se un testo poetico è un oggetto linguistico, e storico, frutto dell'incontro di immagini e parole tratte da quel corpus, "carico di stratificazioni storiche" della lingua ed è pertanto "per sua natura" impersonale e tenendo sempre presente "la capacità di pensare simbolicamente l'antico" proprio delle immagini (nella doverosa sottolineatura "che è quanto di più vicino all'eterno è dato figurarci") auspica con forza la necessità di ripartire in distensione entro quel deposito di frequentazioni di spazi intermedi che queste convocano e che nella loro dimensione di "accoglienza di antiche figure la modernità ha disanimato". Ciò a ribadire ancora, nell'interrogativo se le figure e le forme che costituiscono il testo provengono dalla mente o da fuori (se "il lessico, la grammatica e la sintassi del mondo immaginale arrivano per saturazione o per svuotamento del sé dello scrivente?"), l'insufficienza in poesia della visione soggettiva e che dunque solo un suo "svuotamento", secondo Lucrezi, può favorire quell' attimo, nella immagine dialettica cara a Benjamin in cui, a partire dal presente, passato e futuro si illuminano a vicenda. Passando alla prima sezione dedicata alle "Scritture" ci imbattiamo subito tramite gli appunti del "Taccuino n. 3" con la figura preziosa di Stelio Maria Martini e che alla luce della sua recentissima scomparsa nel marzo scorso si presentano come una ulteriore, preziosa, testimonianza di una figura ricchissima per poliedricità di discorso e di un lavoro animato anche e soprattutto in un dibattito critico assai fertile nelle numerose riviste da lui cofondate ("Quaderno", "Ex", "Linea sud", "Continuazione", senza dimenticare la collaborazione con "Documento sud"). Giacché Martini fu valente critico oltre a possedere qualità di artista e poeta che ne fecero- e ne fanno ancora- uno dei principali esponenti della Poesia visiva (autore di uno dei primi libri d'artista verbo-visuali italiani, "Schemi" del 1962). In queste pagine sono riportate, dicevamo, notazioni che divise in quindici punti hanno il sapore di meditazioni etiche e civili (come le considerazioni sui rapporti tra totalitarismi e avanguardie estetiche , influenza del pensiero religioso sulla vita sociale ed istanze di libertà) mai svincolate dai rapporti artistici. Allo stesso modo, a dimostrazione di una mente fervidissima, pungolano le riflessioni su alcune letture filosofiche e percorsi di correnti storiche quali il surrealismo, sull'opera di Lucrezio, su Boezio, sul Manzoni, su Nietzsche (che gli rimase "crudo sullo stomaco" sempre eccessivamente enfatico, lirico), su scritture cinematografiche e musicali, giornalistiche. Seguono poi, nell'interessante modalità di presentazione volta per volta dei testi da parte di Lucrezi, poesie di Angelo Petrella e Mariano Bàino e di Franco Buffoni (che si presenta da sé) e che precedono lo scritto di Paola Nasti sul bel lavoro di traduzione della poetessa portoghese Ana Luisa Amaral di 100 poesie di Emily Dickinson rilevando (a riprova che in poesia le migliori traduzioni sono degli stessi poeti) come il "tradurre diventa: far gemmare da una poesia, da una lingua poetica, una poesia completamente nuova,espressa in un idioma poetico completamente altro- dunque irriferibile all'originale, alla fonte. Non più una poesia, ma due; che non si rispecchiano affatto; che si pongono una di fronte all'altra, non per specchiarsi ma per differire". E soprattutto, ci ricorda la Nasti, avendo davanti "nel farsi della traduzione" non più "l'inglese" ma "l'inglese" della Dickinson come non "il portoghese" ma il "portoghese" della Amaral recando nel nuovo testo la traccia del primo come punto di partenza. Interessante allora a seguire il cimento di alcuni autori (Luca Benassi, Carmine Falco, Bruno Galluccio, Eugenio Lucrezi e la stessa Nasti) di personali versioni dalle traduzioni della Amaral della Dickinson. Concludono la prima parte della rivista i testi poetici di Flavia Balsamo nella presentazione di Carmine De Falco e che dalla sezione "Scritture" consentono di passare alle pagine dedicate alle tavole di Carlo Bugli ( "AAHHRR" è il titolo facente parte di una serie intrapresa dall'autore per la propria casa editrice Katabolica) introdotte da Marco De Gemmis che ne avvicina il carattere ad alcuni testi poetici del Bugli stesso (che è anche poeta infatti) in cui "ti imbatti in entrambi i casi in segni che producono frastuono e in enti di nuovo conio (neocreature e neologismi), e vedi spazi in cui si affrontano disordine e ordine, segni di interpunzione e precipiti fiumi di parole, informe materia e teche rigorose in cui stanno corpi indefinibili creati da definite linee di contorno". Chiudono infine il numero le tante recensioni tra le quali segnaliamo volentieri quella della Papa Ruggiero su "Blumenbilder" di Giorgio Linguaglossa (Passigli, Firenze 2013), di Lucrezi su "Poetry music machine" di Marco Palladini (libro+cd, Onyx Editrice, Roma 2012) e di Palladini stesso su "Tutte le poesie"di Gianni Toti (Onyx Editrice, ebook scaricabile gratuitamente all'indirizzo http://www.onyxebook.com).
Id: 984 Data: 17/06/2016 12:00:00
*
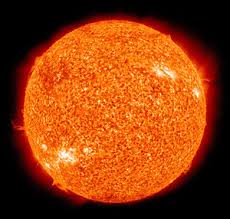 Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
Versi col tempo- anni solari XI
Sempre una gioia, sempre un arricchimento, una festa cadenzarsi ai versi e al mondo di Savino del quale amiamo rughe e lungarni perduti e chiaroscuri di passo tra corridoi reali e del tempo. Già abbiamo avuto modo di insistere (si vedano le precedenti note da noi a lui dedicate) sulla forza e il carattere di questo progressivo e insistente miracolo, di fronda percossa ma viva di questa quercia di novantacinque anni. Parlare di Savino tra l'altro, oggi, è per noi grazia di occasione per ricordare l'amata Gabriella Maleti (con Mariella Bettarini per la cura delle edizioni Gazebo la sua scopritrice), poliedrica autrice ma prima di tutto donna d'amore scomparsa la scorsa Pasqua. Come recita il titolo ecco un nuovo anno solare, l'undicesimo appunto, nel quale nella diaristica di giornate infinite dalla collina di Fiesole, nella fissità di luce della conca a valle a investire Firenze e le proprie memorie, più che raccontarsi il nostro (nell'umiltà di chi sa che "l'uomo perde sempre contro il tempo") tenta in sillabe il respiro dell'ultima casa, tra quadrato di sé e collina, come a consegna di progressiva trasfigurazione tra l'estremità di una durata che va cessando e un segno di terra nitida, di forma finalmente e perfettamente compiuta che nella sua stanchezza alle altre forme si consegna nell'ordine reciproco. E sono allora, adesso, in questi testi che abbracciano un periodo che va dal marzo 2014 al gennaio seguente, proprio la fatica e la stanchezza il motore nel tema dominante (perdonate l'ossimoro) di "un tempo senza sponde", che va a vincerlo (lui lasciandosi vincere), entro la sospensione in un mondo a cui forse, ormai, troppo si appartiene nell'aleggiare dell'altro. Così, rispetto ai testi che lo precedono, per proclamata confessione ("Non ho più forze. Tutto nella mia/ vita rallenta","Sono un uomo finito. Nulla chiedo./Nulla tengo") e per sottesa, rilucente inerzia di ritorni e un passato consumato, senza esser più le mani che si è stretto o i volti a cui si è guardato (per dirla con lui fra immagini e voci di cari a confondersi coi suoni e i pensieri dello spazio circostante), quest'ultimo volume ci lascia tracce anguste, pietrose, in un verso sovente meno luminoso , ad assomigliar sempre più "a un grido/ di ferito animale", a chiamare la fine (la fine avendolo già preso). Ma è qui nella sua consegna di rivendicato miles (di leva fu trattenuto sotto le armi durante l'ultima guerra) l'esercizio di poesia, ancora, come costume, da sempre dato senza porre resistenza rispondendo al giorno, nel vento e nel coro delle sue inoppugnabili proposizioni, dei suoi inoppugnabili luoghi . Al bisogno della vita, nel suo caso, l'amata conca, a sapere solo che il sole la scalda " che mi entra in casa e illumina gli specchi" in fedeltà reciproca (lui del suo spicchio- guardato- leale guardiano tra ascolto e aiuto di musica e libri). Nel nulla a cui rifiuta cedimenti ("un raffronto a cui sfuggo,//specchio, a cui muto ogni giorno mi guardo"), il battito della mano sulle ginocchia, sul tavolo a contar metrica e versi ("le sillabe raccolgo come olive sul ramo") ci restituisce pertanto il sapore di un'identità viva solo nell'ascolto e nel canto di ciò che quotidianamente lo compie e lo trasfigura, soprattutto, per svuotamento ("La giornata passo/ e so cosa perdo e non ritrovo"). Esempio assai luminoso- e alto- questo di artista e di uomo in un percorso lunghissimo di scarnificata e levigata, asciutta, essenziale presenza a richiamarci certo nei suoi echi a riconsiderare noi stessi come umili, meditate figure di un tempo che già sa compiendoci in un superamento di parzialità e finitudini. In ultimo, al proposito, ricordiamo allora anche un altro bene di questi versi, quello del tempo e delle abitudini, delle solitudini- tra fantasmi e più o meno dichiarate paure- degli anziani, e su cui è bene soffermarsi anche per onestà e dignità con noi stessi ("E torno appena alzato alle coperte,/ con le quali mi copro anche la testa,/ al mio silenzio, al nulla in una buca,// a una data di nascita e di morte"). Evviva Savino.
Id: 980 Data: 27/05/2016 12:00:00
*
 Francesco Lorusso - Poesia - La Vita Felice
Francesco Lorusso - Poesia - La Vita Felice
L’ufficio del personale
Perdonateci la facilità del gioco di parole ma non parla di una vita felice- né facile- questo secondo lavoro di Francesco Lorusso, quarantenne pugliese dalla parola secca, a tratti aspra ma senza sconti nella descrizione di un'epoca e di una società spossessata e desacralizzata in liturgie di consumo e di precariato dove anche il lavoratore è un invenduto di magazzino. Entro la scansione delle tre sezioni in cui il libro è diviso è ben scandita allora una perdita collettiva e personale di se stessi osservata- e riportata- tramite gli effetti dapprima di lenta decomposizione fisica prima che mentale del soggetto in rapporto al luogo del lavoro (il chiuso e l'innaturalità degli interni, lo spazio di negazione a pervadere anche il sonno in una fisicità di corpi che paiono appartenersi se non nell'ansia di scadenze) e poi, insieme, in una algida refrattarietà del paesaggio che cancellando se stesso nelle spirali di una economia alogica e subliminare (entro quella "pura corrente calma" di "una bontà che impoverisce"- di quella "dolcezza che guida al niente" verrebbe da dire con Fortini) ci restituisce la dolenza di una condizione senza più forze. Un cronico e sempre più invasivo torpore che nemmeno la parola, forse- ma solo a tratti- la rabbia, in un residuo di coscienza, prova a scuotere. Eppure è proprio questa la tragica forza del libro che si inserisce con partecipata fermezza in quella scrittura di deriva del quotidiano che parte della poesia di questi anni va dedicando a partire proprio- citando l'introduzione di Daniele Maria Pegorari- da quella "lenta agonia del soggetto dentro i meccanismi fagocitanti e alienanti del lavoro" fino ad una più allargata ed esistenziale radicalità di negazioni connesse a quelle problematiche socio-economiche (ancora Pegorari) che di fatto si vanno imponendo, come nei versi che Lorusso va a respirare sin dalle prime pagine, sopra "vite all'altezza solo dei loro disavanzi". E' un mondo allora nel racconto a cui non è concesso il sogno nella gabbia di una progettualità recisa, di identità generazionali al buio nel rendiconto a perdere coi padri. Un mondo in cui " ognuno viene inghiottito solo a tempo dovuto" nel meccanismo di una fatica che non ripaga nel fallimento delle prospettive e dove anche il dolore è racchiuso in una asettica ripetitività priva di grida (che poi è ciò che più raggela nella lettura). L'uomo, il lavoratore, si osserva perdersi in uno scardinamento biologico che nell'assuefazione per sopravvivenza, come il sole smarrito, si fa finzione nel gemito latente dei capannoni e delle macchine. Il tutto tra l'altro mantenendo sempre la coscienza del meccanismo di manipolazione cui giocoforza si va a concorrere ( "Sono solo il respiro di una convenzione", di "un prodotto senza funzioni") e che ha all'esterno, nell'uniformità di case e strade senza spirito ( o "persone nelle piazze/ in quell'ora più sana per gli incontri") quel dondolio che "non si converte in musica" ma in un "tremore senza emozione" che bene ci identifica tra le crepe di "uno stare nella pioggia continua" (l'amore stesso condiviso a piccoli bocconi "nelle luci tiepide di locali ammassati/da un gioire continuo di analgesici"). Così in questa aria continua di finta festa, di "costumi che non hanno nome" a configurare "valori senza corpo", anche la poesia, la parola ha difficoltà ad incarnarsi se non in questa evaporazioni di immagini e costruzioni non più umane dove piuttosto- ma quale?- "il vero si cela in bolo/ di oscuro verbo gentile". Eppure, pur pagando nello sforzo in cripticità, Lorusso non cede mentre "la voragine ci gorgoglia dal fondo", alzando nella parte finale l'indignazione: contro la mancanza di una trama vera e di coesione sociale, contro le responsabilità politiche e sindacali, contro gli interessi occulti- soprattutto- alimentati da un sistema di favori personali e mediatici evidenziando però, insieme, le responsabilità personali entro quella mancanza di vigilanza- e di reattività dunque per coscienza critica- che ognuno fa partecipe e in qualche caso, in qualche modo anche complice di un ingranaggio che nulla e nessuno risparmia. "E ci raccontiamo di continuo/storie di paure su parole buie/di mestieri malamente masticati/per mantenerci chiusi in casa/a consumare miseri respiri/e provare un prodotto cotto/sulla forza di una fiaba bassa": in questa onestà anche si fonda allora una scrittura e un percorso personale da seguire e che volentieri consigliamo.
Id: 973 Data: 15/04/2016 12:00:00
*
 Oronzo Liuzzi - Poesia - Puntoacapo
Oronzo Liuzzi - Poesia - Puntoacapo
In Odissea Visione
Lo scenario in cui si muove la poesia di Oronzo Liuzzi è in quella negazione dell'umano, distratto e imprigionato dentro se stesso, a calpestare ostinatamente "una terra soffocata dal caos" come da subito ci avverte. Il cuore dell'uomo ("una pietra/identità perduta") spaccato da un'economia falsa, preda di speculatori (che in modo criminale "creano nuove realtà visionarie/la finzione del vivere la morte") a cui contrapporre in grazia d'unione lirica pensiero (anche di sé e del proprio corpo- nella sue riserve, nelle sue sofferenze) e storia nella concretezza e umiltà di una terra a ricordare ancora che è l'intreccio di relazioni (fatto di fango e sangue) che ci compone a costruire il mondo: qui, in questo elastico, cerca scioglimento il disagio poetico di un autore di poliedrica e vasta esperienza (oltre che per la ventina di pubblicazioni tra narrativa e poesia lo si ricorda anche per le diverse mostre personali e collettive a livello nazionale e internazionale, libri d'artista, libri oggetto, scrittura verbo-visuale e mail art). Entro una scrittura veloce, nervosa, quasi a cercare senso e a liberarsi da un tempo che divora e cancella (ma chiara comunque e a suo modo libera) l'assunto, allora, la direzione son tutte nell'inciso di uno spazio (narrazione "che incarna la poiesis del pensiero") che è creaturalità e amore dunque- soprattutto e ostinatamente cercato in queste pagine come "conoscenza dell'enigma in apparire"-in cui dissolvere ogni "lacerazione sociale". Per Liuzzi infatti sconfessare l'altro è sconfessare se stessi e solo una rimemorazione attiva della prossimità può aprire varchi in queste rovine di eliotania e poundiana memoria (facendoci tornare alla mente tra l'altro l'apertura de "Il pianto della scavatrice" di Pasolini). Semplicemente però dapprima l'opera deve partire da se stessi, da un'auscultazione congiunta di coscienza e corpo ("il mio cantico della natura" che viaggia"dimenticato dal tempo/nella voce del non veduto") capace di ricucire dispersioni e dare verità concrete sul proprio stare nel mondo e il mondo stesso. Solo questo infatti il germe che "crea e ci racconta" nel vero nonostante le distruzioni, in un discorso sulla bellezza (nella formazione che in Liuzzi viene dall' Estetica) che qui aggancia il suo sogno di resurrezione possibile contro questa logica del profitto che al contrario come detto procede per manipolazioni e cancellazioni. Recupero del respiro quindi in una storia ed un'epoca , la nostra, come l'amore stesso " minacciato / dalla morte dal limite dal patire " , stordita nel collasso di un'ipocrisia di figure " golose del potere " - in odio di destinazione - " in conflitto col pensiero di una vita in comune". E un Umanesimo forte dunque che tenta di fondere le proprie riflessioni (di giustizia, di filosofia, di coralità) entro un fare poetico che può compiersi solo nella sua irraggiungibilità, nel rincorrersi sempre della sua luce negli strappi quotidiani che va ad illuminare, nel suo essere spirito (e spingendoci ad esserlo) in quanto "luogo umano dove vive sente/e pensa" (si leggano "una forza passionale disegna" e "modifichiamo fuori e dentro"). Voce che va a sciogliere le voci, a ricomporle in unità, a interrompere quel requiem di prigionia "del crimine commesso/ dal principe del nulla" e che piuttosto come l'invisibile dell'ultimo testo relazionandosi col sensibile " nel taglio profondo della pena", va a rispondere "in visione al dialogo". Ed è proprio qui allora nell'accordo di una Storia e di un amore "che non si nega alla ragione" ma che finalmente canta le proprie ragioni la riuscita scommessa di una scrittura densa, vitale, sapientemente circolare.
Id: 967 Data: 15/03/2016 12:00:00
*
 Emidio Montini - Poesia - Gilgamesh Edizioni
Emidio Montini - Poesia - Gilgamesh Edizioni
I vecchi di Colono
L'uomo, in quanto creatura, in quanto figlio lasciato solo dal Padre, dal suo Fattore: è questo il tema, antico e doloroso insieme, di questa spinosa- e per questo apprezzabile- raccolta di Emidio Montini (all'ottava pubblicazione in versi). Senza ombre entrando subito,fin dal primo testo, nella nostalgia e nella rabbia per una caduta e una separazione inspiegabile il lettore si sente tirato dentro, o per meglio dire, raccontato lui stesso entro una terra desertica, di rovi dove nessuna rispondenza sembra esservi, o accolta dall'alto a proteggere, a riparare da un male che ci possiede e che ci fa, "ciascuno vero ciascuno solo", "prigioniero al suo livello". Il dolore di cui si nutre il testo allora è sapientemente rimesso all'interno del percorso di una parola umana, per questo insufficiente certo e criptica sovente nell'oscura difficoltà del volo, che agganci nella scossa quell'altra Parola da cui nasce, quel Verbo che era in principio e che ora appare non essere, non accadere più se non per rivelazione di fallate promesse. Dove quell'amore, di cui comunque si avverte la forma, dove quel Bene a cui si dovrebbe essere commisurati e di cui piuttosto si sente l'indifferenza se non per punizione l'ostilità? Sono questi dunque alcuni degli interrogativi più pressanti tra lamentazione e invettiva in un libro che nel crescendo della sua lotta si fa aperta, alta, contrastata preghiera (per quanto avvertita vana) a chiedere così dichiaratamente ragione al Padre di questo regno di morte e della mancanza di pane per tutto ciò che ancora va reclamando vita. "Dalla via del supplice non c'è ritorno", ci ricorda così nell'irata consapevolezza di una più facile condivisione di un abisso quotidiano a cui l'Eterno ci espone: come le citate Lia, Rachele, Sara e Rebecca anche noi chini nel fardello ad un' obbedienza terribile ("dite l'inferno/ del dominio perfetto del Padre") del cui amore però non c'è ombra sulla pelle. Eppure, proprio qui, a incalzare nel dettato non c'è benevolenza, non ci sono attenuanti per chi sulla terra, celandosi dietro le convenienze, dell'umano consesso è predatore ("tanto, nel frutteto-chi lo vede?"). Luogo centrale questo di una Storia in cui giustizia e amore sono progressivamente calpestate (i più non sanno nelle illusioni l'inganno di un secolo crudele , ci dice ) e che nella sezione omonima ha la cucitura esatta del testo. Infatti, nella risonanza del mito a cui ricorre, con chi possiamo identificare questi anziani lascivi e detentori del potere a colpire i giovani che non si piegano, e sempre più dentro un'avidità in nome di un divino che non accolgono? Siamo noi ognuno con la propria responsabilità di uomini e cittadini? La chiesa stessa, forse, arroccata dietro a un Padre ancora e sempre, ai suoi occhi, l'eterno colpevole? Montini non dice, ci lascia alle nostre interrogazioni, nella freccia però di un'Italia definita da lui terra indifferente ("lacrime tante,/amore niente"). Pure, il percorso continua, non smarrisce l'alto delle sue ombre, piuttosto le accetta compiutamente in sé rimodellandosi diversamente al Padre inchinandosi al mutevole, "Signore dell' acque-/ sterili il torto e la ragione", in invocazione sublime:"O Tu non vista radice,/o già avvenuto colloquio". Conferma dunque di un antico procedere col divino che si inerpica anche tra i sassi e le ferite dei nascondimenti e dei silenzi a noi inspiegabili, della rabbia allora e dei graffi a dire il bisogno e la paura, quando la non più cupa disperazione. Eppure, è proprio qui- ma forse, e lo sottolineiamo, è un nostro eccesso di interpretazione- il vero scarto del libro, il sorprendente e appassionato rovesciamento (che lo renderebbe esemplare ): se un'unica Croce accorda ardendo continuamente "le colpe del Padre,/le colpe del Figlio" a conferma di un redenzione non compiuta in una separazione tra i due comunque continua, Montini nel suo ritorno pare dare la connotazione di quasi di offerta, di amore all'amore mancato, nella condivisione stessa col Padre del suo eterno dolore. Su questo crinale però ci fermiamo, alte e altre le suggestioni e i richiami che andrebbero insieme, in dialogo aperto, affrontate. Aggiungiamo soltanto la doverosa sottolineatura di una lingua e di uno stile ricco, assai efficace nella difficoltà e nell'urgenza del dettato (la cui sola pecca a nostro dire è in un eccesso di aggrovigliato- più che ripetuto-livore) a conferma di un itinerario valido e assolutamente personale.
Id: 959 Data: 26/02/2016 12:00:00
*
 Clara Nubile - Poesia - LietoColle
Clara Nubile - Poesia - LietoColle
Squame
Quarantenne traduttrice editoriale e scrittrice che vive fra l'Italia e l'India dopo alcuni romanzi e una raccolta di racconti Clara Nubile esordisce ora anche in poesia con un testo che ha al centro appunto il subcontinente asiatico, luogo all'autrice evidentemente caro non solo per motivi professionali. L'occhio, l'anima però che guidano i versi entro un andamento prosodico segnato da ricchi spunti lirici sono quelli di una vita ai margini dalla Nubile e l'amore cui si accompagna scientemente desiderata, aggredita e perseguita a fondersi in una quotidianità di estrema povertà e violenza per gravità di squilibri sociali e una natura anch'essa ora avvolgente ora inquietamente incalzante. A determinarne la direzione (ma in questo caso sarebbe meglio parlare di non direzione per il carattere di un esistenza sovente priva di logica e di quell'ordine forse agli occhi dei più necessari) è un imprinting ramingo che non tiene conto di ferite e smarrimenti ma che pare nutrirsi costantemente di un qualcosa di inesprimibile (squame appunto?) ricco di evocazioni e arcaiche suggestioni più che del mondo condiviso che li attraversa (e che attraversano) di un sé piuttosto scongelato, libero di agire al bisogno in consonanza alle rincorse dei propri sogni e ribellioni. Un addestramento questo che avviene allora entro una grammatica interiore che rifugge dall'ordinarietà di una vita incapace "di stabilire diottrie,/distanze" , di possedere decaloghi in un consumo che stordisce quasi sotto quel cielo di un Dio avvertito come anoressico e sazio, quel cielo meridionale di un Salento anche che sovente si riaffaccia tra echi di compressione e ancestralità di ritorno nel dilatarsi delle quotidiane reincarnazioni ( "E le ossa buie dei nostri antenati/- o erano forse gli ulivi?-/ci facevano da ombrelli,/e su di noi non pioveva mai"). Nell'irregolarità di un antagonismo che come per febbre ne altera il battito vediamo allora le due figure, tra boschi e balconi , spostamenti e sconfitte provare a diluirsi come gocce entro un amore che ricercato "venerando il tempo della polvere" li salvaguardi per confidenza solo con la severa bellezza della natura (in quella cosciente illusione che è la forza vera del testo) da una tecnologia e da un'età maledetta (incisiva in questo senso i versi in "Scardinati" dei reparti oncologici). Così il salto dai boschi della prima parte ("Boschi" ne è infatti il titolo) nella seconda ci immerge direttamente tra le strade di una Bombay (secondo la vecchia nominazione) oscura e violenta ma comunque sempre disperatamente sacra. Sacralità che nella dominazione asfissiante di un aggressività maschile (a parte l'avvocato musulmano che tenta di proteggerli) ora sottesa ora spregevolmente diretta (bambine "violentate dagli dei azzurri" a chiedere pietà o rupie) sembra preservata in questi versi dalle tante figure femminili che s'intrecciano nella presenza a regalare grazia nella miseria delle strade (esemplare in tal senso in "Kalina-Kurla road" la donna che "c'era sempre", "trionfale sul suo letto di ferro battuto" con attorno "un Impero di carta straccia" a tenere sempre con sé un librino "fra le gambe scavate dai secoli", "un breviario dei sogni" o "bestiario"). Uno sguardo allora quello della Nubile fermamente radicato nella terra (tante tra l'altro le immagini delle notti e dei sonni a dimenticare il proprio nome a contatto stretto col legno o col suolo) nella nota a perdere su tanta disperazione per uomini e dei che a suo dire continuano a sbagliare. Desolazione nel proseguo (e che ha nella bella immagine della città vista con gli occhi di un cane una compiuta descrizione) che si dilata nel sapore dell'annuncio dell'Autunno di un tempo (anche del proprio amore) e di una parola ormai estinta e comprensibile, forse, solo dai morti che "chiocciano dentro di noi" ("macchie su vestiti di seta,/quelli che non nascondiamo: l'unto/che rimbomba fra carne e apocalissi"). Andando a concludere allora è un buon testo, poco ordinario questo della Nubile, ricco per autenticità di dettato e per franchezza di scrittura ma che non sempre emoziona e coinvolge difettando a volte di un eccesso di autoreferenzialità che limita la lettura. Ma che comunque merita.
Id: 954 Data: 19/01/2016 12:00:00
*
 Roberto Mosi - Poesia - Teseo Editore
Roberto Mosi - Poesia - Teseo Editore
La vita fa rumore
Autore prolifico e sempre entro un'incisione critica ed etica del reale, già come dirigente della cultura alla Regione Toscana e come redattore di "Testimonianze" (la rivista fondata da Padre Balducci), Roberto Mosi conferma qui tutto il suo timbro insieme passionalmente partecipativo e incalzante tra le maglie di un contemporaneo riportato sempre alla dimensione cruda delle sue spoliazioni e delle sue dolenze. L'evento- l'occasione, il pretesto- da cui prende le mosse il libro è un corteo di protesta che ha visto sfilare tanti giovani, tanti cittadini per le strade di Firenze nel luglio 2013 dopo la decisione di un giudice di anticipare alle 21 l'orario di chiusura della Libreria Cafè de la Citè, luogo di aggregazioe culturale e sociale di non poca importanza. "La vita fa rumore" nella scritta in rosso di un cartello (e che fa da prologo nella foto dello stesso Mosi nella copertina del libro) viene ripresa dall'autore e segnata a paradigma di un contrasto sempre più evidente tra urgenze, sempre più comuni a molti purtroppo, e non ascoltate e un convivere civile sordo, monco entro corde e sacche di indifferenze e nascondimenti (quando non di repressioni). Perché la vita attorno a noi preme- ci viene ricordato- ci tira per la giacca e ci scuote, ci mette a nudo con la sua palestra di interrogazioni e perdite. A partire dal lavoro, sovente, cui Mosi dedica buona parte del libro ricordando dapprima le lotte di conquista dei più elementari diritti (a ritroso tratteggiando figure epiche come la Tosca e lo sciopero delle trecciaiole) la cui eredità viene messa poi a rischio nella precarietà di una condizione odierna il cui futuro sembra farsi ogni giorno più oscuro (non a caso il libro ha la sua dedica per i giovani fiorentini in cerca di occupazione). Alla poesia, allora, viene esplicitamente chiesto da farsene carico nella denuncia e nella testimonianza (vedi la lavoratrice in "Manifattura":"Parla delle nostre ide,/tessi il filo della memoria") di un canto ormai senza più versi se non quelli rappresentati dalle grida degli operai di fronte alle sirene della polizia, dei tanti migranti (mirabilmente tratteggiati come figure in un mondo di uccelli) e dei tanti lavoratori- neri- in nero nelle nostre campagne che coi tanti dispersi bussano con la loro fame, con le loro mani direttamente ai nostri infingimenti. La dignità smarrita nei lineamenti e nelle strade allora tenta una fuoriuscita negli appelli del giorno a cui queste pagine danno volentieri credito e voce spingendoci ad una misura, ad una tenerezza di luce, che in quanto umana non ci è mai estranea e, dunque, tanto meno diversa e che rappresenta la gemma di bene del testo (tra i tanti l'infermiera del manicomio, il vecchio ferroviere "capovaccaio" "che segue lento le greggi/ ai margini di lontani deserti", l'addetta alle pulizie che digita appuntamenti d'amore col proprio uomo). Il riconoscimento reciproco, l'interconnessione, si sforza così Mosi fino in fondo di far risalire come i valori forti a vincere quel mercato delle anime cui tutto per ogni sofferenza è a saldo seguendo (come lui in "Ospedale") tracce di storie e di figure attraverso i tanti padiglioni della vita per orientarci- ricalcando le sue stesse parole- nei labirinti delle nostre notti infinite. Ognuno guerriero contemporaneo delle lotte di tutti i giorni, novelli Ulisse la sera a casa come tornando a Itaca, nel sogno di un "incontro con altri/ cieli, con la sua stella cometa".
Id: 950 Data: 08/01/2016 12:00:00
*
 Francesca Simonetti - Poesia - Edizioni del Leone
Francesca Simonetti - Poesia - Edizioni del Leone
Per sillabe e lame
Fare della poesia un ponte tra finito e infinito: in questa tensione ambiziosa si muove la scrittura di Francesca Simonetti, insegnante e autrice siciliana di non breve cabotaggio. Al termine di questo libro al lettore, però, resta semmai più l'impressione di un versificare segnato da antiche ferite alle quali dare, nel lenimento ontologico di una parola che rinominando ricuce e annulla distanze, spazio di lettura e incontri di mondi nuovi. Non terreni però, si badi bene, giacché per l'autrice il nostro è un luogo chiuso, se non di morte comunque di reclusione e di annullamento. Così se in apparenza l'anima si muove sempre rivolta al cielo ( a spazi siderei che per eccesso di astrazione sovente poco a chi legge rischiano di comunicare) è il ventre nero della memoria e del suolo a pronunciarsi cruentemente, a bussare senza inviti tra le maglie di un quotidiano stonato, privo d'ordine, nel segno di una " storia infinita/ che si eterna maligna". E, di più, nella lotta di contraddizioni che contraddistingue il testo, nella ricerca di un'armonia che venendo dalla lingua possa liberare varchi è piuttosto la nota, la sillaba rimossa ad imporsi con forza con rigurgiti ed esiti poeticamente validi per autenticità di dettato dolorosamente e urgentemente incalzanti (fallendo piuttosto proprio nello spirito che la dovrebbe muovere e cioè - come sostiene Ruffilli nella prefazione- in quella capacità di tradurre dunque per melodia "il dato filosofico-riflessivo in immagine poetica"). Forse, anche oltre le sue stesse intenzioni, perché è una poesia del freddo questa della Simonetti: freddo e distanza da una vita che non ha che vani impacci- e separazioni e silenzi- da proporre e a cui rispondere pur inghiottiti; ma freddo anche come bene prezioso "che tiene all'erta", contro le illusioni del caldo e dei suoi falsi conforti. Condizione umana tutta che però, nella sottolineatura, ha nella donna il portatore maggiore di carico aprendosi qui, per immedesimazione e gratitudine,al significativo dialogo con la poetessa svedese Katarina Frontenson che sa parlare"per chi ha perso il canto" e dare dignità al "silenzio del reale" là dove si celano parole e angosce mute. Perché sono infatti i ricordi dolorosi che la ragione e la parola tentano insieme di chiarire e di tacere a consentire al verso di restare "con voce di canto nella certezza del cerchio" sfidando e opponendosi allo strappo che ci attende (nell'incisivo concetto di chiamare amore le fratture) e a quella morte che "nella nenia di preghiere" consente solo una breve sosta e un'uscita dall'ombra (come il volto del padre che si fa avanti tra refusi e detriti). La morte, già.., davvero inaccettabile per la Simonetti, così quasi come la vita perché compressa come detta in un tempo per noi non eterno e addomesticabile solo rendendolo vuoto nella direzione di uno "stacco/ fra la terra e ignoto". Ma se "la musa moderna è la precarietà" (come da Montale nella poesia a lui dedicata) e dunque nessuno squarcio può svelare nella "illusione/perversa/ d' una possibile quiete" e nulla forse può aggiungere, solo la poesia per fede autenticamente estrema può farsi pane di salvezza e "transumanza/per gli umani trafitti dal gelo". Con questa convinzione e una sincera pietà per il creato tutto (che ha la sua più struggente immagine in "Magie della sera" dove "forse solo le piante che resistono/allo sterminio del sole cocente/ e le foglie sparse sulla terra brulla,/ sembrano piangere il distacco dal tronco/come recise vene") finisce col rispondere pertanto a se stessa e alla propria domanda in conclusione di testo sulla possibilità o meno che ha l'arte di salvare e che è in questa costanza di interrogazione e presenza atta a dare in qualche modo trasparenza ad ogni "storia incompleta" e a magnificare nella liberazione dell'altro in sé (eternato nella gioia ancestrale accarezzata nella giovinezza- "Mani prigioniere") quella finitudine che tanto la sgomenta.
Id: 944 Data: 08/12/2015 12:00:00
*
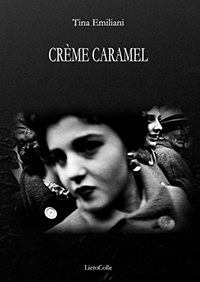 Tina Emiliani - Poesia - LietoColle
Tina Emiliani - Poesia - LietoColle
Crème Caramel
Libro d'amore e dunque libro di vita, di una vita insieme intensamente promessa, accarezzata e recisa per la scomparsa improvvisa del suo lui, dell'amato bene che a meteora ne ha attraversato il cuore e il cielo, questa nuova prova di Tina Emiliani, autrice romana qui al suo quinto lavoro. Così nella resa è proprio bruciante l'aggettivo che meglio va a descrivere il libro nella varietà delle sue incisioni. Sì, bruciante perché arco bellissimo di un dono e di un incontro inaspettato nella reciprocità di corpi e anime finalmente libere e per questo ancora caldo nella sua fine della densità di promesse e dolcezze infinite e poi dunque sempre più fermo, fisso nel dolore alto della mancanza e dello svuotamento, nel sapore amaro di una ferita cui solo il ricordo può arrecare con sé lenimento. Ed è la poesia allora a raccogliere fin dall'esergo da Neruda ("Voglio che ciò che amo continui ad esser vivo/ e te amai e cantai su tutte le cose"), nelle istanze che la distinguono il racconto che nel detto, nella pronuncia può in qualche modo scuotere raccogliendo sotto diversa luce passioni ed emozioni chiuse dal grido di morte. Nel viatico del diario a ritroso la Emiliani ci riconduce tappa per tappa entro le stazioni di una stagione e di un'anima che le ha cambiato, stravolto ma innamorato la vita alla ricerca strenua, sanguinosa, molto, molto femminile di ritrovare, trattenere qualcosa che quella stessa vita e quella stessa anima possa come detto salvare. In un' estenuante rincorsa ecco sfilarci davanti innamoramento, passione, conoscenza e cura reciproca, progettualità e vita in comune e poi l'ospedale, l'angoscia, la fine e l'onda di azzeramento che nel travolgerla la strattona e la inchioda, nell'assimilazione la penetra ma nel miracolo dell'unione (quel fiore, quella rosa che lui amava tanto donarle) comunque non la infrange, non la vince. C'è infatti qualcosa che ha del cristallo in questa scrittura limpida, densa, chiara in cui anche lo sgomento, il ventre colpito e lasciato solo nella regione del lutto dove il terreno frana aiuta a sopravvivere, a ricucirsi sempre, a cercarsi sempre- ché qui poi è l'umana ragione. Scrittura, ancora, in un esercizio di fede che per affidamento e stupore, nella confidenza con la solitudine del male che ogni donna porta con sé, la consegna in alcuni tratti -e non sembri un azzardo nell'equilibrio del paragone- ad alcuni esiti cari ai lirici greci per quel sole e quella luna alle cui scie si rivolge nell'intreccio maestro di aspirazioni e ricordi. Nudità esposta che quotidianamente proprio nei suoi affondi, proprio nell'oro di certa ordinarietà perduta la rinnova: giovani coppie tra abbracci ed effusioni pubbliche, luoghi e gesti cari del ricordo che le fanno sentire, oltre l'intensità dei primi lunghi impatti, più forte la presenza del suo amore bello "che vince il buio" ed il cui calore come l'amore stesso appunto non morendo "lieve si innalza/ e si espande, e fiori gli rubano il profumo". Il grido imploso così piano piano si sfibra, non più mozzo a risuonare entro sé come un gemito, confessa la propria felicità di ricordo libero, intatto, puro a vincere rimpianti di insufficienze e incomprensioni e senza più necessità di costruire mondi di separazione tra richiami e realtà di morte a dimostrazione infine che l'impasto dell'antico lievito "è rimasto vivo", l'uomo non più perduto ma accanto a sé ("e che importanza ha se gli altri non ti vedevano") sul Ponte Carlo a Praga nell'esaudimento di un comune sogno. Un testo in conclusione assai degno in cui la poesia in assunzione catartica porta anche teneramente, disperatamente, finalmente diremmo, in superficie quel po' di valore terapico che è nelle sue corde.
Id: 943 Data: 01/12/2015 12:00:00
*
 Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
Giovanni Stefano Savino - Poesia - Gazebo Libri
I gomiti sul tavolo
Il miracolo e la bellezza dell'espressione artistica è sottesa anche in quella grazia di gemme che del campo sanno l'attesa e la semina, il tempo di sua esatta compiutezza nello spuntare ad eco del giardino. Maturazione, dunque, ogni volta propria nella rimessa delle direzioni e dei mondi e senza tema di profluvi, anche, la parola, il gesto finalmente nella luce per il dovuto abbraccio. Quell'abbraccio, verrebbe da sottolineare a più riprese, che viene soprattutto per fatica e carico d'amore, di vita ecco che reclama le proprie ragioni e i propri slanci insieme alle proprie dissonanze. Vita per questo ancora più aperta- al suo limite vera- negli anni tardi della vecchiaia il cui canto sovente non comprendiamo, o per meglio dire, non scorgiamo negli inceppamenti di un orizzonte in cui forse non crediamo appieno. Eppure, è questa l'età a cui nel ritorno la vita stessa, per custodia, si raccoglie nella sua definitiva creazione e che in poesia sovente ha dato in diversi autori i suoi esiti migliori (Yeats probabilmente su tutti fino, per restare a noi, a certe cose di Saba, Ungaretti). Fra questi il fiorentino Giovanni Stefano Savino per cui davvero la parola caso non è un abuso. Classe 1920, ex impiegato delle poste e soldato durante l'ultima guerra, insegnante poi dalle elementari alle superiori di italiano e storia fino al 1979, scopre in sé solo dopo i settanta (più precisamente nel 1994) quel deposito in versi che più non lo avrebbe abbandonato in esercizio- ed offerta- esemplare di scrittura. Il merito della cura e della scoperta, giacché come in ogni piccolo miracolo l'incastro è nell'incontro, è nella sapienza autoriale ed editoriale di Mariella Bettarini e Gabriella Maleti, sue concittadine (per nascita o per adozione) ma soprattutto da decenni alla guida di quella pratica di vita e poesia tra le più illuminate, per palestra e per scardinamento d'impronta, che porta il nome di Gazebo libri. Così ecco - nella puntuale dicitura di Anni solari (a comprendere in successione la cadenza periodica dei testi)- l'ultimo suo lavoro, il decimo, raccolto tra le primavere del 2013 e del 2014. Dalla collina di Fiesole, dove ormai da diverso tempo risiede lasciato il centro storico, il suo sguardo abbracciando la conca a valle disteso sulla Cupola del Brunelleschi si fa rovescio ed accordo di rive tra i lungarno della memoria e del cuore e i lampioni di un presente il cui segno è tutto nella grafia incerta e sofferta di una parola a cui ancorare nel dialogo scioglimenti e bagliori di una storia non finita. Così oltre a caso e miracolo è proprio la parola lavoro a rendere adeguatamente conto del compito di registrazione anche minima di quegli elementi i cui eventi reclamano vita principalmente, quando non unicamente, negli spazi interiori di volti, voci, mura che si riaffacciano. D'altronde è il timbro stesso del titolo a richiamarlo: i gomiti sul tavolo- la testa tra le mani- ogni giorno, ogni giorno avanzando (o retrocedendo a seconda dei richiami) di un passo, di una parola nel cerchio di una scrittura che si dona tutta nella veglia e nel sudore che venendo dal sonno al mattino lo sospinge al suo verso. In questo soldato, miles sempre nella misura di un passo che tra le stanze e il mondo di fuori coi suoi uccelli e le sue luci del tempo solo, immanentemente unico dell'uomo ne fa l'umile guardiano di se stesso fra rimbalzi di antiche gioventù di Santa Croce o Via da Verrazzano, di marito e di padre, in un autoritratto che viene"dalla sassosa riva dell'Arno e da un pane raffermo" e in un essere solo, ora, per "nascita non scelta". Pur uomo ("colonnato definito in tutte le sue parti") l'immagine, allora, è ancora quella del sé bambino a fermare per sé solo sulla carta "l'altalena dei giorni e della corda" nella bellissima analogia del ritorno senza scarpe a casa tra le spigolosità dei sassi e il come se ne andrà lasciando le scarpe sotto al letto ("a metà strada il volto di mia madre"). Respiro in polifonie d'età a levare del vivere l'intera fatica che in definitiva però nulla poi si trova a chiedere se non, nel sole, l'essere ogni volta parte di un giorno che per Savino, in Savino- caparbiamente- non può che compiersi in ascolto e trasfigurazione d'ombre. Trasfigurazione che viene, come ci sembra indica anche lo stesso Giuseppe Panella nella illuminante introduzione, per la necessità "di capire affidata a una rievocazione del passato che permetta di trovare ancora il segno di ciò che è stato", giacché in quest'autore "scrivere equivale a vivere e vivere serve a continuare a vivere senza disperare" in una scrittura che è racconto "di poesia come sorta di verifica sul campo"- in un' esistenza che appunto ha nell'Arno figura dello scorrere e dello svanire. Trattenimento, a perdere e ricominciare del tempo nella consapevolezza delle evanescenze (in fondo come tutta la vita stessa-"passerà, passerò") che nella partitura che non cambia nel morso ossessivo degli endecasillabi ne fa esempio tenace di uomo e cronista insieme che su ignota soglia si ferma in attesa (parafrasandone un verso), a mutare il silenzio in parole "come fiori, per i campi". Disposizione di parola fattasi bastare nella stretta della propria umana e perciò caduca sorte che in un'epoca insanamente inquieta come la nostra ci appare come una delle ultime vere e perciò più care lezioni "all'attracco sulle rive del nulla". Senza dilungarci, allora, ma rimandando all'avventura di una lettura che di cuore raccomandiamo (corredata nella parte finale da numerose testimonianze critiche e d'affetto) ci piace in conclusione lasciarlo come lui stesso invita a fare, a pensarlo (nella stessa intensità della fotografia della Maleti che lo testimonia): al mattino con la testa fra le mani, all'alba, "coi gomiti sul tavolo in cucina" pronto a ripetere la vita- il suo teatrino abbassata la tela, tutti andati via. Il verso, "intatto fiore nel suo gambo verde", custodito come una volta il pane da portare poi alla madre- a tutte le madri.
Id: 933 Data: 02/10/2015 12:00:00
*
 Raffaele Castelli Cornacchia - Poesia - Italic
Raffaele Castelli Cornacchia - Poesia - Italic
L’alfabeto della crisi
Può la poesia, con le frecce che le sono proprie, porre domande e alternative diverse rispetto al consueto racconto, alle consuete analisi circa una crisi economica che ormai da più di un lustro brucia consumando pianeta e anime? Può soprattutto, per questo, smuovere coscienze già scosse- già provate e senza direzioni- e indifferenze di saccheggio, anche, per quel che rimane tra secche di vita? Coscienza di una scrittura mai alternativa ma nella radice piena della vita stessa, appunto, e che ha nella voce della misura delle cancellazioni e delle restituzioni lo spirito del proprio- e del nostro- fiorire. Diversi gli autori, allora, che su questo tema si sono tentati e si tentano (mentre è in stampa per la cura di Giovanni Dino per la Libri Thule di Palermo una ricchissima antologia, un ricchissimo coro proprio di "Poeti contro la crisi"). Tra questi Raffaele Castelli Cornacchia, della provincia di Mantova e insegnante (a Brescia) oltre che poeta e autore di testi teatrali, il quale in questo libro nella struttura di ventuno testi (ognuno scandito in più movimenti) ad indicare esattamente il numero delle lettere dell'alfabeto (ma qui a ritroso dalla Z alla A segnate nel titolo dal neretto della prima parola) ci consegna, aprendosi a graffi sempre più rabbiosi, un violentissimo e dolente atto d'accusa contro un sistema di valori (?) e di poteri nel quale (pochi miseri esclusi) i più sono chiamati a sentirsi responsabili. Nel tono della ballata (Castelli Cornacchia componendo fra l'altro spettacoli per adulti e bambini in collaborazione con attori e musicisti) sprofondiamo così con lui senza sconti entro quella quotidiana scena di saccheggio, decomposizione e fame che sempre più nelle forme più diverse andiamo a conoscere e a provare ma che, illuminate bene nella dinamiche di una storia che non da adesso affonda le radici del proprio sussistere in uno status quo che ha poco di democratico e imbonente , queste pagine con efficacia riportano nella sua origine di vita "e tempo relegato a rango di merce". Babele allora, è il caso di dirlo, di comportamenti e lingue nel quale la perpetuazione di piccoli e grandi imperi, di piccole e grandi cancellazioni, di dignità calpestate son riportate a partire dai sottotitoli a quel frasario, subliminare o meno, con cui il gioco direzionato delle crepe, nel possesso delle anime, si apre prima ancora nella mente che nelle tasche. Esemplificativa in tal senso è dunque la presentazione stessa dell'autore in seconda di copertina a chiarire il senso del lavoro. "Le parole- avverte- sono come la sabbia del mare, si fanno fango, s'induriscono formando dei mattoni con i quali si costruiscono muri e case. La poesia, allora, sgretola quei mattoni, rende scorrevole il discorso, e riporta la sabbia al suo mare". Opera di carico e decomposizione, nel rovesciamento stesso delle decomposizioni, che si rivela nell'imputante inserto dei sottotitoli nei quali la scena già nei termini si racconta nei luoghi e nelle dinamiche di una mascherata rovina senza ritorno. La demagogia, l'egemonia culturale, il lavoro, la globalizzazione, il mercato, il liberismo, il debito pubblico, la finanza: in ordine sparso eccone solo alcuni nel caleidoscopico frantumo delle identità messo in scena qui nel sarcasmo dolente di un espressionismo che per colore e grottesca iconicità della scena ci riporta, forse non a caso, a certo clima pre o dopoguerra. Si direbbe però , a ben leggere, un' Apocalissi già scritta (tutto tornando e presentandosi di nuovo a confutare il presente come se la storia non avesse nulla da insegnare) nella quale Castelli Cornacchia, come detto, non salva quasi nessuno, la gente, il singolo muovendosi come se dapprima fosse stata sfollato da se stesso. Eppure, come in ogni "malattia che potrebbe guarirti, ma anche farti morire", alla piaga bisogna impastarsi, saggiarsi- perdersi anche- per una fuoriuscita finalmente scevra, ripulita da possibili incrostazioni da ricaduta. In questo dunque il senso forte di una scrittura che non si perde sterilmente in se stessa ma che giustappunto secondo uno scardinamento civile, nella ridefinizione, o per meglio dire, nella riappropriazione della propria storia e delle proprie misure di determinazione sa indicare il solo-e necessario- presente nell' orizzonte possibile. Così nella cronistoria di una crisi (parola che nella propria etimologia- dal greco, guarda un po'..- ci spinge nel turbamento anche alla scelta che comunque senza possibilità di fughe siamo chiamati a fare) lo sguardo si sofferma, a partire dagli anni ottanta, da un costume di vivere ben al di sopra delle proprie possibilità a sistemi di regole imposte a scavalcare i più elementari diritti, da guerre (?) di cortesia i cui effetti stanno cambiando il profilo del mondo ("le peggiori guerre quelle, quelle fatte per il bene comune/ quelle di un padre che si dimentica del proprio padre") a un potere bancario- usuraio, come nel medioevo- al servizio dei potentati ecclesiali ed economici: e poi, in una corsa sempre più incontrollata, dal relativo aumento dello squilibrio con gli ultimi pignorata la vita di milioni di individui fino a un lavoro che ci rigetta, rigettandola, su una terra appena arata (come il mare sulla riva il corpo dell'ultimo colpito) e, ancora, a parole come deregulation o promesse di taglio del debito ad alzare sbarre di separazione e prigionia. Il tutto anche sotto l'azione complice di intellettuali che come gli altri "nell'oblio/ temono di non esistere" perdendosi in pensieri fuori tempo e di una politica- soprattutto- presente essenzialmente nel rafforzamento di un potere ("conferitogli da dio, dagli altri e più su: da noi stessi") che quotidianamente si reinventa nutrendosi "nel profondo d'un bisogno superficiale" in cui nel crogiolo molti di noi sovente rischiano di evaporare, occultare la propria responsabilità- e vigilanza- di cittadini. Responsabilità e vigilanza a cui questo libro nel suo merito maggiore richiama strattonandoci con forza grazie a una lingua che, come detto, proprio nella virulenza delle forme radicalmente compie se stessa facendosi cultura: società, prima di tutto, ed epoca interrogata a partire dai vuoti e dalle mancanze che ha di se stessa grazie a scrittura poetica, finalmente, edulcorata da orizzonti da cartolina. Sì, parafrasandone e rovesciandone un verso: è proprio poesia questa.
Id: 924 Data: 16/10/2015 12:00:00
*
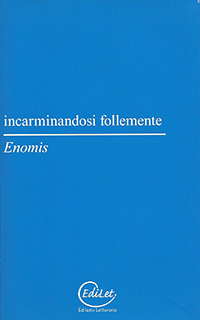 Enomis - Poesia - EdiLet
Enomis - Poesia - EdiLet
incarminandosi follemente
"Enomis è un invenzione di S. Carunchio (dottore di ricerca) il quale ha trovato i testi di questo autore , per caso, in un suo angolo d'uno scantinato, nel corso del suo operare come bibliofilo". Così, in terza di copertina, viene presentato al lettore l'autore di questo libro dietro al quale però non è difficile pensare celarsi il doppio letterario di Carunchio stesso (che di nome infatti, come da lettura al contrario di Enomis, fa Simone), figura fittizia insomma grazie alla quale muoversi liberamente gettando magari curiosità- e scompiglio- tra lettori e critici. Operazione non nuova ma per questo coraggiosa perché soprattutto in questi casi quando il dettato non è supportato da un adeguato e vero, provocatorio, dire del mondo, il rischio della banalità nel vaniloquio è sempre dietro l'angolo a confermare piuttosto una tendenza a servirsi (non servendolo..) dello strumento poetico per spegnersi dietro scritture senza altro interruttore che quello di un solipsismo privo d'uscita. Per buona parte è il caso di queste pagine, nel senso del rischio intendiamo, il nostro Enomis- Simone gonfio di letture di poesia italiana e francese e di filosofia, soprattutto giuridica, "intellettuale visionario e viaggiatore" con "venature moderne e romantiche" (così, sempre in terza di copertina, nella descrizione allo specchio) del quale questa è la prima prova di altre uscite successivamente ("Ondivaghe per Lepisma nel 2014 dopo "Nudi vermi" per Poiemata nel 2012). Poesia di "sogno e di ragione", come l'ha definita Elio Pecora, che ha però nei tic e nei diktat ossessivi di un pensiero sempre acceso, sempre interrogante, sempre auto-fustigante la freccia e il limite evidente di un orizzonte ora rivelato ora negato per una impossibilità connaturata e sempre ritornante, sempre ostacolante, di una semplice- se non per brevissimi istanti- liberatoria e respirante, dimenticanza di sé. Il tormento dell'equilibrio, nell'instabilità, è allora il punto nodale del libro; non tanto, si badi bene però, relativa ad una condizione umana tout court quanto così strettamente personale, appunto, da potersi rivelare solo raramente in qualche modo paradigmatica e dunque, per noi- anche per gli altri- illuminante. Volendo allora seguire le tracce di un discorso poetico così fortemente annunciato nella "ricerca del sublime" anche tra gli oggetti e i luoghi più oscuri del quotidiano, di una bellezza che per Enomis trova misura con la danza soprattutto ( oltre che con la musica e il canto ) letterariamente a suo dire legata in poesia colla giovinezza e al ridare nitidezza a ciò che è confuso, a sorreggere la lettura è piuttosto una fortissima malinconia, una dolenza di fondo che, sotto il dominio di un io che (come direbbe ancora Elio Pecora) sovrasta instancabile, ce lo rende alla fine più caro tra goffi propositi e fallimenti diurni, tra evanescenze oniriche e confuse idealità di notti infinite (con punte che ci ricordano qualcosa alla lontana di Lautremount e Laforgue) . Di più, lo riscatta, dicevamo, e ci cattura nella perenne sconfessione di un sé passivamente ed eccessivamente allo specchio. Vanità di viaggi, di visioni autodivoranti, di salite e di incontri di mare: è questo spossarsi continuo a chiedersi e a negarsi aiuto entro spirali di inaccessibili accordi, di irrivelabili risucchi a ricordarci allora (seppure non sempre nella volontarietà delle intenzioni) quella permanente inarrivabilità a se stessi che altro non chiede se non il cogliersi in mancanza, anche di speranza se fosse, sì.. come in "Tappeti di colore" dove nella struggente confessione ne fa "punto di partenza". "L'umano/ non si è ancora con fiducia abbandonato/ all'oscura e misteriosa memoria del creato", ancora (in "Rovine), a dire tra i denti- e in subitanea, mortifera dimenticanza- quel fluire pietoso, senza rancori né perdite, di un paesaggio che nel riconoscimento teneramente si leviga- e ci invita- "al carico di tutte le penitenze della vita" (di una vita che altrimenti "a volte, /assomiglia ad un'insonne/veglia funebre per la morte/ di un'innocenza che, in verità,/non si è mai verificata"- "Canto lugubre"). Forse allora, nella progressione del libro, nella consapevolezza che l'uomo "non può essere/ improvvisamente/ diverso" potendo"solo camminare nel mezzo della sua umanità" basterebbe essere proprio in questo, "minutamente" (come da omonima poesia), minuziosamente umani, dimenticandosi e annodandosi al mosaico divino in quel soffio per pochi istanti appena percebile ("quando il ritmo del respiro/ si accorda a quello della mente"- "La brezza azzurra") in quell'abbandono "al pensiero del creato,/ nella sua eterna creazione" che in "Magica contemplazione e melodioso presente" prorompe poi finalmente in canto "con una sconosciuta/ armonia di fondo:/ una magia di allegoria: una danza:/mancanza assoluta di prigionia". Mancanza di prigionia che si rivela allora per tenerezza, quella tenerezza che l'uomo all'uomo sovente nega a partire da se stesso, Enomis dimostrandolo- e mostrandolo- nel soffertissimo tentativo di suo scioglimento in parte realizzato e che ci pare il punto vero, la direzione interessante di una scrittura di cui non conosciamo, però, gli attuali approdi e a cui auguriamo (valendo anche per ognuno di noi) più umile pace.
Id: 922 Data: 15/09/2015 12:00:00
*
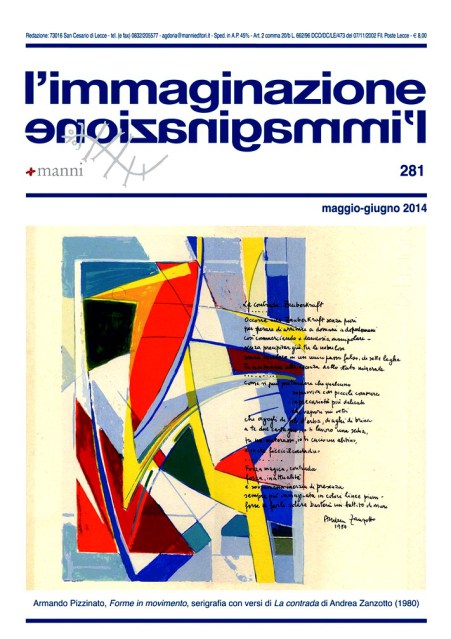 Aa. Vv. - Rivista - Manni Editori
Aa. Vv. - Rivista - Manni Editori
l’immaginazione
Ricco di spunti e riflessioni questo numero de L'immaginazione per buona parte dedicato, nella sezione "Per ricordare" con cui la rivista si apre, alla preziosa figura di intellettuale, intessuta a tutto tondo come vedremo, rappresentata da Paolo Volponi. Preziosità a cui ben si richiama Fabio Moliterni e che qui riportiamo subito, esemplificativamente a dire di un acume e di un rigore etico e critico assolutamente non marginale nella cultura del nostro paese del secondo novecento. Così infatti Moliterni ce lo presenta (ne Sul Materialismo di Volponi):"Eretico e "fuori canone" sin dagli esordi lirici e poi nelle colate espressive dei romanzi e delle ultime colate di versi- nella elaborazione di una prassi di scrittura ispirata alla più anarchica osmosi dei generi e delle forme letterarie,tra poesia e prosa, tra epica e saggismo- testimone e interprete controcorrente delle diverse mutazioni che hanno intaccato il midollo della società italiana dagli anni cinquanta e sessanta fino alle soglie del nuovo millennio". Ed ancora:"Volponi resta all'altezza di questo presente (insieme con vecchi e nuovi compagni di strada) una delle voci più potenti e necessarie per decifrare in senso antagonista il nostro contemporaneo". Questa ricca introduzione a dire anche della densità del lavoro operato in questo numero per una più esaustiva, seppur ancora parziale ovviamente, sua conoscenza nel corredo oltre che critico anche di semplice, ricordo personale (si veda ad esempio quello di Vito Bruno a proposito di un viaggio fatto insieme da Milano a Pesaro nel giorno della semifinale Italia-Polonia dei mondiali spagnoli) e nella cucitura di fotografie che lo ritraggono tra affettuosità familiari e pensosità critiche tra colleghi (Guttuso, Pasolini tra gli altri). Lavoro, dicevamo, che a poco più di vent'anni dalla scomparsa (e con la contemporanea uscita proprio per Manni dei "Discorsi parlamentari- qui presentato a pagina 53) ci riporta un Volponi sotto la lente delle sue tante sfaccettature, anche caratteriali certo nelle comunanze e discordanze con altri autori ed amici persino in dinamiche a volte di difficile scioglimento (vedi Gian Carlo Ferretti nel racconto dell'incrinatura dell'amicizia per una definizione- a proposito dell'opera poetica- in una recensione su L'Unità). Così, interessanti sono le diverse testimonianze relative alle dinamiche professionali che Volponi ebbe nelle sua esperienze alla Olivetti e alla Fiat , poi da sfondo o spunto pei suoi romanzi ( basti riportare quanto Enrico Capodaglio scrive a proposito di "Corporale " o "Le mosche del capitale" dove lo scrittore coglie con chiarezza "che smateriare l'economia attraverso la finanza e l'informatica, vuol dire sì renderlo più leggero, ricco e rizomatico ma rendendo anche i lavoratori più leggeri e incapaci di resistenza nell'attrito sociale"). Eppure in queste pagine, ed è ben comprensibile, i ragguagli più numerose forse restano quelli relativi agli intrecci con Pasolini. Evelina De Signoribus riporta l'incontro con l'autore-regista alle origini con il riconoscimento dello stesso Volponi nell'altro- almeno all'inizio del legame- della figura del maestro (sul tema del maestro si veda più avanti soprattutto il bello scritto di Gian Luca Piccone) che lo spinge a superare le suggestioni dell'ermetismo e a portare il discorso poetico e letterario nella direzione approfondita delle trasformazioni sociali e politiche. Ad occuparsi invece della corrispondenza (1956-75) di un'amicizia, nata a Pietrasanta nel 1954 nell'occasione di una premiazione, è Daniele Fioretti anch'egli confermando e insistendo sul ruolo di maestro (oltre che di amico, ovvio) che Pasolini ebbe per Volponi favorendo una maturazione che nell'approdo alla più congeniale forma del poemetto in versi ("Le porte dell'Appennino") lo disancora, come lo stesso Volponi riconosce e gli scrive nel settembre del 1960, "fino a stabilire sulla mia paura e poi sulle cose e sulla società dell'Appennino, una scala di valori e quindi a emettere un giudizio". Aiuto che gli venne anche nell'ambito del romanzo ("Memoriale", "La macchina mondiale") con lettere appunto che lo testimoniano. Piuttosto, sarà durante la stesura di "Corporale" che la sintonia in campo letterario fu messa in crisi quando il poeta-regista vedendovi un "cedimento" alla neoavanguardia reagì negativamente- anche se il contatto tra i due restò comunque saldo fino alla fine testimoniandolo il fatto che durante la stesura di "Petrolio" Pasolini chiese la consulenza proprio di Volponi nel delineare la figura del dirigente industriale in crisi date le sue esperienze alla Olivetti e alla Fiat. Piuttosto sul periodo alla Olivetti pregnante è lo studio di Giuseppe Lupo su alcuni testi poetici che, contemporaneamente a "Memoriale", ne fanno riferimento. Su tutti "La durata della nuvola" nella sezione "Foglia mortale (1962-66)" della raccolta "Poesie e poemetti" in cui la fabbrica di macchine da scrivere viene indicata attraverso la metafora del giardino:"luogo virtualmente d'incanto, solo in apparenza rassicurante, dal momento che, al contrario di quanto ci si possa immaginare, nasconde l'insidia della prigione" aprendo dunque l'immagine di Ivrea come idea di città-giardino però "piegata alle severe regole dell'economia e del profitto". In riferimento al versante poetico si segnala anche Giorgio Luzzi coi suoi bagliori in un'analisi che, oltre a intrecciarsi a modi e forme del dettato linguistico in riferimento a una dicibilità del mondo che non sia quella della narrazione pura, invita a soffermarsi sugli eventuali svantaggi il successo del narratore può aver procurato al poeta ricordando che, a suo dire, Volponi è soprattutto poeta. A chiudere è Massimo Raffaeli che ricordando l'importanza del rapporto col gruppo di "Officina" (soprattutto per la spinta al versante in prosa , al romanzo) ci offre una splendida analisi del testo "La paura" all'interno de "Le porte dell'Appennino" - da lui considerato "baricentrico"- e dedicato in epigrafe proprio ai tre fondatori e redattori della rivista, Leonetti, Pasolini, Roversi. Analisi, dicevamo, che non a caso dunque parte da una foto scattata con loro alla metà degli anni cinquanta sulla collina bolognese di San Luca essendo principalmente "La paura" un testo di congedo dalla giovinezza ma, insieme, "anche la premonizione di un altrove o di un trapasso". Tutto nella suddivisione in 7 movimenti e composto di endecasillabi il cui vettore nell'andirivieni spazio-temporale è detto "navicella" nel richiamo alla "navicella dell'ingegno" dantesca del Purgatorio disposta "a un viaggio di espiazione e conoscenza". Viaggio dal quale Volponi ridiscende con una paura che non è scomparsa ma "consapevolmente introiettata per essere metabolizzata e infine utilizzata" giacché riconosciuta come "principio della conoscenza di sé e delle cose del mondo" entro una "verità da pagarsi sempre in prima persona" non essendoci tra l'altro "letteratura che non sia (classicamente, etimologicamente) una cognizione del dolore". Eredità questa, per Raffaeli e con il quale concordiamo, monito per una letteratura di oggi, al contrario, dimissionaria. Terminato il lunghissimo e appassionato omaggio a Volponi (sul quale segnaliamo ancora i versi dedicatigli da Eugenio De Signoribus e il rapporto con la storia dell'arte di Leonardo Manigrasso) la sezione "Per ricordare" si prolunga quindi con i brevi ricordi dapprima del pittore Armando Pizzinato di cui Silvana Tamiozzo Goldmann segnala il rapporto con la poesia di Andrea Zanzotto "La contrada. Zauberkraft"(in "Idioma") a cui era molto legato per l'evocazione in trasfigurazione del proprio paese e poi di Giovanni Ragagnin e del convegno a lui dedicato nel paese natale di Buja nel 2013 ("Giovanni Ragagnin. Dire no al nulla. Vita, impegno e scrittura") su cui Carlo Londero sottolinea, tra gli altri, l'intervento di Marina Marcolini dell'Università di Udine a segnalare una scrittura fortemente legata alle sperimentazioni del secondo novecento- soprattutto negli anni settanta- e "all'immissione di altri linguaggi speciali appartenenti ad altri generi". Delle Noterelle di lettura di Anna Grazia D'Oria particolare ci sembra quella relativa a Giulia Ricci, autrice novantenne col suo "Pizzicato (Omaggio giocoso al Cinque Maggio manzoniano") e tra i testi della sezione poesia (insieme a quelli di Cucchi, Tiziana Sala, Alessandra Pancotti) quello di Armando Balduino, filologo e critico qui nella veste inedita appunto di poeta (la sua unica raccolta, "Cielo sui vetri", è del 1957) con un testo del 1998 annotata su un foglio di convocazione di Consiglio comunale. Dei testi in prosa ci colpiscono su tutti quelli di Ivo Prandin, giornalista e scrittore di fantascienza, in "Parole del vissuto" tra memorie di infanzia e campagna e considerazioni sulla perdita di gioie, seppur piccole, del nostro tempo. A seguire ricordi e auguri al critico Remo Ceserani per i suoi ottant'anni da parte di Antonio Prete e Roberto Barbolini ma che qui vogliamo ricordare nell'arguzia delle sue notazioni con un suo pezzo nella rubrica A piè di pagina (dove ci sono scritti ancora di Prete). In queste pagine infatti, da una lettura del romanzo di Francesco Pecoraro "La vita in tempo di pace"(Ponte alle Grazie 2013), a proposito dei tormentati rapporti tra padri e figli cita, traduce e commenta l'incisiva poesia di Philip Larkin "This be the verse" , a suo dire, appunto, segno da parte dell'autore di concentrato e " disperato disprezzo per i sentimentalismi della famiglia mononucleare borghese ". Sapienza critica che ritorna in Pollice recto dove Renato Barilli tesse dapprima le lodi, a conferma di talento, di Giovanni Grieco che in "Ultima madre" (Feltrinelli 2014) affronta il tema dei bambini strappati in America Latina dai regimi alle madri naturali (con loro sparizione) e poi di "Strategie per arredare il vuoto" di Paolo Marino nel tentativo del protagonista tredicenne rimasto orfano di crescere da solo. Raccomandando le escursioni librarie di Piero Dorfles e l'interessante spunto di Cesare Milanese sulla teologia del Belli che lo indurrebbe più che alla devozione alla blasfemia per empietà e non per miscredenza (esprimendo così il crollo della fiducia nella divinità stessa) giungiamo alla rubrica Le altre letterature con versi dell'autore russo Dmitrij Grigor'ev e della spagnola Pilar Sastre Tarduchy. A catturare la nostra attenzione però nella successiva rubrica dedicata a I nuovi libri Manni (di Larocchi, Fiori, Abati, Sepa e come detto Volponi) sono Giuseppe Fiori ("La conversazione sparita") che nella forma della ricordanza autobiografica ci offre un trattato sulla conversazione e Marica Larocchi che in "Fantasmi" raccogliendo storie al femminile in aree dell'alta Italia ne disegna "il viaggio nel tempo, concreto e interiore, che, dall'industrializzazione lombarda del XX secolo e attraverso la deriva di guerra e dopoguerra, sfiora, tra conflitti, equivoci e tradimenti, il margine stinto e fangoso della crisi in atto". A chiudere Le recensioni con interventi tra gli altri di Alessandro Carrera su "Disunita ombra" di Luigi Fontanella (Archinto 2013), di Vincenzo Guarracino su "Riti di seduzione" di Ottavio Rossani (Nomos 2013) e Francesco Diaco su "Il sangue amaro" di Valerio Magrelli (Einaudi 2014). Tra queste ci è cara evidenziare quella di Donato Di Stasi relativa a "La corona dei dodici mesi" (LietoColle 2012) di Marcello Marciani, prezioso autore lancianese di provata forza poetica sia nel versante in lingua che in quello in dialetto. Qui è messo in evidenza quello che Di Stasi stesso, a buon diritto, considera uno dei suoi maggiori meriti, ossia "di inoculare nella lingua poetologica il proprio talento incentrato essenzialmente sulla nominazione e sulla dissacrazione" (qui incastonato nella scatola classica della Corona sonettifera di stampo realistico-giocoso): "libro rubicondo"," radicale e sempre giocato sul rovescio della significazione" (..) con lauta esibizione di mezzi raccoglie le polverizzazioni esistenziali, proprie e altrui, e le riaggrega, le annoda come rettili, cercando di arrivare al nucleo più autentico, più arcaico del nostro animo, quello che non si lascia intorpidire dai sogni senili di una civiltà vicina alla senilità antropologica e culturale".
Id: 915 Data: 21/07/2015 12:00:00
*
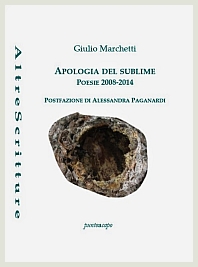 Giulio Marchetti - Poesia - Puntoacapo Editrice
Giulio Marchetti - Poesia - Puntoacapo Editrice
Apologia del Sublime, poesie 2008-2014
Declinazione e canto d'amore come declinazione del respiro e conquista del tronco per incarnazione dal baricentro di anima e forma perfettamente rivelate, questo è nel pensiero e nei sensi il senso e la dilatata prigionia- per sublime solo a tratti espanso- della poesia di Giulio Marchetti, trentenne romano che qui raccoglie l'intera sua produzione- da "Il sogno della vita" del 2008 al recente e inedito "Disastri". Tenendo dietro all'introduzione di Alessandra Paganardi che nel tracciare un piccolo bilancio provvisorio dell'autore ci consegna "l'idea di una poesia capace di abitare il mondo sapendone i vuoti,le mancanze e le impossibilità" invitando a non rinunciare "a sentirsene dignitosamente e costruttivamente parte", ci viene da aggiungere,o da rettificare piuttosto per parte nostra, una forbice sempre più netta tra avanzamenti "verso ciò/ che tu senti mancare", verso il solo destino concepito che dal "cercare l'aria" è dato dall'amore e le ambiguità di distanze non colmabili che non rivelando non possono non comprimere entro abissi privi di spazi di dignità e definizioni. Per questo al termine delle quattro sillogi che compongono il lavoro (la prima edita dalla Joker, le seguenti sempre da Puntoacapo) pensando, come detto, a questa poesia come a una poesia dell'aria e del respiro la sensazione che più coglie, e che meglio forse la definisce, è quella della claustrofobia, della mancanza d'aria appunto, quasi di panico per urgenza di vita compressa se "la paura del silenzio/che trema per un soffio di vita" non spinge al salto, al compimento anche se "non c'è corsa lineare/se la voglia del respiro è la somma/ di istanti isolati". Ci vuole continuità e determinazione per "la ribalta del suono" ci avverte allora Marchetti in una scrittura, in una vita, intesa come scienza di apprendimento e superamento del suolo via imprimatur degli occhi, in quel canale di feritoie e di luce che in ordine e assetto, rivelando, cadenza il respiro (si legga al proposito la poetica di vita in "Luce naturale"). Diario dunque e registrazione senza sconti di appagamenti e perdite senza ritorni di uno slancio che si risolve comunque in apologia (che sempre e soprattutto, nell'insegnamento, è nella misura della resistenza, della fermezza- per convinzione- pur nella perdita dove il dolore stesso nell'assenza non è che conferma) dilatando in un timbro di rabbiosa e dolente investigazione il proprio personalissimo verso (oltre allora le riconoscibili tracce sottolineate dalla Paganardi soprattutto in Saba , Penna e Sereni ) . Del poeta Marchetti ha infatti l'autenticità del porsi a contraltare, di un credo che può sì cozzare ma non recedere preferendo a tratti perfino la consunzione ad una ragione disillusa , andando della natura stessa lo spegnimento privo l'uomo della relazionalità che lo determina (giacché "il ritorno è solo terra piena d'attesa" ci ricorda, seppure nella coscienza che nell'emigrazione dell'amore neppure la casa o il cuore possono realmente contenere oscurità e pulsioni). Nell'arco della narrazione che si dilata nei quattro lavori ( aggiungendo ai succitati anche gli intermedi "Energia del vuoto" del 2010 e "La notte oscura" del 2012) è racchiuso il fervore di un' anima fatto di urgenze e approdi quasi strappati ("Dovevamo solo iniziare a vivere", nell'insistenza sovente dell'amore che viene dal coraggio) e poi resi nello strappo della superficie, alla superficie nella definitiva divisione che viene dall'abbandono ("la vita è l'amore che abbiamo perso"). Così il coraggio della conoscenza (tasto su cui Marchetti insiste sovente a partire da "Il volo" della prima raccolta) al termine del viaggio diventa non più "compostezza del volo" sciolta nella "libera agonia" dell' amore ma anche, soprattutto, soglia e attraversamento del deserto in offerta dolorosa di sé al vuoto in un arrendersi che è piuttosto un atto di forza, varco necessario di "impercebile densità" nella rinascita che viene dall'espulsione di tutto l'ossigeno respirato ( nella confessione giungendo progressivamente quasi ad acquisizione mistica nel freddo dell'inverno toccando l'anima: "Io non voglio uccidere l'aria/ e lasciare che il corpo apprenda/ gli indicibili segreti/ dell'asfissia"). Perché nulla è immutabile, nel lascito di una poesia ardentemente sapiente nell'umiltà di reciproci palpiti come grida d'aiuto sotto l' "eterna sospensione del crollo"- le parole e le voci degli amanti come "piccole lesioni/ del vuoto","memoria di un assenza/ quando è certo/che l'assenza sia l'unica memoria". Dato il tema, in conclusione, scrittura non banale dunque, a eludere con forza nel coinvolgimento stretto col lettore ogni facile mistificazione, ogni compiacente racconto.
Id: 908 Data: 07/07/2015 12:00:00
*
 Umberto Crocetti - Poesia - Calabria Letteraria Editrice
Umberto Crocetti - Poesia - Calabria Letteraria Editrice
L’isola riemersa
Racconto di un'anima che via via riemerge dai promontori e dalle secche di "un dialogo con l'ombra" vissuto e portato con la franchezza dolente e senza sconti di un'età matura che di sé sa infingimenti e sconfitte, abbandoni e impossibili ricuciture, quest'ultimo lavoro di Umberto Crocetti, medico calabrese (ma residente in Puglia) alla sua quarta pubblicazione. Confronto che inevitabilmente, allora, per consapevolezze e parabole delle istanze, non può non cadere nell'assunzione di "toni cupi", come lo stesso autore registra; ma che pure, a dire il vero, proprio nel disinganno, nella sua più che diaristica scrittura sembra in qualche modo trovare l'arma di tenuta della frattura ("Ho un ago nella testa/per ricucire idee/e un filo di paura tra le dita" nella spuntata confessione de "Il matto). Ed è questo che ce la rende cara, perché profondamente onesta e umana la poesia che da queste pagine si interroga e ci interroga togliendo progressivamente ogni velo alle piccole e grandi oscurità che finché non dette, finché non restituite al filtro giusto della coscienza, ci insabbiano nell'inutilità di promesse e tempi non mantenuti. Quel che resta è un peso e un coraggio insieme di difficili ma necessarie ripartenze nella rete di ricordi, figure e movimenti, di quasi impossibili raccordi in cui per larghi tratti solo la corrispondenza della natura, pur distante a volte, pur dominante, pare dilatare in un eco di serene risonanze. Crocetti è poeta colto, infatti, e dimostra di saper sciogliere bene nella spoglia risolutezza di una conoscenza che è anche malinconica riscrittura di sé e del mondo, più concreta e prossima a uomini e persone, quel disordine così tanto ardemente vezzeggiato e di cui forse (come tra i più, o come il tragico protagonista in "Giovanni dalle bande nere") ha saputo o creduto di restare vittima. Così, al proposito, correttamente ci guida Vittoria Butera nella prefazione quando ne sottolinea la capacità di guardare alla realtà facendo affiorare (smaterializzati i luoghi dalla definizione geografica nell'interiorizzazione dell'io) gli aspetti umili delle cose e del mondo; nell'ulteriore aggiunta però secondo noi, anche di una parola che è soprattutto gesto, grido che stagliandosi dapprima oltre la fragilità di se stesso (o da lì partendo sempre in riferimento ad una vigilanza della coscienza spesso ossessiva) sa fondersi e risolversi, tra sensi e forme, nel silenzio della composizione netta del paesaggio dove il pensiero nel desiderio si sospende come tra lentezze e immobilità di destini che si sfiorano (tema anche questo, non a caso, altro punto fermo del libro). Nel centro dell'attesa, dunque, nel dialogo allargato tra parola e foglio (in "quest'ansia costruita sul bisogno/ quando silenzio e suono/ hanno stessa valenza"), come dall'omonima poesia, la linea di partenza - più che d'arrivo- dunque e " limite alla dismisura" ( nel " segreto del frutto che anticipa la semina" ) di una vita e di una scrittura insieme sotto il presagio panico, o il desiderio sì, di un qualcosa che inevitabilmente cadendo andrà a svelarsi (vedi la bellissima evocazione ne "Il silenzio crudele dell'estate":"Quanto manca tra l'alba e questo/ ponte? Quanto potrà durare/ la decadenza vigile dell'ombra?"). In questo pertanto la scrittura ha per Crocetti, nel disumano continuo senso di non appartenenza, in un "tempo che non ha tempo", per fermezza e determinazione del gesto con cui si affida sciogliendosi alla rivelazione comunque sempre benigna delle immagini, valore perfino di disagio necessario "nella logica del passaggio"; nell'impossibilità, infatti, di distinguere voci nel naufragio senza fine delle parole, l'azione poetica, accompagnando quel senso di pietà che sovente trasale dalla terra per le nostre debolezze ed incertezze, come l'amore tutto appare reggere ancora tra distanze e differenze apparentemente incolmabili, avvicinamento che dell'amore stesso ha la sua più capace metafora in "Distanze" dove gli amanti "li tiene uniti solamente una stella/ e il richiamo assoluto della terra" (come il marinaio e l'astronauta qui richiamati nella differente percezione di mare e cielo). Nella consapevolezza in lui sempre presente dell'infruttuosità della conoscenza, sa pure bene quindi che se prendere atto del fallimento è il dolore più grande, più grande ancora è non comprenderlo soprattutto se si è stati molto vicini al volto vero delle cose. Ed è questo pertanto il gesto che può ridare sangue al cuore che ne è privo, nella piena realtà di un dolore che se assunto, come detto, in tutte le sue accezioni alla luce vitale della coscienza è capace di scrostare la realtà dai suoi falsi domini riportandola al suo centro. Altrimenti il rischio, come nei sogni dove nelle proiezioni figure d'altri prendono il nostro posto, è il non aver "scampo da noi stessi" in un rovesciamento dove perfino lo spazio esterno pare stanarci a ricordare la colpa "di non aver voluto superare/ nello scatto il destino", di esservi arresi. Lo scatto, in conclusione, è suggerito nel testo da cui prende titolo il libro in cui se l'isola riemersa è anche quella di un io sconfitto, le insenature allora sono i nodi di un'esistenza che deve spogliarsi dei pesi e dei fantasmi che la trattengono. Nella lotta al demone, "con parole orfane di voce/ inizia il rito della decostruzione" sottolinea finalmente una volta su tutte, per non cadere più, come ne "L'innocente" (la poesia dedicata a Camus) "ad occhi chiusi/ nelle pagine della storia,/come in una cella prigionieri di una promessa". Testo dunque ricco cui andrebbe forse dedicato maggior spazio qui avendo seguito solo alcune delle tracce più evidenti. Solo eccesso, ci sembra, il numero dei testi presentati che alla lunga rischiano la dispersione del dettato.
Id: 895 Data: 26/06/2015 12:00:00
*
 Paolo Pistoletti - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Paolo Pistoletti - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Legni
Classe 1964, umbro residente a Umbertide, Paolo Pistoletti è al suo libro d'esordio per la già preziosa, seppur recente, Giuliano Ladolfi Editore. Esordio non vergine però in quanto tastato, saggiato da una frequentazione della poesia che dal 2010 ha la sua pratica effettiva nella cura e conduzione, con lettura, di un programma ad essa dedicata presso l'emittente umbro-toscana Radio RCC. Luogo allora, il poetico, di racconto del quotidiano la cui scrittura poi si rivela principalmente nel raggio di preservazione di un centro, di una misura ancora adeguata all'umano a fronte delle maglie di un contemporaneo che procede per frammentazioni e cancellazioni. E la misura- ed è questo il miracolo, e la gioia per chi scrive- è quella della famiglia qui nucleo portante di un discorso sul mondo che non si impone ma che si guarda vivere e vive tra incompiutezze o meno generazionali e perdite di riferimento, di separazioni e riconoscimenti di direzione che sovente dicono di noi -come ogni qual volta per sostanza di verso- qualcosa in più e di diverso anche rispetto ad analisi d'altra natura (economiche o sociologiche che siano). Così se la poesia è dialettica di opposizioni in ricucitura delle distanze data per nominazione (in evocazione, in immagini a sferzarci, a rammentarci nella furia e nella dolcezza dei ritorni) l'opera di Pistoletti, in sé stessa casa per radicalità delle impalcature e delle istanze, fa della casa stessa il fulcro privilegiato delle sue osservazioni, di tempi e passaggi insieme interiori e fisici nel collante stretto con una dimensione esterna mai disgiunta ma quotidianamente dilatata in un dialogo di reciprocità e fattualità interroganti. Soprattutto, ancora, il più delle volte nel dire Pistoletti sembra prestare voce non tanto a se stesso ma alla coscienza in divenire e in raffronto del proprio insieme, padre madre figlia anziani genitori, nell'imbuto di galleggiamento e di esistente che nel contenimento al tempo stesso poi li trasfigura e li trascende. Ciò a sottolineare, in un sistema che è il punto di originalità e di forza del libro, la contemporanea appartenenza ad una domesticità e ad una fraternità più vasta, quella umana che non si può eludere ma unicamente, evangelicamente e civicamente, condividere per semplice riconoscimento di se stessi nella verticalità delle passioni. E al proposito andrebbe forse riportata per intero la prefazione con cui Marco Beck introducendoci al testo si sofferma su una sobrietà di visione che ha nella pietas il cardine di prossimità verso chi " intorno a lui soffre, fatica, ama ". Liricità di sentimenti, ed anche su questo siamo d'accordo , espressi principalmente dall'eloquenza dei volti e dei corpi cui è possibile leggere intimità e direzioni. Giacché in quanto poesia nella dimensione pensante del silenzio non può compiersi se non per fragili certezze e subitanee interrogazioni e considerazioni, lasciando poco spazio a verbalità dirette che nulla avrebbero a confermare se non le inappropriatezze di un'epoca in stallo. Distonia dunque tra le proprie inadeguatezze (di parola, di sostanza) e i luoghi a cui si resta sospesi nel tentativo dell'appiglio ben dilatata entro "l'immaterialità di atmosfere, stati d'animo, sensazioni, riflessioni" (ancora Beck) in cui il materiale ligneo nel suo tessuto fa da conduttore in una simbologia vitale che dal casalingo degli spazi si allarga a quello stesso dell'uomo (fino allo struggente paragone del padre nel momento della scomparsa a un bosco a riprendere "la via/ dalla luce che non si vede"). Specchio questo soprattutto dato da due testi iniziali: "Legno di casa" e "Legni", appunto, come dal titolo. Al primo infatti, all'osservazione della forza e della fragilità della casa (sull'età e l'esistenza che oltre noi, nonostante noi, vi scorre) fa da riflesso dal reparto di rianimazione di un ospedale la vita che comunque si moltiplica nelle stagioni della morti che si susseguono. Questa, nella vastità di un tutto che sempre a un qualcos'altro ci richiama, sembra essere "il midollo della luce" che sostiene, nell'onda immensa "forse quello che non si vede" ed in cui lo stesso male pur presente sembra perdere peso nella fluidità azzerante della distesa. Mistero a cui Pistoletti sempre si riferisce tra affacci sovrastanti e piccole metafisiche di interni (in descrizioni che per alcuni passaggi ci ricordano qualcosa di Wallace Stevens ed Edward Hopper) in un intreccio di reciproca percorrenza sovente riportata da meditazioni dell'autore alla guida dell'auto, come a metà strada e nella metafora di un mondo osservato dallo specchietto dove si passa verso l'orizzonte di senso (i propri affetti, le mura care) di "quell'unico punto che conta". Punto la cui chiarezza e profondità di radice, "come l'acqua,/ come la fiamma di questo castagno sul massello della panca", è centrale ai suoi interpreti, la moglie e la figlia forse più dell'uomo del quale rappresentano nelle proiezioni il patto di un cerchio di resistenza al vuoto, di spremitura di "tutto il buio" dai"grappoli di giorni neri" ("Imbronciata", "Vigna") nell'esattezza di un'incarnazione alla misura della trasparenza del vetro, della finestra di là verso l'esterno, superficie a cui vincersi, a cui riemergere come dai cattivi sogni dalle paure dei nostri doppi . Il percorso della coppia così ha proprio in questo la sua forza esemplare, il suo paradigma; tra costruzioni e ferite, tra presagi e scomparse, l'esserci a testimoniare in comunione sempre, come direbbe Beck, nell'amore e nei fatti i nascosti nuclei di verità dell'esistenza. Verità di corpi "che stanno nelle cose" e di anime tese verso qualcuno che aspetta, nel sostegno allargato che unicamente può compierci in dignità di pienezza a fronte di un dettato cui la parola (e non solo quella poetica) sfugge e a cui poter essere uniti solo nell'attraversamento. "Essere uno con quel campo fino all'ultimo giunco/ nel non ancora della terra", ci dice infatti in "Campo", nella consapevolezza che non da soli, nel passo, è il prender conto di se stessi dapprima e poi anche degli altri nell'appartenenza a quel medesimo destino che in "Reti" ha la bella immagine di pescherecci che attendono di tirar su le reti e di esser tratti fuori dal quadro stesso che questa immagine contiene ("come quando un'onda di dolore/ ci fa superare una soglia"). Sorte che all'altro, a ogni altro, in qualche modo ci unisce e fa responsabili invitandoci ad andare oltre la virtualità delle notizie e delle immagini (vedi "Dentro" con i riferimenti alla morte di un bambino nel rogo di un campo nomadi ed alla foto di un barcone di immigrati"carico/con le spalle girate la sorte verso il futuro") giacché nella confusione di tempi in cui le stesse certezze non consolano, nella sofferenza per reciproca recriminazione nei rapporti, lo smorzarsi cristianamente al mondo, il cedere nell'incedere comune è salvifico ed un morire piuttosto il suo contrario: "fiore/che petalo dopo petalo si spegne".
Id: 890 Data: 01/05/2015 12:00:00
*
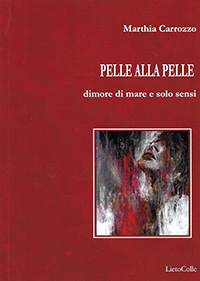 Marthia Carrozzo - Poesia - LietoColle
Marthia Carrozzo - Poesia - LietoColle
Pelle alla pelle
Forse è bene partire dal sottotitolo, "Dimore di mare e solo sensi" , per meglio sciogliersi nella navigazione di questo secondo libro della Carrozzo (a cui segue nel 2012 "Di bellezza non si pecca eppure-trilogia di Idruda", Kurumunni edizioni). Il mare infatti nella vastità delle sue accezioni è fin dal testo d'apertura la madre grande di tutte le simbologie e di tutti gli inviti cui questa poesia si richiama e richiama nella densità appassionata di un eros che in quanto tale non si risparmia incalzando, sospingendo e bruciando elementi, atmosfere, odori nella soddisfazione di una carne mai sazia entro le esplosioni impazienti delle proprie rimemorazioni. Con "Madre di mare" del primo brano infatti già si risolve in canto, nell'apertura della cadenza e delle acque, l'intreccio sensuale dei corpi nel gioco di un maschile e di un femminile a penetrarsi in uno scavo antico di sonorità e armonie, fertili custodie dell'abbraccio che nell'amplesso si risolve in Dio (ed in cui la figura del palombaro che qui emerge ha una valenza più che evidente dell'amante atteso e provvidente che in tutto il libro verrà poi a impregnare di sé corpo e anima della donna). Divino stordimento e sentiero e madre di mare allora l'incontro d'amore perché porta di una ri-creazione, o creazione sempre nuova di sé, che passa per il piacere dichiarato e gridato di unità ricomposte negli incastri entusiasti e scomposti degli organi che nel richiamo delle congiunzioni infinite sembrano vincere caducità e mortalità delle condizioni. Ed è questa, lo diciamo subito, la forza di questa scrittura nella sottolineatura perenne e ossessiva di una bellezza cui non si vorrebbe mai venir meno, come se la vita stessa a volte non fosse- senza voler sembrare qui eccessivi..- che una propedeutica all'accoppiamento, continuo, senza fondo, senza risparmio una volta tra le onde forti del riconoscimento che viene dall'altro (questo a spiegare tra l'altro anche l'esergo scelto dalla Duras della creatura, dell'animale placato dopo l'amore nell'orizzonte che nel farlo risalire lo trascende; e nel piacere il rivolo in più trattenuto e innalzato oltre se stessi per riannodarsi insieme più forti- come in "Difetto"). Ben sottolinea al proposito quindi la Rusticali nella prefazione la sapienza di una parola che nell'intensità di tale dettato spiega, e si spiega, all'interno del suo divenire il processo evocativo e ipnotizzante di una vita che cercandosi nell'ago del proprio disperso abisso ne fuoriesce in ricucitura come avanzamento di terra che penetra il mare. Terra vegliata, custodita, carezzata cui la pelle è per prima allora a riconoscersi per medesima improntitudine e misericordia di superficie, ebbrezza che dal miracolo del tatto dice delle rispondenze semi e solchi di ritrovati orizzonti. Lode, sempre, in una poesia che ne fa per questo l'accento più prezioso, inno d'amore più che un suo discorso giacché l'amore può esser solo levato nel mentre del suo apprendere. Inno sì.. in vibrante pressione a svelare- tramite un insistito e ricchissimo gioco di anafore- fino alla liberazione espansiva e dirompente del coito ("("lo schianto spumoso che ingorga./L'ingorgo che trova ristoro") "il senso nascosto degli idiomi" (qui nel dominio dei significanti sul significato sovvenendo tra l'altro ancora la Rusticali). Lingua vera del corpo quindi che si fa rotta e strappo per ustione di eros che ora accorda e contrasta, ora aggredisce e ammansisce sempre però in traspirazione e benedizione, riflesso d'anima giacché senz'occhi i luoghi e i nomi dell'amore (questi nomi così cercati, così gridati come in richiesta e ricomposizione di umanità tutta) niente altro posson dire, e dare, che sterili morti. Morte ogni volta disattesa piuttosto, come in sospensione di tempo, nella ricomposizione della forma cosparsa e invasa dell'altrui piena (la "rima scucita che non chiede permesso"), la donna incitando alle correnti, l'uomo pronto alla vela nell'invito del corpo che lentamente apre al suo mistero. La risalita, ci dice entro una non comune densità di metafora la Carrozzo, la vertigine nell'intricato nitore "che latra e depreda", non è in sostanza che sconfinamento e allargamento del centro, Amore che non si può rifiutare come la terra davvero non può rifiutare la pioggia che acquieta "ogni mare nel ventre". Preghiera pertanto, "Tabernacolo cosciente di se stesso"... e "di palmi aperti al cielo" nella determinazione dell'arrivo che nel suo plasmare ricolora e sancisce in uno spalancarsi di danza e che in "Piccola ode per chi so io" si fa evocazione in accoglienza di tutte le stelle e tutte le bellezze, all'insù, nell'intelligenza scalza della pelle come detto, nel suo pudore insieme antico e modo osceno, nella sua modestia, in un tutto di compimento che ha la esatta immagine di "boccio capovolto e rosso miele".Nella salmodia il verso allora è quello del seme- umano, tremendamente e gioiosamente umano- come nel ventiquattresimo e quasi omonimo testo in cui nella vena che si fa pulsante, nella vita che si avverte nel battito feroce tutto l'essere sente il proprio compiersi in unità splendente di carne e anima. Ed è questa comparazione quasi dell'incontro d'amore con l'incanto stesso del procedimento poetico il bene autentico di questo libro, eucarestia domestica che l'uomo e la donna non lascia soli ma nel "richiamo ancestrale", nell'eco bruciante del tempo, consegnandoli "al tatto come al senso più consono a Dio" finalmente li scioglie nell'incanto di "due stelle credute distanti", " antico rosario tra le scapole e il ventre disteso". Da segnalare infine in copertina e all'interno i calzanti dipinti di Ester Negretti.
Id: 884 Data: 10/04/2015 12:00:00
*
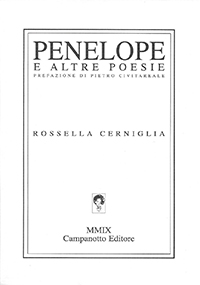 Rossella Cerniglia - Poesia - Campanotto Editore
Rossella Cerniglia - Poesia - Campanotto Editore
Penelope e altre poesie
Fortemente legata al mito forse per interiore necessità, forse per ascendenza d'origine, la scrittura della palermitana Cerniglia trova in quest'agile volumetto pieno e libero scioglimento dapprima in se stessa, in un'andatura quasi prosastica più che lirica (del lirico mantenendo però nodi e ricami di un dettato vicino a modalità diaristiche tipiche di un Canzoniere), e poi nella immedesimazione dell'autrice con la figura di Penelope, paradigma di donna sospesa tra promesse di nuova e definitiva compiutezza e mestizie e incertezze del presente. Ciò che le interessa maggiormente infatti nel ritratto della regalità ferita non è la determinazione o la vigilante scaltrezza di altre narrazioni ma il segno e il tempo della condizione irrisolta consegnata nella prova al rimestare delle cose e dell'anima ("la misera Penelope/ che ancora, ovunque, essendo ancora attende"). Condizione dunque la cui esemplarità viene affrontata e riproposta anche, per dirla con le parole di Pietro Civitareale nella prefazione, in parallelo al "problema della donna del nostro tempo e di un riconoscimento pieno della sua identità civile e sociale". Ed è dunque sul piano dell'identità che si gioca un'interrogazione che continuamente rincorre se stessa tra smentite e appelli del giorno, tra ricerche e distensioni entro una natura che si offre e si nega ai riconoscimenti a seconda delle proiezioni di uno stato d'animo mai quieto. Forma questa (a proposito di mito) che per le per modalità sceniche che vedono la protagonista muovere dallo spazio tutto raccolto della casa coniugale al suo esterno si apparenta a quella del teatro, dal teatro mutuando in più anche la densità monologale che è la vera ricchezza del libro. Qui la lingua si fa e si sa abile nello scandaglio di un femminile che nella mutilazione da colui che la determina grida in se stessa tutta la propria assenza, metà del mondo che nel tormento "guarda il suo resto tolto", Ulisse "sogno naufragato/ in una vita che non ha che il sogno". O l'attesa, come detto, come sovente in questi casi: eterna, infinita ombra di stagioni e giorni che uguali si ripetono in mortificazione di una maturità (di orizzonti, di sensi) per regressione acerba. Ed è l'acqua allora, quest'acqua così presente da guidare più di una volta il canto, il simbolo più evidente di detto processo. Acqua del ritorno, acqua di un sé che si sa infinito, atto all' accoglienza e alla perdita che nell'altro è destinato o sperato ritrovamento, fondamento sempre nuovo, in una valenza insieme fisica e mentale, a vincere nello sciabordio o nella piena della pioggia della vita, entro un"ampio golfo", i santuari spenti del tempo, "lo spento focolare". Perché altrimenti, nonostante la fierezza e la dignità delle opposizioni, l'esistenza rischia nel naufragio di non esser che "viva piaga", "estremo castigo". Questo almeno nell'avvertimento di Penelope nell'inerzia di un destino che rivelatosi avverso la destina alla misura di un apprendimento nuziale inconsueto (e più vicino per certi versi a quello del monaco) in cui tutto sembra condotto ad una "morte obliqua" e al dubbio costante sul proprio esserci ancora ("di me ombra che già più non sono") tra stasi del cuore ed erranza in un percorso che così tanto la somiglia al caro sposo nella sola possibile condivisione dell'anima: il vagare appunto "costretto il cuore nel morso dell'attesa", nella malinconica consapevolezza di esser condotti e decisi da un viaggio a lungo pallido e sconfitto "sogno dal solo Dio sognato"- ed in un riavvicinamento di ciò che il mare ha diviso che nel divino mistero forse si compirà solo nella morte. "Paesaggio andante, mutevole" ai propri umori, ad un tempo attrice e spettatrice di uno spazio e di un'azione esclusivamente interiore, la Penelope della Cerniglia si rivela così nuda desolazione di un avvertito niente che attende il suo tutto, di terreno il passo- ancora- che nell'affondo ne dipinga i contorni (qui eternamente esangui, inerti come le piante del giardino che sembrano anch'esse più non rispondere vivendo della medesima dolente pensosità della padrona in un'atmosfera riportata sempre ad una notte sospesa al ritorno del suo signore). Figura dunque a cui solo il molo è consono, "lo stare di vedetta, lo scrutare" verso "tutto l'altro che adempia" la meta, verso quel mare di fertilità o di morte così ben raffigurato nella carica di contrapposizione e angoscia evocata e descritta in uno dei brani iniziali della seconda parte del libro in cui sono racchiusi altri testi legati in buona parte al poemetto d'apertura ad un sentimento della vita, nell'identificazione con la natura stessa, avvertita come costretta entro una luce che solo tenuamente, per mantenere radici, tenta di fuoriuscire. Oltre che di caducità della condizione umana la poesia della Cerniglia si afferma allora come luogo della sua ritrosia nel "labirinto infecondo" che resiste, di una luce appunto spesso dispersa per mancata partecipazione o condivisione nel bisogno di esseri a cui è rivolta (di qui tra l'altro l'acuta prefigurazione del delitto di Caino in "La luce è sola"). Fedele al mito e ai temi eterni e cari della classicità greca e romana (la giovinezza e l'appassire delle promesse, le " gracili morti/ dei calpestati che tornano alla terra", la gestazione del procreare che nel canto si prolunga) è una poesia che alla distanza finisce col tendere alla preghiera nella preservazione dal male del mondo che viene dalla consapevolezza del senso di fratellanza, "creta impastata dello stesso dolore", che lega gli uomini fra loro. Autrice di lungo corso contando in poesia una dozzina di titoli (ed un paio di romanzi) ci regala con questi versi il proprio coraggioso e sofferto atto di fede nei confronti di una parola nelle intenzioni libera e pura nella rotondità della visione, specchio dapprima di serena bellezza per contemplazione delle cose prima della nominazione e poi di partecipato sgomento alla frammentazione dell'esistente che trova nella vicenda di Penelope il suo più evidente segno. Parola, in conclusione, che si risolve però meglio nello scioglimento interiore dei disagi che non nelle descrizioni e gli slanci di una natura di cui l'uomo sembra scontare comunque, anche nella pronuncia, una permanente irraggiungibilità.
Id: 877 Data: 24/02/2015 12:00:00
*
 Valerio Mello - Poesia - La Vita Felice
Valerio Mello - Poesia - La Vita Felice
Asfalto
E’ una poesia dolcissima quella di Valerio Mello, giovane siciliano trapiantato a Milano. Dolcissima perché poesia dell’appartenenza e della fedeltà alle cose, agli elementi ma soprattutto al mondo da cui mai si disgiunge nel perseguimento delle sue ferite e delle sue rivelazioni. Ed è un itinerario questo che ci viene incontro nella sacralità di due percorsi che convergono: quella dentro di sé, per spoliazione e offerta ad una realtà adottante e adottata e quella tra le maglie, appunto, di una metropoli fagocitata dalle sue tante implosioni in un dialogo di nuove e reciproche origini. Così è soprattutto un dettato di tempi interiori a scandire il flusso degli scambi e dei contrasti in una tonalità di sguardi e di incroci in cui, nemmeno tanto curiosamente, tra tanto rumore e sferragliare di uomini, è il silenzio ad imporsi per trasfigurazione nella sua evidenza di parola. Il merito, allora, è tutto nella nudità di fatica che Mello monacamente persegue (forse perché costretto, forse perché l’unica via possibile) nel rigore antico di un convivere poetico che sa nello scollamento delle forme (qualsiasi esse siano) l’onda trascendente e riformante delle cose. Ciò che personalmente colpisce di questa scrittura, che pure nella sue magnifiche esattezze sconta più di una volta piccole e grandi sbavature, è il tono profondo di chi (non perseguendo proprie scelte) dalla terra stessa appare chiamato alla sua pronuncia (vocato dunque come a chi scrive molto raramente è capitato di incontrare). L’uomo Mello, infatti, non si interroga ma si mette dolorosamente a disposizione, piccola circolare cittadina che dalle monumentalità della storia e dall’imponenza delle nuove architetture fissa, a rovescio, a partire anche da piccolissime screpolature, da infinitesimi oggetti dimenticati, lo smottamento delle impalcature e degli scheletri di una condizione che oltre la propria degradazione non dice e non può. Scrittura dello scavo, ancora, verrebbe da evidenziare e non solo per l’ovvio lavoro di parola ma anche per l’affettività del proprio tronco al rimestare quotidiano dei cantieri e delle gru nel quale riconosce il medesimo sforzo di sollevamento (“crescere per balconate,/ disfarsi del fango di sepoltura”). Lo aiuta in questo caso un uso dell’occhio a uncino, come suggerisce Alessandro Quasimodo nella prefazione e con il quale siamo d’accordo soprattutto quando parla di concretezza fisica del percorso. Concretezza che, sempre a dirla con Quasimodo, muove fin dal titolo a raggiungere dalle profondità snodi e fondamenti del quotidiano comune trasformandoli “in cifre dell’esistenza umana” che dagli slarghi ai luoghi di grande affollamento , dai viaggi in treno alle periferie ( esemplare in tal senso il titolo della prima sezione. “Milano interna, città esterna”) son detti tramite rivelazioni che non possono non venire dall’ “adagiarsi sui tratti”, dal “calpestare i tratti” rivelando al contempo, come già espresso, grande intelligenza di visione e consapevolezza della propria stessa esistenza a partire dalla commistione con l’esterno (“Al di là degli occhi esisto”). Ed è da questa coscienza il germoglio di una poesia che si costruisce impastandosi dei dettagli minimi che compiono la realtà in un nutrimento necessario e sempre reciproco che la rivela (si leggano al proposito gli ultimi versi di “Fioritura”) e che si fanno strumento di rottura dell’idea, che vale per ognuno di noi, “di essere solo un concetto”. Chiave questa da cui muovere per meglio comprendere le istanze di respiro di queste pagine nello scarto e nella reticenza a cui questo tempo ci relega e che solo apparentemente il nostro sembra assecondare, in verità nelle salite e nelle discese che non lo nascondono al “fitto abisso interno” accettando piuttosto di sentirsi vivo nel non sentirsi umano. L’accadere poetico che nel progredire ingemma il discorso deriva infatti da questo procedimento: la misura nel “chiarore del dubbio” si abbandona alla trasparenza dell’oggetto, alla medesima ventura della natura, al suo dire di , senza corteccia di cui vuole però essere portatore d’acqua. A questo punto però è necessaria una piccola digressione perché la reminiscenza, nel crinale di luce dell’offerta, ci appare provenire piuttosto dall’impronta di sole e spazio aperto dell’infanzia che lo reclama dai rigurgiti sempre ben custodendolo comunque nel segno dell’ abbraccio con la nuova terra e che fin dal mattino, “senza aspettare la sera”, a volte è già felicità nella tensione di grazia degli elementi nel tutto del loro pianto (nel vivo credo “del suo soffitto di voci leggere”) a fronte delle urbane degradazioni del moderno. L’attaccamento a questa sorta di religione del verso si fa più insistente perciò dove la luce offesa tende a dilatarsi maggiormente, dove l’osservazione poetica si fa officina (nel termine stesso usato da Mello riaffiorando in noi le memorie della rivista omonima di Leonetti, Roversi e Pasolini) punto a punto nel compimento delle corrispondenze, nell’ “inverso percorso/ del richiamo” dove risiede “la radice del giorno”. Eppure insistiamo , ed è questa forse la forza del libro, a Mello non interessano risposte, non ha alcun orizzonte da proporre semmai al contrario mostrare perfino dove lo stesso verso rischia di essere come un “verme” senza direzioni nella contaminazione e il macello di cui si nutre. D’altronde, sembra dirci e qui il discorso si alza, la poesia svelandosi come “ragione di una pluralità in disparte”, andando a leggere e nominare uno per uno i suoi elementi dove il “chiedere è debole” non può che sciogliersi in modulazioni di voci a ricordare nella tensione “il creato” e a “tornare dal cancellato”, come gli stessi poeti del cimitero monumentale suggeriscono nel testo dedicato a Salvatore Quasimodo . Perché la misericordia e il bene poesia resta nella vicinanza silente al possibile vivere dell’uomo, dove la sua pazienza nella severità della prova rende quella prova e la vita stessa più vera. Verità che come nelle mosche, a cui è dedicata la seconda e conclusiva sezione, è nella visione della sacralità del niente che ogni cosa è, ognuno è, nel suo destino di larva tra la quotidiana aspirazione a liberarsi oltre le finestre “dal ricordo delle zolle” e il buio terminale della ragnatela. Nella condivisione del rischio e del “vuoto ad ogni gradino”, venendoci qui in soccorso Montale, la sorte e la bellezza di questo antico daimon chiamato poesia che Valerio ben pronuncia e ricorda in uno dei più bei testi del libro (“Lampione”) nella sospensione che vige sempre tra primo e secondo verso e l’abbandono confidente della rispondenza nel timore della caduta dove solo può avere origine il riflesso di luce della parti. Con questa lezione, nonostante (o forse a maggior ragione) la dolente malinconia nell’accettazione della vita per ciò che esattamente è (senza mai però sfociare in rassegnazione), concludiamo consigliando questo testo di un giovane autore che ci ricorda quasi il dovere dell’innamoramento e della dedizione al mondo.
Id: 868 Data: 06/02/2015 12:00:00
*
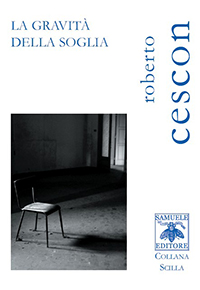 Roberto Cescon - Poesia - Samuele Editore
Roberto Cescon - Poesia - Samuele Editore
La gravità della soglia
Libro secondo questo di Cescon (a cui segue proprio quest’anno il nuovo “La direzione delle cose” edito da Ladolfi) ma soprattutto testo che appare fin dal titolo denso di chiarezza e di coraggio. Intendiamoci, chiarezza di strumenti e di materia perché di apertamente chiaro in ogni vera interrogazione poetica non c’è, nulla può esserci, se non al contrario un magma, seppur vegliato e cosciente, un mistero di voci e di forme che ci attraversano chiamandoci a una accolta, curata e dosata redistribuzione nella misura del mondo e del cuore. E qui veniamo al coraggio, perché al proposito questo giovane autore friulano, ben conscio del ruolo di crocevia, quasi di albero elettrico in sorte al poeta, si pone nel rigurgito esatto del dire tra spazi e movimenti, tra uomini e cose entro una terra che perfino nella memoria pare non più tenere. O trattenere, per meglio dire, in una immobilità di cieli e speranze che si affacciano senza direzione, di spiriti fermi nemmeno più spauriti ma tesi in una angoscia che priva di rivelazioni prima che di relazioni. Ed è allora in questo margine, nell’umanità patita e preservata, che si gioca la scrittura e l’inciso vitale di Cescon; perché, e il titolo adesso ci viene in aiuto a esemplificazione di suddetta poetica, “gravità” e “soglia” in poesia non possono essere considerate due paroline qualsiasi. Entrambe, infatti, sono legate, legandola, a una realtà e a un divenire sempre fondanti e imprimenti:la soglia a sottolineare il quid di relazione tra incontro e sua negazione, di luogo e cura di possibilità e nascite ma anche di scontro per rimanere appena in superficie nella base dialettica delle sue accezioni; e gravità- in questo caso in accompagnamento- a richiamare con forza il senso di responsabilità da cui non è possibile distogliersi non solo rispetto a situazioni e dinamiche che sovente si impongono con scelte e passaggi obbligati ma soprattutto rispetto a un esserci e a un provarsi tout court che fa sempre di ognuno di noi soglia di qualcosa o qualcuno. Gravità, allora, che giustappunto si rivela anche nella duplice valenza di imponenza, di peso e insieme di levità, sì, di stacco quasi fisico dal suolo a mostrare le ambivalenze sottili dei nostri strati che altro non attendono se non il loro scioglimento. E così nel volare basso dell’attraversamento umile, Cescon si affida alla fedeltà di una parola che ha nella riduzione, nella ricucitura delle distanze- a riempire “la carne che ogni cosa vive”- la sua virtù primaria saldamente nutrita di immagini da cui il nostro si lascia guidare per fermare le cicatrici proprio nella presa e nello scoperchiamento del peso (concetti questi del valore rivelatorio delle immagini e dell’accorciamento delle distanze ad opera della parola poetica su cui Octavio Paz ne “L’arco e la lira” ha dedicato sapienti pagine che raccomandiamo con forza). Giacché come nel testo da cui prende il titolo il libro attesta (nell’omonima prima sezione), lo scarto è tra il non perdersi e il compiersi con coraggio. Di muoversi oltre le asfissie di una terra e di un tempo ingrigito a cui però non è possibile nemmeno al cuore, nel suo volere, sfuggire. La sostanza di questo libello, suddiviso in cinque sezioni, ci pare così in buona parte nella reciproca incomprensione, di tradimento di e con la terra, di qualcosa di incompiuto e di separato con e tra gli uomini e di cui solo alcune piccole figure, come le rondini o gli usignoli cercano ragione o qualcosa da dire- lo stesso Cescon il più delle volte aggredito, smarrito tra volti e voci di vivi e di morti, di padri a reclamare ancora spazi di affettività e memoria alle quali cerca di prestare comunque una presa, o una corda di tenerezza, di piccola misericordia nel tempo della nudità e della magrezza. Tutto ciò, in questo convenendo con quanto detto da Cucchi nell’introduzione soprattutto in riferimento all’asciuttezza di tono, entro una lingua che per salti, borbottii, grandi o accennate ritrosie esprime fuori bene lo spaesamento di senso che non è, non può essere di una sola area oppure circoscritto a una dinamica privata ma, per passività, di un’ intera epoca e di cui Cescon tenta il racconto con lo strumento di un dire che troverà poi, infine, nell’amore la grazia di un ordine che sotteso all’uomo lo individua e lo sorregge ( ed in parte, in qualche modo almeno nella visione in precedenza già rivelatogli nel sereno e pacificato incontro di volti, passi e cose che tra la linea di un argine e l’ordine delle case si rispondono consentendo poi agli spazi di parlarsi e di parlargli in apertura di orti e di cortili-“Un affacciarsi di volti che tornano”). Così nel fondo dell’amore, in questo percorso in cui a scontarsi è anche, come lui stesso confessa, una paralisi generazionale per mancanza di adeguata educazione ad esserci, più sentita si fa- e insistita nel dettato- la consapevolezza del valore della parola come “modo per salvarsi”, come misura di una pace necessaria a fronte di una vita che improvvisamente può strapparti e lasciarti “come davanti a un plotone” e a cui lui nello sforzo chiama alla benigna e faticosa contrapposizione tutta raccolta nella bella immagine dell’impegno a restare ritti come “un girasole in inverno” (“Ho molti padri ancora nello stomaco”). Da qui, dunque, nell’equilibrio leggero come tra acqua su cui “allungare piedi come radici” e una fune “su uno specchio da non toccare” (se stessi, il mondo di cui aver custodia e cura come prezioso cristallo?) il respiro di giorni in cui lo sperare appare in tutta la sua concretezza in un amore, in una vita che sorprendentemente piuttosto ci rovescia senza chiedere ma che ci fa compiere come magia e dove nella difficoltà crescente risale un rimando quasi di fede verso un cielo dove anche ci fosse il niente “resteranno le impronte per chi le vedrà”. E noi vedremo allora, in conclusione, prendendo a prestito il titolo del nuovo libro, “La direzione delle cose” appunto, qual è, quale sarà la direzione di questa poetica, di questa scrittura che paga, a nostro dire, solo a tratti il vuoto di qualche verso in sovrappiù ma che pure possiamo dire presente e incisivo nell’estrarre il vivere come corpo che si svuota del peso e prende carne: “Esistere con le parole che vedo”. Sì.
Id: 854 Data: 09/12/2014 12:00:00
*
 Juana Rosa Pita - Poesia - Amatori
Juana Rosa Pita - Poesia - Amatori
El angel sonriente / L’angelo sorridente
Juana Rosa Pita, “El angel sonriente / L’angelo sorridente”, Amatori, Usa 2013. Nata a Cuba ma praticamente da sempre negli Stati Uniti (Boston) è una figura quella della Pita culturalmente brillante, vivace per una devozione attiva (come ci ricorda Jorge de Arco nella prefazione) ad una parola esplicata in una polisemia di gradazioni che, dal lavoro di critica a quello di traduzione, dall’attività editoriale al romanzo, trova nella scrittura poetica la maggiore efficacia per ispirazione e pronuncia del dettato. Autrice in questo campo di una ventina di pubblicazioni (per cui ha ottenuto tra l’altro importanti riconoscimenti internazionali) si presenta in questo piccolo volume nella veste bilingue spagnola-italiana di un testo a fronte efficacemente espresso nello specchio in dialogo delle culture e dei mondi a lei cari: quello del continente americano e dell’europeo nelle incarnazioni e nelle traduzioni di istanze e miti rivelatori. Giacché il mito, soprattutto, è un riferimento importante di una poetica che procede, passateci l’immagine, come un bimbo al setaccio nel filtro paziente di granelli riportati alla luce di un mare che nella pronuncia ci fa cari per naturali e inconsce evocazioni, affidabile e paziente contraltare di un tempo meccanicisticamente sfigurato e sfigurante. Poesia chiara, allora, questa che si impone senza clamori, senza proclami ma con l’arguzia di gesti casalinghi a soffiare via la polvere dai volti e dalle cose, dalle case alle strade financo alle storie restituendo d’ognuno nel sorriso il lato d’ombra vivo e nonostante tutto in voce, nella gioia che reclama nel respiro più forte speranza. Quello dell’angelo sorridente del titolo dunque, bellezza di un profilo che se risale per interrogazioni sapienti ha lo sguardo dolce dell’uomo ritrovato e abbracciato in quanto tale, creatura smarrita e detta nelle sue storie minime (non ci sorprende allora tra gli altri l’omaggio alla Szymborska). Finitezza di una condizione umana al cui proposito ci torna alla mente quanto detto sulla Pita da Brigidina Gentile:”Essendo insoddisfatta della storia ufficiale la riscrive attraverso la poesia, per lei l’altra storia, creazione infinita che rivela il vero senso delle cose dietro il caos apparente”. O, ancora, quelle dello stesso Jorge de Arco su una lingua che divenendo fiume lava la storia e permette gli attraversamenti. Scrittura, ci sembra evidente tra tanti corsi, perciò d’acqua e di ponte come ogni vera scrittura- per sincerità del sentire nel dire- dovrebbe nella posa della propria misura. Fonte di anelli, o come direbbe lei stessa di “mulinelli” nella necessità dell’anima di svegliarsi a un reale cui abbisogna davvero un niente, un poco, ma “sempre che il poco sia immenso” (come nella bellissima immagine in “Partita di Primavera ” ). Coscienza di un sacro in lei sempre presente che ha nella cadenza delle stagioni il contemplato metronomo entro verità e dettagli anche apparentemente insignificanti ma che hanno il potere di legarci “come, secondo gli astrofisici,/ l’armonico tessuto dell’universo” (“La cosa vera”) o come Cristo che dagli abissi ”invoca la terra, eretto e fermo/ dove il suono resta muto” (“Marino clamore”). Consapevolezze queste che si stagliano via via più preziose nella seconda, più lunga ed omonima sezione (l’altra, la prima dal non casuale nome “Soglia”) nella risultanza di una preghiera e di una testimonianza di una “panificazione” di se stessi che sia base di amore e custodia anche dell’altro giacché il bene, come il tempo, è vero solo se contemporaneo (secondo la meditazione in “Cosa strana è il tempo”). Conseguentemente, senza andare oltre, la riuscita della poesia per la Pita è nel rompere il silenzio della “lingua esiliata dalla fonte” ridando parola “dall’intimo involucro” a quello scarto nascosto atto a scuotere in melodia il “mar intimo” di esseri gli uni altri a un tempo umani e necessari, finalmente bastevoli. Soffio e grazia di destinazione ben presente anche nell’accluso fascicolo di movimenti in terzine “meditati fuori libro”.
Id: 847 Data: 21/11/2014 12:00:00
*
 Nadia Felicetti - Poesia - Libreria Editrice Urso
Nadia Felicetti - Poesia - Libreria Editrice Urso
Così sono io
Opera prima questa della Felicetti uscita dalle selezioni del premio “Libri di-versi in diversi libri” che ben rispecchia nell’acerbità del verso l’impronta primaria degli autori che hanno partecipato al concorso. E cioè, quel riuscire d’ognuno “nell’opera di svelare il suo sentire agli altri e, soprattutto, a se stesso”- come in appendice suggerisce il presidente della giuria Salvatore Di Pietro- e che tra queste pagine in una forma quasi diaristica si fa catarsi di una esistenza ferita tra desideri di pienezza e sue disillusioni. Sono poesie, allora, il cui aggettivo vero è dato dall’autrice nella premessa, quel “salutare” al proprio vivere quotidiano, per rabbia ed emozioni trattenute, al contrario qui direttamente espresse nella contrapposizione delle più intime e viscerali rimostranze a fronte di una realtà percepita violenta e in perdita d’amore. Il ritratto, o per meglio dire l’autoritratto che ne esce è quello di una adolescente prima e di una donna adesso in una disputa d’anime ora in avanzamento ora ferme ma sempre sul bordo limaccioso di antiche cadute e presenti paure. C’è qualcosa che stenta ad uscire, infatti, e ove avviene è spesso nel segno di un’inceppata e non perfettamente compiuta gioia, una malinconia di fondo che non libera dall’equivoco forse di in mistero di sé tutto celato tra concrete discrasie del mondo e personali, seppure involontarie, oscure e condizionanti diffidenze. Questo in una appena accennata e certo non esaustiva sintesi giacché la luce che comunque ne fuoriesce- e non è poca- è quella di un’esile figura innamorata e ricca per grazia e ricerca d’incanto che nell’umiltà della voce si tenta in una, seppur piccola, nota in grado di ridare nella verità dell’evocazione un qualche ritorno d’equilibrio nello smarrimento delle certezze. Formula lodevole e continua che già in germe ritroviamo nei testi adolescenziali che accompagnano la prima parte della raccolta fino ad imporsi nel proseguo dai versi relativi al sociale a quelli che investono i sui rapporti d’amore con gli uomini ma di cui si sconta per larghi tratti il fallimento per incapacità di scrittura di svincolarsi da un parlato che poco ha di poetico, il poetico in quanto lingua altra del mondo sovente assente per mancanza di veglia e di strumenti. Gli inceppamenti sopra accennati, dunque, si spiegano così poiché anche nella resa verbale a dominare è sempre un eccesso della coscienza che non consente alla parola di autenticarsi con sicurezza nel riflesso di senso che in forma ed immagine si compie- e ci compie- nutrendoci e rivelandoci. La pecca, in sostanza, è nel non dare al proprio verso quella necessaria, e personale, ed effettiva distanza anche da sé atta a renderla chiaramente identificabile per interrogazione e scioglimento del dettato. Il rischio in questi casi è sempre l’omologazione con se stessi che invece di liberare costringe e deforma nelle ripetizioni senza uscita delle istanze non chiarite. Eppure Nadia ne ha di cose da dire tra intuizioni di memoria e franchezze quotidiane da cui non rifugge grazie a uno spirito che mai si svilisce in valori che non riconosce richiamandosi piuttosto a una cura e attenzione del mondo fatta di caparbietà e dolcezza, di consapevolezza del grado di vita che anche il dettaglio sigilla nella comunione che ci comporta. Forza, e fede, d’amore non a caso ben coniugata nel testo meglio riuscito per capacità di osservazione e rappresentazione, per compassione e indicazione d’esempio. Parliamo di “Due foglie”, brano che invitando ad andare oltre l’immagine dell’albero che inizialmente si impone, si sofferma sulla diversità e le dinamiche di sofferenza e pazienza che legano le foglie tra loro nell’alternanza delle giornate e delle stagioni. Condizione, pare suggerirci, simile alla nostra come nella bella immagine delle due nascoste che barcollando, labili sul limite, danno anch’esse “voce all’insieme”. Senza di loro infatti non avrebbe anima l’albero così come il mondo senza ognuno di noi (“si sfiorano appena e subito rientrano nel/ loro spazio predestinato”). Ed è dunque questo il richiamo vero che spinge il libro: il riconoscimento di dignità di vita e amore impresso in ciascuno nel contrasto di una realtà che quotidianamente tale dignità calpesta e nega. Di qui a seguire la denuncia del ruolo di prima vittima che ancora la donna subisce a conferma di possessi e di radici (vedi “Essere donna” appunto) difficili da recidere e da riapprendere nella sanità di un rapporto a due fatto di dialogo e sostegno, osservazione, il maschio stesso prigioniero di sé (“le tue mani tremano ed il mio corpo/non fluisce nelle tue paure”- “Io sono qui”). La medesima attenzione quindi, ci sembra di poter affermare a conclusione, andrebbe curata da parte della Felicetti per un’ adeguata e maggiore resa della propria parola fin qui spesso dispersa a scapito di un sentire posto a scavo di un’era e di un sé che non si comprende e che non ci comprende. Le chiavi sono nell’umiltà e nella determinazione, doti che in queste pagine si stagliano preziose.
Id: 842 Data: 21/10/2014 12:00:00
*
 Aa. Vv. - a cura di Alessandro Carandente - Rivista - Marcus Edizioni
Aa. Vv. - a cura di Alessandro Carandente - Rivista - Marcus Edizioni
Poeti e Pittori di 2° Tempo
Ci siamo già occupati da queste pagine, in occasione dell’uscita del trentanovesimo libro, del bell’intreccio tra poesia e pittura operata sotto l’egida di Alessandro Carandente dalla Marcus Edizioni con i suoi quaderni di Secondo Tempo, rivista quadrimestrale di letteratura e arte nata nel 1997 e ripartita, come evidenziato nelle sue presentazioni, entro le tre sezioni di testi inventivi, interventi critici e recensioni. Progetto che dopo quasi una cinquantina di numeri ed undici fascicoli monografici, si va nel volume che qui andiamo a presentare ad antologizzare. Intanto però ci preme, prima di passare in rassegna i testi e le tavole dei poeti e pittori qui appropriatamente suddivisi in due parti, ricordare la vitalità di una scena, quella napoletana appunto da cui muove la rivista, sempre nel vivo di una ricerca attiva e interrogante, e per questo spesso scardinante, tra studi di nudità- ed ambivalenza- di parola e riferimenti visivi da cui nell’accorciamento delle distanze il pensiero si riforma e nasce. Pensiamo anche allora ad un’altra non secondaria rivista che da anni prende voce da questa area, “Risvolti”, appunto, guidata con acume da Giorgio Moio (e da quel Pasquale Della Ragione del quale possiamo leggere proprio qui alcuni testi). Avanguardia di ricerca di antica presenza e suggestione, se vogliamo, che già in Secondo tempo si recita e rimanda nel nome, Secondo.. sì, nel legame a quel Primo Tempo del mensile fondato a Torino nel 1922 da De Benedetti, Solmi, Gromo, Sacerdote e giustappunto caratterizzato nella trattazione di “questioni riguardanti la letteratura e l’arte contemporanea con unità di indirizzi e vivezza di intendimenti”. Così, quasi un secolo addietro e così ancora con medesima passione e rigore adesso, almeno da questo gruppo, a testimonianza di una dialettica tra le arti sempre funzionale a un discorso e a un racconto dell’uomo sull’uomo nella polisemanticità dei suoi sguardi e delle sue scritture. Tanto più nel lontano legame tra poesia e pittura nell’incandescente, e spesso medesimo, circuito di espressione e interrogazione del mondo. “Ut pictura poesis” diceva- e sappiamo- Orazio; ma anche, via Simonide : “La pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla” e “La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede”, per dirla con Leonardo. Tema e accordo certo non nuovo che ha attraversato tutto il novecento, basti pensare nel richiamo ai calligrammi di Apollinaire fino ai lavori di Miccini o Isgrò, tanto per fermarci al versante italiano. Come accennato il volume suddivide i suoi autori in due parti entrambe accompagnate da relativi e preziosi saggi introduttivi , la cui essenziale e fondamentale lettura consigliamo vivamente per una maggiore comprensione della genesi e della direzione di testi e tavole. Così Marcello Carlino ne nella nettezza della traccia identificativa non disgiungendo mai l’autore dalla visione d’insieme in cui, inciso, determinato determina ci offre nel gioco delle generazioni una scansione storica puntuale ed esatta di movimenti e legami ideologici e culturali che hanno caratterizzato parte della ricerca del secondo novecento a Napoli (trattenendo nella rete anche artisti precedenti) in un legame tra generi non ideologico ma in dialogo, come lui stesso, avverte ”con la ricerca teorica e letteraria i cui lavori sono in corso” tra “intersezioni, commistioni, scarti di rotta, rideterminazioni operative” in Secondo Tempo trovando la propria naturale corrente. E nella dovuta sottolineatura che seppur nella connotazione regionale di provenienza “la rassegna di testi qui in mostra ha un respiro nazionale” e un valore innovativo “di valore europeo” celebrato nelle forme più disparate del suo racconto. Dal tributo al virtuosismo di Elpidio Jenco de “La Diana” ad “Altri termini” con Franco Cavallo e Franco Capasso (nel segno di illustri e antecedenti capitoli di riviste) al bilinguismo simbolico di Sinadinò e alla poesia-racconto di Scognamiglio e alla tensione civile di Salvatore Violante. E poi, ancora, dalla “inesauribile produttività polisensa della lingua” in Carandente all’ epos di Nazzaro e la distribuzione eventica in quadri di rappresentazione di Raffaele Urraro; dalla modulazione epifanica di Carlo Di Legge alla scissione in Vetromile di “un io dubitativamente conoscente” entro una realtà e “una terra agonizzante per scorrerie di depredazione” e la forte accentuazione visiva della narrazione in Pedicini. Questo per dire di un elenco ricco per qualità di nomi a cui vanno aggiunti però quelli di Annunzio Cervi (nella riproposizione di una ricerca dei primi del secolo scorso), Alfonso Malinconico, Enzo Rega, Alfonso Cepparulo, Prisco De Vivo e come detto Pasquale Della Ragione. Testimonianze anche diverse però, come a chiudere Carlino ricorda, tutte nel medesimo impulso a “condividere nel modo che alla scrittura è peculiare, non rassegnandosi al silenzio, la responsabilità di intervenire”. Condivisione dunque in accordo con i dettami dell’arte pittorica che lo stesso Gerardo Pedicini scioglie ed amplia nel saggio introduttivo alla seconda parte del libro: <”Secondo tempo”: confluenza di segni e parole> in cui richiama nella struttura di ripartizione della rivista (dove la prima e la quarta di copertina contrassegnate dal lavoro di singoli artisti fanno da cornice alle tre diverse sezioni) agli esempi (e dunque ad una sorta di eredità) di molte pubblicazioni dell’avanguardia storica. Anche se, ovviamente proprio per criteri di natura storica, nel segno del necessario ricominciamento in rapporto anche alle “plurivalenze, le innovazioni e le percorrenze della parola poetica determinatasi a seguito del tramonto delle ideologie” . Tracciato in questa seconda parte a cui partecipano tra l’altro molti dei nomi già citati per la scrittura poetica in una varietà di risultati e intenti in queste pagine analizzato e sviscerato in tutta la polimorficità dei suoi intrecci e delle sue risonanze. Basti al proposito qui ricordare davvero paradigmaticamente quanto da Pedicini detto su Cosimo Budetta nel suo “mondo fortemente caratterizzato dai rapporti che i segni stabiliscono tra loro, al fine di posizionarsi nella giusta posizione in cui nasce l’afflato della poesia”, lo stesso Budetta autore tra l’altro poi di parecchi libri d’artista (tra cui quelli per Sanguineti, Pagliarani, Loi, Balestrini, Giuliani, Sinisgalli). Ciò ad accennare appena ad una sintesi di lavoro che va ad onorare anche la collaborazione del curatore Carandente con la Galleria Civica d’Arte Moderna di Spoleto in cui la rivista a più riprese ha potuto pubblicare opere di Alexander Calder, Eduardo Chillida e Marino Marini, riuscendo ad assecondare quindi la rivista anche “la propria vocazione internazionale”. Oltre agli autori già presenti nella sezione poetica, ricordiamo allora nomi e tavole di Andrea Sparaco, Mario Persico, Renato Barisani, Carmine Di Ruggiero, Giuseppe Antonello Leone, Auguste Rodin, Natalino Zullo, Ugo Poli, Ernesto Tatafiore, Alexander Calder, Marino Marini, Eduardo Chillida, Vincenzo De Simone, Salvatore Vitagliano, Claudio Lezoche, Armando De Stefano, Luciano Vadalà, William Xerra, Antonio Baglivo, Riccardo Dalisi, Elio Waschimps, Aulo Pedicini, Luigi Francese, Claudio Vino, Olga Danelone, Mario Apuzzo, Ettore Consolazione, Ferdinando Vassallo, Antonio Fomez, Gianluca Murasecchi, Lea Contestabile, Pino Latronico, Antonio Davide, Loredana Gigliotti, Vittorio Piscopo, Kelly Driscoll, Libero Galdo, Normanno Soscia, Enzo Aulitto, Angelo Noce, Cosimo Budetta, Francesco Cangiullo, Salvatore Emblema, Roberto Fabiani, Claudio Granaroli, Clara Rezzuti, Antonio Testa, Stelio Maria Martini. Antologia allora più che degnamente rappresentata e presentata nelle due facce di un contiguo e rilanciante interrogare che si offre nel dono di una veste raffinata e sapientemente curata a conferma di investimenti editoriali ancora attenti alla scommessa di un sapere e muovere artistico che sempre ritorna nelle bellezze a cui apre e destina. Bellezza che in questa Antologia, nel racconto delle sue direzioni, ha in copertina la celebre futurista firma di Francesco Cangiullo nell’ immagine del Vesuvio.
Id: 813 Data: 06/06/2014 12:00:00
*
 Aa. VV. - Rivista - Oèdipus
Aa. VV. - Rivista - Oèdipus
Lo Stato delle Cose - pensiero critico scritture
Questo numero de “Lo stato delle Cose” (corredato dalle belle illustrazioni di Robert Seymour per The Posthumous Papers of the Picwick Club, 1936 di Charles Dickens) penultimo della nuova serie della rivista diretta da Francesco G. Forte, e che come recita nel sottotitolo si muove abilmente tra pensieri critici e scritture, conferma la poliedricità di un’idea di letteratura e condivisione non scontata ma soprattutto essenziale per l’offerta e gli spunti di valore che va a intrecciare. Vivacità di incontro aperta nella sezione COLLOQUI dall’intervento (“Purché ci sia il neo..”) di Renato Barilli sull’opera di Domenico Rea in un convegno del 2006 a Nocera in cui subito si motiva la necessità dell’inclusione dello scrittore napoletano in un filone “capace di cogliere le ragioni di un periodo, di una situazione generale di cultura, di Stato, di società”. Questo perché dal suo punto di vista di fenomenologo un autore va sempre inquadrato in uno stile che comunque lo supera. Così il discorso si fa forte ripartendo proprio dalla differenza che il neo in accostamento fa sempre rispetto ad altre correnti pur se di riferimento e/o precedenti. Come infatti per il neorealismo che non è proprio la stessa cosa col realismo nell’accostamento interessante anche col suo versante cinematografico, soprattutto con Zavattini dal quale trae quello che per noi pare un termine calzante e straordinario, l’“eventico” appunto (“perché in lui, che prepara degli strumenti per accalappiare l’accadimento allo stato puro”, l’evento è tutto). Ed allora come il neorealista nel cinema si muove sulla base della convinzione che la realtà sia “fonte d’imprevisto” e del quale si può solo prendere atto e metterlo a punto in presa diretta, così è anche nella scrittura in cui Rea lo afferra giustappunto allo stato puro senza però fissarlo al tipico come sempre avvenuto nel realismo (nella registrazione di una sorte infine già predeterminata) ma semplicemente piuttosto eliminando ogni distanza facendosi “compartecipe dei suoi personaggi” con un linguaggio dunque il più possibile prossimo al mondo in oggetto. Allo stesso modo efficacemente Barilli ci mostra come in questa scrittura in cui nulla come detto è mai prevedibile anche la lotta di classe e le disuguaglianze non sono mai stabili per sempre , in una possibilità di caduta o riscatto sempre presente , le figure muovendosi costantemente in una sorta di interregno . Sottolineatura calzante che dopo aver reso omaggio all’autore di “Una vampata di rossore ” anche nel versante del romanzo si conclude con il richiamo a quei nuovi autori, Peppe Barra su tutti, in cui una sorta di neo neorealismo rivive, seppure forse inconsapevolmente, in un’ eredità che ha certo nel debito proprio Domenico Rea. Discorso questo che va a introdurre alla sezione del PENSIERO CRITICO divisa in due interventi. Il primo è relativo all’accurata analisi di Giampiero Marano su alcuni aspetti del lavoro di Roberto Calasso (“Fra India, Mediterraneo e post-storia: l’esoterismo di Roberto Calasso”) nell’arco dei suoi studi sull’esoterismo da lui inteso come “parte maledetta e benedetta” del mondo, fondata sul “pensiero più vicino alla visione che le cose hanno di se stesse”, nella convinzione tra l’altro che il segreto stesso dell’esoterico non possa non risultare dalla consapevolezza del carattere irreversibile del tempo (in una sottolineatura trasgressiva e anomica delle griglie). Interessante però per noi, soprattutto, in queste pagine (che per specificità rimandiamo e raccomandiamo volentieri ad una lettura per intero) è il riferimento alla funzionalità del rito data dai primi poeti e di come la nascita della letteratura che avviene “nell’ intervallo tra gli atti di culto in cui gli aedi raccontano storie di eroi e di dei” sia strettamente correlata all’ambito sacrificale. Cecilia Bello Minciacchi, invece, in “Reificati allo specchio. Per “Le Mosche del capitale” di Paolo Volponi”, ci regala un bel saggio che invita alla rilettura di un romanzo per certi versi capitale (e ristampato nel 2010 da Einaudi con prefazione di Massimo Raffaeli) in cui l’autore marchigiano nello stretto legame tra scrittura e attività politica, nel registrare “il fallimento di un utopia” (pur nella forza comunque scaturita), ugualmente va a colpire l’insaziabilità di un potere tra “assolutismo del capitale”, “disumanizzazione dei meccanismi produttivi” e “dittatura del consumismo”. Soprattutto però alla Bello Minciacchi preme mettere in luce la sottolineatura della “reificazione di un universo non più naturale, nel quale niente sfugge alla piramide del comando e ai surrogati dell’artificialità”. Universo, come qui ricordato, ben conosciuto da Volponi per la sua attività alla Olivetti prima e alla Fiat come consulente poi. Analisi che così va a concludersi poi col richiamo non solo al “Pianeta irritabile” (1978) che prefigura in qualche modo il libro ma anche a “Memoriale” (1962) nella narrazione della nevrosi e dell’alienazione dell’operaio, ricostruendo dunque un percorso che con “Le mosche del capitale” dice molto della coscienza politica e letteraria di un autore costantemente acceso per responsabilità, oltre che alla propria, alla storia di un intero paese. Nella sezione VERSIONI invece sono acclusi in testo a fronte brani poetici e in prosa in lingua originale con relativa traduzione. In questo numero sono presentate poesie in francese di Jean- Charles Vegliante con la versione di Felice Piemontese (tratte da “Rien Commun” e di cui segnaliamo in particolar modo la prima sul tema stesso del tradurre) e in portoghese di Manoel de Barros tradotte da Giorgio Sica (da “Livro sobre nada” e connotate da una grande narrabilità poetica nella magia di un mondo efficacemente presente per semplice- e assurdo- sogno). Similmente in Scritture tra i testi in prosa della scrittrice argentina Ana Marìa Shua (da “Artigianato della magia” nella traduzione di Sara Princivalle) i cui luoghi ed i cui personaggi sono legati tra loro da una realtà vista sotto la lente di un fantastico che più che effettivo è vivo nelle idee che fa scaturire e dai condizionamenti che conseguentemente ne derivano. L’altro autore della sezione è Andrea Inglese le cui poesie (tratte dall’opera in uscita per la stessa Oèdipus, “La grande anitra”) rivelano a filo di uno sguardo silente un pensiero che si rasoia a definire incrostazioni e movimenti in dissolvenza di figure e sfondi immobili solo nell’attimo in cui il verso lo precisa reindirizzandolo però da e in un reale di continue scomposizioni. E’ in DOSSIER, a seguire, la felicissima, seconda riproposta da parte di Francesco G. Forte di testi di Giuseppe Bartolucci a partire però dalla produzione degli anni cinquanta, dunque prima della sua imposizione ai vertici della critica teatrale (e suggerito già accuratamente nel titolo: “Bartolucci prima di Bartolucci”). Al trittico pavesiano (“Il sottosuolo di Cesare Pavese”, “Il primo Pavese”, “La luna e i falò”) il curatore fa seguire infatti per nostro piacere degli affreschi, degli schizzi di vita cittadina dominati da una vivacità di sguardo e di scrittura che tutto assomma, sminuzza e celebra in una Milano velocissima dove le stesse gru alla domenica appaiono “scheletri di elefanti in un cimitero di tetti”. Infine con SCHEDE il numero, come ogni rivista nella giusta selezione dovrebbe, va a chiudere segnalando nella presentazione degli stessi direttori due nuove riviste : Leviana con Eugenio Lucrezi e Trivio con Antonio Pietrapaoli (anch’essa edita da Oèdipus). Quest’ultima però (tra poesia, prosa e critica) che a dire la verità riapre i battenti dopo un periodo di chiusura e che nel titolo allude e alle tre arti (i tre sentieri della scrittura letteraria) e a “triviale” nel rimando “al significato basico di trivio come incrocio di tre strade o vie” e dunque ad un orizzonte di ritrovo, di piazza nelle testimonianze e nelle sperimentazioni più disparate. Leviana invece, semestrale da Napoli, si propone come “laboratorio e dibattito di idee” nella promozione di una discussione poetica “capace di modificare struttura e confini del pensiero” sul crinale di un pensiero poetante, quindi, come attività critica attenta anche “alle possibili intersezioni con discipline scientifiche e filosofia”.
Id: 811 Data: 16/05/2014 12:00:00
*
 Caterina Davinio - Poesia - Puntoacapo Editrice
Caterina Davinio - Poesia - Puntoacapo Editrice
Il libro dell’oppio
“Hey, babe! New rising sun”... così da Hendrix nel titolo lo spirito non di una poesia sola ma di una scrittura che ha nel seno stesso del proprio capovolgere l’orizzonte di una vitalità scelleratamente debordante a dire di un’epoca e di più generazioni la disperata e a tratti autodistruttiva negazione a fronte di un mondo e di una società borghese. Già.. e così ancora la Davinio, negli sfacciati notturni a ricordare gli accordi: “Ehi,/ come va laggiù,/ al motel delle stelle?/ Senti il suono della galassia?”- in un gioco d’echi che ci ricorda qualcosa dei Doors (“An american prayer”, più precisamente). Gli anni qui attraversati, volati via come frecce (o come “spade” volendo restare strettamente nel tema) sono quelli di piombo e d’eroina che vanno dalla metà dei settanta al 1990. Senza criterio cronologico però, entro quell’ordine che forse viene solo dal ricordo da parte di un’autrice soprattutto nota per le sue ricerche tra poesia e digitale, in quegli intrecci di computer art di cui - e non solo per la longevità di lavoro - è tra i primissimi nomi. Qui, in questo diario recuperato dal passato (e che in realtà non è che rimando ad un testo più vasto ancora interamente inedito) ci offre il racconto di un mondo, quello dell’eroina soprattutto e altri stupefacenti, da lei intensamente e devotamente indossato sul bordo di “malattie del corpo e dell’anima” di cui nella nota pre-testo non vuol dire ma che pure in qualche modo si sciolgono e si recitano poi nel manthra ossequioso del libro. Ed è un racconto allora coraggioso per autenticità ed immediatezza di inferni, e di interni tra club dell’ago e marmorei risucchiamenti dal primo buco in un condominio di Ostia (per curiosità e volontà di presenza nel gruppo, nella confessione di non aspettarsi “Dio/ a Ostia/ di luglio/ nei quartieri bassi”) fino ai morsi implacabili della scimmia che mai demorde nel ringhio demonico dei richiami (con il suo “muso lucente” che richiede sempre un “pasto abbondante”). Eppure, ciò che la Davinio ci cazzotta senza ipocrisie in faccia è una scelta non imposta ma abbracciata in cui nell’impietosa avvertenza, che se tutto proviene dalla noia quando ci si annoia si soffre e cade. Poesia ma io direi vita prima ancora (inseguita, blandita e spesso rigettata) che dunque non può non procedere, come segnala Mauro Ferrari nella postfazione, se non per ossimoro nel desiderio violento di un sé tenacemente avvinghiato ai propri abissi d’incantamento e ai propri disamori. Ed eccola allora, eccoli, nella scia intermittente dei balocchi la nostra protagonista e i suoi svariati, incandescenti compagni - di una e mille notti tra interminabili strade e discoteche, di città e menzogne e audacie impossibili - nella cupidigia di un sonno e di una vita rimandata perché non contemplata se non nell’effetto sinfonico dello stupefacente in quell’alterazione moltiplicante a dominare ventre e anima e così minuziosamente descritta (e quasi ancora in presa diretta verrebbe da dire) già nel lungo poema d’apertura, “Flash, Poema dell’eroina”, appunto. Viaggio come detto questo a cui ruota dietro tutto il teatro di figura e di viziosa seduzione che si distende nella dimensione del testo: dalle fascinazioni pericolose della caduta alle grida impazzite dei corpi nelle piaghe e nel vomito di un corpo che si consuma ora ancora giovane e urgentemente rispondente ai reclami del sesso ora inchiodato su quella Croce spesso sospesa tra le rotazioni e i folli infingimenti, le aperte schizofrenie delle membra e della mente (entro immagini tra l’altro, e certi personagetti, a ricordarci le più crude strisce del conterraneo Pazienza). Così da queste pagine ci arriva grazie a una scrittura densissima, e reverente sola alla verità di se stessa, sì il documento libero di uno stordimento, di una reclusione forse ma soprattutto il canto doloroso e pieno d’amore “per tutto ciò che è inutile” (come nel ritratto della ragazza in “Mi piaceva vederla”) nella dolente e ipnotica “costruzione di una vita liberata dal peso della vita” a diga di una impreferibile esistenza coatta tra le file di una quotidiana ordinarietà nella pretesa del cuore e dei sensi. La spina di lettura che ne deriva è quella naturalmente delle dipendenze per lo scippo a più maglie di un sé giammai bastante nell’onnipotenza credulona - e idolatrica - della maschera che tra gli spazi di sanguinose risonanze ci infinge (ognuno nella caratterizzata dimensione dell’io) in nette e proclamate divisioni - l’altro agli occhi sempre fallace, e sbagliato - l’altro nel perenne fraintendimento dei disconoscimenti. E nella separazioni e solitudini dei mondi, qui nel versante opposto di una riflessa visione di buoni e cattivi al vaglio di compiacimenti e indifferenze altrettanto reciproche. Misericordia e carità del simile, non del diverso, che è poi la vera scimmia, il vero demone che la Davinio con lucida franchezza e coerenza ci consegna nel “buco vuoto/ dove passa il vuoto”.
Id: 801 Data: 29/04/2014 12:00:00
*
 Anne Sexton - Poesia - Via del Vento Edizioni
Anne Sexton - Poesia - Via del Vento Edizioni
Una come lei
Della Sexton (1928-1974) nella raffinata ed essenziale veste delle sue edizioni la Via del vento presenta qui, in una piccola ma esemplificativa scelta, alcuni tra i miglior testi. Scomoda per la nudità e dunque verità delle confessioni, sempre sovvertitrice per una modernità di scrittura nella dolorosa visione di un sé cercato e non amato- eppure celebrato, vezzeggiato e accarezzato - Anne è un’autrice che ci reclama e imbarazza ancora adesso, ad ogni sua lettura, tra disorientamenti e lacerazioni di donna investendo tra l’altro il suo discorso (nello sgomento e nello smarrimento delle aspirazioni) anche il senso di una società e di una cultura (quella americana della seconda metà del secolo scorso) a piena velocità lanciata senza interrogazioni né dubbi entro un benessere asettico, in serie, tra le maglie di ruoli - e dolori se vogliamo - ben strettamente definiti. Inquietudini e dolori da subito presenti in lei a cui evidentemente non bastarono i privilegi della famiglia benestante da cui proveniva (Massachusetts) se è vero che fin dall’adolescenza cercò in qualche modo di emanciparsene preferendo al perbenismo ingombrante e senza respiro dei genitori (dietro al quale continuavano a celarsi le nevrosi di una provincia americana disturbata qui espressa dall’alcolismo del padre e dalla repressa aspirazione letteraria della madre - ma soprattutto del presunto abuso sessuale da parte loro) la fuga e l’immediato matrimonio con Alfred Sexton dal quale avrà due figlie (e da cui divorzierà nel 1973, l’anno prima della morte). Da questo momento, dalla depressione che insorge alla nascita della seconda al tentativo di suicidio, dalla scoperta della scrittura nel percorso di terapia psicanalitica al successo e a una vita rovesciata fuori dai canoni di una normale vita borghese è tutto una lunga corsa, di nuova sofferenza ma anche di sorprendente creatività, in cerca di una riappacificazione con se stessa, soprattutto, con esiti poetici intensissimi per la natura dirompente di un verso sempre spinto sul bordo di un’esistenza e di un mondo (il nostro) tra devastazioni di senso e reclami di tormentate (e seppellite) identità. Identità sì, in lei comunque in qualche modo cercata (e per certi versi forse ritrovata non foss’altro per il sentiero di ricerca stessa) in quella terra di misericordia e lingua d’annuncio, di divenire ed essere già liberato della poesia appreso proprio nell’affidamento pieno delle proprie esperienze personali, e dei propri traumi ad una parola sapientemente fluida per una coscienza senza più occlusioni nella confessione di un sé risalente dal mare immenso delle proprie pulsioni. E alla poesia “confessionale” ( termine usato in quegli anni a definire in senso spregiativo una versificazione sentita come sciatta ed esclusivamente riferita al proprio vissuto) infatti fu ascritta, con Robert Lowell (considerato il capofila) e Silvia Plath in testa. Di autentico c’è piuttosto, ed è esemplificativo in tal senso, in questi autori l’uso della parola come abile strumento per “parlare di tutte le cose inconfessabili a cui prima di allora non era stata riconosciuta dignità poetica” (come la De Calmeri nella bella postfazione ricorda) ed in cui Anne “fu tra le primissime a cercare di esprimere un io lirico consapevolmente femminile che parla di amore, di morte, di Dio” (ancora la De Calmeri) portando moltissime donne a riconoscervi e a riflettere in profondità sulla natura dei propri disagi, delle proprie reclusioni (a partire, certo, dalla visione stessa che allora vigeva del femminile). Così la ricchezza delle interrogazioni, partite come detto da investigazioni su se stessa, la portarono a focalizzare l’attenzione sia naturalmente su questioni di carattere sociale ma ancora più naturalmente a dilatarsi sul tema del sacro abbracciato con forza e con disperante amore negli ultimi anni (“Dio è nella tua macchina da scrivere” le disse al proposito un sacerdote a lei caro). Percorso questo che ai nostri occhi, allora, non può non apparire sotto una creaturale e trascendente luce d’incontro tra un essere rigettato un po’ farisaicamente dal proprio stesso mondo e il suo Fattore come meravigliosamente espresso qui ne “In compagnia degli angeli” , in cui nella rivelazione del sogno sceglie di seguirli, lasciandosi condurre fino alla spoliazione completa di sé, senza nemmeno essere più donna, almeno non più “di quanto Cristo sia un uomo”. Purtroppo questo non le ha impedito poi di togliersi la vita a soli 46 anni, vittima di una depressione ed anche di una solitudine dalla quale (aldilà del turbine delle frequentazioni) probabilmente non fu mai abbandonata. In questa scelta di testi è dunque possibile darsi l’idea puntuale di un’autrice a suo modo capitale, anche per i risvolti non solo letterari, della poesia del Novecento. Scelta, dicevamo, esatta anche per la scansione dei testi a seguire in modo efficace l’arco intero della poetica della Sexton, da “Una come lei” (testo paradigmatico del suo discorso e della sua figura nel ritratto di una donna in cui come in un gioco di specchi rivede se stessa: una donna nel cui addomesticamento di madre e di moglie perfetta in realtà sovente si cela il rischio dell’azzeramento) ai reclami intensi di una sensualità piena e liberata sul filo di una mortalità a tratti invalidante (vedi tra le altre “Ora”: ”Siamo qui su una zattera, esiliati dalla polvere”) fino alle ultime in cui come accennato il cuore e lo sguardo sono rivolti a un Dio d’amore in un legame anche se esile comunque salvifico nella certezza di una misericordia in cui “Lui ti cadrà nelle mani/con la facilità con cui un tempo dieci centesimi/ ti procuravano una coca”. (“Fil di ferro”), seppure nella sofferta consapevolezza però di una rinascita che deve partire anche dal coraggio di saper affrontare il proprio malessere altrimenti. monchi, venendo a mancare della nostra parte essenziale, saremmo un “Dio/ senza Gesù a parlare per me”, per noi: un “Gesù/ senza la prova della Croce”.
Id: 799 Data: 18/04/2014 12:00:00
*
 Pietro Secchi - Poesia - LietoColle
Pietro Secchi - Poesia - LietoColle
Un milione di occhi
Figura cara e preziosa quella di Pietro Secchi, per onestà soprattutto e presenza di scrittura senza infingimenti, nuda e cruda nel possesso forte di una semina iscritta senza sconti tra le pieghe più dolenti e inquiete di un moderno che procede tra negazione e abissi di cancellazione. Abisso che infatti è il discrimine, in azzeramento, su cui si muove questo breve ma agile libricino ed in cui nella stretta necessità del ricominciamento e della veglia è la virtù onnicomprensiva ma soprattutto onnisciente dello sguardo a farsi sentinella e guida nella marcia di riavvicinamento ad una terra oramai al limite per presenza e saccheggio umano. Poeta vero, oltre che intellettuale fine nel seno di indagini che si accompagnano da sempre allo studio filosofico, sa bene infatti che la tessitura e la forza della parola poetica è nel potere unificante dell’immagine, nella riduzione delle distanze in cui nomi e cose si riconoscono ogni volta nuovi e rifondanti nella parabola di mondi che finalmente si osservano e si dicono tra riconoscimenti e pronunce di diversità. Nel “potere eterno della visione” allora è tutta la fede e la pazienza di un’impronta salda nel fiorire “come i doni aperti che attendono” in cui è possibile accorgersi di un divenire che con costanza, rigore e amore (come l’esercito di formiche ne “Eppure sono gli occhi di pece”) continua l’opera di una natura che sa in se stessa muoversi e perpetuarsi a dispetto nostro. Nella determinazione del dettato però la singolarità del procedere è dato in Secchi dai coinvolgimenti e dalle risonanze dei sensi tutti nelle aperture e rivelazioni piene della visione cosicché, a proposito di marcia e in particolare nei primi testi, è soprattutto da un presentimento di suoni, di voci l’annuncio e l’immagine (sovente in questa poesia accompagnate da presenze animali) del rovesciamento salvifico a fronte di un terrifico presente di rovina (come in “Chi ha detto che è finita?” nell’avvicinamento invisibile di un milione di occhi pronti nell’aggressione degli spazi a “celebrare la grandezza del cuore dell’uomo”). Marcia ed occhi di giusti, di “colombe mimetiche”, nella profezia e nel silenzio di una nuova era a rompere quell’assuefazione di morte entro cui, tra le maglie di un sistema economico al collasso e occlusioni di libertà fittizie, il mondo rinchiude se stesso. Giacché nella ferma convinzione che la ri-creazione del pensiero passi da una classicità di direzione e forma che viene da lontano (“Atene risorge dove muore New York” ci dice in una sarcastica invettiva), all’inedia di generazioni che vagano coatte e senza testa nel vuoto di un sé idolatrico, Secchi ci consegna nella fatica di nudi“operai/della terra che non ha bisogno di eroi”, di uomini soli e storpi ( in una immagine quasi evangelica che parte dagli ultimi seppure nel registro di un Paraclito le cui pagine sembrano oggi “vecchie e desuete” ) il silente, appunto, e inarrestabile avanzare della falange “dell’umanità risorta”. Ritorno ed alleanza primigenia con la terra stessa, dunque, che il poeta veglia e canta nel compito di profezia e di dolore che gli è proprio, nella visione rivolta a quell’altrove di creazione che di lì nel divenire reclama e lo reclama nella metamorfosi di costruzione di un tempo ovunque nuovo nel movimento e nell’annuncio degli insiemi (in un riferimento non a caso a quel Majakovskij a cui nel sottotitolo va l’omaggio). La necessità “di nomi veri,/ che risuonano solo nel coraggio/ della spina nel costato” , sorge allora dalla considerazione sempre parziale e in superficie che ha di sé, anche nella commozione, un’epoca senza prossimità e vera incarnazione come la nostra in cui la stessa parola risulta sovente ferma ad una pudore che per falsa sacralità non dice. Dizione a cui invece questo testo invita con urgenza partendo dalla scansione, in partecipata e percepita fatica dell’umanità sofferente (secondo la ricordata formula di Berkeley, “Esse est percipi”, che tutto l’essere di un oggetto consiste di fatto nell’essere percepito) sui cui sacrifici si regge il peso del mondo e “che brillano ancora/ costruendo l’universo più vero”. Il riconoscimento, iscritto come detto nel miracolo dell’iride, e tutto in quel vedere per comprendere in cui si chiude il testo, avviene così nell’orizzonte di uno stupore e di uno scoprire che si inoltra fino ai limiti della conoscenza, perché “il futuro è già qui”, proprio nella stretta di mortalità che ci definisce e costringe nella pazienza umile del seme. Ed è in questa erezione di “templi greci/sul mercato del petrolio” (seppure a tratti sotto il peso di un eccesso di retorica) il lascito ed il bene vero di una scrittura incisiva.
Id: 796 Data: 28/03/2014 12:00:00
*
 AAVV a cura di Giuseppe Vetromile - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
AAVV a cura di Giuseppe Vetromile - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Percezioni dell’invisibile #poesiapoeti
Nel nuovo quaderno collettivo della collana Coincidenze de L’Arca Felice Giuseppe Vetromile ci presenta con il supporto di sette ben comprovati autori un’indagine in versi sulla natura rivelatoria ed epifanica della poesia, sul carattere extrarazionale dei suoi rivolgimenti e dei suoi orizzonti secondo un procedere - ed un assumere - più per interrogazione che per acquisite risposte. Tema, come ricordato nell’introduzione, già “caro ai simbolisti francesi del XIX secolo”, che ha nell’invisibile il quid di riferimento tra le maglie del procedere, nel confidamento paziente e incerto- e per questo faticoso- nel rigurgito illuminante di quello spazio sempre sotteso, e in attesa in cui, perché trasfigurato e nudo, in qualche modo l’uomo pare compiersi nell’osservazione dell’incontro e del moto che subito lo reinveste. Verità di sé nel mondo, e del mondo, che quasi in uno sdoppiamento ha piuttosto (per apparente e sublime contraddizione) valore di unità ricomposta nel seno di immagini il cui pensiero si specchia e si dilata ogni volta nello spazio del solo tempo e della sola visione possibile, pensiero- ancora- e dasein finalmente, apertura ritrovata nella perpetua e attiva genesi di tutti i sensi. E però, a scanso di una modalità meramente nella sua accezione più romantica della conoscenza poetica, in queste pagine i vari autori si provano direttamente, sulla scorta del proprio personale concetto di visibile e invisibile oltre che di scrittura, secondo una modalità di percezione legata sì alla materialità, corporeità e quotidianità del tempo storico proprio (perché di partenza) ma nella prospettiva del suo superamento, come correttamente osservato nell’introduzione , nell’assunzione comunque di una nuova soglia, di una terra diversa nell’ eventualità dei ritrovamenti. Ed è dunque questo il bene primo del testo, in una progressione dell’incisione che va di pari passo con una meditazione a tratti metapoetica di se stessa nel prezioso lascito novecentesco di ripartenza. Sette dicevamo gli autori, con una prevalenza netta di presenze femminili in un’ edizione come al solito ben curata e corredata dalle fotografie della cara e brava Gabriella Maleti. Serie dunque aperta da Lucianna Argentino la cui raffinata navigazione è qui testimoniata per prosa poetica in terza persona da testi in cui l’autrice romana rivede, ripassa a ritrosi l’arco della propria personale esistenza sotto la lente di un sé bambina in acquisizione di scrittura e di qui nella scoperta di vita che può appunto essere reinterpretata dalle proprie mappe e dalle proprie chiaroscurali intersezioni in riscrittura stessa (secondo un’intuizione poetica abilmente riportata ora da adulta in frammenti per un’autobiografia postuma) ; diario e già liturgia di memoria nella garanzia della salvezza che in sé in quanto affermazione ha comunque il dire, il registrare, nel cucire e scucire delle parole nella “qualità evangelica della luce” : nel ritmo sì divino in cui risonanze e silenzi si attraggono e respingono tra le figure care di luoghi e familiari (il nonno, il fratello, ma soprattutto il padre nella prossimità del dolore condiviso). Dell’autore seguente, l’ischitano Pasquale Balestriere, si ricorda invece, come felicemente sottolineato da Vetromile, “il lato silenzioso e spesso ombrato della vita quotidiana che si conduce, sovente, senza il prezioso riferimento a radici e valori fondamentali dell’esistenza: come la memoria storica e sociale, il sentimento familiare e l’amore per la natura” che qui trova struggente e intenso intreccio soprattutto nel brano in ricordo del fratello (“Sull’orlo della vita soli fummo/ e non ci fu pietà pei poggi in fiore”). Anche se, a ben dire, altrove un eccesso di aulicità linguistica rischia a tratti di inficiarne il risultato (“Orfica” ad esempio). Con la poliedrica Floriana Coppola, che ha nei collages di poesia verbovisiva uno dei punti di forza, traspare invece nei testi tratti dalla silloge già edita “Sono nata donna” lo sforzo e la ricerca del superamento dell’immediato reale, “dell’immanenza” come lei stessa avverte, alla luce di una traccia che allo stesso tempo apra e trasfiguri i mondi, in cui le stesse ferite umane “nel tunnel di volti” non sono che segno di “un regno perso” forse ma sempre presente- e riflesso- nell’impasto di terra e cielo entro cui disparate e disperate presenze cercano nome e fuoriuscita e che ha il suo suggello, nel sillabario di permanente ricominciamento, in “Elogio del margine”. Piuttosto è con la traduttrice e narratrice oltre che poetessa Giovanna Iorio, nomade acrobata e indagatrice dell’ombra per rimestanza erratica tra le apparenti banalità e bucce del quotidiano e sue necessità di visione, il primo esplicito riferimento al divino tra negazioni e aspirazione d’assunzione nell’altalena di un umano “vivere/senza lasciare impronte”. In più, però, la percezione poetica si nutre, ha bisogno di cura, di veglia: lo sa bene Ketti Martino, di formazione filosofica non a caso, che nel vibrante trittico di cornici consequenziali nel dialogo con gli spazi e le brezze della natura si offre alle sue voci, ai suoi intagli nel riflesso del reciproco riconoscimento (“Delle ombre riconosco il verso/ uguale agli stessi miei rosari”). Amore certo che nella dolcissima, tenace, onniradicata Cinzia Marulli Ramadori si fa chiave di volta, grimaldello di decodificazione e reindirizzo civile del reale, memoria e intreccio salvifico dalle viscere di un umano non espunto ma cullato e ripulito dalle offese (vedi, da leggere nel tremito tutta di un fiato, la bellissima “Pensieri” dedicata alla madre). Indagine chiusa infine da Marco Righetti che dimostra con efficacia, subito, direttamente dove la meditazione e la lingua poetica, che non sono altro dal mondo ma esse stesse compiutamente Mondo per scavo e liturgia dei frammenti, hanno per forza di prossimità e radice luogo e battesimo principe : qui nel cuore dell’esplosione che ha disperso il sogno e la vita di Melissa Bassi, la ragazza di Brindisi che nel maggio del 2012 fu uccisa nell’attentato alla sua scuola. Qui, nell’elegia delle parole dell’adolescente a sua madre, a ricordare la potenza di una scrittura che rompe il marmo del tempo dai cui spaventi e dai cui traumi non si lascia vincere ma muovere in ricomposizione perché, come avverte la stessa Melissa a proposito del suo assassino, la vita vale più del male fatto. Ed è giustappunto nel seme di questa circolarità, innaffiata, offerta e condivisa nel segno pieno di ogni autentica poesia che, in conclusione, andiamo a segnaliamo per ricerca la lettura di questo indicativo quaderno.
Id: 789 Data: 21/03/2014 12:00:00
*
 Emmanuele Francesco Maria Emanuele - Poesia - LietoColle
Emmanuele Francesco Maria Emanuele - Poesia - LietoColle
La goccia e lo stelo
Poesia garbata e di accento antico per consonanza e familiarità domestica col mondo intorno, tra memorie e piccole liturgie interiori mai sovrapposte al canto che le ispira, questa di Emanuele. Soprattutto poesia onesta che non si serve dello strumento lirico per confondersi- e confondere- come nei tanti, troppi, vaniloqui che caratterizzano ancora buona parte della nostra poesia. Ma che, piuttosto, la serve rammentandone l’incanto dello sguardo nella mitezza di una bellezza che ha il potere di scioglierci, e di risolverci se preservata, nel mistero infinito delle sue incarnazioni. Unità, dunque, che in questi versi è data da un profondo spirito e coscienza di terra in gratitudine e perenne affidamento, nella consapevolezza di un sé compiuto ma sempre in divenire tra risonanze e complementarità d’accordi da curare e perseguire pur - e forse soprattutto- nella malinconica stretta dello scorrere. La prospettiva infatti da cui muove Emanuele è quella di un uomo che, nella pratica del sentirsi, si sa tale solo se parte centrale e insieme periferica nell’armonia degli elementi che lo comprendono rimettendo nella costante osservazione ed identificazione con la natura ogni investigazione e iscrizione di sé. Scansione questa che gli consente di raccontarsi, nell’umiltà del tratto che ne caratterizza il verso, entro leggeri cicli di interrogazioni e visioni su cui tutto domina, tra scosse ed ansie di trasformazione, una grazia del tendere sempre accesa nel bagno d’orizzonte che lo investe. La forza di questa poesia si rivela allora nella umana impotenza di pienezza tra le cui oscillazioni ricordo e materia presente si intrecciano in una ricerca continua di ritrovata e rinnovata spazialità. Respiro aperto finalmente che, inevitabilmente, però può sorprendere quasi -come in tutti noi- solo in quell’attimo, in quello stato in cui corpo e anima non si pensano ma liberamente sono, battono come ne “Il risveglio” dove il cuore proprio in questo si sa bastevole nel flusso di mondo che in tutta la sua conferma gli riappare. Così nelle tre sezioni in cui è suddiviso il testo, non a caso già nei titoli (“Allora”, “Adesso”, “Chissà”) secondo una proiezione cronologica delle investigazioni, è una certa tenera benevolenza del ritratto, e di ciò che si mantiene concretamente aperto ai segnali di vita, a risarcire il dettato. Alle memorie degli amori giovanili, ma in particolare a quelle care del padre e della madre, nel riconoscimento di un’eredità di valori preservata negli anni, segue difatti un istinto di partecipazione e detersione sulla scorta della convinzione che solo in relazione agli altri l’uomo si compie, e che ha nel riflesso di sé la ricorrente immagine della volta stellata o della pietra e del fiume nelle cui risonanze di passaggio e trattenimento si osserva scorrere nel fluire espanso della terra. Miracolo, questo, di circolare rinnovamento nel superamento delle forme che in Emanuele si fa, ha il significato sacro d’accoglienza e offerta pudica di poesia nella cui prossimità sa iscritte le infinite ricomposizioni dell’ amore. Grazia che nella coscienza amara del male nel mondo in cui si “consuma/ la parte più bella” si direziona appunto nell’intreccio di una bellezza che proprio nella sua manifestazione massima, come “goccia splendente” che “si appoggia/allo stelo che da sotto/ felice la guarda” è destinata a scivolare via (come nella lirica che dà nome al testo). Seppure qui, in una dialettica di lettura, non conveniamo però con una certa dolenza di riferimento che nella parte finale del libro (corredato tra l’altro da opere di Chia, Echaurren e Paladino) si accalca tra i versi ed in cui, entro una ripetizione forse eccessiva di immagini e considerazioni (e in una lingua che per questo scema di forza), tende a sovrastare la figura umana nella considerazione della sua finitudine. Ma ciò non va a inficiare comunque una meditazione che non si perde mai nel proprio slancio di sogni, e che piuttosto nella cura del sogno ha la prova e la misura, mai scontata, di sé e del mondo in una dilatazione che lo vede, non solo nella scrittura, ma anche nella promozione di eventi ad essa legati, al passo saldo di quella visione di incontri chiamata poesia.
Id: 784 Data: 11/02/2014 12:00:00
*
 Duska Kovacevic - Poesia - LietoColle
Duska Kovacevic - Poesia - LietoColle
Un seme di luce
Prova d’esordio poetico, dopo il romanzo “L’orecchino di Zora”, per la croata Kovacevic della nobile città di Rjeka (Fiume), ormai da quasi vent’anni in Italia dove opera attivamente in ambito sociale e culturale. Un esordio questo già cabotato da pubblicazioni sparse e che, volendo restare al titolo, nel chiaroscuro della sua forma diaristica tenta un’apertura nel corpo di un anima che preme tra trattenimenti ed aspirazioni d’insieme, lucidamente sgomenta - e appassionata - tra rifrazioni e inquietudini di senso. Potremmo dire, a partire dall’esergo della Pinkòla Estes e dal testo d’apertura a seguire , terra che si desidera feconda nella profondità di un seme finalmente radicato ed in luce negli spazi vuoti dei propri effettivi e più naturali bisogni, non più nella rete dei tanti io slegati di una realtà guasta che procede senza amore o dentro un amore morto. Così ci appaiono questi versi come una poesia del coraggio che combatte se stesso tra ossessioni e tiepidezze di crescita e consapevolezza di un mondo la cui direzione può esser ricomposta solo nell’intensità di un legame nel cui cerchio - a fronte di un’immensa e separata accelerazione- onorare il domani (e la cui indovinata visione è nella dialogante giostra degli animali tra gli alambicchi nella foresta). Ed è allora nel timore “di essere felice,/ come fosse qualcosa che non si merita”, il nodo di una confessione che sembra affondare nel destino di un tempo che nella compressione degli spiriti accarezza e celebra le proprie negazioni. La Kovacevic, evidentemente, non può che rispondere come può tra sospensioni e reclami, come sa, in un corpo a corpo d’amore dapprima con se stessa e poi con l’altro da sé che ha nella figura dell’uomo amato il centro esatto del proprio “ventre cosmico”, delle proprie “labbra nude”. Duello che nell’offerta del femminile si snoda nel terreno comune di una nudità in cui per rivelazione e riconoscimento le identità possono dischiudersi e trovarsi soprattutto nel bene reciproco di una fragilità accolta a dire la cura e la direzione dei mondi - “Non siamo soli, le pelli lo sanno/ sotto le ossa scorre la vita di tutti” - nella sparizione di “ogni illusione sul possesso”. L’attrito nel controcanto - ma anche la tenerezza- fortemente impresso in una versificazione recalcitrante alle classificazioni (e che sovente deborda come fiume) è come accennato con una figura maschile che si rivela distratta, in un rapporto tra generi segnata da gelosie e disattenzioni, da avarizie anche ed in cui la Kovacevic si racconta fino in fondo tra recriminazioni, lettere d’addio ed invettive di dolore. Tutto ciò a dire la natura di una figura per cui val bene la definizione di donna d’amore, seppure ancora divisa tra perenni compressioni e slanci di fecondità e liberazione, di stella che aspira a scoprirsi già a sé nella brezza vitale che l’attraversa (come nella immagine in “Desideria). Perché, a dispetto del buio, il seme in cerca di luce si lega qui al cielo di una poesia intesa come confidenza d’anima nei cui tocchi e nei cui respiri - in cui “tutto sembra innamorato” - si cela pienamente la preghiera ed il pensiero della terra nella misura di un raggio “che andrà ben oltre il giudizio”. Anima poetica allora, la cui scrittura però, a dire il vero, risente ancora a tratti degli strattonamenti di uno spirito comunque esitante i cui inceppamenti finiscono, se non sciolti, con una mortificazione linguistica che non rende onore a un dettato e a una vis originale e coinvolgente nelle sue provocazioni ed istanze. E’ sorprendente infatti come con singolare linearità a versi lucidi e senza sconti, dai quali il lettore stesso si sente in qualche modo richiesto per affinità e responsabilità d’insieme, se ne alternano ogni tanto altri in cui, purtroppo, per eccesso di parlato e inutili e banali ripetizioni - in una masticazione priva di controllo e cura (anche per chi cerca decifrazione) - non possiamo parlare di poesia. Poesia che, piuttosto, è nelle corde vere di un daimon pressante ma che ha bisogno di maggiore ascolto da parte dell’autrice per interrogarsi ed esprimere al meglio, altrimenti alla lunga rischia di interrompersi in un desolato, e desolante.., canto strozzato. E sinceramente ce ne dispiacerebbe.
Id: 783 Data: 28/01/2014 12:00:00
*
 Marisa Papa Ruggiero - Poesia - Puntoacapo
Marisa Papa Ruggiero - Poesia - Puntoacapo
Di volo e di lava
Tenace e alta conferma in progressione, come nei suoi inseguimenti di parola, ci pare la migliore definizione del lavoro di scrittura della Papa Ruggiero dopo la lettura di questa ultima fatica appena uscita per la puntoacapo Editrice. Avevamo chiuso, infatti, nella scorsa primavera la nota a “Passaggi di confine” intrecciati ad una tensione linguistica vivacemente attiva, mai chiusa, ai segnali di un divenire rimestante e interrogante nel cui nume è possibile leggere la forza - e la fede - di un’epifania sempre al limite tra inceppi visivi e scarti semantici. Giacché la fertilità di questa poesia nasce dagli affondi nelle opacità e nelle incrostazioni evocative di quell’unicuum vitale, insieme di lettera e terra nelle cui agglomerate dialettiche sono iscritte memorie e infanzie già presenti, già nel raggio di derivazioni e affermazioni possibili. Storia, e scorie, da cui risalire nella consapevolezza delle mutazioni, nell’osservazione puntualmente di nuovo indagante e riflettente dentro l’ invaso paziente di un io a suo modo orante, e arante là dove il mistero del nostro respiro scorporandosi preannuncia sue nuove origini. Dinamica di discesa per raccolta di luce i cui bagliori nelle pratiche sotterranee ritroviamo magnificamente dispiegati entro le viscere di questo originale e potente poemetto. Il luogo qui, “reale e metafora esistenziale” come ricordato nella nota prima del testo, è quello della Latomia di Siracusa detta dei Cappuccini. Un luogo carico di storia naturale ed umana di “straordinaria forza suggestiva”, come segnala Giancarlo Pontiggia nella presentazione: cave calcaree da cui furono ricavate le pietre per l’edificazione della città ma anche luogo di segregazione e di morte degli Ateniesi catturati durante la guerra del Peloponneso. Un luogo nelle cui intersezioni carsiche, nei cui meandri arborei, la donna e l’autrice si sanno incise in qualcosa di oscuro che insieme le trascende e le supera; “cripte cieche della terra”, “vie sacre” che solo a presenze animali, ad uccelli spetta misurare dentro quell’oscuro scherzo in cui, volta per volta, “l’uscita si ritrae” prendendo “una direzione acuta”. “Taglio verticale”, allora, tra grotta e cielo nelle cui cadenze è racchiusa l’aspirazione a una lavacro quasi iniziatico in cui finalmente aderire a se stesse proprio da dentro quel corpo del dolore che, levigato e vinto, permette nell’incontro il vivere nella rinominazione delle dimore e del tempo (“e si è nonostante/solo/ciò che si lascia/lo scarto/di una ragione in più/ che si dimentica”- nella prefigurazione di un passo iniziale). E’ evidente qui, allora, anche un discorso sul femminile, del femminile, pure per una sessualità continuamente riferente che risale e si investiga in questo teatro minerale le cui impervietà , le cui voci ed odori - e duplicità di muffe perfino- sono liberate tutte da questa “botola fossile” così coraggiosamente scoperchiata, la cui distensione al termine è però- per amore ed omaggio- mirabilmente graffiata dagli spasmi di cinque grandi poetesse del novecento dal destino infausto (Amelia Rosselli, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Antonia Pozzi, Ingeborg Bachmann). Tutto ciò a conferma, come dicevamo, di una poesia autentica per l’altissimo grado di apparentamento alla terra e alle sue rimemorazioni, alle sue mutazioni dal buio di una vitalità che preme incalzando nell’ urgenza delle affermazioni. Ma soprattutto una poesia non facile, che non fa sconti nella misura della sua lingua e dei suoi attraversamenti. E da cui viene da dire: meno male.. Perché la poesia deve imbarazzare , non recedere, e coinvolgere in un percorso che venendo e affondando nell’umano non ha strade libere, aperte, chiare ma sentieri irti di rovi, di vani ricongiungimenti anche in cui però sono iscritte quelle costellazioni che dal fondo fanno capo ad una speranza- e ad una luce- finalmente non offesa. Che mi sembra nel senso pieno di questo volo, di questa lava (la “freccia/ tremenda/ che nessuno scaglia” ?) che personalmente ho apprezzato inizialmente per due modalità affini: la celebrazione dei luoghi dando loro in qualche modo parola e il riferimento, nel dialogo, ad autori che ci hanno preceduto. Forza di lingua, appunto, puntuale, decisa, sicura nella decriptazione delle incisioni; sempre lucidamente consapevole dell’ “oscurità insondata/ che resta inconoscibile” nei labirintici riflessi che ci disfano e ricompongono. Sapienza dalla Papa Ruggiero per fede smossa e carezzata in queste latomie grazie soprattutto a una corporeità fortissima che procede ed avanza, rilasciando e appunto scartando, in quell’orizzonte di sé che ha nell’immagine della spina di mirto la sua più riuscita espressione e ad ergersi poi (vedi pagine 57-58) in tutta fierezza di nudità detersa, e compiutamente nitida, quasi benedetta dalla volta e dall’orsa. Qui ci fermiamo anche se la complessità del testo richiederebbe di più nel rilancio di versi che dicono al meglio l’impronta di un’autrice sempre vigile:“ Spalanca il buio/la reazione a catena/di cifre tossiche/ esplose sottolingua”.
Id: 772 Data: 03/01/2014 12:00:00
*
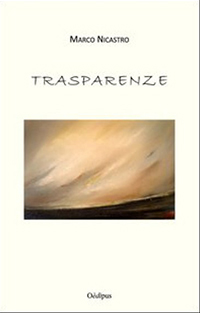 Marco Nicastro - Poesia - Oèdipus
Marco Nicastro - Poesia - Oèdipus
Trasparenze
Poesia della crepa, della frattura che fuoriesce dalle paralisi di un anima e di un io prigionieri di presenze lontane e di un futuro non distinguibile, quella di Marco Nicastro, giovane psicoterapeuta siciliano trapiantato a Padova. Poesia dolente e a tratti pericolosamente e oscuramente romantica ma autentica nel carico di inquietudine che ne è alla base ed in cui la tentazione del buio si scontra con una ricerca, una verità- seppur minima ed improvvisa- di luce a rompere staticità e impotenze di desolazione. Trasparenze, sì, come nel titolo, nella duplicità di squarci di rivelazione e detersione di sé per abbandono di ciò che più non supporta nel chiuso di un divenire costretto. La parabola allora si muove tra remissioni e indagini di natura nel cui “calore muto dell’esistere”, nei cui elementi (soprattutto marini e notturni in un paesaggio dai connotati non altrimenti prevalentemente autunnali) lo scatto di sé, nella pace, si risolve in aspirazioni e nudità di fusione. In ricerca e identificazione di spegnimento entro quel sole greco nella cui fertilità è racchiusa, “la chiave delle cose,/la loro universale combinazione” verrebbe da dire, nel grigio monotematico di una scrittura ancora, purtroppo, pesantemente ingolfata da una verbosità roboante ed eccessiva, lontana per immagini e lingua da quella contemporaneità di riferimento avvertita come occlusiva e reprimente. Seppure lingua che si rischiara un poco nel corso del testo mano a mano la presa di coscienza di un io che intravede, riconosce una possibilità di salvezza nel mettersi finalmente a nudo, re malato che nell’ abbraccio della propria debolezza sa finalmente il punto di risemina nel freddo della piana e dell’anima. C’è infatti un avanzare nella ferita basato non più o non solo sul crinale dei propri inciampi ma anche sul silenzio d’ascolto di una parola non più auto-incentrata ma corrispondente, e per questo feconda in un “Tu come preghiera” a fronte del freno terminale di noi stessi in uno sforzo sia pure a singhiozzo di “assistere infine appagato/ al miracolo della concordanza”- giacché “il gorgo s’avviluppa inutile/ se il centro non sussiste”, i dialoghi interrotti. Solido pilastro a cui Nicastro perviene anche con bei movimenti di verso per piccole e sottili sinfonie interiori dell’attimo, nella cui fede rivelatoria si leva il bene e la cura del libro contro la pressione dell’immediato conosciuto, Babilonia durissima da reggere “in una dissolvenza di punti cardinali”. Almeno questo sembra essere l’orizzonte finale che tenta di scaturire dal pantano di immobilità e sconforto sempre ritornante tra le spire di lusinghe di morte e accecamenti di uno sperare ondivago entro memorie di amori e ore mancate . E che resta comunque il demone tra demoni nella consunzione quotidiana delle prospettive entro le quali la stessa figura di donna amata risulta oscillare tra sintonie di appartenenza e promozioni calme di vita ed annullamenti e mortificazioni di “un apocalisse senza clamore”. Tra i colpi di una lotta eternamente umana si gioca dunque il lavoro di Nicastro cui auguriamo risoluzioni e costruzioni di grazia stando tra le cose, così come pronunciato nell’ultimo brano, lasciandosi intersecare e plasmare da esse- pur e soprattutto nelle inconsapevolezze, senza domande- per “mutare, mutando l’altro da sé” nei binari di una umanità riconosciuta come prossima perché egualmente sofferente e in attesa di rinascita, pensiero forte che si affaccia da queste pagine e le riscrive affidandole al solo squarcio da cui è possibile vivere ciò che si è disimparato a vivere , e cioè l’amore che “attende nel silenzio”, rosa purissima nella sacralità di un divenire innaffiato e vegliato. Per maggiore resa, però, ci permettiamo di suggerire, infine, maggiore equilibrio e sintesi nella scrittura del verso, e sorveglianza poiché, come accennato, sovente il dettato risulta offuscato da una stereotipia di immagini e di parola che rischiano di distogliere, per disvalore e cripticità, dalle istanze appassionate che premono dal fondo di una non banale interrogazione.
Id: 768 Data: 10/12/2013 12:00:00
*
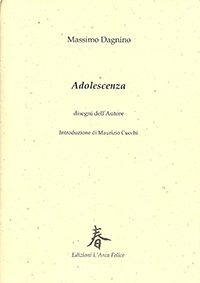 Massimo Dagnino - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Massimo Dagnino - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Adolescenza
Ci siamo già occupati della collana di Arte-Poesia “Coincidenze” curata da Mario Fresa per Le Edizioni L’Arca Felice in cui nei testi al percorso in versi sono accompagnati gli interventi visivi dei vari autori. Edizioni preziose e ben corredate che si confermano in questo smilzo libricino di Massimo Dagnino, sicuro poeta e pittore in cui ritroviamo appieno quel disagio dell’uomo nel suo rapporto con le cose e il mondo esterno sottolineato da Maurizio Cucchi nell’introduzione e al cui interno solo una resistenza o, per contraddizione, una remissione d’attrito pare a tratti la sola incisione possibile. Così, emblematica di questa separazione e ben dilatata, è la figura adolescente alla base della narrazione la cui irretita emozionalità, fin dal primo testo, muove in sospensione tra idiosincrasie corporali e mentali ed un osservazione ferma al legame di corpi e ombre nella massa dentro e fuori e lo sfondo. Sfondo impresso su lastra dentro non-luoghi (senza paura d’abusare della definizione cara ad Augè), o luoghi terzi forse nell’intersezione dei passaggi tra folgorazioni di retina e fisicità di campo, tra postazioni in divenire e svanire ed ansie personali. Carte topografiche e mentali che lo stesso Dagnino registra confondersi in corrispondenza o deviazione di quella realtà via via sempre più magmatica, sempre più sfuggente composta nel quotidiano di campi d’allenamento, scuola, stazioni e sale d’aspetto ed una natura quasi in controcanto a rivelarsi salda fin nei suoi dettagli e frammenti di scorza, seppure all’umano a volte anch’essa ancora oscura e inconoscibile. Esemplificativo in tal senso, soprattutto nel seno di un’età contraddittoria- mai certa, mai davvero doma a se stessa procedendo per disavanzi “nell’ipertensione dello scenario”- è la terza composizione (come le altre senza titolo) in cui, nello scarto tra “primordiale occhio” e algide occlusione vegetali, la figura del sogno viene progressivamente smentita in compresenze di tormento. Così, vedremo, nella densità dei giorni e degli insabbiamenti temporali, resta la notte a verificare ritrosie e desideri, forze e inadeguatezze nelle tradotte posture del sonno. Ma ovviamente a Dagnino non interessa raccontare conferme quanto riportare in una lingua carica, esatta, perfettamente essenziale e funzionale al suo dettato, tracce e forme di una disaderenza nelle cui ambiguità e nelle cui distonie il reale può sorprenderci e perderci fino ad un buio che “non si cura del senso d’appartenenza” e che- come suggerito dalla penetrante immagine di uno degli ultimi testi- “violentissimo” può espellerci come convogli. Puntualità di lingua, dicevamo, in cui lo stesso criptico sforzo talora ritornante si rivela nella sostanza l’efficace riflesso di un crescere e divenire instabile che nella rispondenza sovente procede per enigmi, o per squarci improvvisi, balugini in cui volti, case e stati di natura si spiegano in modo non ordinario. Condizione non solo adolescenziale ci suggerisce evidentemente Dagnino, in un’indagine quasi chirurgica le cui ferite guarire non può ma solo segnalare (come nella tavola in matita su carta “Anatomopaesaggio”) come sintomo di una decostruzione del contemporaneo le cui deformazioni, i cui smottamenti dominano qui nell’alveo di un silenzio continuo, di un gelo atmosferico nel nord del paesaggio, a rimarcare al meglio negli appannamenti d’impronta piccole e irrisolte liturgie personali. Un mondo il nostro, a dirlo con la forza degli ultimi versi, “Inerte” dunque, che “Non cresce mai,/ Esiste costretto in una/ Stupefacente visione frontale”. Visione che l’artista genovese sostiene e conferma nei tre disegni acclusi in un percorso personale rigoroso e incisivo.
Id: 764 Data: 03/12/2013 12:00:00
*
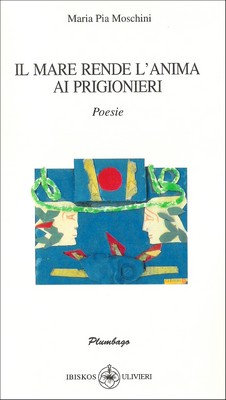 Maria Pia Moschini - Poesia - Ibiskos A. Ulivieri
Maria Pia Moschini - Poesia - Ibiskos A. Ulivieri
Il mare rende l’anima ai prigionieri
La figura di Maria Pia Moschini non ha bisogno di grosse presentazioni parlando per lei un’attività poetica e artistica pluridecennale, ricchissima di spunti e tratte diverse basate fortemente sull’incontro e il dialogo multidisciplinare tra le arti concretizzate poi in quel luogo di ricerca che è “Intravisioni”, dal 1983 prezioso spazio fiorentino successivamente ampliato in casa editrice. Dialogo tra le arti dicevamo, che in qualche modo ritroviamo in questo libricino del 2011 in cui sono raccolti tra gli altri anche testi da “Le radici dell’esistere”, opera dei primi anni ottanta caratterizzata dall’apporto di Eugenio Miccini, uno dei fondatori della poesia visiva. Operazione di memoria e di omaggio alla polifonia della scrittura poetica la cui impronta è accompagnata e conclusa anche dalle poesie restanti che raccolgono, come la stessa Moschini avverte, esperienze poetiche alternative tra loro e riferibili nel tempo a periodi successivi della sua produzione. Così fin dalla prima sezione, “L’intuizione” del dire (dal nome del primo testo che per assiomi con gli altri ne scandisce le tappe) è legata ad una visione della scrittura in cui il fare poetico è strettamente connesso a quella natura in sé propria di veglia e custodia, di salvaguardia della terra dalla quale è possibile essere ripagati solo per il tramite di una pazienza e di una cura ostinatamente perseguite ed apprese. “E per “Solitudine” anche, “inventariando” se stessi ed il mondo nelle reciproche Apocalissi nella consapevolezza di una maturazione che paga anche qui solo entro quella direzione che è sempre lo scorrere del fiume a scegliere, nella compiutezza di una vita che è tale proprio nel grado di assecondamento alla foce. Mutazione” dunque, nei cui risucchi, dalle cui viscere sono richiamate galassie che la poesia restituisce come baluardo di Madre a fronte di un tempo d’uomini “senza sembianze”, segnati e vinti dai cortocircuiti dei propri irrimediabili scontri. Perché l’accompagnamento vero infatti è nel pieno del “Naufragio” (e ci viene alla mente allora il detto gandhiano secondo il quale non dobbiamo sfuggire alla tempesta ma imparare a ballarci dentro), desolazione del contemporaneo, “accaduto per incuria” , aguzzando come lei dice “quel poco di silenzio” e “farne un puntello, un vertice di leva” contro la ritrazione del Mare che tradisce- anche se ci lascia nel sospetto che il vero tradimento è il nostro proprio per le false rappresentazioni che ci siamo fatti del mare. E dalle cui rotte, nelle cui rotte, il ricominciamento non è altro che in uno spiegarsi continuo- necessariamente fiducioso verso nuovi lidi, verso una sempre nuova “Costellazione”. Così nell’ “Illuminazione” che segue è nella gratuità del dono la chiave di scardinamento di quel sistema vano di sicurezze in cui crediamo di porci al riparo dalle oscurità presenti in noi stessi e puntualmente poi ritornanti “ad ogni nostra buia voglia di male”. Offerta con un che di evangelico che (come lo stesso Pasolini amava ricordare) può essere appresa in particolar modo dai puri e dai semplici nella coscienza dell’ affidamento, ancora, e del dubbio, puntello, movimento che è “Incisione” per profezia di ogni vera poesia nella nitida nudità a perdere, “nel filo (..) riposto/ nella noce che canta”, nell’opposto di un percorso in cui si cela ogni identità possibile. Meta così che ben spiega la cruda, bellissima verità che è nel titolo stesso del libro, di un mare che rende l’anima ai prigionieri liberandoli prima di tutto dai detriti delle proprie rimozioni. E che una lingua essenzialmente ricca, vicina in alcuni momenti a motivi ed immagini cari alla poesia araba (l’Adonis del “Libro delle metamorfosi” per esempio), ben scioglie e vivifica in una tematica di superamento continuamente indagata anche nelle sezioni successive. In “Corrispondenza del giorno”, in cui in un discorso tutto legato alle piccole fessure di rivelazione tra le cronache del quotidiano, e in composizioni secche e di poche strofe, di nuovo viene la conferma che “vivere è riempire,/ abitare dentro il sottopassaggio/ di un’idea”. E nella conclusiva “Sul rovescio dell’ombra”, dove la poesia nella sua propulsione è crinale della rottura del guscio, l’uovo nel suo concetto di vita embrionale, di simbologia di rinascita ed offerta. Giacché è una poesia quella della Moschini che sa d’ogni respiro l’angolatura giusta di vento e di memoria “che è legno/lavorato dal mare/ fino/ allo spasimo”, la verità che è da abbracciare nel canto a fronte dell’immobilità e dell’auto-assolvimento dal mondo, del continuo sotteso aleggiare della morte (il Bambino Nero dell’omonima ultima poesia). Affermazione di vita piena allora con la quale vi lasciamo: “Dai retta a me/canta/ un modulo scattante/ una beguine/ per queste luci soffici/ di pergolato:/ c’è chi balla / si abbraccia alla camicia chiara/. Dai canta,/ che sappiamo noi le parole,/ a te il respiro/ o il fischio aspro/ del merlo”.
Id: 741 Data: 30/08/2013 12:00:00
*
 Guido Pellegrini - Poesia - Edizioni Gazebo
Guido Pellegrini - Poesia - Edizioni Gazebo
L’amor segreto e altre storie
Libro di vita prima che d’amore questo di Guido Pellegrini per le care e sempre preziosi edizioni della Gazebo dell’ inossidabile duo Bettarini-Maleti. Libro di vita dicevamo che si compone di due parti in realtà strettamente correlate nel dire d’ognuno lo sfondo d’inquietudine e erranza che solo l’incontro con l’altro può sciogliere nel compimento. Entrando direttamente nel testo, un verso lo testimonia con forza, ma anche con una tenerezza ed un urgenza quasi che ci appassiona, nei “Sonetti erotici”. “Non può lasciarsi andare chi non è/ mai stato abbandonato..” ci sussurra infatti nel bel rovesciamento del concetto di chi per abbandono è restio ad affidarsi. Poesia che nel rovescio stesso della struttura ci racconta suddividendosi, al contrario di quanto suggerisce il titolo, in un prima di movimento e mutazione soprattutto personale e interiore di “Altre storie”, la parte iniziale appunto, e della lotta e della presa comune d’amore della seconda, “L’amor segreto”, poi. Anche se a dire il vero motivi e forme del fervore e delle dispute umane sono legate dal medesimo conduttore della finitudine che ci è propria e dalla condizione di dolore e di fatica connesse. Ciò che le caratterizza è una dolenza che fieramente non si insegue ma che rimette nel registro delle trasformazioni in cui siamo iscritti la naturalezza d’ogni possibilità, e di ogni incisione, nella lotta e nella stretta d’insieme. E’ un versificare allora questo di mondi continuamente in dialogo a riaffermare della mortalità quella pienezza di vita che viene dal suo ciclo di rinascita e fine e che proprio nel respiro e nella forma continuamente rimodellata (seppur nella pena, seppur nell’affanno) dice della terra stessa, da noi, la sua continuità e il suo divenire. Rimodellare ed apertura di terra ma soprattutto di mondi ben cadenzata nella prima parte nella sezione (“Dei due mondi”) dedicata da Pellegrini allo spazio duplice del proprio farsi e della propria memoria rappresentata dall’incontro tra la Montevideo e l’Uruguay della sua infanzia e la Toscana della ripartenza che qui s’indovinano nella rievocazione d’amore tra il pittore uruguayo Domingo Laporte e Giulia Marinelli figlia della seconda moglie di quel genio pittorico chiamato Giovanni Fattori. Nella vicenda ritroviamo dunque gran parte delle istanze e dei temi del libro: da un destino che va seguito nel coraggio della cura alla realtà vivificante dell’ amore in cui nulla mai davvero si perde ma tutto si accompagna e ci muta reciprocamente nell’altro facendo sì che senza questa misura a nulla valgono le pretese dell’io (e il corpo e il nome stesso), alla direzione in noi di padri e di madri che ancora si rivelano e di figli che è “ tutto il miracolo che abbiamo ” . E ancora , anche, le sospensioni tra sosta e movimento, tra scelta del silenzio e dovere dell’ascolto e della parola in un presente che nelle diverse disposizioni con ostinazione si profonde solo nel confronto , nel “prendere il volto degli altri” , perché “l’eternità è un fatto orizzontale , / (..) / è la sua corsa sotto questo cielo”. Coscienze e consapevolezze che trovano poi, entro le cinque sezioni de “L’amor segreto” (nella struttura nobile del sonetto che in una lingua chiara, incisiva e pressante praticamente abbraccia l’intero libro) dilatazione interrogante e ricongiungente nella figura di lei e di un amore celato, non svelato per il timore di chi dubita vedendo nella radicalità d’ ogni autentico amore la sua sconvenienza di vita, il suo contraltare d’opposizione alla morte. E ripronunciamento, qui magnificamente simbolizzato nei quattro componimenti di “Danza nel cielo” nelle cui figure dell’aquila ferita, che nel nido sconta il dolore in attesa di perdersi nello sfondo che lo compie, e del falco addestrato, che nell’istinto che ancora gli è proprio gira in deviazioni non richieste portando tra l’altro sollievo di cibo alla stessa aquila, è possibile scorgere nelle forme dell’ accettazione e della sofferenza quella prossimità della natura presente anche in noi che in Pellegrini ha valore di pensiero e di orizzonte. Ma l’orizzonte, sa anche bene, ha bisogno di un suolo, di una destinazione forse definitiva che in questi versi appare ancora nel volo del falco che scendendo nel giardino atterra e sposa la sua preda coraggiosa, l’amante segreta come detto, la donna tenace e pugnace pronta anche alla guerra e alla scommessa della perdita nella preservazione del sentimento, consapevole giustappunto che è soprattutto nella consistenza del nostro incidere e del nostro imprimere la discrimante tra vivere e passare. Così l’amore sensuale e l’amore domestico con cui ci saluta nelle poesie finali ha nel volto e negli abbracci dell’amata, che sempre gioiosamente e miracolosamente ritorna, il senso del sé di ieri ora raggiunto, e che ne “La finestra di camera da letto” ha fertilità di colore - e nuova direzione- nel quadro di se stesso che perdendosi nel panorama dei luoghi degli affetti cari ne sa vera fecondità in lei dentro la stanza. E’ una lezione questa appresa tra slanci e perdite, tra ritrovamenti e dolori che hanno in queste pagine il sapore e l’odore della forza di un’ esistenza sempre in gioco nella consapevolezza, amara forse ma terribilmente concreta nella sua costrizione di spina, che (come sostiene in “Risveglio dei mortali”) nel perdurare è il male, e che solo argine alla dissolvenza è la corrispondenza nel tempo aperto dell’inadeguatezza e della solitudine. Fatica di vivere e morire, come detto. E di amare, dunque, nel riconoscimento che ci fa più caro, e libero, il respiro. Nella particolarità del libro, nella petrosità del suo esserci, alla fine a noi sciolto e donato.
Id: 719 Data: 15/10/2013 12:00:00
*
 Elisa Poletto detto Feltrinon - Poesia - LietoColle
Elisa Poletto detto Feltrinon - Poesia - LietoColle
Verità nascoste
Seconda prova dopo “Scale di pezza” del 2007, questo piccolo libricino è il resoconto di un percorso tutto pensato, o per meglio dire che si osserva pensare di un autrice che, per formazione e orizzonte, muove e iscrive di base nella filosofia le proprie interrogazioni. Eppure, come ricorda Markus Ophalders nell’introduzione, altrettanto forte è nella Paletto la consapevolezza di una verità filosofica insufficiente all’interno della logica dei suoi schemi fissi a cogliere- e di conseguenza a sciogliere- quel carico direzionale di significati che si cela nella realtà emozionale e passionale di tutti i giorni. Fedele all’ impronta di una poesia filosofica che in lei (come da dichiarazione nella nota introduttiva personale) ha nel Nietzsche zarathustriano il nume tutelare, si affida e affida allora alla capacità rivelatoria insita per intuizione nella natura e nel pensiero d’ogni vera poesia l’argine di illuminazione di un mondo il cui vuoto di valori è da ricreare a fronte della non-cultura e delle compressioni del virtuale. Questo però la Poletto, nella bontà dei suoi richiami e asserzioni di volontà di potenza, mentre poi c’è la Feltrinon, l’alter ego di una ragazza che si rivela dolcissima, impaurita, persa, in un cammino dolente verso e oltre “la Valle” nella consapevolezza di una sofferenza spesso estraniante, oscura ma sempre in lei in qualche modo partecipe della via da apprendere entro una sensibilità che ha proprio nella sua fragile nudità il modo più compiuto di viverla. Dolenza di un’anima e di una giovinezza che se nel racconto, come evidenziato dallo stesso Ophalders, limita il più delle volte il lettore ad una pesantezza di lettura ingolfata da un eccesso di buio ha nella confessione della propria immaturità il suo rivolo acceso, la sua freccia di luce, teneramente e incisivamente espressa nei versi conclusivi di “Estate in città”: “mentre aspetto/ la soluzione (o,/ forse,/ l’assoluzione)/lascio impronte/ nell’asfalto/- come una Pollicina-/ per ritrovare la via”. L’itinerario, che si snoda poesia per poesia nelle tappe e nelle ferite delle tre sezioni (“In viaggio verso la Valle”, “Piccola deviazione” e “Gallerie e spiragli”), ha nell’alternanza di sfondo cittadino e silvestre (anche ma soprattutto nella sua rimemorazione) il quid di un equilibrio difficile da trovare tra alienazioni e abissi fuori rotta che solo il soffio lirico di una caduta di stelle per un attimo pare di nuovo mappare (come in “Settembre 2007” le cui immagini nel medesimo respiro ci riportano ad un altro fervido nicciano, il marradiano Campana) e che in “Esodi e appartenenze” (testo con cui si chiude la prima sezione) nella prospettiva che va oltre la Valle sembra trovare nella prefigurazione dell'apparizione decisa della cometa (in un immagine comunque molto cristiana) il sigillo indistruttibile di chi nell’unione ha superato e forse vinto la notte. Ma nel suo stato di viandante la nostra Elisa sa che il cammino, sulla “strada dei ritorni”, pur tra deviazioni continua. E le verità nascoste, anche se parziali e anche loro fragili come abbagli, possono esser il segno di una scia luminosa abile a rendere meno spinoso il percorso e al tempo stesso provenire da chi, con amore e per amore, più serenamente lo condivide con noi. Consapevolezza questa, e forza, in un gioco d’occhi con l’amato sempre presente nel libro e che in “Ho sciolto lo scrigno” le consente di liberarsi dalle paure riconoscendo la bellezza nell’accettazione fiera di ciò che si è, insieme miseri e divini nei difetti che pure il giorno possiede. Ed è questa, anche, la maestria da apprendere che tra “sogni mistici/ e dialoghi di fede” nei due testi conclusivi (“Armonia” e “Rivelazione”) si leva nel lascito. Maestria che si dispiega però solo dall’amalgama di ”pasta e carne,/ sacrificio e preghiera” che, come nella luna che sfiata dai palazzi negli ultimi versi, ci richiama- vincendo il reciproco abbandono- a quell’accordo di natura qui ben carezzato dell’immagine “del mare da lavorare”. Ci resta dunque al termine un lavoro per alcuni tratti acerbo, soprattutto per personalità nella lingua e nella versificazione, ma presente nelle sue direzioni e nel pensiero e certamente autentico per urgenza e ricerca, e tenerezza che ribadiamo ancora affidandola a questi ultimi versi:” Chissà se/ mi veglierai ancora/ quando sarò/ una vecchia signora,/ saggia e incontinente/- il foulard a chiazze/ i capelli grigi/ di permanente e passioni/ trascorse-/ il doppiopetto infeltrito/ di solitudini e poesia…/ Quando il ricordo/ sarà il presente/ e il tramonto scenderà lieve/ sui giorni della monotonia...”.
Id: 715 Data: 25/06/2013 12:00:00
*
 Ennio Abate - Poesia - Edizoni Cfr
Ennio Abate - Poesia - Edizoni Cfr
Immigratorio
Ennio Abate, Immigratorio, Edizioni Cfr, Plateda (Sondrio) 2011. La parola immigratorio è una di quelle parole che di per se stesse si impongono per il carico di densità e, dunque, di aspirazione umana che la attraversano. Eppure qualcosa nella sua risonanza si perde come per separazione da un muro di cui si sente nel riflesso tutto il disagio. Forse ciò è dato dalle naturali assonanze che la parola stessa richiama e che il nostro immaginario nelle sue tensioni, nella concretezza di una realtà sociale oggi sempre più al limite, tende a rigettare e a escludere. Assonanze, dicevamo, che portano con sé il buio e la solitudine del dormitorio, nel suo profilo d’emergenza prima e d’abbandono poi, o di parlatorio, di stazione di permessi e di transiti strappati o negati. Più ampiamente però contiene anche in sé questa parola, in fuoriuscita, l’incontro e lo scontro di mondi che in qualche modo reciprocamente si sono attesi e vegliati all’interno di una medesima crisi, ed i cui drammi, nella negazione, evidentemente richiedono adesso una risposta diversa nell’inceppamento di un mondo che non sa più ripensarsi. Queste e altre considerazioni solleva e rileva Abate in questo testo che doverosamente (e volentieri) ci sentiamo di consigliare e che ci invita a riflettere insieme partendo dalla sua conclusione focalizzata sul contesto attuale della realtà immigratoria del nostro paese. Giacché il racconto di Abate (figura schietta e poliedrica di professore di liceo e intellettuale di campo, tra saggistica, poesia e disegno) diparte dalle personali e progressive immigrazioni di campano trapiantato dapprima dalla campagna natale al capoluogo Salerno e da qui poi dagli anni del lavoro e dell’Università a Milano. Formazione e biografia la cui catena di risultanze nei suoi diversi passaggi, ben descrivendo riluttanze e marginalità di un Italia da molti e per molti versi subita nel suo momento di maggior crescita, fornisce nella testimonianza una traccia non secondaria per la comprensione, nel superamento, di alcune dinamiche legate ai nuovi flussi. Il segno, dunque, è quello di una scrittura che si serve del dato personale per fare del testo, come ben osserva Pietro Cataldi in una prefazione che per puntualità e ricchezza andrebbe riportata tutta, la “ricostruzione di una condizione stabile della civiltà moderna e del modo in cui il soggetto ha trasformato in destino la scelta dell’emigrazione” e che Abate concretamente realizza a partire da tutte le caratteristiche e “le contraddizioni delle diverse identità che il soggetto si trova costretto ad assumere” . Contraddizioni poi che sono quelle di uno status neppure mai probabilmente a metà tra realtà lasciata o terra che in qualche modo si vorrebbe acquisire ma quelle allora di una condizione terza alle altre sovente sospetta per un'identità non evidentemente riconoscibile (quando non oscura ed invisa persino a se stessa). L’operazione allora è quella di sollevarla nella sua dimensione natale- e per questo esemplare- di pluralità di spazi nei cui attraversamenti, ed anche sì nei suoi deragliamenti, è possibile cogliere, e iscrivervi finalmente un’ orizzonte di percorso attivo e fattivo proprio all’interno, e dall’interno, delle sue sovrapposizioni personali e comuni. Orizzonte che come Abate sa bene ha le sue radici in un mondo, più che in una terra, le cui lacerazioni e le cui ossessioni non smettono di dilatarsi nei fantasmi delle perdite e dei propri reciproci crediti qui raffigurate tra una campagna ed un infanzia ancora magicamente ancestrale (sullo sfondo di una guerra che appare riservata solo agli adulti) ed una Salerno forse per sempre matrigna tra coralità e dolcezze di figure care ed una città murata tra domini clericali e gretti affari locali. Si vedano nella prima parte “O seminarie”, “Oh, parrocchietta del Sud” ma soprattutto “O Requiemm’e pe Franch Alfane” e “A morte e papà” , in cui è rievocata tutta la fatica di una vita e di un mondo che si spegne con lei mentre i figli sembrano assenti, appena nominati, come se non appartenessero a quell’azzeramento, come se il destino li chiamasse già lontano, salvandoli in una fuga che nel primissimo omonimo testo (“Immigratorio” appunto) è consapevolezza, in un resoconto veloce, violento e crudo, di una scelta netta quasi a non sentire il dolore (ché anche quello è un niente e può essere un peso) verso una vita di cui già si fiutano le insufficienze e i pericoli ma che pure appare come l’unica fertile possibile. Nel bagaglio verso la città del Nord, “la più ignota tra tutte le città”, aspirazioni di vita e di cultura affrancate dal presepe lasciato ma subito mortificate da un lavoro che abbassa le ambizioni e dagli inseguimenti ai consigli più diversi nel timore che il denaro possa finire (impaccio o muro che l’esergo anonimo riportato all’inizio e dal sapore minacciosamente dantesco ricorda: “e tu, mo ca si arrivate ccà (Milano), che vulisse?”). Eppure non è solo qua (siamo nella sezione “Alto immigratorio a Milano”), nei dettagli di convivenze di pensione e una grande folla ovunque, di urgenze giovanili e flirt impiegatizi, la misura dell’ approdo e della costruzione di sé (resocontata nella dialettica del contrasto con l’amico Bis rimasto a Salerno). Il cuore del testo è infatti nella sezione “Basso immigratorio a Colognom”, nella sottoimmigrazione col matrimonio da una Milano di “cetomedisti” al trasferimento presso la città satellite di Cologno monzese (pezzo della Milano-Corea anni 60-70), “in quel guanto rovesciato del sud” tra un lavoro operaio e notturno alla Sip e i corsi presso una Statale sempre più politicizzata. Luogo, questo, per certi versi paradigmatico delle più svariate insufficienze, del privato come della cronaca pubblica, di una cultura che sconta forse i limiti delle proprie astrazioni e di una politica quando non collusa incentrata sul proprio piccolo e personale potere . Ne è fedele testimonianza non a caso , tra i tanti testi che dovremmo citare, “Colognosità”, amaro e rabbioso ricordo del tentativo fallito di far nascere una nuova scuola per figli di immigrati in un pezzo di “terzomondo terrone” da cui nella visione è facile purtroppo lo scioglimento della lettura e dello sgomento che si palesa quasi ovunque (come in “Prefabbricati” nelle cui modalità gli amministratori si adoperano contro gli sfratti ed in cui il pensiero non può non tornare con evidenza proprio ai presepi dell’infanzia per la mortificazione delle figure nella sproporzione degli spazi, o anche come nelle figure che gridano ed espellono in marginalissima dolenza da “Un pensionato”). Ma da tanto smarrimento, da tanto scarico umano ci verrebbe da dire, la forza (“Metafisica d’immigratorio”) che, come detto, al termine si dipana è la chiave di consapevolezza- e di intelligenza- con cui si invita a guardare ai nuovi immigrati, ai nuovi immigratori mai disgiunti nell’azione da una prospettiva plurale dello sguardo. Sguardo da Abate raccontato abilmente nella felice e necessaria commistione di poesia e prosa, di dialetto e lingua sulla cui valenza ora purtroppo non possiamo dilungarci, ma incisivamente accolto dalle Edizioni Cfr di Gianmario Lucini, altra figura che certo non conosce retrovie.
Id: 713 Data: 21/06/2013 12:00:00
*
![]() Marisa Papa Ruggiero - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Marisa Papa Ruggiero - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Passaggi di confine
Quello di Marisa Papa Ruggiero è un nome certo non nuovo nel panorama poetico nazionale, soprattutto non ovvio per un percorso in sé mai banale, mai definitivamente e criticamente compiuto ricco com’è, tra l’altro, di relazioni con le applicazioni e le interrogazioni delle Arti visive, altro genere con cui in un gioco aspro e baluginante forse da un tempo ancora più lontano lei stessa si misura. Sentieri dunque, infinitamente e labirinticamente paralleli, che in questo agile libricino si biforcano e si intrecciano in una modalità di tensione ora respingente ora assorbente dentro una lingua- mai sopita- che proprio entro questi rovesciamenti continuamente si prova e si nutre. Degna veste allora ci appare la collana di Arte-Poesia “Coincidenze” delle Edizioni L’Arca Felice curata da Mario Fresa e corredata, oltre che da alcuni interventi visivi dell’ autrice e da una breve antologia critica, da un interessante incontro-dialogo tra il curatore e la Papa Ruggiero. Perché il campo da lei attraversato è partecipe di figurazioni e lacerazioni diverse, di sommovimenti e fonicità di soglia, quasi preconscie, difficilmente catagolabili se non all’interno di una sinestesia di espansione che solo, giustappunto, nei suoi “passaggi di confine” può dire, o meglio, scandire le proprie metamorfosi e i propri tormenti in un nominare che tenta il suo azzardo in una ontologia quasi costantemente azzerante perché di rimando e che ci sembra, sì, l’impronta vera di questa scrittura qui agilmente divisa in due sezioni, “Asintoti viaggianti” ed “Energie di campo”. Sezioni che a ben leggere è facile intuirne l’una dell’altra le derive di scena e i naturali – ma come detto mai definitivi- approdi che già il termine asintoto sapientemente anticipa. Giacché in una storia, la nostra, in cui nulla davvero mai ci viene saldato ma rimandato in un tempo che quotidianamente gioca a smentirne i passi, ogni tensione in realtà può rivelarsi un semplice spostamento di confine che ci avvicina indefinitamente a un qualcosa ogni volta destinato a sfuggirci come curve le cui prospettive non smettono di annunciarsi e insieme svanire. Eppure è proprio in questo costante rimando che l’arte della Papa Ruggiero si staglia tra energia e risucchiante dolore in questo mistero che l’esergo di Kounellis con incidenza dipinge in ogni canto che nella sua rivelazione muore. Ma che pure aiuta a sopravvivere se pure quella rivelazione nel limite di una distesa che procede per scarti e fratture, per automatismi e tra innumerevoli varianti, “mai conoscendo l’intera casa/ma la radice quadrata/ della stanza”, è risonanza- ed eco- a muovere nuove note oltre il recinto. Perchè ciò che interessa qui, nel peso di una consegna che ci condanna al continuo conteggio di noi stessi , è la spinta proprio all’ interno di ciò che spezzando ci rinchiude e ci nega il colore , quasi in una sfida umile a non mancare più “ il solo scatto di congiunzione che spezzi il sistema”, grazie alla misura di una possibilità continuamente ridetta e avvertita, pur nelle sue insufficienze, pur nell’“imprevisto/ di un gioco a incastro/ sempre irrisolto eppure”, come la sola forma di senso in grado di non far perdere i contorni a quel “clandestino” che (come nel canto di Ulisse) nell’erranza in noi continuamente ci compie e ci reinvia proprio nel mantenerci presenti, e vivi, ai diversi segni di vita. Presenza che poi forse è impronta oltre che della vita anche d’ogni vera poesia, se e dove ogni incontro nelle interrogazioni è financo, come detto, ripartenza per restare, come l’ultimo movimento di Asintoti suggerisce, nella sola estrema consapevolezza dello sguardo e del corpo che in questa poesia ha il valore non secondario di crinale e di voce che nelle sue sospensioni assorbendo rimuove e riporta. Così nella seconda parte, in “Energie di campo”, l’accelerazione e la direzione del verso nei fulminei sopralluoghi delle sue istantanee, “forzando il punto del vero/ che accoglie il non visto”, in un movimento che è un andare verso il centro senza mai varcarlo, trova nell’incisione la chiave d’apertura nelle infinità delle maglie, l’assunto base di un flusso sempre in anticipo o in perfetta sincronia col visibile per sua natura il visibile covando e vegliando nella germinalità delle immagini. Ed è quindi in questo incedere che “passa nel dopo ed entra in ciò che segue”, per non interrompere quella scia di annunci che nell’attirare e nel respingere ci salvano dalla trappola definitiva degli arrivi in cui l’io potrebbe davvero perdersi, la bellezza vera di un percorso sempre criticamente e dolorosamente attivo a dire dell’umano tutte le incrinature- e le meraviglie- delle proprie inappagate imperfezioni. E che ha nello sforzo di avvicinamento a quelle figure che nei segnali vogliono esistere diversamente, come nel colloquio con Fresa lei stessa rivela, il segno irriducibile di una poesia e di un amore espansi. Motivo questo che più risalta e apprezziamo del libro.
Id: 708 Data: 04/06/2013 12:00:00
*
 Pasko Simone - Poesia - Interlinea edizioni
Pasko Simone - Poesia - Interlinea edizioni
Piantate tutto
Sì: “Piantate tutto”. E’ l’invito scandito con forza, con sarcasmo ma anche con malinconica dolenza che si leva da queste pagine intrise di rabbia e di bruciante mestizia per un mondo unito da una globalizzazione di rovina; scarnito, divorato, offeso da processi economici e politici deviati, senza controllo nella macina di una produzione che nella crisi provocata da suoi stessi circuiti va ad alimentare all’infinito se stessa senz’altro profitto che la caduta e la cancellazione degli uomini e degli oggetti di cui si serve: il precariato, la morte quasi programmata e poi rigettata degli operai come nel dramma della Thissen in cui si spengono anche le ultime utopie, i tanti suicidi dei pensionati, sono infatti solo alcuni dei segni della avanzante Apocalisse qui adombrata . Ed allora non ne ha per nessuno Pasko Simone (in quel nome quasi da battaglia): dai mangiafuoco della politica, ai tecnici di una bassa economia da fine Impero, dagli ingessati, cerei operatori di borsa, alle eminenze nemmeno tante grigie di un clero avido e ruminante (nelle cui immagini la Deità finisce con l’apparire come una Deità nera che al pari di un usuraio è pronto al riscattare al meglio le proprie compravendite), agli acritici esecutori servili e cerimoniosi dei dettami imposti che insieme hanno contribuito a far regredire spirito e dignità umana fino ai primordi delle divisioni in tribù (come in “Mutazione antropologica”). C’è un passaggio, giustappunto in “Produttori”, che rivela e spiega appieno tutto questo: ” perché per qualcuno più che per altri/ il denaro viene al mondo/ con una gran voglia di sangue/ in piena faccia”. Sangue e carne che viene così bevuto, divelto nelle pieghe di una Storia come sempre divisa tra chi la impone e chi la subisce nel recinto drogato delle proprie piccole liturgie in una contemporaneità di guerre democraticamente perpetuate e videocrazie e informatizzazioni silenziosamente e scientificamente antropofaghe (anche se nell’era digitale il controllo può anche rovesciarsi- in “Generazione-no future” avvertendo). Il discorso di Simone ruota dunque, nella vigilanza, allo smascheramento (come nella poesia omonima) di questo mondo nuovo con tanta demagogia iniettato nei ribaltamenti di un tempo che non ha più nulla d’umano, l’umano sempre più macchina a disposizione del proprio auto-inghiottimento. Eppure, a proposito del tempo, non è solo questo il momento su cui si fonda la narrazione; un altro, strettamente correlato evidentemente circola sullo sfondo in una dialettica sì di rottura ma anche di memoria, forse di ricominciamento. E’ il tempo forse anticipato dalla bella epigrafe in apertura tratta da Char:” Solo gli occhi sono ancora capaci/ di gettare un grido”. Un grido già descritto a dire la separazione in atto da una“terra di nere afflizioni” su cui si leva sottovoce, in una quinta di distanza il pianto dell’astro in cielo, “il dolce punteruolo/d’un sembiante perduto in volo”, mentre gli uccelli ostinati continuano e cercano (loro sì) il volo “ in un cielo ancora/ stranamente/ azzurro”. Il respiro allora prova a fendersi lontano da questo cupio dissolvi, in un ritmo controcorrente senza bilancio dei giorni verso ciò che al contrario, nella passione, può ancora concedere qualcosa di febbre senza più ansie entro un tempo che mai davvero segue il nostro, scombinando piuttosto aspirazioni e progetti e dove la salvezza può passare forse solo nella forza e nella temerarietà della donna, nelle sue capacità creative e di pace. In “Teshima”, dal nome di un’isola giapponese in cui l’artista Christian Boltansky archivia i battiti del cuore dell’umanità, le domande sulle tante esistenze disperse, sullo spreco di vite senza alcuna contropartita, su una infelicità racchiusa ormai in una felicità virtuale, indirizzano così a seguire il discorso verso un affidamento totale e consapevole alle sorti e ai geni della natura, al suo flusso (“Darwiniana”) in una lettura e rilettura di se stesso, all’interno delle proprie forme e dei propri pensieri in cui un io fieramente privo di radici molto anche dice dei propri rivolgimenti e delle proprie contraddizioni:”da solo mi leggo e mi rileggo/ ostaggio di me stesso” (“Ermeneutica”). Ed è questo il punto di maggiore intensità e forza, secondo il parere di chi scrive. Questa rivelazione anche di malinconia, di scompensato fragile disorientamento che soprattutto in “Tra le righe”, dove la sua” modesta ragione” di righe che “non valgono la bestia nera”, ci cattura dal profondo. E che, a nostro dire, va a compensare quel deficit di scrittura (vicino alle corde della Neoavaguardia- qui richiamata nell’omaggio a Sanguineti) in alcuni tratti eccessivamente criptico che rischia, per forzatura e fors’anche per un po’ d’auto-compiacimento, di disperdere quel fondo d’autentica prossimità che è alla base del libro e che nella poesia da cui prende il nome, nel coraggioso invito a lasciare tutto- famiglia, patria, utopie, sogni, possessi, ricerche di giustizia- per “partire a piedi per le strade” si nasconde per Simone la chiave d’ogni vera, della vera resistenza, nello “sforzo della rosa per non rimanere altro che rosa”.
Id: 701 Data: 21/05/2013 12:00:00
*
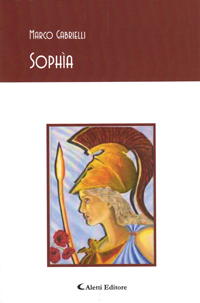 Marco Gabrielli - Poesia - Aletti Editore
Marco Gabrielli - Poesia - Aletti Editore
Sophìa
Riannodare i legami interrotti, rivivendoli ed eternandoli nella (ri)scrittura: quale altra aspirazione, quale altra fede si nasconde dietro ogni verso d’amore, soprattutto se racchiuso nella claustrofobia delle assenze e dei sentimenti spezzati ? E’ quello che si propone Marco Gabrielli con il suo “Sophìa”, diario, o per meglio dire, Canzoniere quasi d’un amore finito durato undici anni e qui celebrato in tutte le sue più diverse fasi (come nella prefazione stessa ci ricorda) tramite gli stati d’animo relativi. Dall’entusiasmo dell’incontro, quindi, e della conoscenza a quello del desiderio, dall’intimità acquisita alla disillusione e alla malinconia degli equivoci e delle chiusure, trentasei poesie - con invocazione, esordio ed epilogo - a delineare un percorso costellato di corteggiamenti e schermaglie, di passionalità e ritrosie secondo i consueti giochi d’amore tra i sessi. Tutto ciò raccontato in una lingua che guardando al passato nell’ossequio della classicità del canone, al tempo stesso ne tenta necessariamente la conciliazione con le contemporaneità dei costumi e delle forme. Così, il nostro innamorato nella rassegna dei propositi di servitù e obbedienza cortese all’amata, nelle lodi delle virtù e delle grazie quasi divine di questa, nel crogiolo degli impulsi e degli irretimenti sopra accennati - tra bellezza assoluta e carnalità dirompenti - muove a una conoscenza di sé tramite la conoscenza dell’amore, tramite il sé dell’amore, che ha nei suoi lineamenti ora assorbenti ora estranianti la propria antica e non scalfibile modernità (in questo caso poi, il rimando al significato di conoscenza inciso nel nome di lei sembra non essere iscritto a caso , come in uno scherzo dei destini e come nell’appello iniziale ad Atena, Dea greca delle arti, della scienza e della giustizia). Stazioni di una malia, anche, scandita volta per volta dagli aggettivi stessi incisi nei titoli e sovente, naturalmente, riferiti alla donna: “Pura”, “Perfetta, “Tenera”, “L’Eletta”, “Giocosa”, “Attrice”, “Virtuosa”, “Gloriosa”, per citarne alcuni. Eppure, in tanto slancio, nell’ardore e nel dolore, qualcosa nella narrazione lirica qui non arriva, purtroppo non funziona. Probabilmente, infatti, il testo alla lunga finisce col pagare un eccesso di ripiegamento dell’autore, spesso al limite di un solipisismo raramente funzionale. Il rischio quindi a cui il lettore va incontro è quello della noia all’interno di un copione tracciato e cantato con una pomposità e una verbosità insapore, escludente, dietro al quale Gabrielli più che celebrare un amore sembra a tratti celebrare se stesso, in un fare e disfare privo di ironia, o di un’autoironia davvero coinvolgente. Piuttosto, in quelle isole di luce di abbassamento di tono in cui l’uomo si sorprende con sgomento, senza artifizi, di fronte a una grazia e a una bellezza che lo rivela pienamente nei suoi limiti, il dettato finalmente si libera in un sentimento continuamente ed umilmente riappreso e dove la stessa gioiosità del gioco ha la brillantezza di un verso forte, consapevole del sentiero cui volge, lo spettatore nel suo teatro riconoscendosi. Da questo dire autentico, di cui riportiamo alcuni passaggi, è possibile allora ripartire ci pare di poter indicare. Come nel testo XVI, “L’onda”, dove nell’amarezza per la perdita dell’amore causata da proprie colpe - in una bella sicurezza lirica - sente la propria sofferenza non esser che l’onda “del vicino mare che’l mondo circonda”. O nel XXII, in “Amata”, certamente tra le migliori, in cui il riconoscimento della crescita personale dovuto all’amore e alle virtù di lei è luminosamente riportato nel rinnovamento della promessa in un inizio ricco di tenerezza: “Come il cavalluccio marino/, Che senza la sua compagna sta,/Monogamo muore,/ Così io mi spengo/ Senza Lei”. E forse non è poco, se alla briglia della scrittura, pur nella miccia delle accensioni, viene dato maggior controllo. Perché purtroppo non siamo molto d’accordo a proposito di quanto scritto nella presentazione da Beppe Costa. Se, nella bottega della poesia “dove si cercano le rime” e le rime si incrociano, si accavallano o si baciano è facile a volte perdersi, o cadere nella banalità, Gabrielli dovrebbe maggiormente soffermarsi sulla qualità o meno degli strumenti in possesso e la conseguente, necessaria e umile aderenza.
Id: 693 Data: 07/05/2013 12:00:00
*
 Nicola Peretti - Poesia - LietoColle
Nicola Peretti - Poesia - LietoColle
Sui campi di battaglia
La fede e l’attaccamento al bene fondante e rigenerante della poesia, che è nella veglia e nell’accompagnamento, nella sua capacità rivelatoria e azzerante, è il segno vero di questa raccolta, opera prima di un autore già fortemente maturo per compattezza e misura del verso, per vigilanza e fronte di sguardo. Per una presenza radicata in quegli spazi dove tra umano e preumano il tempo e la terra si affacciano e si celano rivelando negli sfilacciamenti un progressivo disconoscimento tra persone e luoghi, tra spiriti che seppure necessariamente in contatto non si lasciano accostare. Non a caso, e non a sproposito - proprio nel cuore del testo - la verità del discorso poetico, d’ogni discorso poetico, viene indicata da Peretti stesso in una cosmogonia di impronte nella cui voce è l’origine e il mistero che ci trascende. Cosmogonia qui racchiusa nella piccola (ma in quanto tale compiutamente e perfettamente esemplificativa) area di vita del cuneese in una geografia attraversata e vista profilare nei suoi rimandi verticali, a ricucire e a rimarcare nel peso di un sotteso silenzio tutta l’inquietudine di uno smarrimento non solo personale “nel mondo che non vuole/ più essere nominato/ nemmeno sottovoce” . La dedizione è allora nel solco di un paesaggio da cui l’uomo pare non attendere più direzioni, narrato e vigilato nelle forme e nelle figure di una pericolosa interruzione e di un’oscurità senza riflessi incalzata e avversata in tutte le sue cancellazioni. Campi di battaglia (nel rimando dall’opera di copertina di Chiara Argentieri), inabitazioni che la parola e la presenza poetica tenta di spezzare dagli spazi vuoti, dai suoi frammenti colmandone i margini. Dai sopralluoghi (giustappunto il titolo di una delle prime sezioni) all’elegia della piana (cui è dedicato il poemetto in chiusura) l’attenzione infatti è sempre rivolta a quella linea di fedeltà e tensione tra spirito della natura ed uomo che sola- nei termini di una risonanza antica, e a tratti ancestrale - può rimemorarne e riannodarne il legame. La figura narrante così, nell’efficacia del libro, appare sospesa tra un’etica e una religiosità del territorio come spazio di determinazione e cura del vissuto e i disfacimenti di un moderno ai cui inceppamenti non potendo indicare vie d’uscita ne contrappone con disarmata, e realistica, onestà gli echi, le feritoie (“Che tutto, anche il domani,/ accade alle tue spalle”) e dove perfino l’amore non si discosta da questo senso continuo di terra che si affaccia e si cela, si affida e si nega tra ricongiungimenti e fredde staticità da distacco. Poesia dunque che si imbeve di questi umori nel respiro profondo in cui Peretti tenta di versarsi sempre, sempre trasmettendolo nello sforzo di far tornare alla luce “ il posto di ciascuno/ la sua parte nel vuoto che è di tutti” (come l’amico in “Guida dell’anima”). E determinazione in cui il non compiuto è riformulato già nella sua dignità di desiderio e speranza attiva, nella consapevolezza geologica e costruttiva del verso in cui è riposta (incontro “a una salvezza/ che quasi mai ci appartenne”) tutta l’inquietudine e la corrente della raccolta. Il lume così, pur nella petrosità del dettato, è in una germinalità delle ombre raccolta e racchiusa entro e oltre la refrattarietà di un suolo che dopo aver rovesciato e rimontato i confini in un’opera secca di recisione quasi attende e presagisce ancora tra alluvioni e fughe telluriche un futuro di nuove rovine. Osservatore e custode fedele di uno spicchio del paese, di una zona, di monti che “da sempre /sanno e piangono”, Peretti dunque ne testimonia il paradigma, registrandone e misurandone le voci nel tentativo di ridestare uno sguardo che da noi stessi e le case si ridisponga finalmente in un cammino, per quanto frastagliato e complesso, intessuto di una storia e di una identità comune in una terra non più animale-preda ma ventre nudo su cui, allevato, il nostro profilo nella giusta rispondenza si riconosce e si espande (vedi, ad esempio, le belle descrizioni nel primo movimento della sopracitata parte finale “Frammenti per un poemetto: la pianura”). Richiamo, però, che per lucidità del peso sa bene su quali soglie fermarsi: “Guardati dal tuo stesso guardare”, si dice, e: “Temi il guaito dei cardini,/ tu che sai”, nel pudore e nel rispetto di una poesia che sa diffidare anche di se stessa, dote assai rara ormai in tanta scrittura. Piuttosto, se un limite ci è dato segnalare, è in un eccessiva cripticità di fondo che in alcuni passaggi forse sarebbe meglio sciogliere a favore di una resa piena dello sconcerto e dell’emorragia di un tempo che qui traspare senza difese. Piccola piega comunque in una concezione della poesia raccontata e sostenuta nella sua piena e originaria sacralità: “Poesia/ è sempre l’occidente/ di ogni suo pretesto,/ uno spazio che non curva/ e non conclude (...)/ luogo/ di crolli tenaci, d’inaudite promesse”.
Id: 686 Data: 12/04/2013 12:00:00
*
 Mario Masini - Poesia - Lalli Editore
Mario Masini - Poesia - Lalli Editore
L’Astronauta del cuore
Raccoglie quest’antologia quarant’anni di attività poetica il cui racconto può esser anche letto in termini di cronaca, di romanzo in versi quasi (come ben suggerisce nella bella introduzione Hilde March) di una vita mai quieta, mai doma, nelle proprie rivendicazioni d’amore. Amore che se incentrato attorno alla figura amata rincorsa e patita non esclude però lo spazio esterno dalle proprie corrispondenze e dai propri inceppamenti ma lo coinvolge pienamente facendone il referente primo a cui quello stesso amore deve guardare per il proprio umanissimo completamento. Sacralità e consapevolezza delle iscrizioni che Masini, pur nell’acerbità del verso, ha ben presente fin dalla prima esile raccolta “Quando piangono gli angeli” (che poi confluirà con delle aggiunte nelle successiva “Piccola selezione”) contraddistinguendone la poesia fino alle prove della maturità. Amore di donna e di terra (che è quella del pratese) inscindibilmente legati in reciproco sfondo, in reciproco dialogo, sotto l’egida di una passione a lungo inficiata da ritrosie e pudori ed un canto che soltanto al termine, nel riconoscimento, riuscirà a sciogliersi nel mare dei ritorni. E’ un percorso allora questo che si apprende, tra accensioni e spegnimenti, per una fedele e paziente rimessa di sé entro le metamorfosi di una natura e di una vita sempre volta “a germinare/ per chi non sprecherà/ la forza della spiga, / ma ne farà il suo pane/ di quotidiano amore”. Perché il frutto che già nel bene della fatica si prefigura in bellezza è per Masini (nel conto e nel superamento delle resistenze) la misura di un mondo che pur nella crudezza delle sue occlusioni conserva in sé tutta la creaturalità e le infinite dignità del compiersi. La parabola di fondo di questo lungo apprendistato è allora nell’offerta continuamente rimessa all’incontro, alla ricerca non del candore ma della giusta innocenza, della grazia natale la cui rivelazione nella preservazione ci ricompone e fonde. Rivelazione che passa anche da una comunione scavata nel buio la cui dialettica ha la sua centralità nella terza raccolta, “Pensiero d’amore”, in cui nello sguardo della donna è racchiuso il potere d’ogni amore, dell’amore:” “Ma non potrai scordare,/ come nessuna madre,/il tuo dolce dolore/ quando venni alla luce dal fondo dei tuoi occhi./Puoi abbandonarmi forse,/ ma rinnegarmi mai”. L’incisione dunque è nel solco di questo mistero di cui il poeta si fa servitore leale nel nutrimento delle radici, arnia che brulica di versi (secondo un immagine a lui molto cara), miele per chi ha fame. E, da una definizione del seguente“ Casa di carta ”, astronauta del cuore lanciato al mondo da un amore che nella condivisione lo dispone finalmente come un esploratore alla ricerca e al ritrovamento di “Tanta, tant’acqua/e incontaminata” portandolo in un bellissimo passaggio a deporre il casco per trasformarsi in contadino ed il cui senso è ben detto nei versi inediti di una poesia dedicata alla Dickinson: “Oltre il recinto/ è necessario andare/ per rendere a misura/ l’infinito”. Ed oltre il recinto è necessario andare per una salvezza che non è solo per se stessi nel richiamo riportato a terra là nel “deserto intenso” dove la vita chiama. Direzione in cui Masini si pone con forza nell’ultima fase della sua produzione racchiusa nell’emblematico titolo ”Proibito a chi odia” in cui la parola, sfrondata da inutili accumuli che ne frenavano la voce (e che rifugge come sempre dai luoghi comuni anche quando non riesce), si fa complementare elemento di quella misericordia di sguardo alla base di una narrazione del mondo la cui memoria ed intelligenza d’amore si fa con fermezza risposta- e monito- alle tensioni anche sociali e morali che hanno segnato e insanguinato la storia degli ultimi anni (e qui evidente anche nell’ultima parte di poesie sparse e inedite). Nella complessità e nella semplicità insieme del viaggio ci resta, in conclusione, la poesia di un ragazzo a cui la ricerca d’amore svelandolo al corpo fecondo e trasfigurato dell’umano (“fossile/di durissima pietra”) lo ha donato e rimesso allo spazio intenso della compassione e della presenza, scudo e salvaguardia dell’umano stesso il cui valore, con umiltà e franchezza d’ascolto, Masini sovente rimarca e richiama nei cerchi concentrici delle ferite e degli echi. E che per la testimonianza di fede , inscindibile in ogni vero discorso poetico, fa della sua una voce sempre in divenire, consapevole come ogni volta nelle tracce di avere appena imparato a camminare.
Id: 677 Data: 02/04/2013 12:00:00
*
 Anna Ierna - Poesia - Kritios Edizioni
Anna Ierna - Poesia - Kritios Edizioni
I vuoti del silenzio
Molto s’è scritto e detto (!) sul valore e la misura del silenzio, virtù inscindibile a partire dal suo rapporto con la parola, tema vitale nel cui equilibrio si cela in attività dinamica il seme del dialogo e dell’ascolto (e che tra l’altro la poesia stessa ha iscritto così magistralmente nella sua struttura). Ma il silenzio, che è certamente un modo diverso di vivere e comunicare, e che è di per sé una realtà ambigua e neutra, non è di un genere solo (come in un piccolo saggio ha ben sottolineato il monaco di Bose Sabino Chialà). Accanto a un silenzio fecondo, di spoliazione e comunione di sé, di promozione e custodia, c’è infatti un silenzio di negazione, racchiuso in una gamma assai stratificata di motivi che vanno dalla reticenza al rifiuto, dall’angoscia al compiacimento, con il quale non è facile fare i conti e che se non rotto, se non espresso rischia di oscurare e inficiare davvero alla radice la vita. Silenzi che si nutrono dei disagi e delle paure del vissuto, dei vizi e delle inquietudini singole e collettive contribuendo ad allargare e a scavare quei solchi di incomprensione e di sofferenza nelle cui distanze un vuoto mai sopito di disappartenenza ci consuma e imprigiona. I vuoti di cui ci parla Anna Ierna nascono appunto da questo sgomento la cui urgenza di dettato è testimoniata, gridata con forza quasi, già nel testo d’apertura della prima sezione (che sono quattro e corredate dalle illustrazioni di artisti anche loro d’area siciliana). L’invito che si leva in “Silenzi”- questo il titolo del brano - è allora all’ascolto di quelle aree di non detto, di trattenuto in cui si celano le grandi e piccole sopraffazioni del mondo, le violenze in cui si perde un umanità piagata e piegata. Un silenzio omicida ci ricorda, in stretta relazione colla successiva “Parole” in cui l’impotenza del verbo, perché negato, perché costretto tra indifferenze e implosioni, invece di aprire nella comunicazione un dialogo quel dialogo chiude e secca in partenza. Rabbiose, e lecite, dunque, le domande che si levano in queste pagine sulle trame di una terra che rischia di spegnersi tra idolatrie e remissioni, tra devastazioni dei campi e del cielo, dove la stessa infanzia viene rigettata e cade non preservata dal male (come nel caso del piccolo Tommaso Onofri qui ricordato). C’è nella Ierna un’autenticità del sentire, e del porsi, molto forte, che preme, si tenta nella vicinanza e nella partecipazione e che è ben leggibile nel respiro affannato delle interrogazioni ma che pure paga per buona parte una fragilità di scrittura e una ineluttabilità della mancanza e del vuoto purtroppo a volte scontata, un po’ adolescenziale, che ne smorzano il registro tra echi e rimandi di genere andando a mortificare ogni acutezza di impressione e controllo e ponderatezza del verso che pure in questa poesia sono presenti e che in alcuni testi e in alcuni tratti si rivelano con sicurezza. Come in “Memoria”, o ne “Il vuoto della vita” in cui la tensione si leva in affidamento alla misericordia del Dio cristiano in cui riscontra il nulla della sua somiglianza con l’uomo di oggi entro l’implacabilità di un male infido, senza avvisi, che “piove, incompreso” e a cui solo la preghiera ( vedi anche la poesia omonima) e la croce possono dare protezione e risposta ad un tempo senza coscienza. O in “Chi eri” ed “Infanzia” che aprono un altro capitolo, certo non secondario, dei silenzi che cercano fuoriuscita dal testo. Perché il tono quasi ininterrotto di rassegnazione e dolenza- a cui solo annunci e meraviglie di natura e d’arte, oltre all’affidamento appena ricordato, riescono parzialmente a sollevare nei colori e nei profumi di una Sicilia amatissima- rivelano un tormento ascrivibile forse a una lontana ferita, qui finalmente focalizzata e riappresa in un ritrovamento di se stessa non nel mondo e nel dolore degli altri ma nella prigione “dell’infanzia”, della propria infanzia: “coi ginocchi insanguinati/per le frequenti cadute,/in attesa di crescere” (“Chi eri”). Ritrovamento tra promesse di vita e sue paralisi che giustappunto in “Infanzia” ha l’immagine delle vecchie cassapanche in cui sono raccolti i giocattoli di quel tempo al cui aprirsi (ovviamente nello svelamento di sé dalla rivelazione degli oggetti) assale “un agghiacciante sentore di morte”, la cui crudezza è con sapienza resa nel verso: “pane bianco/spalmato di fiele”. Testi questi che insieme ad altri molto ci dicono, al di là di facili biografismi, sull’autrice e sul modo stesso di intendersi all’interno della scrittura. Una scrittura comunque di slanci, come detto, emotiva, in oscillazione continua tra una prolissità stereotipata ed astratta di immagini ed accostamenti linguistici nella sostanza poveri (che tra l’altro, nelle considerazioni, sovente nulla aggiungono al malinteso della retorica di una poesia di buoni sentimenti- troppe volte letta e sentita- che non si propone, priva di direzione e per immobilità di fattuali, concrete pronunce) ed una versificazione più asciutta, attenta, efficace diremmo, nelle espressioni- e nelle compassioni- di un’ anima che non smarrisce mai (questo sì) la sua grazia. In questo caso il fiore che Anna ci offre è quello della dignità di un silenzio di cui s’è avuta cura perché in piena assunzione e condivisione del peso, provenendo da una parola finalmente libera da inutili orpelli, e da un’oscurità che ancora graffia, ancora morde - anche in reciproca offesa - dal nostro buio più profondo. In conclusione, dunque, una poesia che proprio da questo rigore e da questa luce andrebbe illuminata e sfrondata in direzione di una maggiore originalità. Perché, in questo senso, l’autenticità del sentire e del porsi menzionate all’inizio, da sole non possono bastare; ed allora aiuterebbe molto nella misura del poetico (del pensiero poetico) e della lingua una frequentazione costante e reale (questo però, sia ben chiaro, vale per ognuno di noi) della tradizione in cui siamo iscritti, il cui confronto, anche nella contemporaneità di altri testi, anche nel suo rigetto, non può essere eluso.
Id: 673 Data: 12/03/2013 12:00:00
*
 Claudio Pagelli - Poesia - L’Arcolaio
Claudio Pagelli - Poesia - L’Arcolaio
Papez
Papez, nome curioso, buffo, che rimanda quasi agli spiritelli allegri che si dimenano tra i campi o sulle soglie delle nostre case e dei nostri sogni, ha la sua spiegazione in realtà nell’omonimo circuito, nel percorso intracerebrale implicato nelle funzioni dell’emozioni e della memoria. E all’emozione e alla memoria è legato questo libro di una bellezza che non acquieta, non potendolo tra le derive e le ironie di un mondo smitizzato e dolente. E’ un testo questo che si fa voler bene subito per l’opposizione nuda, teneramente realistica, a perdere spesso (come il pugile a pagina 12) al freddo delle separazioni e delle aggressioni, delle violenze da autodafé di una società che non risparmia colpi entro promesse che acrobazie finanziarie e silenzi di valori non possono mantenere. L’osservatorio, non da poco in questo senso, è quello tra la provincia di Como dove Pagelli vive e lavora e Milano, microregione ritratta appunto tra dinamiche di depennamento e la ferocia di esistenze inghiottite e nascoste. Così il tempo di cui ci parla (“Tempi moderni” tra l’altro è il nome di una delle quattro sezioni) non è solo quello della precarietà del reale e dello svuotamento di capacità professionali ed umane in un livellamento senza più parametri (nel “giù di lì” da cui “si cade proprio in bocca ad un niente”) ma del disfacimento che esso comporta su sagome e volti, nelle azioni e nei riflessi in cui l’incubo si raccoglie e perde in quel vapore, in quella nebbia che se bene dice gli spazi pure prima è dell’anima. E’ lo stordimento infatti la dimensione che forse con maggiore evidenza emerge e ci parla da queste pagine grazie a un’eticità del dire e del sentire che sa del grottesco (e alla bisogna anche della caricatura) più che la denuncia, la stizza delle visioni spezzate, il riconoscimento della ferita comune nella compassione impotente. E se già nel primo testo (“foto ricordo”) l’auto scatto di famiglia con il lago sullo sfondo non ha che lo zucchero della lastra come breve ricompensa nel ciclo dei conti strozzati (il pensiero alla “sagra futura”), la rassegna di figure che segue (siamo in “Papez”, l’omonima sezione d’apertura) testimonia, ricordandocelo bruscamente, l’abisso di una deriva che ruota incalzando e rovesciando i ruoli “tra i fregati di ogni dove” e in cui ”ogni errore si paga col sangue”- il tono asciutto de “l’avvocato” compiutamente incarnando: ”il mondo, lo sai, gira e divora/appena il passo s’intoppa”. Realtà quotidiana soggetta ad una sopravvivenza senza più luoghi che possano dirci, a rigettarci non più contemplandoci e dove, nel contrasto, il discrimine tra rassegnazione e presenza è dato il più delle volte dagli attacchi e le ire delle dinamiche interpersonali di chi si muove come bestia inseguita tra cattività di confine. Tutto ciò, in sintesi, è però magnificamente espresso e descritto nella terza sezione, “La cena”, dove la scrittura poetica ha il suo suggello attorno al tavolo cui vecchi amici si ritrovano e si confessano tra dialoghi di memoria e rovinose cadute. Qui il talento narrativo di Pagelli, sempre guidato da una prospettiva d’insieme che sa ben legare verità morali e fragilità e grossolanità umane, ha il tono secco e pungente delle speranze irrealizzate, di sofferenze a cui nemmeno più i sogni posson portare condivisione nel magma di una crisi che non ha imputati, senza più colpevoli. Ed allora, ogni singolo partecipante è percepito come vittima e marionetta (tra l’altro proprio “Puppets” è il titolo che in origine il libro avrebbe dovuto recare) dei propri abbagli oltre che di un’oscurità subita per intero. Il taglio, di conseguenza- che per sarcasmo e partecipazione, per descrizione scenica, ha qualcosa della nobiltà senza prigionieri della commedia all’italiana (di Risi in particolare- e non a caso comunque dal testo è stato tratto anche uno spettacolo teatrale)- è quello di una comunità, di un paese, il nostro, che più non si riconosce, in cui non ci si riconosce, priva di memoria e, dunque di prospettive, perché soprattutto priva d’amore. Amore che nitidamente, luminosamente è proprio ciò che “Papez” cerca con fatica, e con sgomento, di preservare entro le corde e le istanze di ciò che per natura è poesia (e che negli anni corriamo il rischio di dimenticare tra vanità solipsistiche e deliri metapoetici). Prossimità, vigilanza, capacità di interrogazione e di sostegno del peso, indignazione ed urgenza di ricucire, di iscrivere o reiscrivire la lingua (che è corpo e sostanza di ciò che di più vero ci appartiene) dove la vita strappata manca, fanno di questo libro una testimonianza lucidamente e dolorosamente alta del pericolo che ci attraversa nel percorso d’anestesia e negazione di orizzonti e passioni. Altro ancora andrebbe aggiunto ma ogni segnalazione di un testo, per quanto possa dire, è sempre mutila ed è giusto così dovendo lasciare al mistero della lettura lo spazio nudo dell’incontro; solo, ci piace concludere con i versi che forse più degli altri, o a commento degli altri, sono rivelatori di quanto scritto finora. “Il ficus”: “E’ così- foglia a foglia-/ che si muore, come il ficus/ ridotto a mobilio d’ufficio/ nell’aria bellicosa del condizionatore./ E’ così, allora la tenera eclissi / delle cose, senza sangue che sprizza/ ai lati della carne né divini fotogrammi/ a predire abilmente-/ (ah! l’occhio rosso dell’angelo alle tue spalle/ che ti avverte dello schianto imminente..)”.
Id: 665 Data: 22/02/2013 12:00:00
*
 Maddalena Capalbi - Poesia - La Vita Felice
Maddalena Capalbi - Poesia - La Vita Felice
Nessuno sa quando il lupo sbrana
“E’ una favola l’amore,/ce la raccontiamo per stare bene” ci avverte, o avverte se stessa quasi a proteggersi, l’autrice di questo libricino in una delle poesie iniziali nella cui interrogazione si racchiude in realtà il perchè dell’intera raccolta:” (..) di chi sono- mi chiedo?/Di quale paesaggio?”. Memoria sofferta ma necessaria di sé tra ricomposizioni e accettazioni familiari all’interno di una storia e di una corporeità ferita. Racconto personale che nel dipanarsi degli anni (da quelli della propria adolescenza fino alle malinconie e agli azzardi dei ragazzi di oggi) dice però anche molto delle dinamiche generazionali nel nostro paese dai ’70 in poi. Diviso in due sezioni- la prima “Nessuno sa quando il lupo sbrana”, la seconda “Così i nostri ragazzi”- il nodo che il testo cerca in qualche modo di sciogliere, o quanto meno di raccontare, è soprattutto nell’ambiguità di relazione tra la figura paterna e materna, con la figura paterna e materna, i cui graffi, le cui reciproche occlusioni consumano tempo e anime tra desolazioni e colpa, tra solitudini e rabbia. La Capalbi, nelle osservazioni di sé ragazzina, non fa sconti, in una registrazione quasi automatica di emozioni e reazioni, non tralascia nulla, focalizzando la propria attenzione sulle ripercussioni corporee che nel silenzio delle stanze e nella ripetizione monotona dei rispettivi domini fissano i diversi protagonisti in situazioni il cui unico sbocco spesso sembra non poter andare oltre la caparbia sottolineatura del proprio irricucibile ruolo. Centrale, allora, in questa scrittura a tratti diaristica del dolore è il rapporto con la madre ed insieme della madre col padre la cui inadeguatezza subita di donna e di moglie si riflette (non a caso forse tornando più volte il termine specchio) nel muro di giudizio e durezza con cui la figlia vede e sente se stessa a partire dalle urgenze e dai reclami di un’identità femminile che sente anche nel proprio corpo il veicolo della conoscenza di sé e della propria liberazione. Così, oltre “la gara delle ribellioni” nel superamento di confronti impossibili, oltre una visione che dice dell’uomo e del maschio la diffidenza e il richiamo, questi versi si offrono in un rendiconto asciutto, teso, essenziale, come un rimontaggio da cui ridarsi sguardo per lo scioglimento delle proprie ossessioni. Sguardo che si tenta, come dicevamo, proprio dentro un paesaggio la cui misura nel divenire d’ombra è lo sgomento, a tratti, e l’inappartenenza nell’oppressione e la dirompenza del limite. Che è poi corda d’ogni vera poesia se ancora poesia è ricomposizione e spinta da un paesaggio, sua voce e sua densità profonda (si legga al proposito “Il mare di Foceverde”, brano esemplificativo in questo senso e rivelatorio di una nudità osservata e colta in tutti i suoi movimenti, nelsuo movimento ). Profondità, dicevamo, data con un’abilità di distacco e insieme , ancora, di urgenza emotiva espressa con sicura efficacia da una poetessa ormai giunta alla sua quinta prova (e di cui ricordiamo la sua attività di coordinatrice di un corso di scrittura nella Casa di reclusione vicino Bollate, Milano). Non diversamente nella seconda parte, in cui l’attenzione si sposta sulle dinamiche relazionali e sui riti d’amore dei ragazzi di inizio millennio, “splendidi animali” osservati fra masticature e solitudini, in cui la scrittura scorre con la medesima forza, senza cedimenti di tono, pur rischiando di pagare in alcuni momenti una partecipazione che nel fuoco delle interrogazioni e delle tenerezze (com’è naturale forse) giunge meno accesa. Ciò non vela, comunque, il lascito con cui questo libro si chiude: non smorzano il canto infatti i nostri figli, anche se trafitti e mangiati dai confini. Tentano ancora l’amore scivolando silenziosi, schierandosi “come piccole costellazioni//liberi”. Ma “senza più chiedere aiuto”, come un verso quasi meccanicamente ricorda. Ed in questo, ci domandiamo in conclusione, c’è poi davvero differenza con la generazione materna? O, venendo incontro al testo: quanto di non detto ancora ci ferisce, e ci confonde dividendoci?
Id: 659 Data: 07/02/2013 12:00:00