chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Paolo Polvani
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
 Maria Grazia Palazzo - Poesia - La vita felice
Maria Grazia Palazzo - Poesia - La vita felice
Toto corde
Viviamo e moriamo così senza prestare quasi mai il consenso
Nella poesia che inaugura Toto corde, di Maria Grazia Palazzo, trovo illuminante questa domanda precisa: “Dove vi siete rifugiate, sconosciute altre me?”.
Illuminante perché rivela la profonda consapevolezza della molteplicità di ogni singolo essere umano qui intesa nella variante dell’asse verticale, del tempo considerato come successione di istanti, cento volte partorita, recita il primo verso, e mille volte morta.
Non conosco personalmente Maria Grazia ma leggo dalle note biografiche che è nata a Martina Franca, città situata a uguale distanza dal mare Jonio e dall’Adriatico, e che dal 2006 vive a Monopoli, affacciata sul mare dove “si sono rotte le acque della poesia”.
Si tratta di una indicazione fondamentale per accostarsi alla poesia di questa autrice. Un saggio interessantissimo e approfondito di Franco Cassano, contenuto nel volume Il pensiero meridiano, individua nella presenza del mare la nascita della cultura greca, ed in special modo della filosofia e della tragedia. Argomenta che l’intelligenza ha un rapporto diretto con il mare, perché quest’ultimo allena l’intelletto alla mobilità, alla pluralità, la costringe a “passare da riva a riva e da popolo a popolo”. Il mare porta con sé l’idea dell’infinito, sorgente di domande e di profonde inquietudini. È significativo quindi che le acque della poesia si siano rotte sulle rive dell’Adriatico e soprattutto che il dato costituisca oggetto di precisa sottolineatura.
Nella poesia di Maria Grazia Palazzo si agita la stessa inquietudine marina dalla quale affiorano le infinite domande che la presenza del mare stimola e sollecita. La prima domanda davanti all’orizzonte marino è: che cosa si cela al di là dell’orizzonte?
E ogni verso di questa raccolta Toto corde sembra ispirata da questa basilare richiesta di chiarezza. E come dentro ogni mare che si rispetti, si intrecciano e si intersecano qui correnti molto diverse.
Il punto di domanda chiude parecchi dei versi di questa raccolta, la cui caratteristica è appunta quella di cercare, di chiedere, di interrogare il mondo e interrogarsi, poesia di matrice filosofica, intrisa di aspirazione alla verità, alla chiarezza.
Nell poesia Ode alla molteplicità, Adam Zagajewski si sbilancia in una profezia che ha qualcosa di terribile: “Chi per una volta / ha sfiorato la filosofia è perduto, / non lo salverà la poesia, resterà / sempre, rimanenza / incalcolabile, la nostalgia”
Così in questa raccolta che illumina aspetti del quotidiano la principale direttrice è costituita da un inesauribile interrogarsi e interrogare, e sempre si avverte, sottomarina o superficiale, una corrente dalla evidente vocazione filosofica.
Con incursioni in ambiti zen, come dichiara il verso di una delle poesie più intense e profonde:
Il cappero l’hai osservato?
La sua pianta sorge spontanea e illetterata.
Si erge con la sua capigliatura folta, a sorpresa
sulla pietra porosa dura o impertinente tra zolle di arsura.
È ricca di fronde e foglioline gemellate, quasi animate
da un’amicizia selvatica di un verde senza stagione,
resistente a ogni presuntuosa sollecitazione.
Nei più nascosti e impervi anfratti rocciosi
Sembra dire “vita, vita, vita!”.
Dalle sue ramificazioni spuntano piccole teste,
boccioli che, se colti al momento opportuno,
portano capperi saporiti e, se lasciati alla pianta, fiori.
Il cappero, ai miei occhi, è la pianta dell’amicizia
A una prima lettura colpisce un’atmosfera che fa dell’andamento epico il proprio terreno privilegiato: “Nel labirinto di rinascite andirivieni di corpi e di pelli nude”.
Si avverte la presenza di un sostrato culturale nutrito dai classici, e anche, in maniera continuativa e persistente, un sottofondo sinfonico, come se lo spessore delle letture traesse forza e robustezza da una sana alimentazione musicale.
Sinfonie dai timbri potenti, tardo ottocenteschi e ancora meglio da ascrivere al primo novecento. Durante la lettura avvertivo toni e timbri decisamente sinfonici, e pensavo al Canto della terra, e anche alla sinfonia Resurrezione, di Mahler.
Mi colpisce un verso di una delle poesie iniziali della raccolta Toto corde, “una lingua che consuma ogni residuo d’ali nero, volo di stormo su pelle tesa di tamburo”, che mi pare una precisa indicazione sul tipo di linguaggio usato. E sul tipo di atmosfere che si registrano nel corso della lettura.
Un linguaggio complesso, articolato, ben saldo nella contemporaneità ma con radici e affondi nella classicità. E l’utilizzo di materiali residuali del linguaggio, scarti della gregarietà della lingua, accenni di conformismo linguistico utilizzati come inserti, per esempio pret a porter oppure tamagochi, le madri origami, grafic novel, dejà vu, disseminati lungo i versi in maniera consapevole, non come esito di sottomissione alla tirannia della lingua ma come utilizzo alternativo al fine di evidenziarne lo scarto comunicativo, la voluta, ricercata dissonanza, come quegli sfrigolii, quei rumori anche molesti che a volte punteggiano testi musicali al fine di tentare una nuova armonia che comprenda anche la sua antitesi.
Altra notazione da evidenziare circa la tessitura lessicale è l’utilizzo di parole composte. Tutta la raccolta presenta fonemi raddoppiati nella ricerca di una forzatura della lingua che evidentemente risuona stretta nel vocabolario personale dell’autrice. Così nei versi incontriamo terracielo e vitasuono o vitamorte, testaspallemani, in funzione agglutinante oppure ossimorica: silenziofrastuono. Personalmente avanzo dubbi sulla reale efficacia di tale operazione, tuttavia la positività del gesto risiede nell’ambizione di creare una lingua che sleghi i lacci che l’avvincono come una camicia di forza, lacerare e creare varchi lì dove le regole costringono in maniera ossessiva, aprire nuove strade comunicative.
Una poesia molto concettuale, dove la domanda “chi siamo e dove andiamo” risuona continuamente nella scansione dei versi, che in definitiva raccontano il disagio di vivere, perché tra i compiti della poesia c’è quell’anelito del ricomporre, del frugare con le parole dentro la realtà per trovare un senso che giustifichi il dolore dell’esistenza.
Nel ritorno a casa, azzurro cupo che increspa
nostalgia tenerezza nella spinta di separazione
di corpi riemersi da una superficie incomprimibile
di acque, nello sprofondo di tutto il dolore.
Strana dolcezza le impronte di morti che nessuno vede.
Nel ritornare non ricordare il corpo disanimato
ma il mare che suona dentro un campo di papaveri
nel silenzio vivo cercando un varco
di orizzonte in movimento, sollievo sulla pelle.
Se esiste una chimica interiore, bisogna recuperare
il reperto affettivo, il relitto migliore.
Il tocco di una mano, una postura vicino alla spalla,
il suono minimo, al tavolo o in cucina, che precede
l’abbraccio, a riaccendere quel vulnus.
Così sulla pietra conservo intatto
lo sguardo luminoso e il sorriso.
Il compito della memoria è la resa, il vuoto
di ogni nostalgia, per lasciarsi sfinire dal sole.
Infine, a marce forzate, accettare di morire.
Toto corde, scrive l’autrice, è un esercizio d’amore e di memoria. Ed è sicuramente un libro complesso, dai molteplici richiami, dalle suggestioni estremamente variabili, che traggono linfa dalla cultura orientale per approdare a Zanzotto, forse il più terrestre dei nostri poeti, quello indissolubilmente legato alla natura tellurica dell’esistenza.
Tenerezza e asprezza si avvicendano nei versi, così come natura e cultura, nella ricerca continua di un equilibrio nuovo, di un assetto che restituisca alla vita armonia e benessere, capace di seminare “pomodori di utopia”, di rifare il mondo secondo un nuovo schema.
Con tutto il cuore vorrei tornare indietro, cancellare
con un battito l’amore mancato. Riempire
il vuoto con ciò che il cammino ha portato
nell’abbandono di silenzio inaudito.
È sempre nella stessa Ode alla molteplicità che Zagajewski scrive: “Chi per una volta ha conosciuto / la folle corsa della poesia più non proverà / la quiete petrosa della prosa familiare”.
Così è con tutto il cuore che l’autrice ci offre i suoi sprazzi di sincerità e di ricerca, con totale partecipazione di intelletto e di sentimento.
Id: 1258 Data: 16/10/2020 12:00:00
*
 Giancarlo Baroni - Poesia - puntoacapo
Giancarlo Baroni - Poesia - puntoacapo
I nomi delle cose
Lanciamo proiettili di fuoco
Alcuni autori, quando propongono un nuovo libro, inseriscono testi appartenenti a precedenti pubblicazioni, a significare la continuità, a sottolineare l’ininterrotta corrente che attraversa ogni creazione. In Giancarlo Baroni, anche in quest’ultima opera, I nomi delle cose, sono presenti testi comparsi in altre raccolte, e riaffiora la stessa esigenza narrativa, la stessa vocazione a far balenare i germogli di una storia.
Si tratta di disegnini appena accennati, embrioni di racconti espandibili a piacere dal lettore, piccole storie tratteggiate a matita, in bianco e nero, come tavole di fumetti.
I battesimi del conquistatore, il testo che dà inizio alla raccolta, apre una profonda riflessione appunto sui nomi delle cose, sul nesso tra potere e nominazione
I battesimi del conquistatore
Montagne laghi fiumi
mano a mano che procede li battezza
con i nomi della sua lingua.
Da domani sarà proibito
chiamare le cose in un altro modo.
Il racconto procede con la medesima concisione e speditezza riscontrate in Le anime di Marco Polo, anche qui pochi tratti a delineare le possibilità di una storia, come a suggerire che le potenzialità narrative sono infinite, appunto come i nomi delle cose, come il potere infinito della immaginazione.
Il fascino di queste poesie è legato all’atmosfera favolosa che le attraversa, al sapiente dosaggio di avventura e di mistero, a quel tanto di riconoscibile che emerge da ogni sequenza e che viene comunque contraddetto dalle successive, in un continuo mischiare e confondere le carte.
Le sezioni, Un seme tra le mani, e La partenza del padre, affrontano il tema della morte con piglio originalissimo, anche qui l’intento narrativo è manifesto, si gioca a carte scoperte, vengono ripercorse le tappe di un evento, dal momento della sepoltura
(Depositando per primi una manciata di terra
o spargendo dei fiori
si deve seppellire chi ci è caro,
accertarci che la voragine l’accolga.
Arriverà altrimenti
come un fantasma furioso ad insultarci…)
all’incontro e confronto con le altre anime, al giudizio finale, qui ubicato dentro un castello che richiama certe atmosfere kafkiane, col riferimento, che sospetto esplicito, non casuale, al processo, al giudizio, e appunto al castello.
La metafora della rinascita è affidata a quel seme tra le mani che accompagna il defunto e che spunta dal suolo, germoglia, cresce, ti fa ombra d’estate, - lo battezziamo col tuo nome gli parliamo -.
Scrive acutamente Fernanda Ferraresso a proposito di questo libro:
- Polveri elementali, atomi di un universo, che si approssima senza che noi siamo consapevoli di quei suoi corpi, che sono gli stessi nostri, i corpi delle cose, a cui diamo un nome per poterle afferrare, per potercene nutrire, procreando ogni volta un altro modo di assaggiare il mondo che già abbiamo nel corpo nostro, e solo, senza nome, ci conduce fino alla soglia finale dove morire è un cambiarci d’abito. -
Uno degli incontri più coinvolgenti che questo libro dona è la poesia che offre una perfetta visione della capacità di inclusione dello sguardo dell’autore, l’attenzione al particolare, al dettaglio, l’ascolto affettuoso e carico di un vivo desiderio di partecipazione, di condivisione di aspetti del mondo e vicissitudini quotidiane:
Siete voi che amiamo
Siete voi che amiamo
care signore
che stamattina
attraversando questa strada
l’avete profumata di pane.
Sporgeva dalle vostre borsette
come una luna in miniatura.
Sappiamo che tenete
nei portafogli come resto
le chiacchiere del droghiere,
e che per ogni
confidenza scambiata
– per ricordarvi
di scordarla al più presto –
stringete un nodo sottile al fazzoletto.
Giancarlo Baroni è anche un valente fotografo, e trasfonde nei versi l’abilità di catturare dentro le immagini particolari di preziosi dipinti, di entrare dentro un’opera pittorica e in alcuni casi farne oggetto di gioco, motivo di ironia, come nel caso della Gioconda:
Gioconda desnuda
Lascia cadere le vesti
si sdraia, le mani dietro la testa
le ginocchia chiuse
lo stesso enigmatico sorriso.
Gioconda al Louvre
Si diverte quando tentano di carpire
un segreto che non esiste;
a luci spente diventa triste.
In altri invece semplicemente evidenzia un piccolo dettaglio e ne fa oggetto di poesia, pone in primo piano un particolare del dipinto e lo rende protagonista nei versi:
Il cagnolino di Tiziano
Festoso coi bambini
della famiglia Vendramin
accucciato di fianco ad Eleonora
Gonzaga vestita dalla festa
ai piedi della Venere di Urbino,
il bianco e nocciola cagnolino.
In definitiva un libro molto variegato che racconta i molteplici interessi dell’autore e le varie abilità in cui sa cimentarsi, un libro che regala un lungo viaggio nella creatività e nella eleganza.
Id: 1250 Data: 21/08/2020 12:00:00
*
 Vera Lúcia de Oliveira - Poesia - Fara Editore
Vera Lúcia de Oliveira - Poesia - Fara Editore
Ero in un caldo paese
Versi di gioia e di nostalgia nella poesia di Vera Lucia de Oliveira
Perché erano ubriachi / di ogni cosa ed essere / creati da Dio
Il titolo dell’ultimo libro di Vera Lucia de Oliveira è un omaggio a Sandro Penna. Anche l’esergo in apertura del volume riporta versi di Penna. È anche una dichiarazione programmatica sulla scelta di un preciso indirizzo stilistico, si tratta di componimenti per lo più brevi, di fulminanti illuminazioni. Una coincidenza quindi non solo geografica, Penna era originario di Perugia, città nella quale Vera vive ormai da molti anni, ma anche di sensibilità poetica.
Nella postfazione al libro Maria Borio parla di “legami stilistici con i maestri di questa poesia – come Ungaretti e Penna – attraverso una sensorialità immediata”.
Nel libro colpisce la ricorrenza di alcune parole, una di queste è mondo, palpita molto mondo in questo libro, si respira una forte adesione alle vicissitudini del mondo, sebbene circoscritta al perimetro entro il quale si muove la personale biografia dell’autrice, nei versi circola molto pane dell’amicizia e molto vino della poesia.
La dedica del libro è per Ilde Arcelli, valida poetessa perugina ora scomparsa.
È anche spesso presente la locuzione “dall’altra parte del mondo”, chiaro riferimento ai luoghi di nascita e di provenienza di Vera, il Brasile, e probabile sorgente primaria della sua ispirazione.
Dominare due lingue, riuscire a esprimersi in versi in maniera egregia e compiuta, significa possedere non un solo mondo, ma una varietà di mondi. Non è né saggio né opportuno stilare una classifica della intensità emotiva raggiunta in alcune liriche, tuttavia quando il discorso è proteso nell’ascolto dell’altra parte del mondo, è lì che i versi denunciano e dichiarano un livello di coinvolgimento che inevitabilmente si riversa sullo stato emotivo del lettore e gli consente una viva consonanza.
Così commuove già dalle prime liriche “la voce del figlio distante che dentro / la notte veniva a svegliarla mamma / ti va di parlare con me oggi’”
E più avanti: “la notte è un grande orecchio / sento persino il letto / scricchiolare / mentre ti giri / dall’altra parte / del mondo”.
E poi una delle più belle e compiute, che mi piace riportare per intero, col bellissimo richiamo nel quale riecheggiano i versi di una delle più conosciute poesie di Penna:
Il mare è tutto azzurro
il mare è tutto calmo
il cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo.
Vera esordisce in questo modo lineare, altrettanto epigrammatico e icastico nel dettato semplice dei versi:
Il mare qui è un orizzonte azzurro
di monti su monti a perdersi in fondo
nelle giornate limpide puoi vedere la mamma
dall’altra parte del mondo e se c’è luna
luminosa vedi il babbo piegato sul suo
orto d’estate che neppure da morto
ha lasciato.
Anche la parola corpo risuona spesso nei versi di questo libro, “c’è una ballerina in me / pronta a occupare il mio corpo…” e ancora “…questo corpo ardente…” e infine una dichiarazione fulminante: “nel grembo la parola è il corpo…”
Quel corpo labirinto dove il minotauro, quando hai aperto gli occhi, ha detto: ti verrò a cercare. Secondo una visione psicanalitica il mito del labirinto rappresenta la condizione edenica prenatale:
amava l’infanzia
e non poteva crescere
tutto attorno a lui parlava
di un grembo felice
in cui poteva nuotare
senza soffrire
dire mamma
ci sono
e lei
son qui
Anche la parola città ricorre, estensione naturale del corpo, propaggine modellata in forma di abito, di cornice necessaria: “in questa vertebra di città sono venuta a cercarti”.
In fine la lingua, quella lingua alla quale ti afferri sperando che regga, perché è l’unica certezza, l’evidenza minima dalla quale germogliano e fluiscono i temi cari alla poesia di Vera, l’adesione al mondo, l’infanzia come luogo degli affetti e dei ricordi, la parola come felicità e tormento: “il dire è la sola / cosa che ci resta”
Un libro in cui la nostalgia scorre come un fiume carsico, a tratti scoperto, esposto alla luce del sole, a tratti sotterraneo, una nostalgia a raggio variabile, perché ogni cosa, appena intravista o vissuta, nel riverbero della fugacità della bellezza, diventa sorgente e motivo di nostalgia, come se soltanto sfiorarla evidenzi la possibilità di una perdita, di un abbandono. E così la nostalgia, nel suo significato letterale di dolore del ritorno, diventa una forma per aderire al quotidiano, diventa l’atmosfera che accompagna ogni incontro e permea ogni verso. Fino dal titolo, con quel verbo “ero” al passato, che dichiara l’inafferrabilità della bellezza, che si può più facilmente cogliere nella luce del passato:
sotto la luce
la città lontana
luccicava nella sera
e pareva che si potesse
essere felice persino
nella pena
Id: 1237 Data: 05/06/2020 12:00:00
*
 Rossella tempesta - Poesia - Pietre Vive Editore
Rossella tempesta - Poesia - Pietre Vive Editore
Diario pendolare
Un piccolo ordito di destino
Il primo contatto con Diario pendolare, il nuovo libro di Rossella Tempesta edito da Pietrevive, è visivo e tattile. La carta, il formato, l’impaginazione, sono una dichiarazione di intenti, dicono la cura, l’attenzione, la creatività che l’editore Antonio Lillo mette nel proporre i suoi preziosi libriccini.
L’illustrazione di copertina, della bravissima Lucia Lodeserto, ci racconta di un compromesso tra fiaba e realtà, tra immaginazione e quotidiana necessità, che costituisce appunto la struttura di questo libro.
Rossella ha legato tutta la sua vita alla pendolarità, ha incrociato treni, partenze, arrivi, stazioni, viaggiatori, ritardi, scioperi, visioni di paesaggi, fin dall’infanzia, quando, bambina, da Terlizzi si recava a Bari per apprendere l’arte della danza, e poi ragazza per studiare all’università, e poi per lavoro nelle varie località cui è stata destinata.
Questo piccolo, delizioso librino è tutto dedicato alla poetica dello sguardo affettuoso, uno sguardo che comprende, avvolge, abbraccia. Esiste una simmetria nell’organizzazione dei testi: in versi sono il primo e l’ultimo, come fossero i manici di una corda, al cui movimento si alternano e saltano i pensieri, gli sguardi, le impressioni, al ritmo antico del ciuf ciuf; come esiste una simmetria tra immaginazione e dura realtà, evidenziata per esempio nelle considerazioni legate al lunedì, quando il treno scoppia di pendolari con le facce stralunate, gli occhi gonfi, e un’amara verità: ”sono quelli che sanno che anche la realtà peggiore contempla la speranza di essere vivi”. Eppure “solo pochi guardano fuori ma le campagne e il mare sembrano i sogni sognati da chi dorme accanto”
Nei testi affiorano in maniera prepotente due importanti esperienze: la prima è l’esperienza poetica, cioè quell’attitudine particolare a rizzare le antenne, aguzzare la vista e l’udito, captare le atmosfere, intercettare ciò che resta invisibile agli occhi di chi non è poeta, riuscire a vedere l’oltre, che costituisce in un certo modo l’armamentario dl poeta, riconoscere la babele che circola nei treni, prenderne atto, arrendersi a questa ninna nanna delle lingue, tradure in parole le sensazioni, le realtà, avere a che fare con i versi, e cimentarsi, provare, riprovare, correggere, limare, lucidare, nell’eterna lotta del poeta con le parole, nella lusinga e nella minaccia, che sono gli strumenti con cui chi scrive attira, seduce le parole, oppure le scarta, le allontana.
L’altra è l’esperienza del pendolare di lungo corso, quello che ha incrociato la viaggiatrice occasionale, ha attraversato le stagioni, è incorso nella malattia: “Perché gli amici del treno sono così amici, che il pendolare assente lo fanno viaggiare con loro anche quando non c’è. E non lo invidiano che è restato a letto, perché è malato e ha perso il treno”. Ha incontrato le Pasque, quando la primavera fa scoppiare le gemme in fiore e l’erba cresce di un palmo ogni notte, ha percepito il gusto esotico del fare il pendolare in piena estate, ha sperimentato i ritardi e gli scioperi.
Il pendolare realizza la sua vita nell’alternanza, è tutto compreso nelle partenze e negli arrivi, e in questo ritmo è bello ritrovare la metafora di tutta l’esistenza, compresa tra la vigilia e il sonno, la respirazione e l’espirazione, la nascita e la morte, in una parola nelle maree comuni a tutte le esistenze.
- Le madri pendolari
Le madri pendolari partono sempre a strappi, arrivano trafelate e calde di baci dei loro figli, dati nel buio mentre ancora dormono. Sul treno si accrocchiano come intorno a un luogo domestico, una sala, una cucina, le più curate sembrano salottiere. E iniziano un mormorio sommesso e lento, mentre i paesaggi scorrono veloci dai finestrini che inquadrano una dopo l’altra le case di altre madri, di altri bambini. Parlano come pregassero, come facessero una confidenza lunghissima, si dicono delle vite, delle fatiche, di quei viaggi che rubano tempo ai figli e un poco ne restituiscono a loro stesse”. -
Più di un cenno meriterebbero le illustrazioni di Lucia Lodeserto, che fanno da controcanto alle veloci narrazioni, ai bisbigli in prosa che tanto ricordano quel monologo interiore che sempre ci accompagna, quelle interne riflessioni che la mente non smette mai di produrre. Le illustrazioni raccontano il suono del movimento, sono attraversate da un vento musicale, un brusio sommesso e ininterrotto, come la lunga chioma della ragazza che a cavallo dei vagoni governa il treno, “suo fidato destriero, un cavallo di ferro, che lo condurrà a destinazione, a tessere, - anche stamattina – un piccolo ordito di destino”.
Id: 1211 Data: 07/02/2020 12:00:00
*
 Luigi Paraboschi - Poesia - Terra d’Ulivi
Luigi Paraboschi - Poesia - Terra d’Ulivi
...e ci indossiamo stropicciati
Nel segno di domanda
La poesia? ma cos’è mai la poesia, si chiede la Szymborska nella famosa A qualcuno piace la poesia. Più d’una risposta incerta è stata data in proposito, prosegue. Quella incertezza rappresenta la sorgente infinita dalla quale zampilla la variegata genìa dei poeti. Viene il sospetto che la poesia fin dal suo nascere sia una forma di interrogazione. Prima di tutto di quel bianco della pagina che si apre come una voragine dall’irresistibile richiamo, che promette di inghiottire e costituisce una seria minaccia all’identità fragile del momento in cui s’invoca la Musa, si chiamano a raccolta i santi protettori dell’ispirazione. Che sia il bianco della pagina o il bagliore di uno schermo o il biglietto del tram su cui prendere appunti, è quello il momento in cui il vuoto ci fa da specchio e c’interroga, ci restituisce e amplifica quel vuoto che chiede di essere riempito. Forse la poesia è chiedere la strada. Informazioni sulla destinazione. Dove si scende? Qual è la prossima stazione? Quindi domanda come ricerca spasmodica di senso, come disperato appiglio, investigazione di un significato più profondo delle sollecitazioni che zampillano dalla realtà. L’ultimo libro di Luigi Paraboschi, “…e c’indossiamo stropicciati” è tutto giocato su un alternarsi ed inseguirsi di domande:
Quanto mi resterà di tempo?
Mi rimarrà il tempo
per misurare il tonfo
delle parole tronche,
d’udire il rumore dei passi
che s’allontanano nei corridoi,
di pesare dentro il palmo
una manciata di sorrisi definitivi?
Sono domande destinate a rimanere senza risposte o spiegazioni, scopriamo nella poesia Non è vita il tuo attendere, e il vuoto che ne riviene è “un sipario che cala all’improvviso / sopra la ricerca di un significato”. Una caratteristica ricorrente nelle figure in cui il poeta s’incarna, quasi una costante antropologica, è la sensazione di essere fuori luogo, goffo come l’albatro sulla tolda, spaventato come un bambino che piange, trafitto dalla consapevolezza di un altrove, di una irriducibile estraneità. Ricordo che nella interessante introduzione all’antologia dei Novissimi, Alfredo Giuliani prova a demolire questo concetto: “La nozione piccolo borghese di poesia – quella che fa dire ai miei conterranei: quant si poet -, a chi è svagato, troppo tenero e balordo – traduce appunto, in termini di senso comune l’idea della poesia romantico-crepuscolare, ed è quella nozione leziosa, autocompassionevole e un po' stolida che viene ancora fornendo la quasi totalità dei testi di poesia “. Ma subito dopo parla di “schizofrenia come modalità dell’esistenza” e dunque se nella mitologia popolare il poeta è visto come individuo straniato, il dato è suffragato dal riscontro statistico ma anche dalla stessa percezione del poeta come soggetto a disagio nel perimetro di un’esistenza votata al consumo compulsivo e ad una tensione perniciosa all’apparire. La cifra distintiva del poeta, ma forse potremmo aggiungere alla categoria le persone più avvedute, consapevoli dell’inganno in cui siamo immersi, è quella di non riuscire ad appassionarsi alla banalità.
La non appartenenza
Trapassa anche te il malessere
della non appartenenza come se
viaggiassi dietro vetri oscuri?
e ancora ne
Quella sottile voglia
M’attraversa talvolta
una sottile voglia
d’appartenenza,
………………………
è malcelata nelle incerte sicurezze
del respiro o del passo
…………………….
così passo accanto ai giorni,
………………………….
teso a immaginare
come sarà l’istante
in cui cadrò nel pozzo
Sia l’attesa, sia la voglia, sia la tensione dell’immaginare sposano bene il punto interrogativo, sono esse stesse segni di domanda, costituiscono per il poeta l’àncora del corrimano, quella cui s’aggrappa la Szymborska nella chiusa della poesia citata in apertura: “Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo / come all’àncora d’un corrimano.”
Forse è la stessa poesia ad assolvere la funzione di corrimano, di sostegno prima di essere inghiottiti dal pozzo, “Così, per allentare ogni nostalgia”. Il poeta vive la sua condanna a inventarsi immagini bellissime che parlino per lui, del suo malcontento, del suo desiderio di essere consolato:
Nel sole, sopra un cassero, un gatto
s’assopiva dopo essersi strofinato il collo
e miagolato il suo bisogno di consolazione.
Questo desiderio è approfondito nella poesia dal titolo Il vuoto di una finestra:
Il vuoto di una finestra spalancata sul mattino
è spazio che racconta l’inizio di una giornata altrui;
quando con occhi avidi interrogo quel riquadro scuro
senza conoscere il genere o l’identità
che vi vorrei vedere, ho solo un desiderio di contatto.
Si tratta di quel desiderio di contatto che prende molti di noi davanti alle finestre illuminate nella notte, attraversando in treno una città o anche semplicemente camminando lungo le strade, desiderio che nasce dal vuoto che regala la solitudine contemporanea, quel vuoto pieno di merci così ben illustrato nel libro Dissipatio H.G. di Guido Morselli.
Desiderio di contatto che spinge il poeta ad allargare il suo sguardo e ricomprendervi ogni genere di creatura e di pianta e di paesaggio, così la presenza reiterata del gatto, “che non sa la solitudine del suo miagolare”:
– Il mio gatto non conosce le parole
invece io le metto in fila per riempire
un vuoto che ha bisogno di concreto –
E dunque trovano spazio il profumo della salvia decimata e “qualche grappolo tardivo / d’uva americana sottratta con cautela / alle api sedate dal primo autunno”; e “Per il becco avido e pettegolo / degli storni.”
Riprendendo l’attacco di una poesia di Alfredo Giuliani: “Come devo comportarmi, domandai per sapere (per avere, invece, si chiede)..”, mi viene da pensare che la poesia di Luigi Paraboschi è sicuramente attraversata da una serie infinita di domande, nasce nel segno della domanda, ma è pur vero che insieme alle domande allinea, in maniera neanche troppo sotterranea, una sequenza di richieste: abbiamo visto la richiesta di sentirsi parte di qualcosa, la richiesta di essere accolto e amato e compreso che si affaccia in molti dei testi di questo libro. E ci sono anche molti tentativi di risposta. Per onestà devo confessare che trovo molto più suggestive e affascinanti i momenti in cui vibra la tensione di una domanda, piuttosto che quando il poeta prova a dare una risposta che coinvolga il senso dell’esistenza:
“Viaggiamo tutti sopra un treno con i finestrini
chiusi e sporchi, con il bagaglio da noi stessi
affardellato, che ci è stato messo sulla schiena
alla partenza, e il convoglio cammina
dentro la notte,…”
Dove la resa estetica e sentimentale raggiunge il suo apice è in alcune poesie in cui tutta la lezione del novecento si manifesta in una trama di armonia e nostalgia, che rivela la passione per le infinite letture dei poeti, sia quelli destinati alla classicità e al ricordo, sia di quelli, altrettanto numerosi e variegati, ai quali Luigi negli anni ha dispensato critiche e suggerimenti con una pazienza e una costanza più che ammirevoli. Propongo un testo secondo me esemplare di una confluenza di sapienza artigianale, capacità di sintesi culturale, tensione sentimentale:
Vecchia parte di città
Pavia
All’occhio resta la ferita dei vecchi muri,
il rosa antico steso sopra la parete smossa
di una camera da letto, il verde salvia forse
di un soggiorno tracce sbiadite di progetti.
Tegole impilate con meticolosa cura
all’angolo del cortile, testimonianza
di quasi un secolo di piogge riparate,
foglie raccolte in fondo alla grondaia
piena di sabbia che il vento ha raggrumato
per smerigliare il cotto e farlo spento.
Pochi i suoni, un silenzio piatto
dietro le persiane che un sole addenta
tiepido in questa vecchia parte di città
dove la massicciata arroventa
le lame dei binari di stradelle strette
dentro le quali la luce taglia i muri
come in certi quadri di Morandi.
Cortili angusti per i troppi vasi d’oleandri,
cancelli dalle colonne sormontate
da leoni in gesso, balconi liberty
dai quali sgocciola una pioggia di gerani.
Così ti vivo, strada della città vecchia
dentro un languore di primavera tarda,
sotto un cielo dalla calura triste
che stonda i sassi nel giardino all’ombra
ma non uccide l’erba, ove nervosa guizza
una lucertola che s’abbevera alla pozza
sotto il fico dalle foglie come palmi aperti.
Id: 1180 Data: 31/05/2019 12:00:00
*
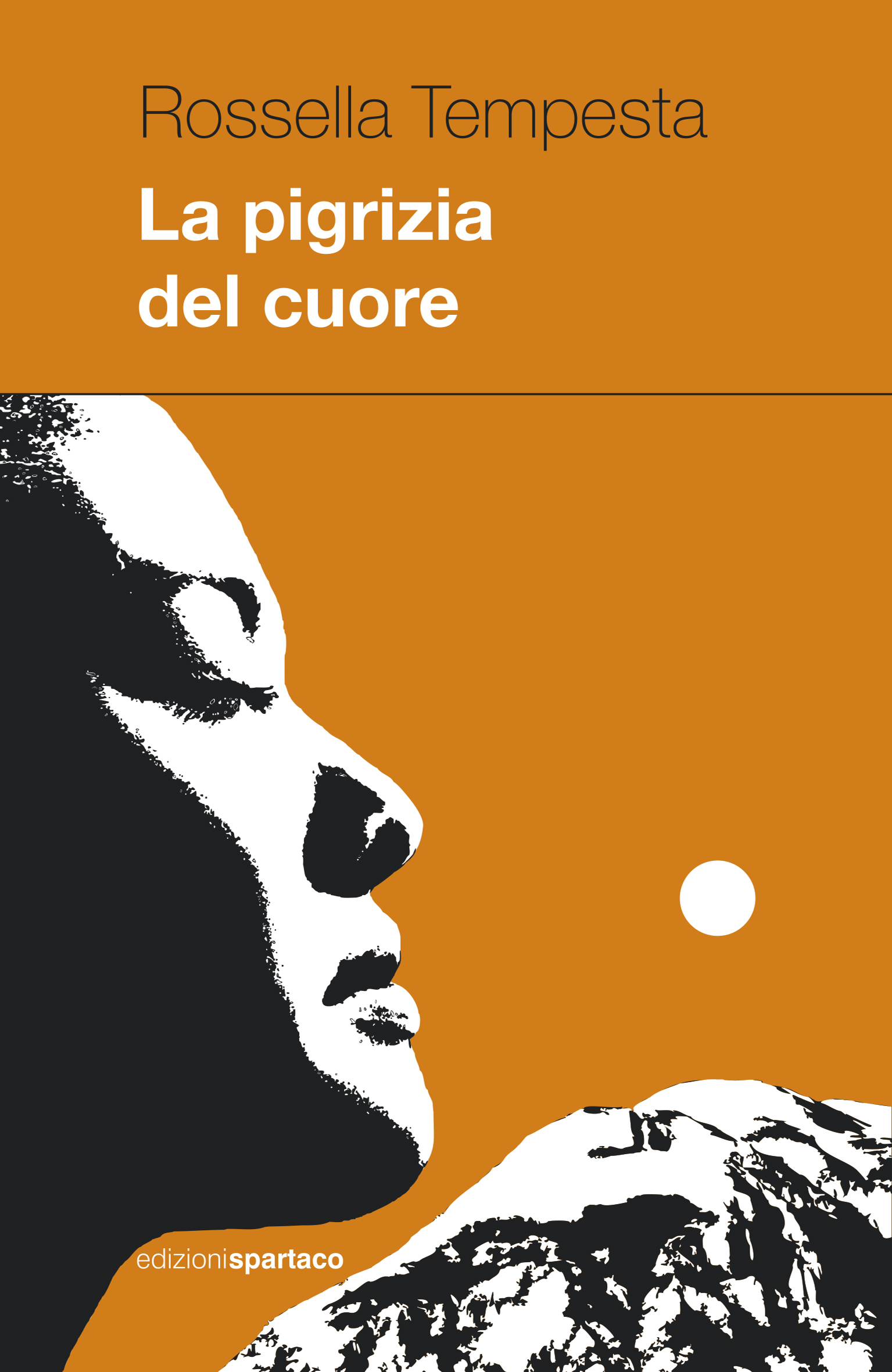 Rossella Tempesta - Romanzo - Spartaco
Rossella Tempesta - Romanzo - Spartaco
La pigrizia del cuore
Un libro come un bodhisattva
Il bodhisattva è un essere vivente che aspira all’illuminazione conducendo pratiche altruistiche. Il suo tratto saliente è la condivisione empatica delle sofferenze altrui. Mi è venuto spontaneo questo pensiero già alla pagina uno del romanzo di Rossella Tempesta, La pigrizia del cuore, quando la protagonista, durante un tragitto in metropolitana, osservando le persone intorno a lei compie questa riflessione: “ Vorrei appoggiare la mia fronte a ogni fronte e leggere i pensieri”.
Proseguendo nella lettura appare evidente che uno dei tratti distintivi del libro è appunto questo, mettersi al servizio di un ideale e dedicare la propria vita a rendere migliore la vita degli altri, così la protagonista Stella Di Mare, avvocato giuslavorista in carriera, sulle cui spalle grava il peso di un intero studio legale, è impegnata nella difesa di chi subisce un torto, si tratti di un licenziamento ingiusto, si tratti di un trattamento non conforme alla legge.
Durante un pranzo con Lorenza, commessa in un negozio di articoli sportivi, viene a conoscenza di una situazione incresciosa subita dalla donna ad opera del marito da cui è separata. Situazione già sfociata in episodi di violenza e che fa presagire una progressione all’insegna della sopraffazione. Subito Stella ne sposa la causa e se ne fa carico. Con esiti finali che il lettore conoscerà da solo, non sta mai bene anticipare le vicende di un libro la cui partenza non è immediata, ma quando, dopo alcune pagine, entra nel vivo dei sentimenti, degli accadimenti, dei proponimenti, diventa subito affascinante e si fa fatica a interromperne la lettura, come accade sempre quando si prende in mano un buon libro e si desidera soltanto restare in compagnia dei suoi protagonisti, sapere cosa ne sarà di loro, che succederà nella pagina successiva, e così si arriva all’ultima pagina con un misto di soddisfazione e di rimpianto perché abbandonare personaggi cui ci si è, nel corso di appena poche ore di lettura, affezionati, genera sempre un certo dispiacere.
Altro tratto distintivo di questo libro è l’atmosfera di entusiasmo che affiora pagina dopo pagina, un irrefrenabile ottimismo, che è lo stesso solare ottimismo che come un alone magnetico circonda l’autrice. Si potrebbe aprire a caso una pagina del libro e respirare quest’atmosfera gioiosa, di continua determinazione e proponimento: “Neppure riesco ad analizzarlo bene questo momento in cui le sensazioni fisiche mi spiazzano. Il cuore, per esempio, il mio pigro cuore addormentato sta battendo come quello di un bambino felice per le sorprese che gli ha portato il Natale appena trascorso.”
La parte del romanzo che più avvince è quella relativa alla storia di Angelina, nobildonna vissuta all’inizio del secolo scorso, che a causa delle convenzioni sociali, dei pregiudizi che incatenano l’agire degli esseri umani, rinuncia per tutta la vita ad una relazione sentimentale soddisfacente e soltanto per una notte si concede la conoscenza dell’amore. Questa vicenda risveglia il cuore pigro di Stella, che si identifica nel personaggio scoperto su di un libro di storia locale, e porterà ad una specie di illuminazione circa la sua situazione sentimentale.
Si affacciano tante cose nelle pagine di questo romanzo, riflessioni sulla situazione della giustizia in Italia, sulla condizione ancora subalterna della donna nella nostra società, digressioni sul Buddismo, descrizioni di paesaggi attraversati nel corso di viaggi.
In tutti i libri spesso si individuano tracce dell’autore, brandelli autobiografici e credo che anche in queste pagine si possano ritrovare esperienze e sentimenti vissuti dall’autrice.
La scrittura possiede uno stile brioso, vivace quanto basta per accattivarsi l’attenzione del lettore, con momenti in cui la discesa nelle profondità delle emozioni compie il lavoro proprio dello scrittore che è quello di rivelargli aspetti della sua stessa vita, di aprirgli in un certo qual modo gli occhi su certe zone inesplorate della sua personalità.
Sempre con lo spirito altruistico di mettere la propria vita a disposizione di quella altrui, esattamente come fa il bodhisattva. Quindi un libro che svolge questa funzione, di incoraggiamento, di sostegno a chi la pigrizia del cuore ha smorzato, attenuato la gioia di vivere, il desiderio di guardare al presente con il giusto ottimismo, con quell’entusiasmo di cui troverà piene le pagine di questo libro.
Id: 1085 Data: 26/01/2018 12:00:00
*
 Bartolomeo Bellanova - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Bartolomeo Bellanova - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Gocce insorgenti
Quando le parole ci pesano
Il titolo del nuovo libro di Bartolomeo Bellanova, Gocce insorgenti, non lascia dubbi sulla prospettiva critica da cui si pone, sullo sguardo privo di indulgenza e di remissione dei peccati, corroborato, in apertura, dalla frase di Sophie Scholl, una delle voci di intransigente opposizione al regime nazista: -“Noi non rimarremo in silenzio. Saremo la vostra cattiva coscienza” - . Sophie con uno sparuto gruppo di studenti dell’università di Monaco dette vita al gruppo della Rosa bianca, che clandestinamente combatteva la barbarie del tempo; una volta scoperti furono ghigliottinati dopo un fulmineo processo. Una vicenda analoga è stata raccontata in un film dello scorso anno, Lettere da Berlino, del regista Vincent Perez, in cui viene raccontata la storia di una coppia di operai che sfida il regime con la sola forza delle parole. Ed è alla sola forza delle parole che si affida l’autore di questa raccolta per denunciare la barbarie che sembra radicarsi e crescere sempre più nel nostro mondo.
Qui tutti i mali del mondo sembra che trovino il loro inventario, finalmente un posto al sole da cui evidenziare le storture, quel subdolo impasto di malvagità e fatalità, quegli incroci malefici ai quali gli uomini sembra non vogliano rinunciare. Così in apertura è la prostituta nera tredicenne cui l’autore dedica un primo piano di crudele spietatezza: - Non è colpa mia se tua madre / ti ha lasciato partire / dal tuo paese di sterco e polvere. –
E subito dopo un episodio ancora più terribile, la vicenda della bambina siriana, diabetica, cui i trafficanti di uomini hanno gettato in mare lo zainetto con l’insulina, condannandola così a una morte atroce, sotto gli occhi dei genitori sbeffeggiati: - e ridevano le iene / ghignavano sui rintocchi a morte -.
E poi la fredda determinazione dei kamikaze: - esploderemo in un centro commerciale -, e qui la voce del poeta non si limita a registrare la cronaca (Sei esploso in fila per il pane caldo della mattina / scugnizzo di Palmira, dieci anni e il cuore tisico), ma a un certo punto invade la scena e prega il giovanissimo kamikaze di prendere coscienza, alla sua morte non troverà le quaranta vergini promesse, ma solo l’oblio del tempo: - Corri e impara l’amore / corri, esalatati d’amore, / esplodi alfine d’amore.-
Tra i mali recenti del mondo non poteva mancare il destino tragico, amaro di Giulio Regeni, del cui assassinio è apparso fin da subito evidente che andava imputata la responsabilità ad appartenenti alle istituzioni egiziane, come appare evidente che la ricerca della verità è stata sacrificata sull’altare delle convenienze economiche e politiche. E poi Donald Trump, con l’alone macchiettistico che lo circonda e la sua cinica, stupida cattiveria: - cecchino implacabile di esseri migranti -.
Elio Pagliarani nel suo La ragazza Carla scriveva:- “Le abitudini si fanno con la pelle / così tutti ce l’hanno se hanno pelle” -. Credo che un certo tipo di poesia nasca dalla pelle, dal dolore bruciante sulla pelle che la cronaca dei nostri giorni imprime come un marchio infuocato, dalle esperienze, dalle sensazioni urticanti che si avvertono girando per le nostre strade, attraversando i territori del nostro tempo.
Così il raccoglitore di pomodori: - Del tuo sudore nutri le ore / nel tuo sudore affondi la vita – e poi tutto il dolore delle madri: – madre nostra coi capelli strappati dai fili spinati – e ancora, lo squallido paesaggio delle periferie, le sue terribili promesse : - nella camera a gas / di questa pianura lambrusco e svincoli tangenziali / rotaie, capannoni, autoarticolati, / e veleni sospesi.-
Ed è ancora un fatto di pelle se un paesaggio urbano incide le sue note come fossero artigli e chiede di essere esplicitato sulla carta, chiede accoglienza dentro i versi, e così Genova si imprime con le sue atmosfere: -…Madonne barocche / benedicono chi passa a testa bassa / benedicono chi passa e contratta...-
In questo libro c’è anche tanto spazio per il terreno prediletto della poesia, per l’uso inventivo del linguaggio, per la ricerca di un lampo di bellezza che squarci la monotonia delle giornate e illumini di meraviglia e di sorpresa:
Scugnizzi
Sono merli scugnizzi
saltano i pilastri uno ad uno
saltano giù i gradini due a due.
Ridono sgranati
come chicchi di riso
gettati al cielo
e calciano la luce.
Sgommano a sciame,
masticano gomme,
saltano eccitati
del loro volo inerme,
atterrano e si fiutano
le illusioni.
Anche le rondini offrono solidi appigli per spargere versi di bellezza, col loro desiderio di circuire le torri altere con canti, trine e merletti
essere una manciata di pura grazia
incurante di questa luce
e più avanti, ancora, saranno sempre le rondini a suggerire nuovi accordi, impasti inauditi del linguaggio, che richiamano i versi di Montale – la gazzarra nel cielo degli uccelli – e mutano prospettiva pur evidenziando una stessa vivacità celeste:
M’accompagno a te,
pulsante creatura dei cieli,
fessura alata del possibile.
E di seguito anche la bellezza dei passeri viene ricordata ed esaltata nei versi:
Gioia di luce il vostro canto è un attimo breve,
poi torno a incespicare nei miei occhi sbarrati
Spesso ci si dimentica che il confine della poesia, la sua parete comunicante, e dunque anche la sua sorgente, è tutto dentro il silenzio, custodito come in una sacca amniotica, il silenzio è la sua cella, la sua vera radice, e gli spazi bianchi del foglio sono lì a ricordarcelo, a evidenziare il respiro buono da cui prende vita il verso:
Silenzio
Cos’è questo silenzio notte?
Questo corpo oscuro?
Dove inizia?
Hanno confini i suoi arti
e il suo tronco?
Lo senti il suo canto muto
La sua ipnosi irresistibile?
Ci stacca i sensi a uno a uno
ci alita buio negli occhi
e c’inghiotte a uno a uno.
Poi se avrà pietà
ci sputerà fuori
all’abbaglio del mattino.
Il motore che fa viaggiare un libro di poesia è lo stesso che fa viaggiare la letteratura ed è la fascinazione del linguaggio, cioè la capacità di prendere per mano il lettore e condurlo a spasso dentro le storie, dentro i versi, col potere incantatorio delle parole. Questo potere scaturisce in virtù dell’amore che l’autore profonde nell’impastare il linguaggio, nel farne materia viva, incandescente, da plasmare e da addomesticare; questo concetto è riassunto e spiegato alla perfezione dal filosofo Giorgio Agamben nel libro Il fuoco e il racconto: - Scrivere significa contemplare la lingua, e chi non vede e ama la sua lingua, chi non sa compitarne la tenue elegia né percepirne l’inno sommesso, non è uno scrittore -. E in questo libro sprazzi di luce e di bellezza si rincorrono senza sosta :
In Via San Leonardo si stirano
le ossa i primi scuri cigolanti.
Sono occhi impastati d’ocra
e viola tenero, incerti e muti.
In questo libro le parole sono divenute materia, hanno preso corpo dalle vicende della storia, dai nostri tempi cupi e malati, e da questo libro ci guardano, ci accompagnano, ci pesano:
Con te le parole hanno preso materia,
hanno preso corpo dalla caverna di buio e saliva,
ci accompagnano, ci pesano, ci vivono la vita intera
dal primo vagito all’ultimo rantolo.
Alle parole abbiamo affittato corpo,
cervello, muscoli, sangue e ossa.
Id: 1074 Data: 10/11/2017 12:00:00
*
 Claudia Zironi - Poesia - Marco Saya Edizioni
Claudia Zironi - Poesia - Marco Saya Edizioni
Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni
Un tempo lunghissimo che non abbiamo avuto
Nell’accostarsi ai versi del nuovo libro di Claudia Zironi, Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni, viene spontaneo attendersi un’atmosfera notturna, è legittimo prevedere sconfinamenti nel macabro, nel sepolcrale, incursioni in un mondo di incubi, in un percorso orrifico e in compagnia di un ricco sventagliamento di paure, corroborati in questo dalla immagine di copertina, fotogramma tratto dal film Poltergeist, incoraggiati anche dai testi che introducono le sezioni che scandiscono il libro, vere anticipazioni delle arie delle poesie, dove per esempio apprendiamo che – I fantasmi sono particolarmente sleali, pericolossissimi per il nostro inconscio: mostrano solo uno dei propri tanti aspetti – di solito quello fascinatorio – ci illudono della loro esistenza reale –
Accade così che fin dall’inizio assistiamo a un radicale rovesciamento della prospettiva illlusoria in cui titolo e copertina si erano largamente spesi in promesse, e scopriamo invece una subitanea luminosità dei versi: splendido sei, nella parola tua – e un dispiegamento di energia creativa che si trasmette al lettore con una specie di furia aggressiva, un impeto che non esiterei a definire amoroso, se tale parola non risultasse un limite, un rinchiudere dentro un perimetro, al contrario di quello che realmente è, un’espansione del senso, un tentativo di abbattere qualsiasi tipo di confine, di barriera:
non senti il profumo della carta
nuova, della musica, del vetro ?
ti scaglio contro una ribelle foglia
rossa
ti chiamo tutta la poesia del mondo.
Il tema del fantasma è centrale in questo libro di versi, e si trova associato al tema della parola, al tema del tempo, dell’amore forse. Sono temi che chiunque abbia una minima dimestichezza con il pensiero filosofico non tarderà a sentire come centrali, essenziali, ad avvertire come unica certezza quali vertiginosi baratri spalanchino davanti a sé, quali domande in cerca di risposte dispieghino, mettano allineate una accanto all’altro, con la consapevolezza di un orizzonte che sempre si allontana ogni volta che un passo in avanti viene commpiuto e che non ci sarà un punto fermo, un approdo definitivo, una soluzione all’equazione. Ed è forse alla poesia demandato il compito non già di definire, quanto piuttosto di tentare, di provare a proiettare dei bagliori, dei fantasmi, delle forme che per quanto illusorie provino a dare una forma di concretezza al mistero della parola, al mistero del tempo. Niente è più illusorio del tempo e suscita un riso amaro accostare al tempo la parola reale, come se il tempo possedesse una realtà. Così è anche il mistero della parola, questa fascinazione che lancia i suoi riverberi, cosparge di mistero tutto ciò che sfiora o tocca:
…..risplendere di luglio
avvinghiati nella terra come forme
giovani d’argilla, riconoscersi nel vero
profondo accordo interno delle fronde,
almeno uno stormire unisono di corpi
duri e dolci, protesi al vento, almeno
una vegetale essenza, una lunga vite
di agili colline.
E’ in queste sequenze che il lettore ritrova un barlume di verità, una potenziale contiguità con la fascinazione che produce il verso, una specie di carezza assolutoria che avvicina, una piacevole sensazione di accoglienza, di ritrovarsi in un luogo amico. E’ un libro che mette insieme i frammenti di una esperienza di ricerca esistenziale, il tentativo di inseguire un senso, di arrivare a un approdo, una ricerca che ha a che fare con l’amore, con l’esperienza, con tutte le domande che perennemente ci sfiorano, ci lambiscono come instancabili maree. E’ anche una disposizione a dare luce, a illuminare: -..uguale/ a tutte le falene attratte dalla luce.- La cifra stilistica di questa ricerca in versi coincide perfettamente con la esuberante, vulcanica personalità di Claudia Zironi, con la sua suadente vitalità e il suo repentino adombrarsi, con la sua caparbietà nell’inventarsi paesaggi, nel costruire percorsi e possibilità:
di come oggi potremmo camminare
per una via di Milano senza conoscerci
Viene il sospetto che il fatidico approdo suggerito dai versi di Claudia sia appunto delineare un panorama di ipotesi, che una qualche parentela coi fantasmi di un progetto possono forse vantare, una mappa di evenienze, di possibili incroci, per arrivare a dire:
di esserci incontrati e subito baciati
in un chiassoso mercato rionale.
Anche il tema del ricordo possiede sicuramente una contiguità, una vicinanza con la realtà fantasmatica, essendo il ricordo una proiezione filmica privata, segreta, una costruzione di immagini che in qualche modo gira intorno alla realtà, vi si attorciglia senza possederla e forse in alcuni casi travisando e costruendo a nostro piacimento, fino a ottenere il giusto fantasma che ci piace ritrovare, quella personale verità che pur piegandola è la nostra verità, come quella mano piccola da bambina, e la statura di chi non vuole crescere, e il campetto sotto la vecchia casa popolare ad accogliere la palla e la sbucciatura del ginocchio, risultano così eventi che riemergono da un passato e ci chiamano col loro canto incantatorio.
Il libro racconta anche di un confronto, di un dialogo a distanza, serrato, intenso, di una presenza oltre lo schermo che tanta importanza ha rappresentato nel cammino poetico di Claudia, ed è un tu anche questa volta fantasmatico, sfuggente, doloroso e cercato, inseguito, e dunque cantato:
ho paura di te, di come
potresti sparire, prendermi
il cuore e mangiartelo
dirmi di essere morto,
di come ti appartengo.
E questo confronto certamente si colora d’amore, cresce e si dispiega illuminato dalla luce dell’amore; si ha l’impressione che il punto di partenza del libro sia appunto un dialogo a distanza, compiuto secondo le nuove modalità dell’evoluzione elettronica, e che in maniera neanche troppo sotterranea si mostri sotto forma di attrazione, di fascinazione, si conformi al modello di comunicazione vigente nell’attualità, come ci confermano appunto i seguenti versi:
io non so come si chiama
questo bene che ti voglio
né se ci sia un perché
al tremito della piuma
giovane, alla vertigine
del passo sulla soglia
al suono incessante
del dolore dei morti,
ma se guardo il cielo
sopra le cime, bianco
chiaro lo vedo tutto
e potente, solo amore
per abbracciarti intero
al di là dell’ostacolo
di luce e vetro, oltre
il confine della parola
Scrivere a proposito di un libro significa rimanere comunque aggrappati alle impressioni, alle sensazioni, cioè riportare le foto di un viaggio, quelle piccole luci che il paesaggio ha regalato in forma di riverberi, cioè significa rimanere nel campo delle ipotesi, sul terreno paludoso e sdrucciolo della soggetività. Ma c’è qualcosa comunque di solido e di concreto alla fine del viaggio, ed è il tipo di scrittura sinuoso e limpido, questa pioggia di parole che a volte scende in forma di scroscio, convulsa e compulsiva, a volte si fa chiara e luminosa, comunicativa e sensuale, sempre seduttiva, come un caldo abbraccio, una presenza sicura, che rispecchia fedelmente l’autrice, le sue sinuosità, la sua scoperta malizia, la sua energia che prorompe nel verso, il suo andamento attraente:
le isole risiedono nell’azzurro
di snutrono di cielo e sono
di poche parole
si dice che amino
bagnarsi nella pioggia
e farsi visitare dai gabbiani.
di solito stanno lì
dove sono sempre state
anche d’autunno.
ma dalla tua finestra talvolta
ne ho vista qualcuna volare.
Id: 1059 Data: 11/08/2017 12:00:00
*
 Luciana Moretto - Poesia - La Vita Felice
Luciana Moretto - Poesia - La Vita Felice
Veder chiaro
Il puro lampo di un giardino riflesso nell’argenteria
Il titolo della raccolta di versi di Luciana Moretto si presta a essere osservato da differenti angolazioni. A partire dalle citazioni poste in esergo: Larkin e Szymborska, autori che attraverso la lente di un’affettuosa, a volte tagliente ironia, ci aiutano spesso a veder chiaro nelle faccende del mondo; e subito dopo a partire dalla stessa essenza di un libro di poesie, che quando è di buona qualità ispira sguardi nuovi, alternativi, e induce quindi a una visione diversa, a un veder chiaro, appunto.
Come la poesia da cui la raccolta prende il nome:
Ah si, essere anche noi per una volta
simili ai domestici di doviziose
dimore che lucidando a specchio
la posateria d’argento vedono
come per incanto risplendervi
dentro il puro lampo di un guardino.
Intanto aiutano il lettore a vedere dentro lo sguardo dell’autrice, perché è dentro il suo sguardo che si concentra la tensione dei sentimenti, la scelta degli oggetti intorno ai quali costruire poesia.
Mi piace a volte partire dalla fine di un libro, per motivi a volte a me sconosciuti: forse perché l’autore mette davanti le poesie più belle ? in un tentativo quindi di coglierlo in fallo, di individuare le eventuali, possibili crepe? o forse semplicemente per assecondare un impulso alla libertà della lettura?.
È dunque una piacevolissima sorpresa la cura del verso, la sua asciutta eleganza, certe sottigliezze stilistiche, una leggera ironia surreale:
Con un pennino intinto nell’inchiostro
nero scrivevo l’altra notte in sogno
sopra un foglio nero. Chissà che versi
intensi, decisivi, mi son persi.
E subito dopo il battito del cuore letterario farsi più intenso nell’allontanarsi dall’isola che dette i natali a Foscolo: …quel profilo greco / che andando lascio, ahi! / lungamente indietro.
Le poesie successive ci aiutano a entrare nel cuore dell’autrice. Mi torna in mente il verso di Whitman: anche il rospo è un capolavoro di Dio!, perché mi imbatto in versi dedicati a una vespa che rischia di affogare in un succo di carota, al bar; le riflessioni della vespa scampata si concentrano nella poesia Illazioni di una vespa.
In Amici come prima l’autrice ringrazia alcuni amici silenziosi della loro presenza in casa: sono tarli, cimici, formiche, pesciolini d’argento, compagni ideali delle giornate storte. Si tratta di rivelazione importante, dichiara quanta cura, quanta attenzione per le forme di vita anche minime, segrete, quelle cui non badiamo affatto, e ricorda l’attenzione dei monaci buddisti della foresta, che camminano facendosi precedere da un delicato spazzare la terra con rami per evitare di calpestare e uccidere la benché minima forma di vita.
L’autrice dichiara la sua attenzione in questo modo: …basta a farmi credere / che esista un’anima animale / in sé comparabile a una rivelazione / e come tale da salvaguardare.
Ma anche i ranuncoli, e l’amarillide, sono oggetto di attenzione nei versi di Luciana, sempre celebrati con misura, con quella sobrietà stilistica che parla di un rigore morale, dichiara una propensione alla pulizia, e un rifiuto di qualsiasi tentazione trionfalistica.
Ulteriore possibilità di interpretazione del titolo: veder chiaro in contrapposizione alla possibile visione oscura in virtù della durezza dei tempi, quindi un tocco di ottimismo, un’aspirazione a non scoraggiarsi. Di piacevolissima lettura anche le prime poesie, con l’amante mancato e il rimpianto per quell’unica occasione: - l’incontrollata audacia di poggiare / le mie labbra deluse sulle sue -. E anche Interno sera, con sprazzi luminosi di vita quotidiana.
Ma forse a questo punto il titolo della raccolta ha mostrato il meglio di sé, ha dispiegato il suo effetto, e si, finalmente ci vediamo chiaro, perché il mistero della poesia è appunto questo: portarci in giro per paesaggi domestici e visioni altre, per territori sconosciuti, dischiudere infine uno spiraglio in cui la vita si manifesti, ci offra lo splendore di momenti intimi spalancati nei versi: la bellezza di una vespa salvata da sicuro annegamento in un succo di carota, la segreta amicizia di tarli e formiche, la vicinanza della poesia e dei poeti, la visita di un’amica malata col turbamento che l’accompagna, piccoli frammenti di vita che ci rivelano qualcosa di più chiaro, di più vero. In compagnia di un sottofondo di silenzio, di un alone di riservatezza, di elegante misura:
Similmente custodire
il silenzio con parole scarne
misurate, minime.
Id: 1050 Data: 09/06/2017 12:00:00
*
 Marisa Cecchetti - Poesia - Giovane Holden Edizioni
Marisa Cecchetti - Poesia - Giovane Holden Edizioni
Il tavolo antico
La voce di una comunità
Il libro di Marisa Cecchetti si apre con una dichiarazione programmatica cui si atterrà per tutto il corso della raccolta:
Raccatto i miei versi per strada
li rotolo insieme al pedale ed al passo
rammendo ed intaglio in cucina non amo
indagare soltanto le strade di dentro.
Intento operativo dichiarato e realizzato in maniera egregia, i versi di questo libro si offrono come la voce di una comunità, come una serie di ritratti, una sequenza di immagini, e comunque la traduzione verbale di situazioni legate a un ambiente dapprima ristretto, che nell’incedere si allarga a ricomprendere nello sguardo esperienze più vaste. Si parte infatti dallo spazio privato, anzi privatissimo di un tavolo antico, sodale di scritture (Ora so / che lì ho scritto le righe più belle), per attraversare il dolore di certi ricordi familiari, il dramma della malattia di un figlio (negli occhi / tuoi verdi grandi / io leggevo paura mentre / cercavi di sorridere), il ricordo della casa della mamma, ora abitata da altre persone: - che non era mia madre né era sua / la mano che ho intravisto -, e il ricordo di un incidente familiare, con l’urlo della sirena ancora presente col suo corollario di sciagura. Il discorso si estende, si apre sull’immagine di una chiesa dove si benedicono gli animali, e dove sul sagrato: – paesani ognuno con il suo ricordo -. Il presente delle nostre città si apre a persone provenienti da altri paesi, così: - lei è una rumena di mezza età – che staziona sulla porta del bar e le augura buona giornata; e la poesia successiva ritrae una giovane donna con gli orecchini d’argento ai lobi:- E’ bella. Come può essere bella / una giovane donna africana -. E a seguire lo sconcerto per lo sgombero di un campo rom. E il racconto della prima occhiata del mattino, che va alla finestra in alto, al piano di sopra, per verificare che la vicina novantenne abbia iniziato la sua nuova giornata. In definitiva la cronaca in versi degli accadimenti del luogo in cui si vive: il prete anziano che segue con lo sguardo protettivo il giovane diacono, i giovani studenti che inforcano le bici: - vanno in ordine sparso le biciclette adolescenti-. Troviamo qui indagate non soltanto le strade di dentro, ma il paesaggio dentro e fuori la città, il fiume che la lambisce, i personaggi che la abitano. Il procedimento richiama alla mente la vocazione originaria della poesia: incidere nei versi gli avvenimenti di un territorio, di una comunità, per farne memoria, per sottrarli alla tirannia del tempo e proiettarli in una dimensione futura, fermarli dentro le parole, restituirli, all’interno di una privatissima visione, a una fruizione collettiva, ampliarne gli orizzonti e il senso, farne una direzione di marcia, un progetto, divenire la voce di un corpo che allargandosi ricomprende gli avvenimenti minimi privati e le vicende di una città; fissa dentro immagini paradigmatiche lo spirito del tempo e insieme le cronache che lo caratterizzano. Nei primi versi si accenna al pedale e al passo. E’ da rimarcare questa situazione europea di civiltà ciclistica, perché se è il tavolo antico testimone della nascita dei versi più belli, è la presenza della bicicletta ad averne propiziati altrettanti, o almeno accompagnati nel loro accadere: Intorno all’ora nona vado nel sole con la bici – e poi : - Hanno inforcato / le biciclette e sono scesi in fila – e ancora: pedalo per fare vento. Viene da una tradizione antica, perché riaffiora anche nella memoria: …- mi è apparsa la sagoma del nonno / in equilibrio sulla bicicletta con il sacco del grano -…
Di un libro di poesie rimangono i tratti più felici, le invenzioni linguistiche più riuscite, quelle che s’incidono e chiedono di essere rilette, e nei versi che compongono Il tavolo antico non fanno certo difetto le soluzioni memorabili, i versi la cui perfetta riuscita invoglia a leggere e rileggere:
Della mia terra ho riscoperto il grano
voltava al giallo chiacchierava basso
che ha il pregio di spalancare una visione d’insieme, un intero paesaggio adoperando meno di una decina di parole. E anche:
…e quando
si fa zitta la strada parlano gli alberi
di un parlottare fitto d’uccelli.
Marisa Cecchetti padroneggia uno stile che trova antiche radici dentro la classicità, e avanza in un’atmosfera di rigore formale, di essenzialità e di pulizia del verso, in una visione chiara, ampiamente empatica, che fa apprezzare e amare i suoi versi:
Sull’argine la ruota della bicicletta
scorre sul ciglio che scende
obliquo verso il fiume e freme d’erba
piccola di un ottobre caldo
e le foglie cadute vi stanno
come stelle accese.
Id: 1011 Data: 18/11/2016 12:00:00
*
 Roberta Lipparini - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Roberta Lipparini - Poesia - Terra d’ulivi edizioni
Per mare mio amore
Mi cuci l’amore addosso?
Il nuovo libro di Roberta Lipparini, Per mare mio amore, edito da Terra d’ulivi, si apre con una dichiarazione programmatica: Dicevo e pensavo / come le parole sanno ben curare / lenire / anche se dicono il terrore / o consegnano vergogne alla memoria.
I versi che compongono questa nuova opera si pongono sulla scia del precedente, Io ce l’ho un amore: in quello ruotavano intorno a un amore che in parte manifestava una sua corporalità, una presenza, seppure ambigua, sfumata, continuamente giocata sul filo della linea esisto / non esisto; quest ultimo invece dichiara in maniera esplicita che questo amore è un fantasma, una chimera, una sorta di ossessione, che il letto è vuoto, il cuore registra una vacanza, il desiderio è tale da inscenare un bellissimo gioco. Il libro su pone infatti sulla linea della necessità propria del gioco, che non è un diversivo, un’occupazione piacevole del tempo, ma nasce dall’impellenza di un desiderio, dall’emergenza di un vuoto, di una mancanza. Così Roberta mette in scena la mancanza di un amore, e lo fa attraverso il gioco, giocando con le rime, con le assonanze, con un uso sobrio ma avvertito del ritmo, con piccoli stratagemmi estetici che regalano al lettore la sensazione della messa in scena di un desiderio, di un vuoto da colmare. Quando Roberta scrive per i bambini lo fa con estrema professionalità, da adulta consapevole dei limiti e degli ingredienti adatti a un pubblico giovanissimo. Quando scrive per medicarsi le ferite, come scrive in apertura del libro, lo fa con la grande serietà che i bambini mettono nel gioco, e mette in campo la straordinaria strategia terapeutica del: facciamo finta che.
Ti parlo a lungo
ti confido ogni ricordo
frammento particolare
Parlo di te all’acqua del mare
riscrivo sulla sabbia
ogni tua frase
gesto, pensiero
Come se fossi qui
come se esistessi davvero.
Roberta dispone già di un suo pubblico affezionato, abituato alla leggerezza, alla soavità dei versi che in realtà affondano le proprie radici nella sofferenza che genera una mancanza, una privazione dolorosa e mortificante come è il bisogno di amore. Un pubblico devoto, che ama il sorriso che nasce dalla leggerezza di quei versi, nella consepevolezza che spuntano da un terreno rigoglioso di lacrime, dalla sconforto di non sentirsi amati. La devozione che le tributa il suo (piccolo ma nutrito come un esercito esiguo) pubblico trova la sua giustificazione in una duplice evidenza. La prima è costituita da una indubbia commestibilità della sua poesia, dall’uso di un linguaggio accessibile, immediato, leggerissimo, aereo, che trova un facile varco nella sensibilità del lettore: Mi cuci l’amore addosso ? / Stretto stretto / col filo rosso / Stretto stretto / che non deve scappare / forte forte / che lo devo sentire / così tanto da far battere il cuore / Me lo cuci per favore?
Una leggerezza che sembrerebbe tenere il dramma fuori dalla porta, prenderlo garbatamente in giro, fare finta che non si tratti di vero dramma, fargli le linguacce, imprigionarlo dentro rime facili facili, dentro versi trasparenti, dolcissimi che si fanno assaggiare da un pubblico niente affatto popolare, un pubblico smaliziato, avvezzo a letture ardue ma che possiede la giusta avvedutezza per gustare la tenerezza di questa poesia gelato, questa poesia lecca lecca. La seconda ineccepibile motivazione che lega il pubblico alla poesia di Roberta sta nella fame di amore che tutti avvertiamo. Tutti desideriamo essere amati e tutti sentiamo in maniera atrocemente dolorosa che non siamo amati. Questa comunanza del sentire è alla base della universalità della poesia di Roberta Lipparini. Ci piace soprattutto che ce la spiattelli in maniera deliziosamente leggera, come sa esserlo una filastrocca infantile: Bambola bambola / cuore di pezza / bambola vuole una carezza / e piange lacrime di stoffa blu / per quell’amore / che non c’è più. Che ce la sbatta sul muso sorridendo, facendoci gli occhiolini d’intesa che solo rime facili, ritmi non complicati, sanno suggerire. E meritare così tutta la nostra gratitudine, perché il suo canto riesce ad alleggerire la nostra pena, riesce soprattutto a renderla accettabile sdrammatizzandola, mettendoci quel pizzico di ironia, di levità che ce la rende persino amica, che in fondo ci fa sentire fratelli, accomunati da una stessa, identica fame, ma con sobrietà, senza smancerie, tenendosi al largo da qualsiasi tentazione di tragedia, di autocommiserazione. Unisce sincerità e leggerezza, non ci inganna, non nasconde l’amarezza della verità, ma attraverso una delicatezza dei modi ci incoraggia:
Dicevo del conforto
Di quel calore che ti senti accanto
quando la parola ti entra lieve
perché è canto.
Id: 996 Data: 29/07/2016 12:00:00
*
 Martina Campi - Poesia - buonesiepi libri
Martina Campi - Poesia - buonesiepi libri
Cotone
Ci s’incontra nei panorami
Accade a chi frequenti blog, siti, riviste letterarie, di imbattersi in saggi di critici catastrofisti che annunciano la definitiva dipartita della poesia. Allora è una vera fortuna fermarsi al rango di lettore, perché in veste di lettore mi capita di incrociare libri che al contrario proclamano che la poesia è viva e lotta insieme a noi, abita ancora qui, anzi è bello sapere che la praticano persone che conosci. Mi viene da pensare che questo accadrà ancora a lungo, a dispetto dei catastrofisti, e registrerà continui aggiustamenti delle modalità espressive, dei mezzi utilizzati e, si spera, anche del bacino di utenza.
Il libro di Martina Campi, Cotone, è di quelli che restituiscono fiducia nelle sorti della poesia, assicurano che la poesia ha un presente e probabilmente un futuro. E’ un libro che possiede una voce sicura e incisiva, una scrittura rarefatta che procede per approssimazioni, per avvicinamenti, per allusioni frammentarie, e si allinea con certi graffiti metropolitani, con le recenti espressioni della danza contemporanea, col fumetto raffinato, con certa sperimentazione in ambito musicale, un modo fresco, arioso, intelligente di restituire la contemporaneità. Penso alla bellissima Il silenzio delle finestre, con quella donna che urla da lontano, … - in un’altra sera / che è calda, grossa, rossa / sopra la biancheria, sopra la televisione / fatta a pezzi, oltre le finestre, pezzi di vetro dalle finestre.-
Una duplice notazione stilistica: il titolo posto, in alcune composizioni, al fondo della poesia, come se il testo non fosse altro che l’intento didascalico per giungere alla fulminante, compiuta bellezza del titolo: disegnata contro la notte, o anche: corridoi sotto gli ombrelli, o anche: mi affido ai cappelli, o anche: luoghi del parapiglia, e infine: ci s’incontra nei panorami. Inoltre rispetto a Estensioni del tempo, suo libro precedente, il verso si è allungato, s’indirizza ora verso una tensione narrativa i cui orizzonti si allargano fino a comprendere porzioni sempre più vaste della consapevolezza dello stare qui. Sono piccoli dettagli che parlano del lusso di un artigianato che è appannaggio esclusivo di una nicchia, e tuttavia possiede quell’autorevolezza adatta a indicare una strada, una possibile direzione per la poesia futura.
Nel libro precedente scriveva: - c’è qualcosa di doloroso nello scorrere -. Qui è la suggestione raggelante del freddo a suggerire un possibile percorso: - Tu sai questo freddo tu sai / o non sai questo freddo -. Emblematico del libro potrebbe essere il verso: -…e provare / un affetto incontrollabile per le cose -. Che propone questa non inconsueta parabola: dalla luce interiore che illumina la poesia di Martina si giunge a una sorta di struggimento, e infine a un disagio, a una sofferenza, a un progressivo straniamento. Per un eccesso di amore che diventa eccesso di incomprensione, di estraneità, di lontananza. Perché un eccesso di partecipazione, di adesione, non può che risolversi in questo: - allora, grazie di tutto, / grazie, eh, di tutto tutto. / E noi, tra poco, non saremo più qui -.
Le radici profonde di questa connessione affondano nella lingua, affondano in quell’affetto che è la sorgente primaria di questa poesia, attenta e consapevole di ogni piccolo incantesimo. - E poi, venirsene fuori con qualcosa / di completamente differente -. La struttura del libro ripete la scansione per capitoli del precedente Estensioni del tempo. Le ultime poesie manifestano una potente bellezza, rivelano la tentazione della disperazione, sebbene addomesticata da una parvenza di fredda ironia. – E poi perché ci vuole la calma, / sapete, ci vuole la sorrisa -. E’ un libro destinato a restare nel cuore del lettore.
Id: 833 Data: 12/12/2014 12:00:00
*
 Marco Righetti - Romanzo - Leone Editore
Marco Righetti - Romanzo - Leone Editore
Sole nero
Nel romanzo Sole nero convivono più generi: il racconto lungo, di cui ricalca velocità narrativa e parametri di lunghezza.
Il frontespizio riporta, appena sotto il titolo, la dicitura – cortoromanzo – che non sappiamo se sia cugino del già citato racconto lungo e in quale rapporto di parentela, o almeno di affinità, si collochi col romanzo, col quale condivide, seppure ridotti in scala, intreccio, numero dei personaggi, respiro, e del quale conserva il tono espositivo ampio, la tessitura della trama, i piani narrativi dislocati in spazi temporali differenti.
Nel corso della lettura affiora netta la sensazione di essere dentro un film d’azione, con cambi improvvisi della prospettiva, una varietà ricercata di inquadrature, dissolvenze e primi piani si alternano, così come concitati dialoghi e riflessioni private.
Dal fondo della scrittura sembra persino di sentire una colonna sonora che sottolinei i momenti cruciali del racconto.
E in certo qual modo Sole nero sconfina persino nel fumetto, quello colto, d’autore, per certe allucinate raffigurazioni, per certe ardite e stranite inquadrature; per la fissità icastica di alcune allocuzioni, per un fraseggio breve in cui l’accelerazione è finalizzata a tener dietro al passo della storia.
L’incipit del romanzo vede un Frecciarossa tagliare la pianura padana alla velocità raggiunta nel 2022. Tra i tanti generi corre l’obbligo di ricordare che non resta immune il territorio della fantascienza, col racconto proiettato in un futuro che si può toccare allungando appena la mano, quando l’attività solare raggiunge un picco mai registrato in precedenza. Ma forse qui fantascienza non è altro che fantasia applicata alla scienza, a quella che privilegia le energie rinnovabili, col termodinamico in fase di sorpasso rispetto alla tradizionale fonte di approvvigionamento energetico, il petrolio.
Di qui lo scatenarsi di appetiti e incontrollabili passioni.
Si muove a suo agio tra i vari ingredienti una porzione di giallo condita da una fettina di spionaggio internazionale. Righetti fa entrare il lettore nel cuore del racconto con una telefonata notturna al geochimico Federico Loriga. A chiamarlo è il fratello Gian Mario, al lavoro nel pieno del Sahara: una comunicazione criptica e sibillina lo invita a raggiungerlo nel deserto.
I personaggi chiave non sono numerosi, come si conviene a un cortoromanzo.
Che rivela infine una chiara parentela col cortometraggio, film dalla veloce trama, e col documentario, che possiede intenti divulgativi, che documenta appunto una realtà.
Sullo sfondo vediamo agitarsi i sussulti della grande finanza, le neghittosità della politica, gli interessi dei famosi poteri forti, misteriose apparizioni e altrettanto difficili scomparse. E non è esente da mistero il principale personaggio femminile, Alissa, concretissimo asse portante nel plot, sulla quale il noir accende le sue luci per lo sconcerto del lettore.
La globalizzazione certifica una presenza massiccia attraverso un tipaccio inglese dai modi poco british, Carew, lo spagnolo ingegner Fuente, i nomadi del deserto, una enigmatica ragazza giapponese, i viali di Milano, le dune e le rocce del Sahara, la fascia del Sahel, e ancora la laguna di Cabras, Oristano e le sue tradizioni, le feste di Lentini.
Tale ricchezza nell’offerta di generi si traduce in una serie di positive caratteristiche che rendono appassionante la lettura: avvincente quanto basta per rimandare la chiusura del libro al prossimo capitolo, e poi a quello successivo, che immagino costituisca l’aspetto più gratificante, il vero premio, per un autore.
Si rivela ulteriormente interessante perché affonda le mani dentro un tema già attuale e impellente.
Scrive l’autore:
- Le macchie solari che ogni 11-12-13 anni lanciano tempeste solari sulla terra e creano piccoli o grandi blackout sono fenomeni certificati dalla scienza, così come sono temi veri la mafia del petrolio (in Algeria è ben presente) e la rete di centrali solari termodinamiche (con specchi riflettenti su una cisterna) che tappezzerà il Maghreb... -
Nel romanzo questa rete si chiama Lightstorm mentre nella realtà il progetto è realizzato da Desertec, un consorzio di 55 imprese internazionali, e sono già all’opera i primi appalti in Marocco e Tunisia. È recente la notizia che nel 2014 inizierà la fase operativa per queste centrali che copriranno l’Africa del nord con una rete di 825 mila eliostati.
Ed eccoci finalmente allo svelamento del protagonista effettivo del romanzo: certamente è il dipanarsi della trama ciò che lo rende avvincente, la sua plausibilità, la definizione dei personaggi, il ritmo della narrazione, insieme ad altri fattori.
Ma è la scrittura il reale binario sul quale s’incanala l’attenzione e si accende la passione della lettura.
Ci sono stati periodi storici recenti in cui la scrittura si fermava nella cucina di un ipotetico appartamento del linguaggio, in altri nella camera da letto, in altri sostava nell’ingresso.
In questo romanzo la scrittura ritorna nel salotto buono, torna alla tradizione della tessitura testuale ricca, variopinta, densa, profonda.
È questo che il lettore avveduto chiede: scorrevolezza ma eleganza, ritmo ma corposità della parola.
Una qualità che rivela la provenienza dell’autore dai cieli di una poesia alta, da una dimestichezza con la parola, da una padronanza piena del linguaggio.
Cito a esempio la descrizione contenuta in questo brano:
- Dalla finestra vedo transitare una fila di cammelli, evanescenti sullo sfondo dell’altopiano, inconsistenti, irreali.
Qualche esemplare porta due persone, altri seggiolini vuoti. No, mi sono sbagliato, sono tutti occupati, la carovana è al completo, passa esausta e leggera.
Il minuto seguente è un filo di sabbia che si distingue dagli altri, una linea del deserto che si sfila e prende una strada sua, mettendo nell’aria l’odore aspro della pelle animale.
Il blu dei mantelli riga la sabbia nella disumana lentezza del movimento, la carovana ha tutto il modo di comporre un episodio sognato, il contrasto tra le tuniche accese e il giallo scuro delle dune tende a ricomporsi, a sedare ogni ansietà, proclamando l’unione tra silenzio e luce, viaggio ed erranza.-
È questa lingua lussuosa, misurata eppure esuberante, che fa di Sole nero un romanzo da leggere e da gustare, insieme con la indiscutibile attualità dell’argomento trattato, con la velocità del racconto. Ma è soprattutto la eleganza della parola che per il lettore esigente fa di questo percorso un luogo di ininterrotta festa.
Id: 645 Data: 09/11/2012 12:00:00
*
 Monica Martinelli - Poesia - Altrimedia edizioni
Monica Martinelli - Poesia - Altrimedia edizioni
Alterni presagi
Nella borsa valori delle parole la quotazione di presagio sembrava aver raggiunto i minimi, risalire dai quali appariva impresa ardua.
Che si riaffacci in questa raccolta di poesie di Monica Martinelli è certamente un segno dei tempi, misura di una incertezza, di una instabilità che trascende la dimensione individuale e diventa fenomeno sociale.
Il presagio è un segno dal quale si può trarre la previsione di determinati eventi futuri.
Il presagio dunque annuncia, è la vigilia di un accadimento, confina con la profezia.
Che siano alterni la dice lunga su certe altalenanti motivazioni all’origine dei versi:
Sono l’attimo saltato fuori
da una galassia di felicità..
Ma anche: ma è ancor peggio scoprire che la realtà / è più orribile del peggior incubo.
Il presagio sposa sempre l’attesa, il compimento di un evento: - Ho sempre aspettato qualcuno o qualcosa -. Nel libro di Monica l’attesa è legata a una speranza d’amore: Ho sempre sperato fossi tu / tutte le mie attese.
Sarebbe sbagliato tuttavia catalogare queste poesie nel genere di un semplice canzoniere d’amore.
Certo l’amore rappresenta una componente fondamentale nell’economia del libro, così come nell’orizzonte poetico ed esistenziale dell’autrice.
Il mio vocabolario è forse scarno – dichiara Monica in un eccesso di modestia, - ma love & passion le conosco bene -. E invece più che scarno si direbbe sobrio, sebbene l’autrice si conceda incursioni in terminologie tecniche o scientifiche, e a volte raggiunga una tessitura testuale intensa e variegata:
Profili di calanchi seguono
angoli concavi di pendii e vallate.
Sotto una pensilina trefoli
a proteggere parietarie ruvide e inerti,
come balle di paglia da refoli
trasportate in tregge fuori dimensione…
Le caratteristiche di queste poesie sono una felice semplicità espositiva, legata a una giovanile ingenuità: Vorrei condurti per mano / all’ombra di fitti cipresseti / nella speranza di prati d’erba / che portano lontano.
E tuttavia possiede uno sguardo indagatore, riesce a penetrare la durezza delle superfici apparenti fino a individuare la radice della bellezza.
La bellezza non ha meriti – Spesso non è dove si vede. Bisogna saperla scovare, scoprirla sotto un’evidenza che non appare: - forse era quella coccinella rovesciata / che tentava di ritrovare l’esatto orientamento -.
Il libro si snoda in dichiarazioni di fragilità: Fragile come guscio d’uovo/ che si frantuma / leggera come foglia sbattuta dal vento / esile come giunco spezzato dalle intemperie / troppo debole per sopravvivere.
E tuttavia appaiono interessanti tentativi in cui il linguaggio si libera dalla intrinseca gregarietà e riesce a spiccare il volo, piccoli frammenti, embrioni: - riuscirò a sbrinare i miei pensieri -, oppure, più avanti: - sgretolati in coriandoli sogni e speranze, solo rimpianti restano / a baluardo di un’età ostile -.
Ed è questa età ostile che fa da sfondo e sottende l’intero panorama dei versi, e s’ incasella in maniera precisa nel contesto che ci appartiene, parla di noi e delle nostre inquietudini:
Frenetici come pesci gli altri si muovono
Inseguono le smanie di vivere.
Io bimba autistica chiusa
nel mio mondo al quadrato
alla ricerca di un iperuranio d’occasione
germoglio di tenerezza e insanità.
Ed è esattamente questo germoglio di tenerezza a tenderci la mano dal dipanarsi dei versi e a trovare subitanea accoglienza nel cuore del lettore.
Id: 641 Data: 23/10/2012 12:00:00
*
 Narda Fattori - Poesia - Edizioni L’arcolaio
Narda Fattori - Poesia - Edizioni L’arcolaio
Le parole agre
Esistono diversi motivi per apprezzare e amare Le parole agre di Narda Fattori.
Il primo è che vi si leggono tutti i libri che l’hanno preceduto, non soltanto quelli, numerosi, che ha scritto, ma anche tutti quelli, ancor più numerosi, che ha letto, recensito, annotato nel corso della sua lunga militanza poetica.
Il pregio di tale qualità conosce un doppio versante: a un occhio smaliziato balza agli occhi la pazienza artigianale, la cura per la pulizia, per il rigore stilistico, in una parola il lavoro che sta alla base del fare poetico, che è quella tensione perenne a ricercare la parola esatta, il giusto incedere, l'angolatura perfetta, quell’impegno totale affinché il verso sprigioni per intero il suo potere seduttivo, che semplicemente significa prendere la mano del lettore e condurlo nell'esperienza della condivisione senza che scivoli via, senza che si perda: strumento di contatto, esperienza esistenziale di reciproco arricchimento.
Questa capacità del lavoro artigianale emerge dall’impasto lessicale, dalla tessitura sapiente eppure lieve in cui ogni parola trova la giusta collocazione per liberare la propria intrinseca energia.
Un’esemplare semplicità espressiva è il risultato di un lavoro intenso e costante.
Io l’apprendista non ho mai imparato
e i giorni mi sono scorsi come sassi
come profumi e calori sulla pelle
ma come si può imparare la vita
senza farsi del male senza scivolare ?
Apprendista – mi dico – e viva
per lo stupore che ancora mi prende.
L’altro versante di questa caparbia tensione e attenzione nel lavoro con le parole è offerto dall’apparente naturalezza dell’incedere, come se fosse usuale e quasi scontata la resa del verso, quel buon sapore che procede dalle parole quando vengono organizzate in maniera encomiabile:
in fretta in fretta sul frutto maturo
piccolo passero di minuta fame
quel miele in gola quel miele canta.
A volte il gesto atletico manifesta una tale naturalezza, appare talmente privo di sforzo che a molti certamente viene da pensare che non sia poi così difficile correre una maratona, tanta elegante leggerezza manifesta la falcata.
Mettere insieme un buon libro di poesie non è diverso dal correre una maratona, ci vuole la costanza di molti chilometri poetici, impegno, muscoli allungati, polmoni capienti.
Tutte qualità che in Narda si lasciano leggere controluce, nella stessa leggerezza del maratoneta.
Mi sembra che sia questo un insegnamento basilare per tutti quelli che intendono cimentarsi nella costruzione del verso.
Per vincere la resistenza delle parole, l’attrito che le avvince alla banalità del quotidiano, bisogna averci molto combattuto e lottato, e anche sofferto, nel tentativo di liberarle dalla gregarietà e restituirle lucidate al loro splendore originario.
È vero – ho cambiato voce
m’infilo sottotono annuso tracce
attendo paziente sempre più spesso
taccio.
C'è troppo rumore attorno.
Altro aspetto che rende amabile ed esemplare questo libro è la capacità di immedesimazione, l’assumere punti di vista diversi, entrare nello spirito e nella vita di molte persone.
La poesia mette in scena irrimediabilmente l’io.
Tuttavia anche l’io è un’entità modulabile, estensibile, dalle dimensioni variabili.
Qui non ci troviamo di fronte a un io che fa agire personaggi, tira fuori soggetti che reclamano una vita autonoma, attori oggettivamente individuabili.
Nella sezione intitolata Frammenti di anatomia è l’io dell’autrice che si cala in diversi panni, che si seziona secondo un procedimento anatomico e rivela le sue molte componenti.
Un metodo procedurale ben espresso nei seguenti versi:
Sono la moltitudine che niente sa del male
e si suicida spesso e con fantasia.
Così l’autrice veste i panni di figure emblematiche che raccontano l’oggi, documentano il vivere quotidiano, diventa somma di molti soggetti, multipla e irripetibile, allarga il suo io fino a ricomprendere la sconnessa, la scampata, la mentitrice, la predatrice, l’inadeguata, la svergognata, l’assassina, la bestemmiatrice, la viandante, la disperata, la ladra, l’ammalata, la precaria, e a tutte offre la voce, offre un nido alle prese con la bufera.
Sono una donna di poco pregio
neppure tanto salda nell’anima e nel sangue
attardata e troppo avanzata
insomma sempre fuori tempo fuori luogo.
Narda ci offre una visuale ampia e generosa, assume un tono partecipativo e corale, abbraccio in cui è sospeso ogni giudizio, ci regala la tensione di una poesia che comprende il destino degli uomini.
Id: 576 Data: 24/04/2012 12:00:00
*
 Fabio Franzin - Poesia - Il Vicolo - divisione libri
Fabio Franzin - Poesia - Il Vicolo - divisione libri
Canti dell’offesa
Mia madre corrisponde in maniera esatta alla descrizione delle vecchiette che nelle poesie di Fabio Franzin s’incontrano dal tabaccaio appoggiate al bancone, intente a grattare con la moneta i cartoncini del gratta e vinci.
Ostaggi del gioco, rincorrono un sogno impossibile.
Le ho letto la poesia in questione e si è riconosciuta, si è persino commossa. Poi però si è fatta seria e ha detto: - Ma non potete toglierci ANCHE questa illusione -.
Ricordo che Borges parlava di miseria che si aggrappa alle lotterie.
Abbiamo attraversato anni di feroce perdita, fondati sull’inganno, scivolati lungo un degrado senza sorprese: si sapeva che l’economia nascondeva al suo interno bolle d’insincerità, la politica ci aveva abituati a flussi di mostruosità, di comportamenti indecenti, di follie e di lampanti menzogne, senza neanche i sussulti di uno sbigottito stupore, in una colpevole assenza di pudore.
Il degrado più terribile e infamante è stato quello del comune sentire.
Nella poesia del gratta e vinci la vecchietta torna a casa, alle sue preghiere, alle pentole e all’odore di brodo, alle care fotografie che dalle mensole la guardano e sembrano dirle: - E adesso, sei contenta ? -.
Anche in queste poesie, al termine di ogni quadro il poeta sembra suggerirci: - E adesso siete / siamo contenti ? -.
Di che cosa dovremmo essere contenti? Del fatto che politici presunti autorevoli non avvertano l’enormità di vantarsi di non conoscere Mario Luzi, non avvertano la colpa della inadeguatezza, dell’approssimazione, il peso di una colossale stupidità.
Siamo contenti dei manovali stranieri, quasi sempre in nero, che volano dalle impalcature, siamo contenti dei turisti che riprendono col telefonino i cadaveri iracheni congelati dentro un camion frigo, siamo contenti dell’assurdità di quella morte, ma ancora di più dell’allegria scanzonata al cospetto della tragedia.
Questi canti dell’offesa di Fabio Franzin sono uno scossone, un brusco tentativo di risveglio.
Eccolo il disfacimento morale, i cui segni germogliano a partire dai fatti della cronaca, le violenze sessuali consumate per noia, lo straniero come capro espiatorio, gli sgomberi forzati delle baraccopoli dei nomadi, la disumanità degli ospedali, gli anziani costretti dall’indigenza a rubare nei supermercati.
Alla fine ci si chiede: - Ma era proprio così il mondo / che sognavamo ? -
E ancora: - Ma siamo proprio noi quelli là? -
Queste domande costituiscono l’atmosfera che si respira nel fluire dei versi.
Il giudizio rimane al di qua, l’invettiva è implicita, più che l’ indignazione, è lo stupore per quello che siamo diventati, è la dolorosa meraviglia di fronte all’enormità dei fatti la protagonista di queste poesie.
Leggerle è una sana scrollata, è riaprire finalmente gli occhi su una realtà che ci rivela insieme offesi e offensori.
*
Riflessioni di FABIO FRANZIN su CANTI DELL’OFFESA
Certe mie raccolte poetiche - anche poco più che plaquette come i CANTI DELL’OFFESA di cui parlo - hanno una gestazione decennale o ultradecennale; lo dico, anche in risposta ad alcuni critici che, benevolmente, mi accusano di aver pubblicato molto, negli ultimi anni: crf, ad esempio, Daniele Maria Pegorari [1].
Molto di ciò che esce ora – anche perché solo ora, dopo che proprio le opere in questione uscite mi hanno dato una certa notorietà, trovo editori disponibili, a volte addirittura su loro richiesta, a pubblicare i miei lavori -, ha una sua lunga e sofferta gestazione (nella primavera dell’anno in corso uscirà, presso Città nuova, nella collana VERSUS diretta da Daniele Piccini, la mia raccolta “Margini e rive”, parte in lingua e parte in dialetto; per dire: “Margini e rive” è un lavoro portato avanti per almeno un ventennio, fra stesure varie, revisioni, ripensamenti…); è vero altresì, che le mie raccolte “Fabrica” e “Co’e man monche” hanno avuto una gestazione rapida e compulsiva – una sorta di “presa diretta” quasi giornalistica con ciò che (mi) accadeva, e che hanno avuto la fortuna, proprio per l’aspetto voluto di testimonianza-reportage, di uscire a ridosso della loro stesura.
Nel dicembre del
Intanto, sia nei luoghi di lavoro, sia all’interno della società, avvertivo l’accrescersi di una crisi che, prima ancora sfociasse poi in economica, era già incistata all’interno della società: vuoi il regredire delle condizioni di tutela dei lavoratori stessi, vuoi certi proclami razzisti e omofobi, le tragedie dei “clandestini” del mediterraneo - diventato un vero e proprio “cimitero marino” -, o del riflettersi nei gesti e nelle abitudini di tutti noi dei messaggi subliminali della tivù, sempre più vuota, maleducata, arrogante, sempre più portata a una malsana pruderie: pensiamo all’audience cavalcato sui vari delitti insoluti, alle macabre gite nei luoghi dell’orrore; tutto ciò lo sentivo / lo sentiamo sempre più come un’offesa all’umanità; non un’indignazione, come ha giustamente rilevato un giovane critico a ridosso dell’uscita della raccolta [3], ma una vera e propria offesa.
Poi, nell’estate del 2007, avvenne il fatto tragico di Mestre; prendo dalla nota al testo in questione che ne è scaturito: Il 14 luglio 2007, nell’area di servizio Bazzera, a Mestre, da un camion-frigo tedesco che trasportava angurie, furono estratti i corpi congelati di tre clandestini iracheni. I giornali raccontarono le risa divertite dei turisti di passaggio, le foto ricordo fatte coi telefonini.
Quelle risa, quegli scatti-souvenir dei telefonini su quei poveri corpi morti, mi rimbombarono dentro come una selva di tuoni, non mi diedero più pace. In quei gesti senza cuore avvertivo un brusco scivolamento verso l’inciviltà, la barbarie. Nacque il testo “Povere statue”, che è il secondo della raccolta.
Andavo intanto maturando anche la convinzione che il poeta non potesse più limitarsi solo a scrivere dei “bei versi”, ma che dovesse ergersi a testimone della sua epoca, epoca travagliata che, secondo me, segna uno spartiacque fra la civiltà dei consumi, dell’abuso sulla natura e il paesaggio, e quella del necessario ripensamento, tanto più che si è ormai giunti, volenti o nolenti, a una sorta di resa dei conti con le istanze suddette.
Avverto il lettore di queste mie note - anche per rispetto della sua pazienza - che non continuerò a fare la cronistoria di ogni testo che compone la raccolta, ma che era necessario averlo fatto per i primi due testi per darne conto sulle origini della stessa, del tema contenuto in epigrafe del titolo.
Poi, nel 2008, partita dall’insolvenza dei mutui subprimes negli Stati Uniti, dall’infestazione cui non c’era antidoto - perché ogni banca mondiale aveva “in pancia” i suoi parassiti di carta straccia -, tutti abbiamo incominciato a fare i conti con l’offesa di un’economia non più “controllabile”, con una crisi economica che, come ogni virus, attacca per primi gli esseri più indifesi: i ceti più umili, i pensionati, le famiglie con qualche malato o portatore di handicap da assistere, i migranti che, vorrei ricordarlo per l’ennesima volta, espatriano da paesi in cui non c’è civiltà, libertà, possibilità di emergere dalla fame, non perché vogliono venire qui a insidiare le nostre indifferenti tranquillità.
Nel 2009 ho ripreso per mano appunti che avevo fermato sui miei notes da quel testo su Luzi in poi, e che per loro stessa natura, non potevano essere in dialetto, lingua con cui mi confronto da sempre, ma che, sgorgate per lenir/mi le offese quotidiane sempre più avviluppate al linguaggio televisivo, venivano fuori nella stessa lingua in cui si palesavano all’interno della società.
Non ho altro da aggiungere.
Al lettore resta da aprire la raccolta, se ne avrà voglia e benevolenza, per specchiarsi nella mia scrittura, per dare un senso ad essa e al bisogno, che tutti avvertiamo, in una realtà e in una società più giuste, meno offensive.
[1] In La letteratura postindustriale dei Trenta-Quarantenni, in “Incroci” XII n° 24, Mario Adda Editore 2011, pp. 73-77.
[2] Mario Luzi, Muore ignominiosamente la Repubblica in AL FUOCO DELLA CONTROVERSIA, Garzanri, 1978.
[3] Alberto Cellotto, “Canti dell’offesa” di Fabio Franzin: molto più dell’indignazione, in http://www.librobreve.blogspot.com/, 30 novembre 2011.
Da: Canti dell'offesa
di Fabio Franzin
Questi vostri nomi Andreas Peppe
Jordanu Emir Mailat questi nomi
sporchi di sabbia e calcina volati
da impalcature posticce il giorno
stesso dell'assunzione queste urla
perse fra putrelle e betoniere sono
il grido che resta imprigionato fra
le celle in cartongesso dei nostri
appartamenti e nelle intercapedini
le piastrelle sono lapidi che il mocio
lucida il detersivo cancella il sangue
e i nomi sudore e precariato caporali.
* * *
Oggi il kosovaro che lavora con me
mi ha chiesto se potevo imprestargli
cinquanta euro si guardava nei piedi
mentre formulava quella sua richiesta
chissà quanto a lungo meditata - lo sa
che ho due figli il mutuo per la casa
e tutto il resto - e sono sicuro sapesse
anche la mia risposta perché non se l'è
presa sì sì certo comprendo continuava
a dire scrollando la testa intanto che ci
avviavamo verso i reparti stretti i guanti
nella mano. Però io non lo riconoscevo
quello che ha dovuto dire mi dispiace
proprio quando suonava la sirena e non
c'era più tempo neanche per la vergogna.
* * *
Oh quelle vecchiette che incontro
spesso dal tabaccaio quando entro
a comprarmi le sigarette: ostaggi
del gioco lì appoggiate al bancone
tutte intente a grattare con la moneta
quegli allettanti cartoncini colorati
coi simboli della fortuna: dadi carte
da poker e segni zodiacali...le guardo:
paltò di grisaglia grigia a bottoni grossi
sformato odoroso di naftalina grigio
come i loro riccioli scarmigliati grigio
e sformato come la loro vita ormai
-anche se condita da progenie- di anni
volati in un lampo fra un ballo lento
e una sberla del marito fra uno sgorgo
di gioia e mille malanni e umiliazioni;
babbucce di feltro ai piedi calzerotti
di lana mista fatta a ferri....le guardo
dilapidare la miseria della pensione
per rincorrere un sogno impossibile
grattata dopo grattata.... le seguo poi
andar via deluse e coi loro stanchi
passi tornare all'appello con quella
realtà che le ha grattato via un altro
po' di speranza un'ulteriore patina
di vita tornare dalle pentole dalle
loro preghiere dentro quelle stanze
che sanno di brodo da quelle care
foto che sulla credenza sembrano
dirle severe “e adesso sei contenta ?”.
Id: 514 Data: 24/01/2012 12:00:00
*
 Daniele Giancane - Saggio - Genesi Editrice
Daniele Giancane - Saggio - Genesi Editrice
Scrivere poesia. Essere poeti
Un libro per gli artigiani della parola
Ecco finalmente un libro che possiede molte ragioni per appassionare un poeta o aspirante poeta, quei piccoli artigiani della parola, o volontari del verso, che fanno della scrittura poetica una passione esistenziale.
La prima ragione: è scritto in modo chiaro, comprensibile, e questo non può che essere motivo di rallegramento per i cultori della poesia, che aspirano a percorrere le strade dell’approfondimento teorico, vorrebbero ampliare il discorso, ma spesso vengono respinti da un linguaggio indecifrabile, oscuro, si direbbe cifrato, per pochi addetti.
C’è una frase di Borges, tratta dalle lezioni americane sulla poesia, a questo proposito illuminante: - Ogni volta che mi sono immerso nei testi di estetica, ho avuto la sgradevole impressione di leggere le opere di astronomi che non avessero mai osservato le stelle. Voglio dire che si trattava di scritti sulla poesia come se la poesia fosse un dovere, e non quello che in realtà è: una passione e una gioia -
Certamente il motivo di questa prima ragione si deve all’autore, Daniele Giancane, che della poesia ha fatto una passione e una gioia. Sono infatti più di quaranta anni che si occupa di poesia in maniera attiva, essendo contemporaneamente poeta, editore, direttore di una rivista di poesia, critico, saggista, docente universitario di Letteratura per l’infanzia, e soprattutto animatore culturale.
Seconda ragione: fornisce validi motivi agli appartenenti alla categoria di cui sopra, poeti, aspiranti tali, piccoli artigiani della parola, per non cedere allo sgomento, non cadere in depressione, ma anzi trovare un elenco pressoché completo di argomenti a favore della umile e solitaria attività scrittoria.
Uno: poesia è guardarsi dentro; in una società della frenesia e della superficialità in cui domina il culto dell’immagine, della esteriorità, della diffidenza e della indifferenza verso tutto ciò che è fine, spirituale, impegnato, mi pare che si debba andare controcorrente e invece esaltare i valori dell’entrare in se stessi, della forza della meditazione, della lentezza che aiuta a star bene con se stessi.
Due: poesia è osservare il mondo; osservare il reale quotidiano vuol dire elevarlo a una sorta di miracolo che si concretizza davanti ai nostri occhi.
Tre: poesia è inevitabile tensione etica. Scrivere poesia vuol dire abituarsi al superamento di razzismi, pregiudizi, ideologismi.
Quattro: scrivere poesia vuol dire fare emergere le emozioni. Se esprimere emozioni è un’operazione importante, c’è forse uno strumento più utile allo scopo della poesia?
Cinque: scrivere poesia vuol dire entrare in relazione. Ogni autore scrive per essere letto, per entrare in dialogo col lettore, per costruire un ponte tra sé e l’altro da sé.
Sei: la poesia è linguaggio in festa; viene esaltata la polisemia, le molte dimensioni del senso.
Il libro si compone di sei brevi saggi sull’esperienza della poesia, alcuni occasionati da un corso condotto all’interno del carcere di massima sicurezza di Trani, altri da corsi di scrittura creativa tenuti all’interno di scuole di vario ordine e grado.
Poiché poche cose sono contagiose come la passione, è una lettura che appassiona fin dalle prime pagine, avvince come un racconto, e in effetti si tratta del racconto della propria vocazione a scrivere.
- Dobbiamo partire da una certezza: in un universo omologato, artificiale, schematico, economico quale quello attuale, scrivere è un atto rivoluzionario. Il poeta, di qualsiasi livello estetico sia, in ogni caso compie un’operazione contro, un’azione di recupero della propria soggettività, della propria identità. Manifesta la sua esistenza in un mondo che ci vuole numeri, segni, compratori. -
Da questa lettura il piccolo artigiano della parola esce confortato e motivato, corroborato nel suo impegno da aspetti a cui non aveva mai pensato.
Certo, viene da riflettere sulle conseguenze operative dell’atto rivoluzionario, sugli esiti effettivi, specialmente se si considera che spesso il povero volontario del verso viene irretito da un cospicuo numero di case editrici che in cambio di duemila euro circa, in media, vendono l’illusione di entrare a far parte per sempre dell’esercito dei poeti.
C’è anche un altro aspetto, positivo però: questa massa considerevole di artigiani della parola si cimenta quotidianamente in furibondi corpo a corpo con il linguaggio, e questa lotta ne fa dei frullatori del linguaggio, dei volontari che lo rivitalizzano, lo smuovono, lo tengono in vita, e noi, che ci cibiamo soprattutto di aria e di parole, dovremmo essere grati a questi volontari del verso che iniettano ossigeno nella lingua che usiamo tutti i giorni e ci mostrano che la creatività, che la poesia, distruggendo la banalità del linguaggio, sollecitano modi di vivere più umani.
Id: 464 Data: 19/08/2011 12:00:00
*
 Anna Raffaella Belpiede - Poesia - LietoColle
Anna Raffaella Belpiede - Poesia - LietoColle
L’amare delle donne
Con l'Amare delle donne, edito da LietoColle, Anna Raffaella Belpiede traccia le coordinate di una mappa autobiografica in cui delimita il perimetro degli affetti, una circumnavigazione in mare aperto dei sentimenti, dei legami, delle vicissitudini, condotta con apprezzabile coraggio e invidiabile sincerità.
Vi sono riportate le tappe salienti di una vita, gli incontri e le partenze, mentre in controluce si stagliano le passioni intellettuali, l'impegno civile.
Il libro si apre con una prefazione poetica, versi dedicati al padre, un padre – amato, rimosso, quasi odiato – secondo la definizione dell'autrice, testimonianza delle lacerazioni contenute all'interno di culture contrapposte o comunque in movimento.
Più avanti dichiara:
vengo da terre lontane, da antichi
fardelli, conosco la tortura dei santi...
I versi di queste poesie manifestano, già dal titolo della raccolta, una partecipazione attiva, una fase sempre dinamica, in movimento, un'azione radiante, che sortiscono come effetto immediato il coinvolgimento del lettore.
Così ci si appassiona subito al racconto della scoperta dell'amore:
...l'annientamento amoroso, e
un tempo colmo d'incontri.
E la scoperta dolorosa della violenza della morte, e una disperata solitudine, e tuttavia:
Sono rimasta aggrappata a questa vita
con ciò che mi hai lasciato.
La lettura risulta appassionante fin dall'inizio, il dettato poetico non è mediato da alcun artificio letterario, l'andamento dei testi è diretto, scandito da una lingua concreta, ispirata alla praticità del discorso, finalizzata a contagiare il lettore, a invischiarlo nella stessa trama passionale da cui muove l'autrice.
Risultano apprezzabili la sincerità e il coraggio di mettersi a nudo, che nella poesia - Io - raggiungono un apice di consapevolezza:
Doppia, multipla,attraversata
da moltitudini caotiche, passionaria
attaccata alla terra per non disperdermi
l'anima spinge per uscire dal corpo
per sbattermi su non so quali moli.
E tuttavia la stella polare di queste poesie rimane un ostinato, tenace, pervicace attaccamento alla vita, mostrato sempre nella sua veste dinamica, partecipativa, che insieme al coraggio e alla sincerità costituiscono i tratti salienti anche della personalità dell'autrice:
Vita
Godo di ogni tua sfumatura
M'inebrio di ogni tua bellezza
Quel raggio di sole mattutino
M'irradia di desiderio
Un sorriso mi rende preziosa l'esistenza
Fanciullescamente gioiosa
Per lo spuntare di un fiore sul balcone
Ardentemente innamorata di te
Id: 451 Data: 19/07/2011 12:00:00
*
 Vera Lùcia de Oliveira - Poesia - Società Editrice Fiorentina
Vera Lùcia de Oliveira - Poesia - Società Editrice Fiorentina
La carne quando è sola
Di questo libro ha scritto Davide Rondoni sul Sole 24 ore: - Un calvario tra mormorio e grido, pudore e durezza, un'inchiesta sul morire di una persona cara. Qui, scrive il bravo studioso e poeta Alessandro Polcri, si sente “il grado zero della speranza”.
Paolo Valesio scrive nella premessa al libro: - La de Oliveira osa scrivere un canzoniere d'amore, anche se di tipo particolare, un amore coniugato con la malattia e la sofferenza, connesso ai due poli della nascita e della vecchiaia, e che si esprime a volte attraverso una soggettività maschile -.
Nel presentare i versi, Alessio Brandolini scrive: - E' una storia in versi, un flusso intensissimo di grumi narrativi che tracciano un mondo particolare, con i suoi luoghi e personaggi, convinzioni e speranze. A parlare sono i tanti protagonisti di queste vicende, con le loro paure e manie, uomini e donne, anziani e malati. Non si sa di che parte del pianeta, in che tempo storico. -
L'intera raccolta muove da una domanda: cosa si sa del dolore ?
E ogni singola voce ne individua una personale declinazione, ne illumina una sfaccettatura, la pone dalla sua ristretta angolazione.
Ne deriva una coralità drammatica, una moltitudine di piccole voci ognuna impigliata dentro una privata sofferenza.
La poesia sottolinea l'umanità di queste voci, la comune appartenenza, l'identico mondo all'interno del quale ci muoviamo, quella che spinge a dire:
quanto era bello il mare azzurro d'estate il vento
fra i corridoi il bianco nelle case illuminate dal sole
poi ho visto le cose sformarsi e mettersi a soffrire
come se si fossero pentite della loro felicità
Si rinnova l'accorata delusione che sorge dalla constatazione del dolore, la necessità di affrontare il mondo armati di corazza, la paura scoperta da bambini che non ci abbandona crescendo:
ma l'anima aveva paura di tutto e tutto era
pronto a ferirla.
Sorgente di dolore si scopre anche l'amore: - perché Dio me l'avrà messo nel cuore ? -
Il dolore dei vecchi: il dolore di non poter
più essere amati...
e quello dell'attesa: aveva atteso per ore
il telefono non aveva suonato...
Come scrive Vincenzo Guarracino a proposito di una precedente raccolta: - Ci troviamo di fronte a una concezione molto personale del valore catartico e salvifico del linguaggio, di un linguaggio proteso sull'abisso e tutto fatto di parole minuscole, di dimessa quotidianità e devozione al male luminoso della vita, al deposito buio capace di tramutarsi in flusso di canto. -
il poeta Sandro Penna
girava per le strade alla ricerca di Dio
annusava ogni cosa guardava
era capace di vedere quello
che gli altri non vedevano
che colpa ha avuto alla fine
se Dio aveva deciso di nascondersi
nei corpi di quei poveretti infelici
quell'Ernesto ebreo mandato
a morire ad Auschwitz ?
Id: 449 Data: 01/07/2011 12:00:00