chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Timothy Megaride
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
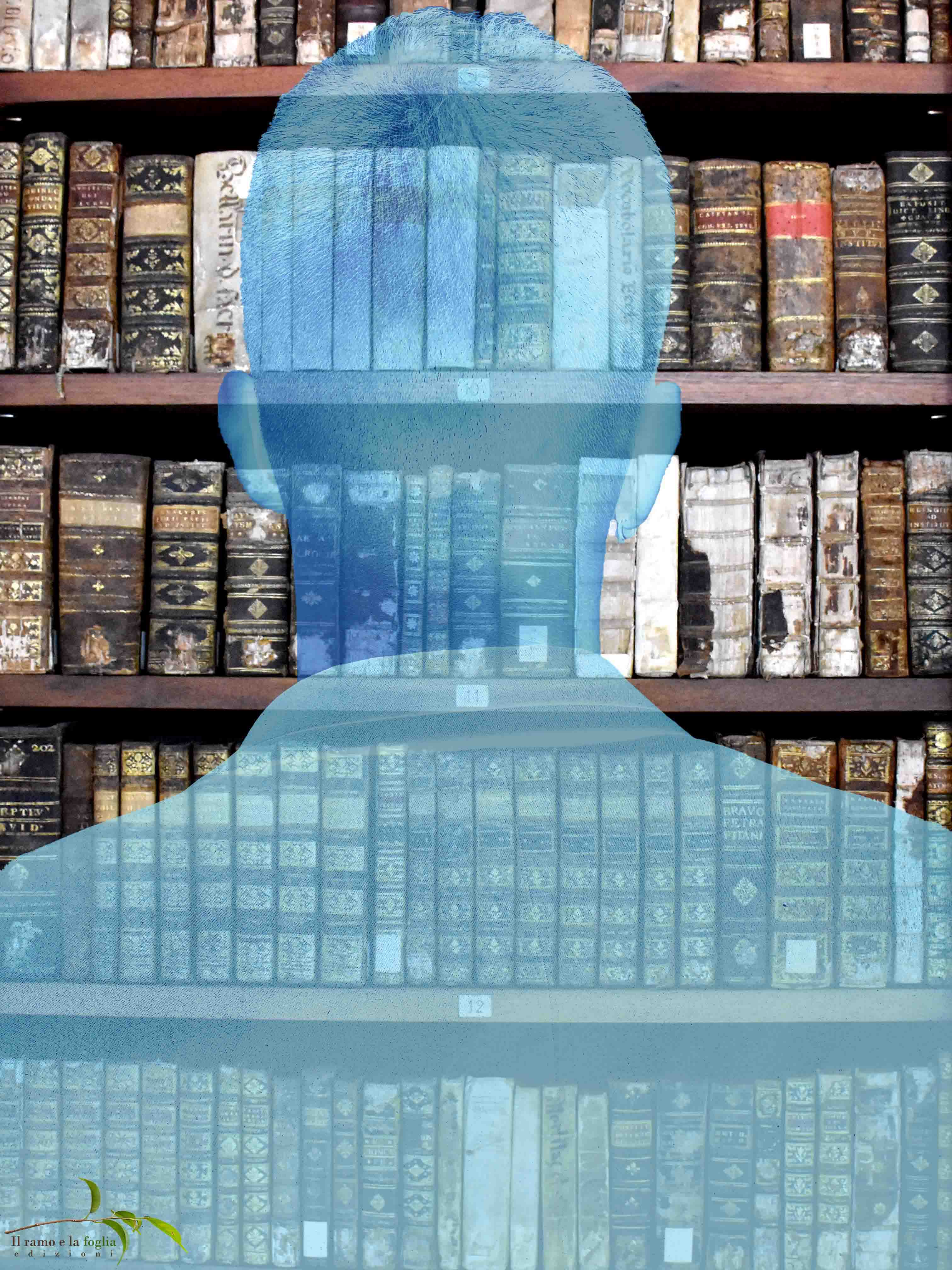
*
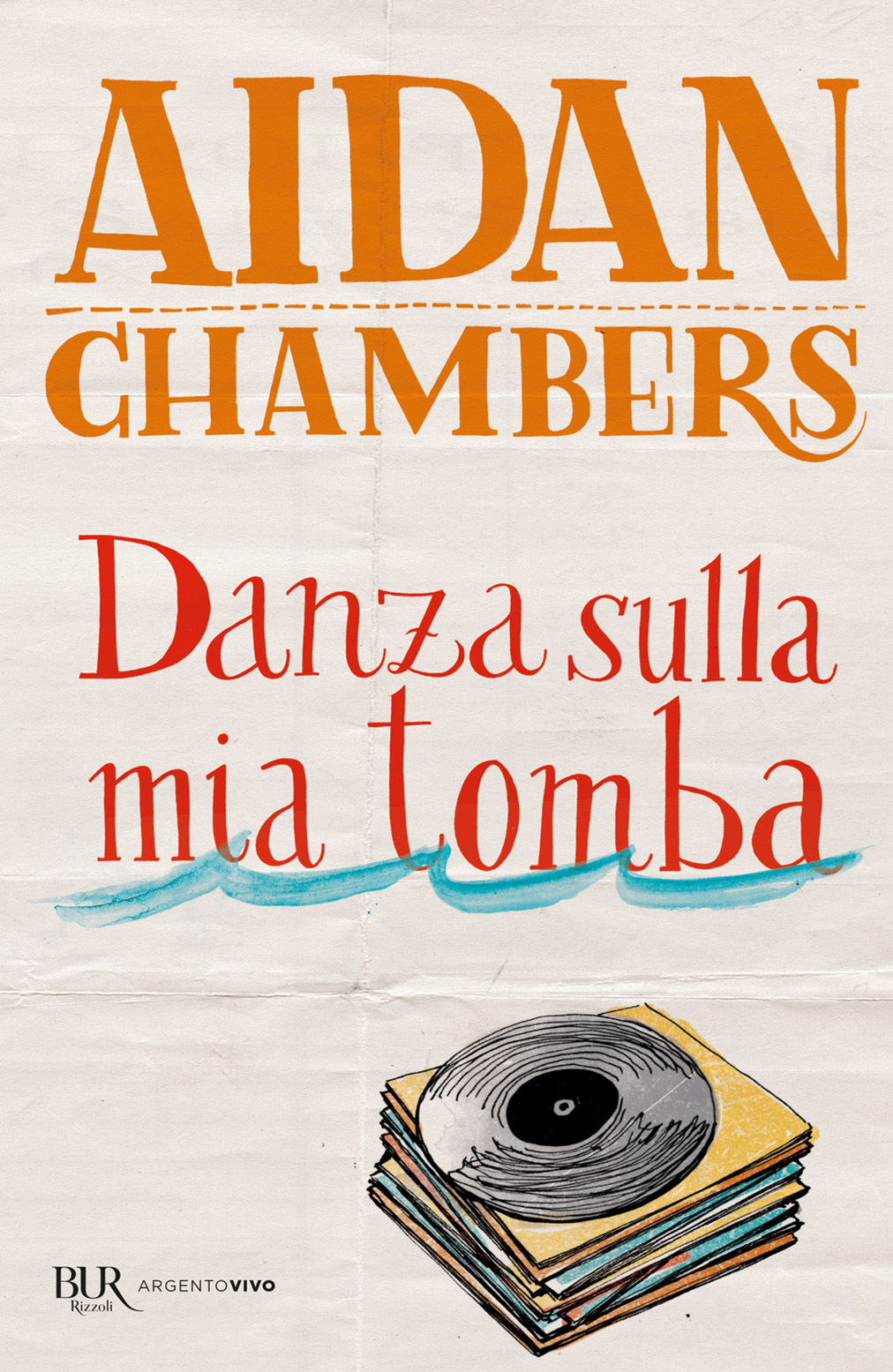 Aidan Chambers - Romanzo - BUR
Aidan Chambers - Romanzo - BUR
Danza sulla mia tomba
L’organo più esteso del nostro corpo è la pelle, il confine che ci separa dal resto del mondo, ma anche il primo rudimentale ponte che ad esso ci congiunge. È l’ampio sensore attraverso il quale il mondo penetra dentro di noi e ci fa sapere di esistere. L’oggetto invade il soggetto a colpi di stimoli. Prima che ci vengano in soccorso altri recettori (vista, udito, olfatto, gusto), la pelle legge gli stimoli e li classifica in maniera manichea: caldo-freddo, gradevole-sgradevole, bello-brutto, buono cattivo. Introietta le percezioni, le immagazzina in un angoletto della memoria e ne fa il primitivo metro di valutazione dell’oltreconfine, dell’altro da noi. È così che conosciamo lo straniero, “a pelle”, e lo giudichiamo, lo includiamo come “amico per la pelle” o lo respingiamo come avversario.
Queste forme rudimentali di conoscenza e di giudizio sono tipiche dell’infanzia e dell’adolescenza, sia pure con qualche differenza di rilievo tra le due stagioni della vita. Nel primo caso gli ormoni interferiscono marginalmente, nel secondo sostanzialmente.
Quando tu cresci in un ambiente protetto, non fai a botte coi coetanei e non pratichi uno sport agonistico accade che l’imprinting della pelle sia l’unica chiave di lettura della realtà fenomenica (che peraltro non vedi). Sei categorico e intransigente nelle tue aspettative, non osservi il fenomeno, cerchi il noumeno dentro il quale ti crogioli e ti bei, fino ai sedici anni e passa, quando cioè i sogni bagnati aggiungono ulteriori improbabili connotazioni al tuo amico ideale.
Questo io desumo (e penso faccia qualsiasi altro lettore attento) dal bellissimo romanzo di Aidan Chambers, Danza sulla mia tomba. Suggerisco vivamente ai pochi lettori di queste note di leggere, ove mai non l’abbiano già fatto, questo straordinario Bildungsroman per nulla inferiore alle analoghe produzioni artistiche di Mark Twain, Kurt Vonnegut, Jerome David Salinger, scrittori ai quali Chambers rende esplicito omaggio, sia pure servendosi del dire partigiano dell’io narrante nonché protagonista della storia.
Il giorno del loro primo incontro Henry (Hal) vede nella camera di Barry la riproduzione di un dipinto di David Hockney, Peter che esce dalla piscina di Nick. Il ragazzo conosce il pittore, lo apprezza per il nitore dello stile, ma non manca di manifestare qualche riserva. È palese il carattere prolettico delle sue osservazioni. Solo alla fine del lungo resoconto a due voci noi udremo dalla bocca di Kari il disvelamento dell’errore di prospettiva. Barry verrà finalmente inserito nell’universo fenomenico di cui fa parte. Chambers, in parole povere, ci dice che l’adolescenza è il breakdown dell’età evolutiva. Spetterebbe agli educatori sostenere adeguatamente il trauma della frattura, ma questo non avviene, ahimè! Si osservino attentamente i comportamenti degli educatori di questo romanzo e si capirà quanto siano inadeguati al ruolo. La terribile conseguenza di un’educazione distorta è che molti di noi restano prigionieri dell’adolescenza per tutta la vita e si rendono artefici o complici di disastri peggiori di quelli raccontati da Chambers. Occorre apprendere per tempo che le case della pubblicità di Mulino Bianco non esistono e non esisteranno mai, come non esiste la bella e linda casa di Barry. È un’illusione ottica, una messinscena non diversa dalla vetrina di un mobiliere.
Tutto parte da una composizione, come una natura morta, un po’ troppo in posa per essere la vita vera, tutto molto pulito, luminoso nitido, arioso. Mi piaceva la loro qualità cristallina, la messa a fuoco assoluta, e la sensazione che ci fosse qualcosa di elusivo, qualcosa come in agguato dietro tanta studiata casualità.
Significa che non tutto ciò che ci piace è vero. E ciò che ci piace, malauguratamente, essendo d’acchito una “questione di pelle”, è necessariamente ingannevole.
Henry ricorda che molti dipinti di Hockney sono stanze abitate, una sorta di trompe-l'œil rovesciato che consente di spiare dentro le case della gente attraverso una finestra spalancata. Cosa accade veramente in quella stanza nessuno può saperlo con certezza, ma può certamente immaginarlo. È esattamente ciò che accade al fantasioso protagonista del film di Nella casa (2012) di François Ozon, qui ricordato perché, puta caso, risulta essere sceneggiatore e regista del film Estate ‘85 (2020) liberamente tratto dal romanzo di Chambers.
Sono il film recente e la conseguente riedizione italiana del libro le ragioni per cui ne scrivo. Al di là dell’appassionante storia narrata e, direi, narrata anche bene, mi attrae una sorta di efficace sintesi del plurimillenario discorso amoroso, che è ed è sempre stato un discorso, sia nelle formulazioni poetiche-letterarie che filosofiche. In altre parole, tutto ciò che sappiamo o abbiamo appreso sull’amore è prodotto di cultura, non di natura. Chambers, attraverso la voce di Kari, ci invita a fare i conti con la nostra ferinità, che è fatta di carne e sangue, biologia, chimica e fisica. Il discorso amoroso esclude troppo spesso l’apparente brutale confronto. Se provassimo a confrontarci con ciò che realmente siamo o i sistemi educativi ci aiutassero a farlo, probabilmente ci imbatteremmo in un fenomeno e non in un improbabile noumeno. Per quanto brutale, la realtà ci renderebbe saggi perché scopriremmo che nessuno di noi è una categoria, ma un individuo unico e irripetibile. Nessun altro essere umano ha il diritto di proprietà sui nostri corpi, tanto meno sulle nostre scelte. È vero che siamo animali sociali, ma lo siamo per scopi contingenti e limitati nel tempo e, soprattutto, per libera scelta. Alcuni antichi patti stipulati dai nostri lontani antenati non hanno più ragione d’essere. Ne stipuliamo di nuovi e più funzionali ai bisogni contemporanei. Anche il patto che riteniamo il fondamento delle nostre società, cioè il matrimonio-patrimonio, non può essere regolato da antiche culture agricole-pastorali quasi del tutto scomparse, ma dalle odierne società attive e dinamiche e fortemente coinvolte in un annoso, ma affascinante dibattito che cerca di conciliare i diritti dell’individuo (liberalismo) con la necessità della pace e dell’equilibrio sociali (socialismo). Potremmo provare a discuterne?
Id: 1331 Data: 04/02/2022 12:00:00
*
 Giuseppe Catozzella - Romanzo - Mondadori
Giuseppe Catozzella - Romanzo - Mondadori
Italiana
«Il banditismo sociale e il millenarismo – le forme più primitive di riforma e di rivoluzione – storicamente vanno di pari passo».
[Eric J. Hobsbawm, I banditi]
Citazione in esergo di “Italiana”
«Bisogna pur concedere qualche cosa a quelli che sono in basso, ai presenti, a quelli che sudano il loro pane, ai miserabili. Perciò diamogli da bere le leggende, le chimere, l’immortalità, il paradiso, le stelle».
[Victor Hugo, I miserabili]
Detto questo, è pur sempre un romanzo[1]. Il dimostrativo si riferisce alle fonti documentarie che inverano il contesto nel quale la vicenda narrata si espande come un fiume in piena e consente di definire storica la narrazione. Solo Giuseppe Catozzella poteva pensare di riprendere un genere che ebbe i suoi più illustri rappresentanti nel XIX secolo e che oggi mi pare poco bazzicato, se non altro per la fatica che comporta e per la difficoltà di reperire lettori capaci di attenzione e sapienza storica. Tutti abbiamo poco tempo per riflettere, ma ne abbiamo di bastante per seguire l’avventurosa vicenda di Maria Oliverio (Ciccilla), una brigantessa calabrese che sembra abbia dato filo da torcere ai suoi segugi piemontesi negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia. Circa un ventennio di storia nazionale viene vissuto, letto e interpretato da una donna che, suo malgrado, ne fu testimone, vittima e protagonista. Catozzella le dà voce perché è compito di un romanziere dare voce a chi non ce l’ha e non l’ha mai avuta, ma anche e soprattutto per creare un mito, unico genere di narrazione capace di generare identità e speranza, speranza di libertà nella fattispecie, sia pure entro un vagheggiamento che prelude all’anarchismo libertario. Un ideale che fa di Maria Oliverio un’eroina romantica bella di fama e di sventura. La tendenza al favolistico, che è uno dei tratti della produzione letteraria dello scrittore, consentirebbe di analizzare il romanzo alla luce del funzionalismo di Propp senza tradirne lo spirito, benché il modello letterario di riferimento sia il vasto appendicismo ottocentesco che ebbe nella produzione di Alexandre Dumas una delle massime espressioni. Mi ci fa pensare il personaggio di Teresa, l’antagonista, rappresentata come una vera incarnazione del male. Il manicheismo è tipico delle semplificazioni narrative del romanzo popolare, del feuilleton che con la favola di magia ha proprio questo in comune, la tendenza a rappresentare il male come contrapposto al bene, per fini didascalici, direi, considerando il pubblico al quale è rivolto, i bambini nel caso della favola, il lettore illetterato in quello del romanzo d’appendice. La dicotomia si ripresenta puntuale in tutti i generi “popolari” della contemporaneità quali, ad esempio, le telenovele o le seguitissime serie. Ho motivi intrinseci per tal genere di argomentazione. Dalla quale deduco che Dumas sta a Robin Hood come Catozzella sta a Ciccilla. Se è vero che entrambi i personaggi ebbero un fondamento storico, è altresì vero che il loro mito rinvia alla necessità di un ragguaglio che ascolti le ragioni dei vinti e degli sconfitti. Quando gli storici non lo fanno o non lo fanno a sufficienza, perché è forse vero che la storia la scrivono sempre e soltanto i vincitori, l’empatia dello scrittore va oltre la storia ufficiale quasi a voler compiere un atto di giustizia postuma.
A costo di sembrare pedante, allargherei la visuale fino a includere una tesi apparentemente eccentrica, ma certamente degna di attenzione, se non altro perché proveniente da uno storico di sicura competenza. Alludo a due interessantissimi saggi di Eric J. Hobsbawn, I ribelli e I banditi, entrambi pubblicati in Italia da Einaudi rispettivamente nel 1966 e nel 1971. Intanto farei riflettere sulla circostanza che la presenza delle donne nelle raffazzonate armate contadine è tutt’altro che rara. Lo storico inglese ne cita un bel po’. In secondo luogo, il brigantaggio è fenomeno antico e non di esclusivo retaggio italico. Nel confrontare molteplici casi di bande armate nello spazio e nel tempo Hobsbawn elabora il concetto di “banditismo sociale” che, a mio avviso, ben descrive anche le masnade calabresi di Catozzella e di altri da lui stesso ricordati[2]. Ecco cosa scrive l’autore de Il secolo breve:
Il punto essenziale, per quanto riguarda i banditi sociali, è il fatto che essi sono fuorilegge rurali, ritenuti criminali dal signore o dall’autorità statale, ma che pure restano all’interno della società contadina e sono considerati dalla loro gente eroi, campioni, vendicatori, combattenti per la giustizia, persino capi di movimenti di liberazione e comunque uomini degni di ammirazione, aiuto e appoggio[3].
Il brigantaggio meridionale del quinquennio postunitario è delineabile esattamente in questi termini, benché occorra precisare che il movimento di liberazione di cui le bande furono espressione ebbe un carattere prepolitico e confusamente reazionario, se è vero che a sostenerlo per qualche tempo, anche e soprattutto in termini finanziari, furono gli stessi Borbone in esilio, oltre al Papato e a un nutrito gruppo di fanatici nostalgici (spagnoli, francesi, prussiani, austriaci) dell’Ancien Régime. Per combattere ci vogliono armi e munizioni in grande quantità; sarebbe poco credibile che i briganti nostrani ne possedessero a sufficienza per fronteggiare un esercito. E tuttavia non è con gli eserciti che si combattono le disuguaglianze, non è con le forze di polizia che si ripara alle promesse non mantenute, non è con le rappresaglie che si realizza la giustizia sociale. In quell’occasione, come costantemente in seguito, la politica fu latitante. I nuovi governanti ignoravano del tutto che le vaste province meridionali erano indietro di secoli, che parlavano altre lingue, che erano ben lontane dalle strade maestre del progresso e della civiltà. Non conoscevano il Sud ed hanno continuato ad ignorarne le peculiarità anche in seguito. Cristo si è fermato a Eboli fu pubblicato nell’immediato secondo dopoguerra. Quanti ne intesero la lezione e corsero ai ripari? Il cancro sociale del Meridione oggi è andato in metastasi, diffondendosi sull’intero territorio nazionale, confondendosi col resto del paese, invadendone i gangli vitali. Di che ci si lamenta?
Lo stato unitario finanziò la guerra al brigantaggio con l’oro meridionale a quanto sembra; meglio avrebbe fatto se avesse investito gli stessi denari in infrastrutture, in assetti produttivi, nella formazione di una nuova classe dirigente moderna e competente. Meglio se avesse mantenuto le promesse di Garibaldi o dato una risposta politica agli ideali di Pisacane! Non seppe farlo, non volle, non capì, a dispetto delle istanze provenienti dal meridionalismo più accreditato. I contadini del Mezzogiorno si trovarono sul groppone gli stessi “cappelli” che un tempo li avevano soggiogati, fattisi ancora più arroganti e prepotenti per essersi accortamente schierati col vincitore. «Avevi ragione, papà – afferma Maria – da noi le cose cambiano solo per non cambiare mai». È lo stesso concetto che Tancredi esprime ne Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».
I mutamenti formali, quali quelli ai quali abbiamo assistito per oltre un secolo dopo l’Unità, lasciando inalterate le società meridionali e i rapporti di potere, hanno finito con l’allontanare sempre più il Sud dallo stato unitario. Catozzella narra fatti di un lontano passato, ma fa pensare al presente. Il divario c’è ed è palese ancora oggi. Il Cristo di Carlo Levi, che meglio sarebbe chiamare istruzione di qualità, formazione professionale, cittadinanza attiva e consapevole, ancora non raggiunge vasti strati di popolazione meridionale. Le giovani eccellenze del Sud, che pure esistono e sgomitano per vedere riconosciute le loro qualità intellettuali, culturali e professionali, sono costrette a migrare, al Nord nel migliore dei casi, all’estero per lo più. Chiamano l’evenienza fuga di cervelli. Fuga! Come puoi non scappare da questo paese pachidermico di cialtroni e azzeccagarbugli? C’è da chiedersi come mai la fuga dei nostri uomini e donne migliori poco interessi al ceto politico. Semplice: troppo consapevoli dello sfascio e vittime dell’oscurantismo metodologico italico, probabilmente liberi perché esclusi ed esclusi perché intelligenti, i nostri ragazzi mai eleggerebbero legislatori e governanti ignoranti e corrotti non meno dei funzionari pubblici che ressero le sorti del Meridione fin dai decenni postrisorgimentali. Andate a verificare, uno per uno, chi sono, oggi, i funzionari pubblici che rendono un inferno le nostre vite, per incompetenza, ovviamente, per ignavia e corporativismo. Non si sono mossi di un passo dalla scartoffia. Stanno lì non perché sanno e sanno fare, ma perché portano voti ai loro referenti politici. Ancien Régime! Niente diritti (e doveri) del cittadino, ma rapporti di vassallaggio. Feudalesimo puro! Aggiungeteci campanilismo, clanismo e familismo nutricanti sangue e suolo e capirete perché l’Italia è e resta una mera espressione geografica.
Il ritornello del cambiar tutto perché tutto resti uguale sembra applicabile ad ogni fase della nostra storia nazionale. Chissà se verrà mai il giorno in cui in cui il fatto soppianti la ciancia e la cultura fecondi il giudizio. L’opera di Giuseppe Catozzella, nel complesso, oltre che in questo bel romanzo, la sua età, la sua origine, il suo vissuto sono indizi di speranza e incoraggiamento per gli sfiduciati.
[2] Catozzella riconosce il suo debito al saggio di Peppino Curcio, Ciccilla. La storia della brigantessa Maria Oliverio, del brigante Pietro Monaco e della sua comitiva, Pellegrini editore 2010. In appendice al saggio Curcio pubblica il racconto storico inedito di Alexandre Dumas, Pietro Monaco sua moglie Maria Oliverio ed i loro complici tratto dal giornale L’Indipendente, Napoli 1864. Dumas era il direttore di questo giornale.
Id: 1315 Data: 17/09/2021 12:00:00
*
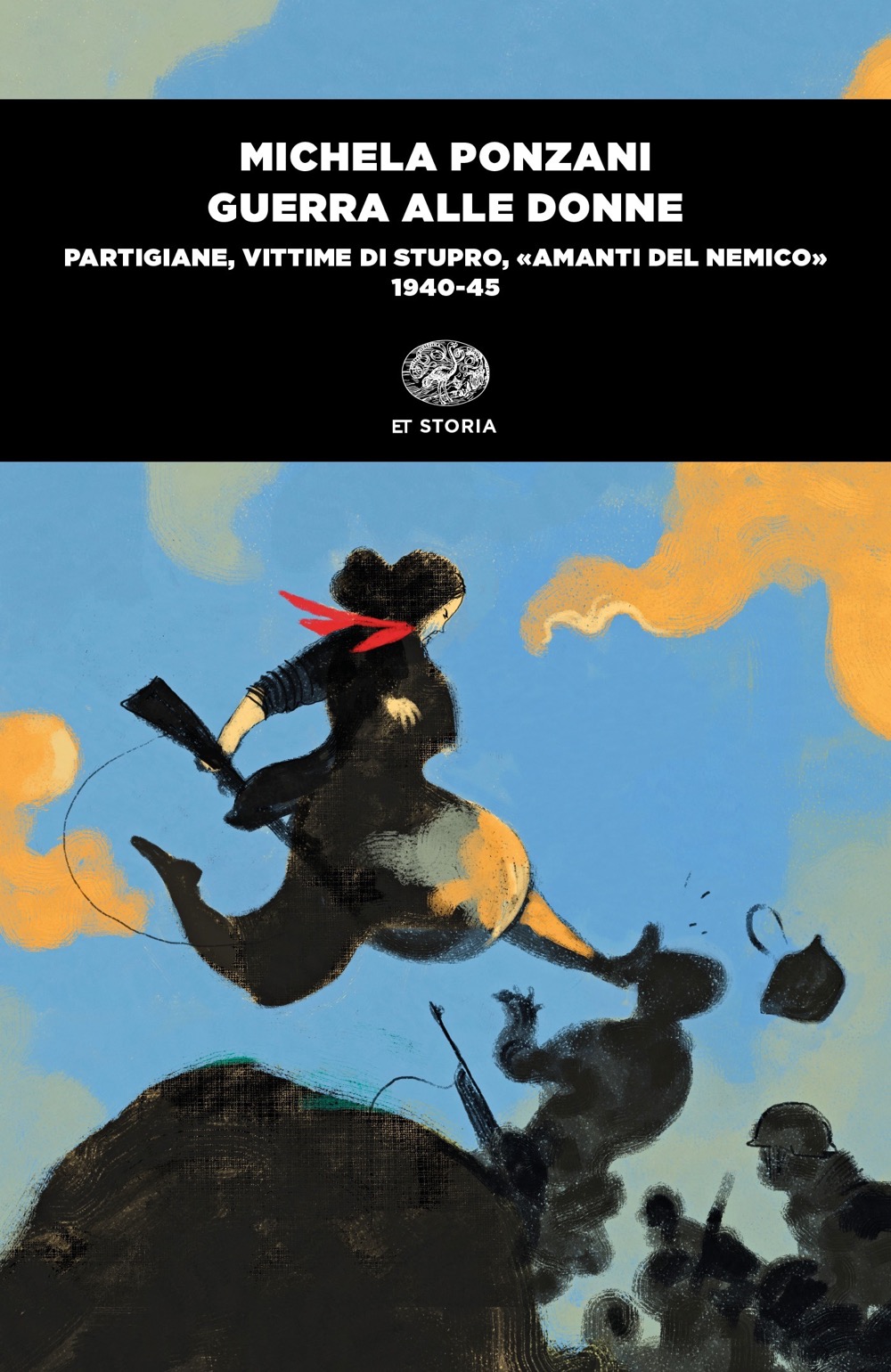 Michela Ponzani - Saggio - Einaudi
Michela Ponzani - Saggio - Einaudi
Guerra alle donne
CREDERE NON È SAPERE
Inizia da fatti relativamente recenti questa seconda edizione del saggio[1], dalle migliaia di donne bosniache di religione islamica stuprate dalle milizie serbe. Se aggiungiamo le analoghe violenze sulle donne del Kosovo, abbiamo forse chiara la tesi di fondo di questo libro, che lo stupro di massa è un ordigno bellico finalizzato a logorare non il nemico belligerante, ma la dignità di soggetti sociali non immediatamente coinvolti nel conflitto in atto. Non è la prima né l’ultima volta che il panico si abbatte sui deboli e gli indifesi. La guerra del terrore è stata già ampiamente sperimentata nel corso della Seconda guerra mondiale e, prima ancora, in quella che ne fu la prova generale, la guerra civile spagnola del 1936-39. Guernica docet.
I numerosi bombardamenti aerei che colpirono solo ed esclusivamente obiettivi civili servirono non a fiaccare l’esercito avversario, ma a demoralizzare il cittadino rimasto a casa, il più debole della catena, che si trattasse di bambini, anziani, disabili o donne. Ne morirono tanti, moltissimi altri rimasero senza casa e senza mezzi di sostentamento. La guerra del terrore prostrò certamente gli animi, ma indusse alla reazione tanti giovani e giovanissimi che, fino a poco prima, si erano tenuti lontani dalle schermaglie politiche sul conflitto in corso. Ora, ove mai non lo si fosse già fatto con cognizione di causa, anche le ultimissime generazioni sentirono il bisogno di reagire in qualche modo al massacro. Si organizzarono intorno ai nascenti nuclei resistenziali. Non era impossibile sapere da che parte schierarsi. Quando assisti ai massacri, alle torture, ai rastrellamenti, alle deportazioni, alle rappresaglie e ti vedi privato degli affetti più cari, sei indotto all’azione, per rabbia, forse per ansia di vendetta o per convinzioni politiche. Il nemico non può che essere uno: l’occupante nazista che, con la complicità dell’illegale governo repubblichino, non combatte più una guerra, ma distrugge ogni cosa che viva o che aspiri alla vita sul suolo che calpesta. Alla ferocia irrazionale, cieca, animalesca, rispondi con la lotta armata al fianco di coloro che si presentano come i liberatori, le truppe alleate. Non creiamo spartiacque, per ora, tra le forze del bene e le forze del male. Nella guerra totale è difficile individuare il discrimine esatto. È prioritario cacciare il nemico e domare i suoi complici. Alla fine del conflitto si tireranno le somme, anche se i conti non torneranno mai del tutto. Gli storici ci si adoperano ancora, quotidianamente, nel loro paziente lavoro di ricostruzione dei fatti, per accertare la verità, benché tante siano le ombre che l’oscurano, ancora l’oscurano. È per questo che Michela Ponzani scrive questo bellissimo e godibilissimo saggio, per fare luce su aspetti poco noti, se non del tutto ignoti, della Seconda guerra mondiale in Italia. Che fu anche guerra di donne e alle donne come il sottile argomentare del libro dimostra, così come fa riflettere sulla circostanza che il bene e il male non sono di esclusiva pertinenza di uno dei due belligeranti, ma abbia complesse articolazioni che possono trasformare in mostro sanguinario l’amico e in empatico protettore il nemico. Qui non si giudica per categorie o per artate, se non propagandistiche, generalizzazioni. Il microscopio della giovane storica romana punta sugli individui più che sui gruppi, pur nel tentativo di ricostruire la generale condizione della donna durante e dopo il conflitto. Le testimonianze di cui si serve sono tutte di persone reali, tutte documentate nelle copiosissime note, tutte passate al vaglio di un giudizio equanime e scrupoloso. È così che si fa storia? Sì, certamente è anche così, mettendo insieme le minute tessere di un mosaico che ancora si va componendo.
Che la donna sia figura di spicco del ventesimo secolo è innegabile, ce lo dicono persino i manuali scolastici. Non la questione femminile, evidentemente, che ha ascendenze più antiche ma che, per converso, fu retaggio di pochi gruppi isolati. Nel Novecento la donna diventa protagonista per ragioni contingenti e matura la consapevolezza del ruolo storicamente subalterno che ha sempre rivestito all’interno della società. Il valore aggiunto è che tale cognizione raggiunge, in moltissimi casi, gli strati infimi della società e promuove la rivolta pacifica che presto si chiamerà femminismo, militante nella fattispecie e che non pochi cambiamenti epocali apporterà allo sviluppo civile di vaste collettività, non uniformemente purtroppo e non sempre con risultati soddisfacenti. I diritti civili sono una conquista mai definitiva. Una volta conseguiti, occorre difenderli con le unghie e coi denti; all’orizzonte è sempre in agguato il nemico storico del progresso, la cultura patriarcale plurimillenaria che vuole il mondo fermo alla presunta creazione, a fronte di una realtà visibilmente dinamica alla quale persino il progressismo più agguerrito fatica a star dietro.
La Prima guerra mondiale rese necessario l’impiego delle donne nelle occupazioni più disparate, perfino in quelle tradizionalmente maschili. Per forza di cose. Quando i maschi sono spediti al fronte, occorre che qualcuno ne prenda il posto, per sostenere lo sforzo bellico, ma anche per garantire la necessaria produzione agricola e industriale, nonché i servizi essenziali, alla restante popolazione stanziale. La guerra la facevano i maschi abili ed entro i limiti di un circoscritto, benché crudelissimo, teatro, il fronte; non i bambini, non i vecchi, non le donne, se si escludono i necessari servizi infermieristici nelle retroguardie delle trincee. Fu questa la contingenza che rese molte donne consapevoli delle loro capacità e a spingerle a rivendicare un ruolo più attivo nella società. Non la pensavano in questo modo i fascisti, i quali tornarono a relegare le donne al ruolo di madri, custodi del focolare e degli armenti. Tutta la politica fascista marcava visibilmente la subalternità delle donne rispetto al maschio. Anche l‘istruzione restò sessista fino al quindicennio successivo alla fine del conflitto. Ma le molte donne che avevano fatto la guerra come combattenti presero a smascherare gli stereotipi di genere e a rivendicare diritti. Ora votavano, erano presenti in parlamento, potevano condurre battaglie politiche per la parità. La riforma della scuola, il divorzio, il nuovo diritto di famiglia, l’aborto, l’accesso a professioni prima loro interdette furono altrettante tappe di una lenta e progressiva emancipazione, benché ancora oggi esistano norme giuridiche retrograde che limitano le libertà e discriminano, sostenute da un’opinione pubblica retrograda e poco sensibile ai casi di violenza sulle donne, dal femminicidio alla stupro, dalle mutilazioni fisiche allo stalking, dalle discriminazioni sul posto di lavoro all’abuso sessuale. Le forze conservatrici, parte delle quali culturalmente eredi del fascismo, se non fasciste di terza e quarta generazione, sempre più arroganti per essere di fatto sostenute dalla morale primitiva che le alimenta e sostiene, ostacolano qualsiasi iter legislativo mirante alla conquista dei diritti civili e all’inclusione sociale. Inneggiano allo sviluppo, ma non sanno o non vogliono sapere che lo sviluppo è strettamente connesso al riconoscimento dei diritti, all’inclusione, alla lotta alle disuguaglianze. Le società più sviluppate e dinamiche sono quelle più inclusive e meno discriminanti. Sono più ricche e opulente perché incentivano la partecipazione e la responsabilità individuali. In tali società, quando la casa brucia, tutti collaborano a domare le fiamme perché la casa è comune e tutti ne beneficiano. La cittadinanza attiva e consapevole è diretta conseguenza dell’uguaglianza tangibile, non formale.
La tirata di correità rinvia direttamente alle ragioni della Ponzani quando analizza a fondo le umiliazioni e gli oltraggi inflitti alle donne nel corso della Seconda guerra mondiale. Le torture, le mutilazioni fisiche, le violenze carnali, le feroci uccisioni, le deportazioni nei lager nazisti non sono memoria genetica della ferinità ancestrale. No, nessun animale inveisce tanto barbaramente sulle sue prede! La violenza maschile durante la guerra fu frutto di una deliberazione politica che mirava a sottomettere, a soggiogare, a umiliare, a cancellare l’umanità delle vittime. E non fu neppure solo opera degli accertati avversari, ma anche degli amici, dei liberatori, come dimostrano le cosiddette marocchinate, delle quali furono vittime molte donne del basso Lazio e della Toscana. Alberto Moravia, nel 1957, ce ne lasciò una cocente memoria nel celebrato romanzo La ciociara, libro dal quale Vittorio De Sica, nel 1960, trasse il non meno acclamato omonimo film. Infine, alcuna indulgenza fu mostrata alle donne che, per indigenza, per l’impellente necessità di portare a casa un tozzo di pane, ma anche per mero conforto personale se non per amore, si diedero al nemico. Su di loro si abbatté feroce la condanna sociale, senza che nessuno si interrogasse sulle condizioni pregresse o sullo stato d’animo delle supposte fedifraghe.
In Italia non ci fu alcuna Norimberga. Fu un male e un errore storico. La maggioranza dei criminali di guerra non fu mai processata, in nome di un perdonismo generalizzato e certamente di matrice cattolica che anteponeva la morale alla giustizia. La nascente repubblica fu laica solo sulla carta; la circostanza che fosse retta prevalentemente dagli uomini ci dice di quanti pregiudizi si alimentasse la classe dirigente. I pochi processi tenutisi per risarcire le vittime delle violenze belliche, le donne nella fattispecie, furono celebrati da uomini (le donne non avevano ancora accesso alla magistratura). I giudizi furono pesantemente condizionati dall’imperante morale cattolica che prevede la mortificazione dei corpi quale emblema del sacrificio di Cristo. Balle, balle colossali! La mortificazione della carne serve solo a creare schiavi, non uomini liberi. Un corpo sano, ben nutrito, bene appagato nei legittimi desideri, ivi compresa una sana e appagante sessualità, è ben più giovevole al benessere personale e sociale. Le frustrazioni derivanti dalle violenze subite generano individui scarsamente o per nulla inclini alla cooperazione e alla partecipazione, segnatamente quando nessuna giustizia è resa loro da chi avrebbe il dovere di realizzarla. Le umiliazioni esacerbano gli animi.
Anche le procedure per il riconoscimento alle donne del prezioso contributo dato alla Resistenza furono farraginose e non prive di sperequazioni. In questo caso se ne voleva sminuire il valore, pur di negare il loro diritto alla parità.
Guerra alle donne è un libro che non si esaurisce nelle poche parole qui spese per dirne. Occorre leggerlo e farlo leggere, soprattutto ai giovani, che spesso non sanno e sparano sentenze senza sapere. I ragazzi non sanno quanto le bisnonne hanno dato per il loro presente benessere. Occorrerebbe dirglielo.
Scrivo in costanza di eventi internazionali che mi sconvolgono, mantenendo viva la memoria di ciò che accadde circa un ventennio fa. I Talebani riprendono il potere in Afghanistan. La produzione letteraria asiatica[2], spesso eco di un’incalzante cronaca, ce lo disse: vittime di soprusi e violenze furono soprattutto donne e bambini. Cos’accadrà ora, se a reggere le sorti di quel popolo sarà ancora la sharia? Come si possono governare intere popolazioni in nome di supposte norme dedotte da un testo religioso prodotto circa 1400 anni fa da un popolo di pastori nomadi ai margini della storia? Come supporci fermi al presunto atto creativo e rappresentarci prigionieri di un’immutabile condizione primigenia? Quale divinità sanguinaria predica l’umiliazione dei suoi figli o, ciò che è peggio, l’odio irredimibile tra i popoli? Quale Dio ordina la fitna e il jihad? Quale padre vorrebbe dare sofferenze e umiliazioni ai figli che egli stesso ha generato? Lo so, parlo dalla condizione privilegiata di un occidentale di buona cultura; che sa che è suo dovere supremo tener separate politica e religione e che il suprematismo maschile, etnico, razziale o religioso è una fede priva di riscontro nella realtà fattuale. Credere non è sapere. Sapere spesso non conviene a chi manda avanti la baracca, richiede solida volontà e sane intenzioni.
[2] Penso a Atiq Rahimi (afghano), Khaled Hosseini (afghano), Mohsin Hamid (pakistano), oppure al loro più anziano precursore, Salman Rushdie (indiano), intellettuali di fede islamica non fondamentalisti. Tradotti in molte lingue, ci hanno fatto conoscere un mondo spesso ignoto agli occidentali. Gliene siamo grati.
Id: 1314 Data: 03/09/2021 12:00:00
*
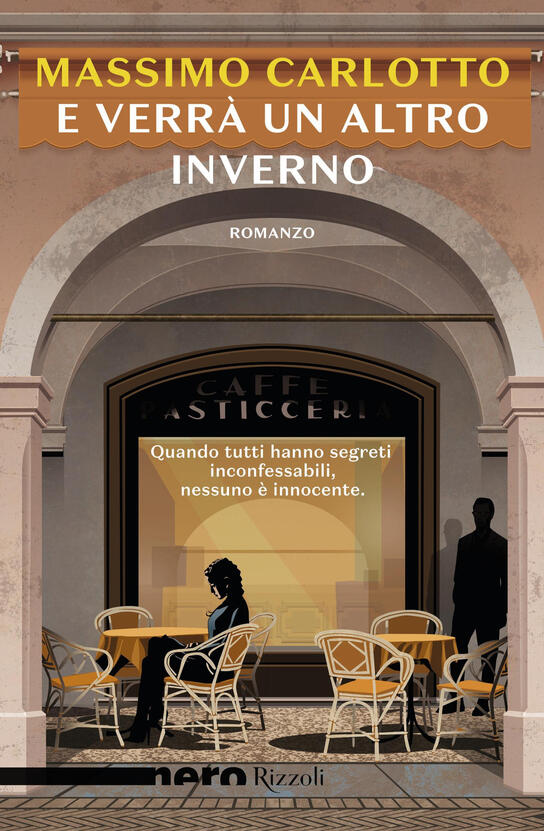 Massimo Carlotto - Romanzo - Rizzoli
Massimo Carlotto - Romanzo - Rizzoli
E verrà un altro inverno
L’ANIMA NERA D’ITALIA
«… la percezione che la morte non sia nulla,
che sia un accidente della vita,
una caccola rappresa nel naso,
è in principal modo dei criminali,
di coloro che privano gli altri dell’esistenza con serenità».
[Giuseppe Catozzella, Alveare]
Mi piace il cinema e un po’ lo conosco, senza la presunzione di esserne esperto. Così per me l’associazione è stata immediata. Signore e Signori, ho pensato, il bel film di Pietro Germi del 1965 potrebbe essere la falsariga di “E verrà un altro inverno” di Massimo Carlotto[1]. Il film di Germi era ambientato in un’imprecisata cittadina veneta; il romanzo di Carlotto ha come scenario una valle, una delle tante prealpine che preannunciano note e bazzicate località turistiche di montagna, una valle tranquilla e poco frequentata dalla marmaglia di ogni tipo.
Non serve il dove in entrambi i casi. Serve certamente il quando. E il quando, i nostri giorni, traduce la satira di costume in un hard boiled all’italiana. Gli investigatori, ammesso che si possa chiamarli tali, sono dei balordi; crimini efferati sono compiuti da cialtroni rosi dall’invidia e dal rancore. I delitti non hanno alcun senso.
Il microcosmo messo in vetrina è in realtà il macrocosmo della vasta provincia italiana, non tanto in senso geografico quanto in termini antropologici, quasi che l’autore abbia voluto rappresentare prototipi più che personaggi. I quali, tutti, sembrano marionette o, per adeguarci ai tempi, dei robot agiti da un diagramma di flusso che non lascia adito all’improvvisazione, all’imprevedibilità. Ne emerge il quadro di un’Italietta ben più e ben oltre la mediocrità; l’italiano medio vi appare, a tutti i livelli sociali, come un potenziale criminale vincolato ai dettami di un familismo amorale irredimibile e irredento. Tutto questo nel terzo millennio. Catozzella innestato su Germi, mi vien da dire con un buon margine di approssimazione. Localismo e familismo in felice connubio.
In siffatta cerchia la verità, ovviamente, non esiste, neppure quella giudiziaria, i soliti pregiudizi collettivi determinano il giudicato, i processi sono tenuti sulla pubblica piazza, le cui sentenze, ovviamente pilotate da dozzinali regie, sono inappellabili e inappellate. Il dibattito corrente sui temi della giustizia che vede apparentemente contrapposti giustizialismo e garantismo è in realtà farsesco perché serve contemporaneamente entrambe le cause, a seconda del momento e delle circostanze.
Siamo tutti prigionieri della “valle” e tutti convinti che i panni sporchi si lavino in famiglia. Così il povero imprenditore Bruno Manera (che presumibilmente si muove nell’ambito della legalità), per il semplice motivo di provenire dalla città, diventa, nell’opinione collettiva, uno che ha qualcosa di torbido da nascondere e viene estromesso dalla collettività prima ancora di essersi ambientato. Si vedrà come. La xenofobia è regola da non violare, a meno che non comporti vantaggi economici. Va bene che arrivino i romeni da sfruttare per le loro professionalità o i negri perché costano poco e puoi mandarli agevolmente via quando non servono più, non va bene la presenza dei “terroni”, salvo che non si tratti di rappresentanti delle istituzioni che abbiano sposato una valligiana, come nel caso del comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo capo Piscopo, l’opinionista ufficiale della comunità.
La pratica dell’endogamia produce ovviamente aberrazioni umane quali Michi e Robi Vardenega che, … Come i loro coetanei frequentavano i bar, giocavano a biliardo e partivano in comitiva per andare a scopare le nigeriane che battevano alla periferia della città … ; non è loro da meno la guardia giurata Manlio Giavazzi, sebbene inizialmente appaia più scaltro e dia l’impressione di condurre il gioco; costui è altrettanto sfigato quanto Stefano Clerici, consulente finanziario della filiale locale di una banca, comunque impiegato e dunque subalterno, oltre che scapolo ambito dalle zitellone del luogo, a meno che non sia un culattone come la voce comune non tarda a bollare gli scapoli impenitenti.
Non so spiegarmi perché Carlotto rappresenti alcuni personaggi, anche femminili, come dotati di un certo sex appeal. Io sono stato nella valle del romanzo e vi assicuro che i mostriciattoli dei film horror sono molto più carini. I valligiani non sanno che un po’ di sangue esotico migliora, e spesso di parecchio, la specie, anche in termini estetici. Pare che esogamia e genetica siano parole estranee al vocabolario valligiano.
Ovviamente i terroni sono tutti mafiosi; il che in parte è vero, ma molto in parte, credete! La circostanza mi fa porre un quesito inquietante: perché gli industriali della zona che sfruttano, inquinano ed evadono le imposte a man bassa si servono di un noto penalista romano per le grane in cui si impegolano? Non sarà costui uno dei famigerati colletti bianchi della mafia? Boh!
Mi sento di affermare che il libro di Carlotto denigri abbastanza ‘l giardin de lo ‘mperio perché mi ci metta anch’io. È decisamente aberrante la rappresentazione che ce ne offre, ben distante dall’idillio nel quale, per scarsa memoria o per quieto vivere, vogliamo credere. Abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo l’arte. Che pretendiamo di più? Il nostro è il migliore dei paesi possibili. Me ne convinco quando leggo i giornali, che spesso riferiscono con precisione maniacale ciò che accade nella valle di Carlotto. Qualche esempio.
Porto Cervo, luglio 2019: in una villa del luogo pare che una ragazza sia stata stuprata da quattro giovani rampolli della famiglia Pesenti. Si sono ripresi col pisellino da fuori per documentare la loro presunta bravata. La famiglia Pesenti, notoriamente giustizialista, invoca il garantismo. Pubblicamente e con un video commovente. Si sa che i maggiorenti adorano le telecamere. Come dite? Potrei essere stato io l’autore del presunto stupro? Suvvia, che vi salta in mente! Io mica ce l’ho la villa in Costa Smeralda. Tutt’al più potrei montare la mia tendina canadese sul Lido di Ostia. Poi verrebbe la polizia e mi denuncerebbe per occupazione di suolo pubblico. Meglio evitare. Le multe sono salate.
Dalmine (Bergamo), 2 gennaio 2021: Francesco Colleoni, 34 anni, ammazza suo padre, ex assessore provinciale leghista, nel cortile del ristorante che gestisce; mette tutto a soqquadro per simulare una rapina che non c’è mai stata. Voci immediate: sarà stato qualche immigrato della zona. Il maresciallo capo Piscopo ne è convinto.
Monteveglio, municipalità di Valsamoggia (Bologna), 27 giungo 2021: Chiara Gualzetti, una ragazzina di quindici anni, è uccisa a coltellate da un coetaneo, più o meno. Era un suo amico. Pare che l’assassino si sia lamentato della lenta morte della ragazza. Non è mica facile ammazzare qualcuno, così, senza un motivo apparente, giusto per divertirsi un poco. Pare che l’assassino sia un valligiano; qualcuno suppone che si tratti del fratello minore di Robi Vardenega.
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 6 aprile 2020: un nutrito gruppo di guardie carcerarie, inscenando una perquisizione straordinaria, infligge un violentissimo pestaggio ai detenuti del carcere locale. Hanno osato protestare, sia pure energicamente, per le scarse misure di protezione dal contagio da coronavirus. Gli esecutori materiali del pestaggio vengono tutti dalla nobile scuola di Robi Vardenega, anche se i mandanti potrebbero essere esponenti della famiglia Pesenti, la quale, per l’occasione, ha cessato di essere garantista ed è ritornata nell’alveo del giustizialismo. A insegnar loro a menar le mani è stato il manesco della valle, il solito maresciallo capo Piscopo.
Questi sono solo alcuni fatti recenti, probabilmente ancora presenti nella memoria dei lettori di questa nota. Tuttavia, occorre dire che la storia d’Italia è costellata di fatti analoghi se non peggiori di quelli qui ricordati. Che so, per esempio, i casi Lavorini, Braibanti, del Circeo, Emanuela Orlandi, del mostro di Firenze, Roberta Martucci, Yara Gambirasio e via discorrendo.
Ci vuole una bella fantasia per associare la cronaca “nera” d’Italia al recente romanzo di Massimo Carlotto. Qualche nostro sovranista afferma che lo scrittore padovano non alla cronaca italiana si ispiri, ma a quella locale di qualche oscura provincia russa, ungherese o polacca. L’Italia, appunto!
Bando alle cattiverie, non deve nutrire timori il lettore di Carlotto, la cui prosa è piana e godibile, a fronte di una trama avvincente e ben concepita. Insomma, per chi ama la lettura come svago, il romanzo è un eccellente passatempo, magari sotto l’ombrellone, nelle ore stanche delle lunghe giornate di vacanza balneare. I libri in sé sono innocui; la loro nocività alla pace dello spirito dipende dalla maniera in cui si leggono. I lettori maliziosi non sono tantissimi, credetemi!
Id: 1312 Data: 23/07/2021 12:00:00
*
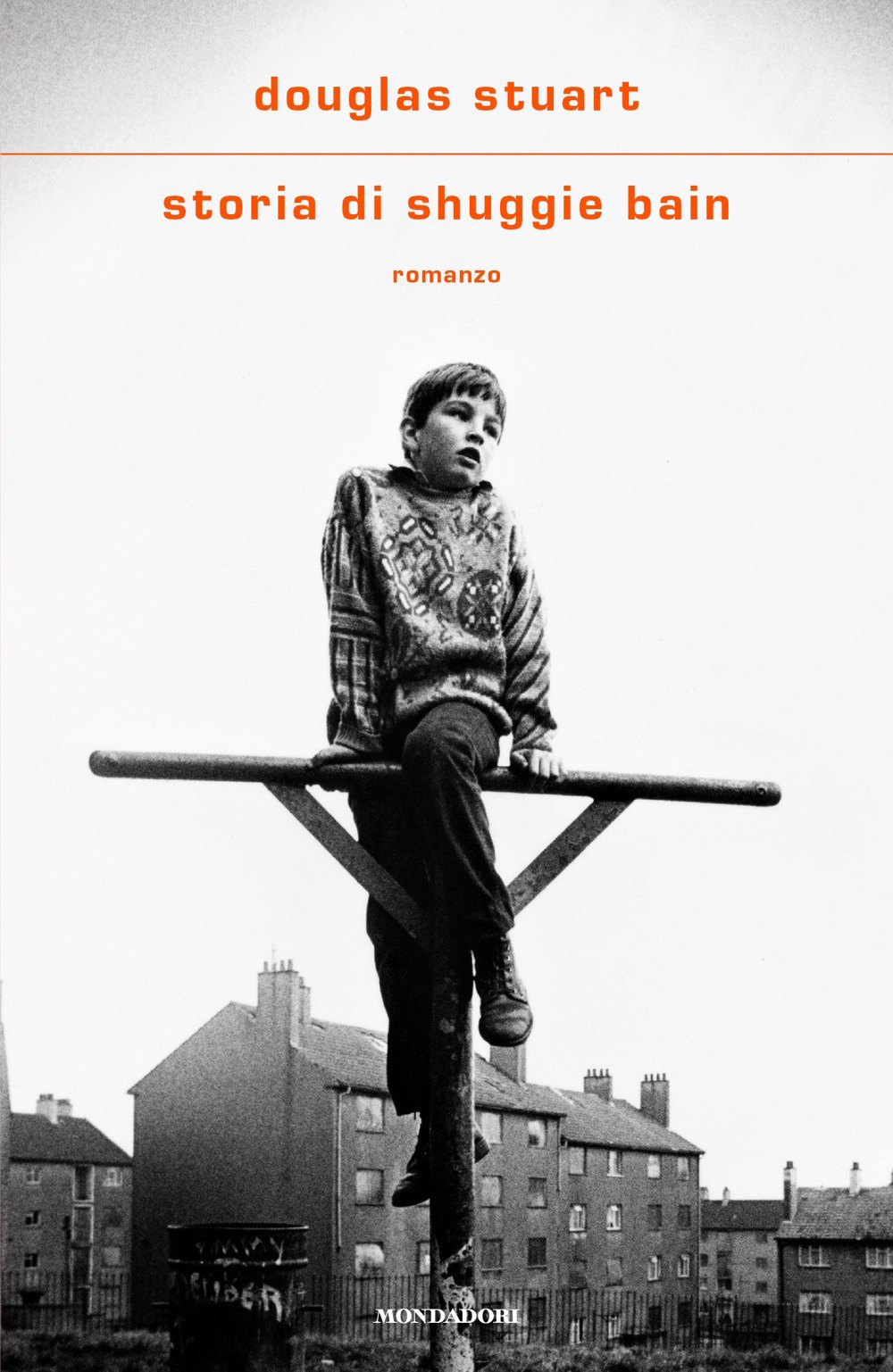 Douglas Stuart - Romanzo - Mondadori
Douglas Stuart - Romanzo - Mondadori
Storia di Shuggie Bain
SHUGGIE BAIN
Ogni tanto, senza che abbia fatto una scelta precisa e consapevole, mi imbatto in uno di quegli scrittori che definisco dickensiani. Mi colpiscono, ovviamente, perché vi riconosco le mie radici, forsanche la mia sensibilità o, se si vuole, una sorta di imprinting letterario che ha fatto di me ciò che sono. Dickens è stato il primo scrittore nel quale mi sono imbattuto, a dodici anni più o meno, perché qualcuno mi ha messo tra le mani un’edizione ridotta di Oliver Twist, ritenendomi sufficientemente maturo per affrontare un libro tutto da solo. Tardi, probabilmente. Ma la mia storia personale è storia di ritardi, per necessità, mai per scelta. Sono nato e cresciuto in un ambiente nel quale i libri semplicemente non esistevano, sillabario a parte perché la scuola primaria era obbligatoria. Quanto alla lingua, non ne avevo nessuna, eccetto il frasario stantio della miseria e della disperazione. Mi esprimevo solo coi numeri, per me era più facile.
Non si va da nessuna parte con un capitale del genere. Devo alla scuola la mia completa alfabetizzazione e l’emancipazione linguistica; beninteso non a tutta la scuola, ma solo alla sua esigua parte meno retriva, probabilmente socialisteggiante, libertaria, umanitaria, non saprei, certamente di ascendenze onestamente antifasciste. Anch’io presi a parlare come un signorino bene educato, a dispetto dei cenciosi indumenti che indossavo. Esattamente come Shuggie Bain, il protagonista del romanzo che ho appena finito di leggere[1]. E, benché anche allora si dicesse che l’abito non fa il monaco, per molti dei miei insegnanti i malconci vestiti che indossavo denotavano la classe sociale di straccioni alla quale appartenevo. Non si è mai visto un pezzente parlare come un aristocratico o scrivere, si fa per dire, come Manzoni. Lasciamo perdere. Torniamo a Shuggie Bain.
Dicevo che il suo autore, Douglas Stuart, un giovane scrittore scozzese naturalizzato statunitense, riconosce il suo debito a Dickens non solo nella scelta dei temi e nello stile, ma anche lasciandosi sfuggire dalla penna espliciti echi dickensiani. Così, en passant, compare quasi per caso Oliver Twist (un personaggio somiglia a Fagin); di lì a poco troveremo Shuggie leggere ad alta voce brani di Danny il campione del mondo, un romanzo di Roald Dahl, scrittore di libri per ragazzi di evidenti ascendenze dickensiane.
Invito a leggere, da qualsiasi fonte, la biografia di Dickens, il più noto romanziere di età vittoriana, famoso per aver lasciato alla posterità i canoni del romanzo sociale, negli stessi anni in cui il socialismo europeo muoveva i primi passi e principiava a dare speranza agli esclusi. Lo sfruttamento indiscriminato della manodopera minorile, il feroce maltrattamento dei ragazzini, la miseria morale e materiale delle plebi, la necessità di giustizia sociale sono i temi ricorrenti dei suoi grandi romanzi e poco importa che la soluzione dei mali di allora sia affidata al buon cuore o all’inopinata conversione alla bontà di questo o quell’altro filantropo; resta ferma la denuncia associata alla sensibilizzazione dei lettori più accorti, tra i quali bisogna noverare gli educatori contemporanei e di là da venire.
È servita la lezione di Dickens, a dispetto dei suoi detrattori, perché il romanzo moderno trova nuova linfa proprio a partire dai temi da lui trattati. Gli emuli, sia pure a differenti livelli di resa, hanno fatto giungere la sua lezione fino a noi, coi necessari aggiustamenti di tiro, via via che la cultura evolveva verso forme meno retrive di conoscenza. È così che Dickens perviene al suo omologo scozzese contemporaneo e l’induce a scrivere un romanzo di grande spessore e qualità artistiche. Douglas Stuart, come Dickens, mette tutto se stesso nell’opera che offre alla valutazione dei lettori e lo fa come solo sa e può fare uno scrittore di razza, cioè trasformando il vissuto in segno rappresentativo che include milioni di vite e ne canta l’affanno e l’afflato.
A parziale verifica di quanto affermo suggerirei la visione del film Every Thing Will Be Fine (2015) di Wim Wenders. La critica non ne ha detto un gran bene, ma a me è piaciuto proprio per gli aspetti didascalici coi quali lo sceneggiatore tratteggia il carattere del protagonista, un acclamato e tormentato scrittore. Sugge le vite degli altri e cerca nella memoria personale riscontri plausibili. Si costringe a rivivere le pene dei personaggi per poterne dire con sufficiente cognizione di causa. La parola con la quale scolpisce, definisce, racconta è tanto più incisiva quanto più filtrata dalla viva percezione della materia. Un estenuante lavorio di introspezione e cesello che produce il grande romanzo.
È quel che accade a Douglas Stuart quando, in affreschi di ampissimo respiro, delinea il decennio thatcheriano in una Glasgow afflitta dalla crescente disoccupazione e dall’insufficiente, se non deleteria, politica sociale dei conservatori al potere. Un disastro umanitario dalle immani conseguenze che spinge gli abitanti delle degradate periferie urbane e dei tenement al livello di precaria sopravvivenza. Droga e alcool sono la fuga prediletta di un’umanità in subordine, miserevole antidoto alla condizione subumana nella quale è relegata.
Minuziosa la caratterizzazione dei personaggi, precisa la rappresentazione degli ambienti, incalzante la narrazione, incisivi i dialoghi. C’è dentro il romanzo non solo la perizia dello scrittore, ma l’esperienza del vissuto e del sofferto, se è vero, come sembra, che dietro il protagonista della vicenda si celi l’autore medesimo.
È un romanzo ottocentesco, alla Dickens appunto, ma con la marcia in più di un personaggio a tutto tondo che agli occhi di un uomo del XIX secolo, non per negligenza, ma per vizio di sapere, non appariva nella sua palpabile evidenza. Eppure, qualcuno può ben supporre che, tra le tante vessazioni subite dalla frotta di bambini rappresentati da Dickens, potesse esserci anche l’abuso sessuale e che gli atti di “bullismo” ai danni dei più deboli altro non fossero che un patente oltraggio alla diversità. E, se né storici né cronisti hanno mai speso mezza parola per una tipologia umana sfuggente e digressiva, oggi lo fa uno scrittore, restituendoci vivido l’autentico e doloroso dramma di un ragazzino “diverso” ben oltre gli orizzonti del politically correct imposto dal perbenismo di facciata. La diversità non conosce vincoli sociali, ma è tanto più amara negli ambienti del degrado e della miseria morale, nelle periferie delle grandi città, nei casermoni costruiti con poco denaro per dare una specie di tetto ai supposti nullatenenti, negli universi inesplorati delle retrive province. L’emarginazione e le vessazioni subite sono un peso intollerabile per un bambino “solo al mondo”, certo di non avere simili con cui confrontarsi, incapace di adeguarsi ad ancestrali modelli comportamentali che lo vorrebbero altro da quello che è e che non può non essere. D’accordo, nessuno sopporta d’essere altro da sé; ma l’educazione suasiva può ben domesticare e indurre alla cieca ubbidienza, soprattutto se il tornaconto, in termini di prestigio e sicurezza, è sufficientemente allettante. E tuttavia ci sono giovani puledri che non si lasciano cavalcare; non possono, per natura non possono accettare la cavezza.
Shuggie Bain è uno di questi. Non si appassiona al tramandato derby calcistico Celtic-Rangers (una specie di storica rivalità tra cattolici e protestanti, una guerra di religione in sedicesimo), benché provi ad apprenderne le memorabili prodezze da un libriccino che gli è stato regalato a mo’ di palliativo. Non intende le scazzottate “virili” dei coetanei, non riesce a modificare postura e tono di voce. Non può, semplicemente non può. Paga per ciò che è e non può non essere. Commuove, certo che commuove, ma non smuove nessuna coscienza, neppure qui da noi, in Italia, dove ancora si discute sull’opportunità di una legge cretina che regolamenta l’ovvietà e che dovrebbe già essere nel patrimonio genetico di tutti. Pare che i giovani se ne infischino della trivialità sacrilega dei loro padri e dei loro nonni, beceri tutori d’una pedagogia arcaica e primitiva che si crogiola nel privilegio del peccato. I giovani non peccano, si ribellano all’idiozia. Saranno loro, per forza di cose, a soppiantare una classe politica degenere e bacata per statuto. Animo ragazzi, dateci dentro! Il futuro vi appartiene. Dai vostri padri e dai vostri nonni avete poco da sperare. E non mancare di leggere Storia di Shuggie Bain, anche se nessun insegnante troverà mai il coraggio di proporvelo.
Id: 1311 Data: 16/07/2021 12:00:00
*
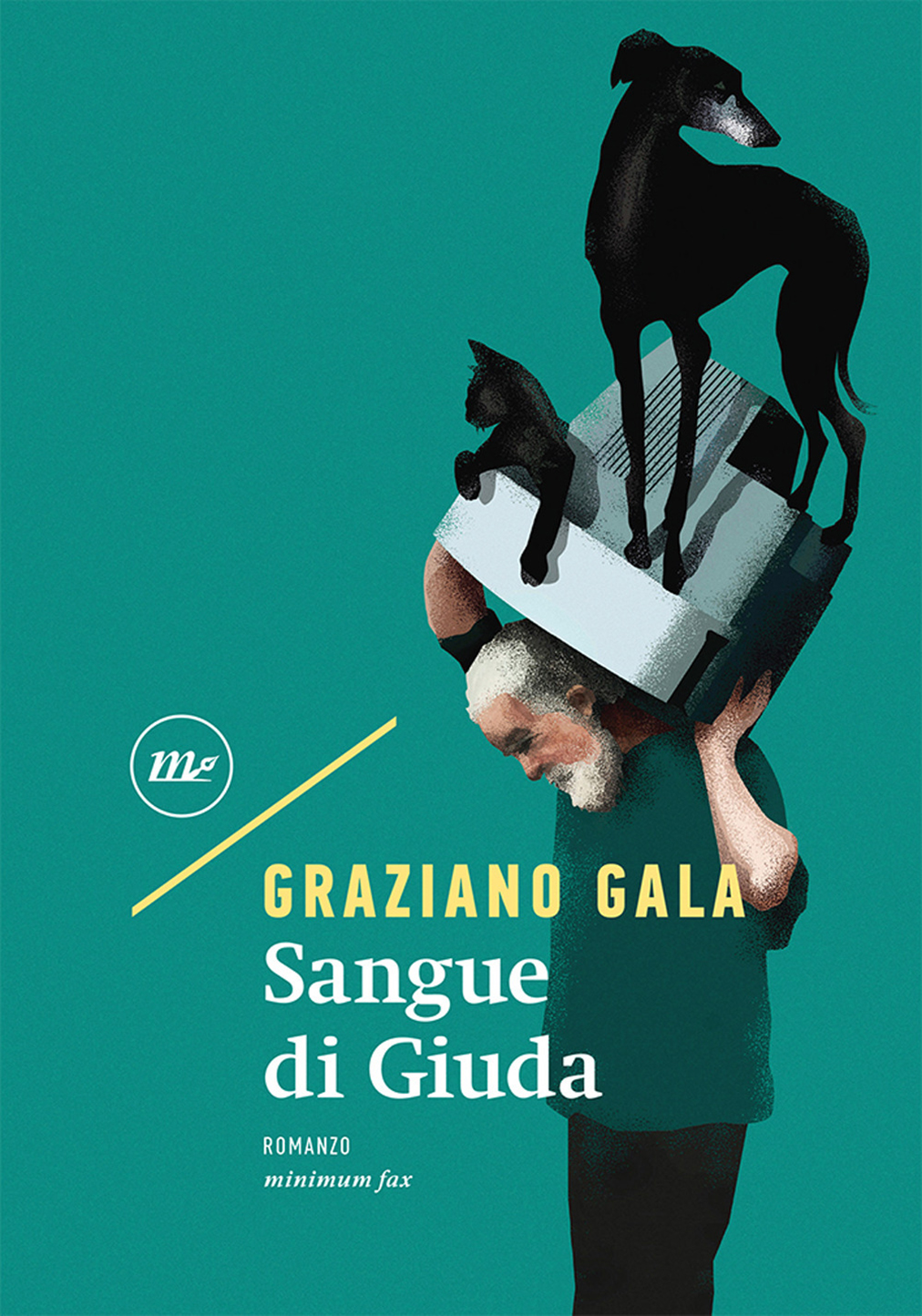 Graziano Gala - Romanzo - minimum fax
Graziano Gala - Romanzo - minimum fax
Sangue di Giuda
L’«URLO» DI GRAZIANO GALA
«Merulana, tu si’ sporca e corrotta, ma tieni nu poeta che può tornare a scrivere». Non so se il toponimo sia un caso o un esplicito omaggio a Gadda, a quel suo inventarsi lingue pastrocchiate fortemente espressive. Graziano Gala ne segue la lezione e lo sa fare, coniando una koinè dialettale dalla forte caratterizzazione meridionale.
Tuttavia, a voler leggere con attenzione il suo bel romanzo, si può agevolmente immaginare un’ambientazione non solo provinciale e paesana, ma nazionale e forsanche internazionale, a giudicare dal personaggio di Ferlinghetti, un poeta anglo-americano che vive a Merulana, ma che poco o nulla ha da spartire con l’omonimo editore e poeta della beat generation, alla quale il nostro giovane scrittore vuole forse alludere per quel suo cantare la marginalità sociale, la ferocia del Sistema o dar voce ai “fuori di testa”. Magari è Gala medesimo a celarsi dietro il più illustre e famoso poeta recentemente scomparso e, se americano non è per nascita, lo è per condizione culturale e psicologica, essendo egli transfuga della terra natia, che forse ha ripudiato per diventare cittadino di un mondo meno feudale di quello dal quale proviene, e probabilmente meno censorio. A dilatare lo spazio geografico ci pensano i due personaggi che vengono dal Norditalia, ‘a Patuana e suo marito. Il resto è un ordinario bestiario provinciale.
Il protagonista e narratore di questa favola nera è Giuda Iscariota, «ca so’ io – afferma in premessa – o ammenu cusì me chiamane ‘ntra ‘stu paise». Il lettore ne conoscerà il nome anagrafico solo alla fine del suo lungo sproloquio e gli sembrerà un atto, l’unico, di giustizia nei confronti di un derelitto al quale è stato tolto tutto, finanche l’identità. Forse se ne starebbe buono e tranquillo se, malauguratamente, qualcuno non lo derubasse del suo bene più prezioso, il televisore, un vecchio Mivar panciuto con i pulsanti per cambiare canale.
È dal furto del prezioso elettrodomestico che cominciano, o ricominciano, tutti i suoi guai. Oggetto apotropaico più che mezzo di intrattenimento, il televisore tiene lontano dalla sua misera casa lo spirito del defunto genitore, un uomo aduso a menar le mani, come altri in questo romanzo, anche da morto. La voce di Pippo Baudo, «ca è l’unico ca ha fatte cose buone ‘ntra ‘sta nazione», ha una funzione scaramantica e sembra proteggere il povero Giuda dalle sevizie un giorno patite, come tanti suoi coetanei, in virtù della raccapricciante massima pedagogica del bastone e la carota (Qui parcit virgae, odit filium suum), la medesima che il fascismo promosse a sistema di governo della nazione. Nel caso presente di mazzieri ce n’è più d’uno, come il lettore vedrà, e la loro funzione non sarà diversa dai famigerati predecessori del ventennio.
Il fatto è che Giuda è uno strano smemorato perché, se non ricorda il suo nome e non sa dove si trovi l’amata ‘Ngiulina, mostra di avere una cultura non indifferente se usa parole attinte dal lessico colto e cita personaggi ed eventi dei quali, a rigor di logica, dovrebbe sfuggirgli la conoscenza. Ma l’efficace accessorio retorico del conio linguistico consente anche la trasgressione di dare al protagonista della storia una pregante consapevolezza di sé e della sua condizione. Che non è di miseria materiale. Giuda non denuncia la sua povertà, ma l’ingiustizia di cui è costantemente vittima. E nel nostro paese, l’Italia, se è vero che esistono fasce sociali estremamente indigenti, ciò che più cuoce è il senso di disuguaglianza e di ingiustizia che riguarda un numero enorme di connazionali ai quali è del tutto estraneo il concetto di Stato di diritto, perché non ne hanno mai sperimentato uno. Si può dimenticare un pasto saltato, non si può dimenticare un torto subito e, quando il sopruso è sistemico, ti segna nel profondo della coscienza, per sempre, e fa di te un relitto umano. Per i più, segnatamente nel meridione del paese, vige l’antico assolutismo monarchico che elargisce e concede in relazione all’assoluta fedeltà dei sudditi. Il cento per cento dei voti auspicati e ricevuti da Mammoni, ‘o Presidente, chillu ca possiede pure l’aria ca respiri, altro non è che un rapporto di assoluta sudditanza. E, siatene pure certi, il beneficio concesso in cambio della cieca fedeltà è la patente negazione del diritto di cittadinanza per il quale ogni membro della comunità è titolare di diritti soggettivi, non fruitore di elargizioni.
Intanto, nel nostro paese, i processi durano un’eternità, le querele stipano di cartacce le procure e le questure, senza che abbiano un seguito giudiziario o, se lo hanno, assai spesso è a discapito del malcapitato querelante, a meno che questi non sia uno potente e danaroso in grado di saldare le salate parcelle di rinomati avvocati.
No, i disgraziati non denunciano i pizzi e le tangenti, i ricatti, le calunnie e le diffamazioni, le violenze private, i furti, gli scippi, le angherie delle forze dell’ordine o gli abusi della burocrazia. Non ne verrebbero mai a capo e, se mai adissero le vie legali, avrebbero sicuramente la peggio. Il nostro sistema giudiziario è arbitrario, non suffragato dalla certezza, non dico della pena, ma della sentenza. Ed eccolo ben rappresentato dal nostro Giuda Iscariota, del povero cristo che subisce ogni tipo di violenza senza batter ciglio.
Qualcuno lamenterà l’eccesso di brutalità ai danni di poveri disgraziati già ai margini della società, un povero smemorato, un ricchione, una frotta di puttane. Questo qualcuno probabilmente non legge i giornali e non sa cosa è avvenuto nella caserma Levante di Piacenza: ambigui festini, spaccio di droga e arresti illegali, pestaggi ed estorsioni ai danni di vittime che non hanno mai avuto il coraggio o la forza di denunciare. Questo qualcuno non sa com’è morto Stefano Cucchi e, giusto per non lasciare il primato dell’orrore al nostro paese, non sa come è stato massacrato e seviziato il compianto Giulio Regeni, sì, certo, non in Italia, ma in una nazione il cui sistema giudiziario non è molto distante dal nostro a giudicare dalle condizioni in cui è tenuto il povero Patrick Zaki, senza credibili capi di accusa, senza processo. Il qualcuno in questione mi sa dire di che panni vestivano i seviziatori del povero Willy Duarte Monteiro? Che genere di trogloditi erano costoro?
Gala non esagera, prova solo a dare voce a chi non ce l’ha e lo fa con l’enfasi della letteratura, l’unico strumento in suo possesso. Ma, per quanto urli, lo udranno in pochi. Qui non legge più nessuno e l’analfabetismo collettivo si nutre di pregiudizio. Ponete mente al personaggio di Turi Bunna, un omosessuale costretto a travestirsi e prostituirsi. Rende i suoi servigi ai caproni di mezza Merulana, ma l’intera Merulana lo ignora e neppure si accorge della sua scomparsa. Chi lamenta la sparizione di una prostituta o di un frocio? Non sono palpitante umanità, sono stracci logori da gettar via. Nessuno riflette sulle loro pene, sulle loro traversie. In questo romanzo gli unici esseri dotati di un minimo di empatia sono un gatto e un cane. Poi una giovane donna e un ragazzo, la prima per onesta pietà, il secondo per l’ansia di verità della giovane età. Volontari, in altre parole, che rischiano in prima persona.
Svolgono una funzione che dovrebbe essere pubblica e finanziata dallo stato: la tutela della comunità dagli abusi delle istituzioni, l’assistenza gratuita per coloro che non sanno come muoversi nelle faccende giudiziarie o non ne hanno i mezzi. Non intendo la difesa d’ufficio, sulla quale si potrebbe a lungo discutere; intendo un vero e proprio ufficio, dotato di personale esperto e qualificato, capace di fungere da intermediario tra i cittadini e la Legge. Che non viaggia sullo stesso binario della Giustizia e, se il legislatore, qualche volta, azionasse uno straccio di scambio, uno scambio fatto di pietà e commiserazione, forse saremmo tutti meno animali.
In Italia non avremo mai un’avvocatura del popolo. Magari siamo il paese più corrotto della terra, un paese orribilmente sporco. Gli unici a prendere le nostre parti sono i poeti. È per questo che Graziano Gala urla e il suo Urlo somiglia tanto all’omologo che nel 1956 rese celebre un giovane Allen Ginsberg e portò sul banco degli imputati il suo editore, Lawrence Ferlinghetti.
Id: 1309 Data: 18/06/2021 12:00:00
*
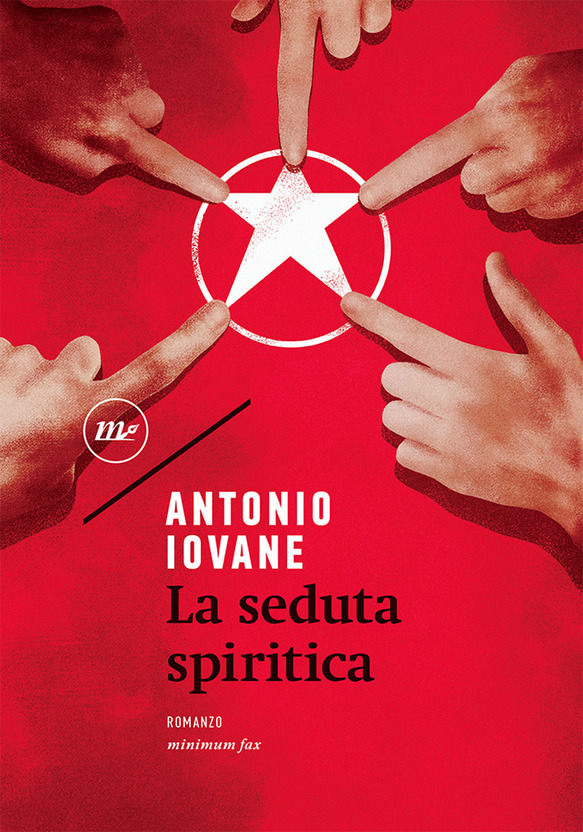 Antonio Iovane - Romanzo - Minimum Fax
Antonio Iovane - Romanzo - Minimum Fax
La seduta spiritica
Della tavola ouija lessi per la prima volta in un romanzo, forse di Irving, non ne sono sicuro. Mi venne da sorridere. Io la conoscevo come “il gioco del piattino” e da bambino ne avevo fatto uso insieme a qualche amichetto, per giocare appunto, probabilmente già diffidente circa la possibilità che l’ordinata sequenza dell’alfabeto, la serie di cifre del sistema di numerazione decimale (0-9) e l’aut out di una coppia di avverbi (sì-no) potessero fornire oracoli dall’aldilà. Ma c’è chi ci crede o ci ha creduto fin da epoche remote; poi, sul finire del XIX secolo, una coppia di americani ne lanciò la versione industriale, una specie di board game, che tuttora è commercializzata negli Stati Uniti.
Che ci giochino dei ragazzini in vena di strizza da suggestione, passi; ma che a giocarci siano dei distinti e stimati professori dell’Università di Bologna, nel corso di un intero pomeriggio (piovoso?), il 2 di aprile del 1978, sembra una barzelletta, benché i partecipanti alla seduta spiritica[1] fossero cattolici. Una persona di sana cultura, per credente che sia, al massimo si presta al gioco dell’oca per compiacere figli o nipotini.
Intanto la versione dei fatti, ben nota ai lettori dei quotidiani, non è stata mai sostanzialmente smentita dal giorno in cui Romano Prodi, futuro presidente del Consiglio, ne riferì ad Umberto Cavina, il portavoce dell’allora segretario della DC, Benigno Zaccagnini; Cavina, oggi defunto, passò la notizia a Luigi Zanda, che era a sua volta portavoce del ministro degli interni Francesco Cossiga.
Gli spiriti di don Luigi Sturzo e Giorgio La Pira avrebbero suggerito il nome “Gradoli” come luogo della possibile prigione di Aldo Moro. Gradoli è sì un piccolo comune in provincia di Viterbo, ma anche di una strada di Roma. L’equivoco suona come un grattacapo, se non un diversivo.
Ripeto, l’intera vicenda e ciò che ne seguì sono fatti conosciuti. La domanda è: perché Antonio Iovane sente il bisogno di farne un romanzo? Sì, è proprio scritto così sulla copertina del libro: romanzo! Intanto perché dove non arriva l’investigatore istituzionale giunge lo scrittore, colmando i vuoti con l’immaginazione e le congetture. In secondo luogo, perché intende dirci qualcosa di fondamentale, qui ed ora, non strettamente connessa ai fatti di oltre quarant’anni fa. Intende dirci qualcosa intorno al concetto di verità, la quale, non esiste come fenomeno unico incontrovertibile e dunque non può essere singolare, ma necessariamente plurale. La scienza della verità, in altri termini, è scienza speculativa di mera inferenza. È probabilmente in tal senso che Pasolini poté affermare di sapere senza avere le prove. E quand’anche fosse stato un investigatore istituzionale, sarebbe giunto a conclusioni “istituzionali” secondo i vincoli procedurali riconosciuti dalla legge. Una sentenza passata in giudicato non è affatto la verità, ma solo una delle sue possibili versioni. Le altre versioni dei fatti sono tante quante sono le deduzioni alle quali giunge chiunque ne sia informato. Pirandellianamente: così è, se vi pare! Le sentenze definitive accertano l’esistenza del fatto, dei possibili attori e dei loro moventi. Uso la parola “attore” perché, in ogni caso, chi agisce, per quanto approdi a un crimine, recita su canovaccio. Tant’è che ci sono dei codici che prevedono la fattispecie del delitto, lo inquadrano, lo descrivono ancor prima che il crimine sia commesso. In altri termini, quando infrangiamo una legge, non siamo mai veramente originali, siamo piuttosto interpreti di un copione. Molti grandi artisti recitano Amleto, ma ognuno lo fa a modo suo. Dietro ogni maschera si cela un volto. Iovine, a mio avviso, mira al volto, sulle orme di uno scrittore che probabilmente legge e ammira, Leonardo Sciascia.
Lo scrittore agrigentino fu membro della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia” meglio nota come “Commissione Moro I”. Nella sua biografia leggi fedeltà e coerenza ai principi dell’Illuminismo che tanta parte hanno avuto nella formazione dei pochi intellettuali autenticamente laici del nostro paese. C’è Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini e Ernesto Rossi, Pannunzio e, perché no, Pannella. Il quale lo volle candidato per il Partito Radicale alle elezioni del 1979. Come mai? Ne condivideva la visione della realtà, inglobava il sistema Sciascia nel programma politico del suo partito. La buona politica ascolta la voce della gente, tanto più se la voce proviene da uno che sa “cantare”, lo fa con cognizione di causa, mira alla qualità del dibattito politico, poco o nulla curando i giochi di potere. Il mandato parlamentare sarà, per Sciascia, un servizio reso alla collettività. Tale dovrebbe essere, ma ben pochi lo intendono così.
Come scrittore e studioso non aveva mai fatto mistero della sua sperticata diffidenza (forse disgusto) per Moro, che il regista Elio Petri volle interpretato da Gian Maria Volonté nel celebre film, Todo modo, liberamente tratto dall’omonimo libro pubblicato nel 1974. Volonté trasforma lo statista democristiano in un uomo mellifluo e dissimulatore tale da apparire come una specie Tartuffo molieriano. È il “gesuitismo” colpevole di un partito politico che regge le sorti del paese dall’immediato dopoguerra fino al suo dissolvimento negli anni Novanta del secolo scorso. La Democrazia Cristiana aveva nei geni la straordinaria capacità del compromesso e della mediazione, una roba che sa di colpevole ipocrisia finalizzata al mantenimento del potere. Tale appare ancora oggi, se è vero che con l’aggettivo democristiano viene puntualmente etichettato qualsiasi politico dai comportamenti ambigui e dal dire sfuggente. È del 2017 il film “Si muore tutti democristiani” che, riecheggiando un celebre titolo del quotidiano “il manifesto”, allude esattamente alla necessità del compromesso con la coscienza ai fini della sopravvivenza in questo nostro sciagurato paese.
Ma Moro viene barbaramente ucciso dalla Brigate Rosse. Cessa di essere un dirigente politico. Di lui resta la nuda umanità, la medesima che emerge dalle lettere che scrive nei cinquantacinque giorni di prigionia-agonia. Sono lettere dure e amare, ma anche umane. I suoi compagni di partito le dicono dettate dalla soggezione; non è così o non lo è in assoluto, non lo è per Sciascia, non lo è per Iovane, non lo è per me! La parola dello statista si fa mite o determinata, incisiva o malinconica a seconda delle circostanze, e diventa tenera e premurosa quando scrive alla moglie, Eleonora Chiavarelli (Nora, Noretta, gran donna, mi viene da dire, e compagna impareggiabile!), dolce e affettuosa quando si rivolge al diletto nipotino Luca, autodefinendosi nonnetto.
Dinanzi alla nuda umanità s’inchinano gli uomini di sane intenzioni. Chi volle morto Aldo Moro, figlio del medesimo tartufismo imputato ai democristiani, dello stesso “gesuitismo” del quale il cattolicesimo nostrano si è nutrito per secoli, indossava una maschera non diversa dai politici che intendeva combattere. La clandestinità implica giocare sporco: bravo ragazzo dinanzi agli occhi della gente, feroce assassino in privato. All’interno 11 del civico 96 di via Gradoli non abitava Mario Moretti, ma tal Mario Borghi, distinto ingegnere, educato, rispettoso. Ecco cos’è la clandestinità, tramare nell’ombra né più né meno come avevano fatto i servizi segreti deviati e settori delle forze armate già anni prima. Con quali aspettative? Gli uni ci avrebbero regalato un novello Stalin, gli altri un redivivo Mussolini. Bella prospettiva! Senza considerare che la geopolitica del tempo avrebbe allargato il conflitto tra bande armate italiane ben oltre i confini nazionali. Le tensioni della guerra fredda non erano ancora cessate. Il senso di quella frase attribuita a Leonardo Sciascia, ma mai da lui veramente pronunciata (Né con lo Stato, né con le Brigate rosse) andrebbe forse interpretata in questo modo: non mi piace la classe politica italiana, non mi piacciono le Brigate rosse. Il dissenso motivato non implica alcuna complicità. Con chi si schieravano Sciascia e altri come lui? Con chi si schiera, infine, Antonio Iovine? Ecco cosa scrisse Moro ad Andeotti:
«Si può essere grigi; grigi, ma buoni; grigi, ma pieni di fervore. Ebbene, On. Andreotti, è proprio questo che Le manca […] Le manca proprio il fervore umano. Le manca quell’insieme di bontà, saggezza, flessibilità, limpidità che fanno, senza riserve, i pochi democratici cristiani che ci sono al mondo. Lei non è di questi. Durerà un po’ più, un po’ meno, ma passerà senza lasciare traccia».
Sembra Adelchi, al quale Manzoni fa dire, riferendosi a Carlo Magno vincitore: “Questo è un uom che morrà”. Sono certo che Sciascia approverebbe il parallelismo.
Le manca il fervore umano! Quello che lo stesso Iovane, personaggio narrante, mette nell’interrogare suo padre, quasi sconvolto dall’assurda vicenda della seduta spiritica di Zappolino, forse certo di non venirne mai a capo. La gente, afferma, la gente, cioè noi, era diversa! Il papà gli risponde:
«Lo scollamento tra la politica e la vita della gente comune che c’è da sempre, in questo Paese. Quelle lettere [di Moro, NdR] ci colpivano, perché la vita della gente è fatta di emozioni. È fatta di passioni. Volevamo che Moro fosse liberato, anche trattando. E i partiti erano invece così distanti…».
Lo sono ancora, ahinoi! Che ne sanno, i partiti, delle nostre vite, dei nostri sentimenti, dei nostri patimenti? Che gliene importa di noi?
Il romanzo di Antonio Iovine è più un viaggio nella nostra coscienza che una vera e propria investigazione. Ciascuno di noi è responsabile della sua versione dei fatti. La verità è fatta di ipotesi, di ragionamenti, di deduzioni, di quasi nessuna certezza. E di un unico raggio di sole che riscalda il nostro cuore.
Id: 1305 Data: 04/06/2021 12:00:00
*
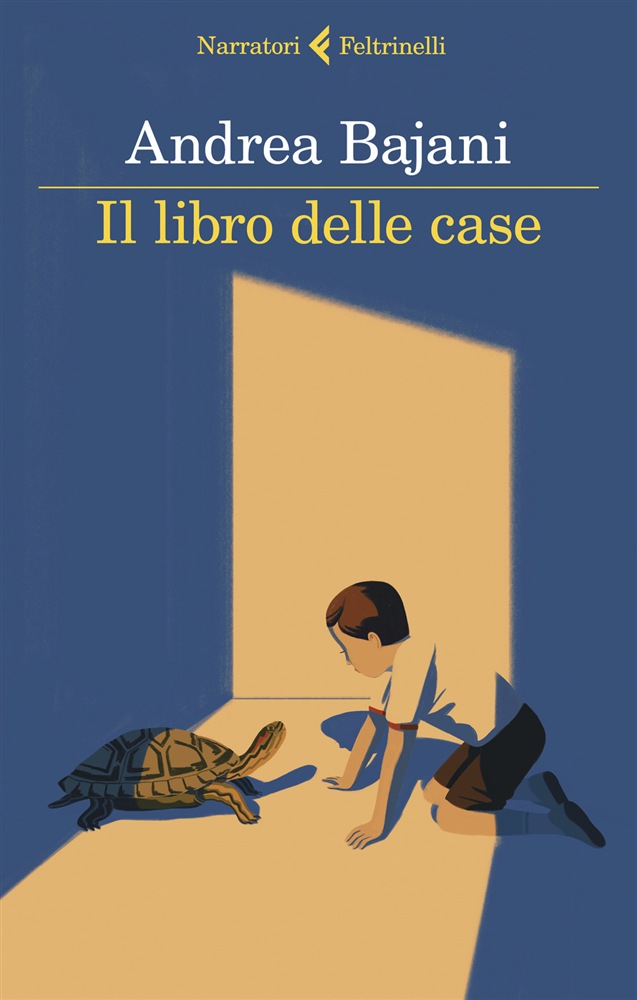 Andrea Bajani - Romanzo - Feltrinelli
Andrea Bajani - Romanzo - Feltrinelli
Il libro delle case
Verso l’altrove
L’esergo cita un vecchio romanzo di Milan Kundera, la Vita è altrove[1]. Mi colpisce l’avverbio perché mi ci sono imbattuto spesso recentemente, in altri libri, in altre storie. Forse vorremmo tutti essere altrove, benché l’altrove non esista e, se esiste, non può essere che la morte. Di altrove si muore, anche giovani se è per questo, esattamente come Jaromil, il protagonista del romanzo di Kundera.
Beh, se Andrea Bajani si sente autorizzato a confonderci e disorientarci, non vedo perché noi, umili suoi lettori, dovremmo esimerci dal formulare ipotesi stravaganti; tanto più che non sappiamo nulla di lui, a parte averne letto alcuni libri. Ne vedo per la prima volta la faccia sul risvolto di copertina. La foto in bianco e nero ritrae il volto di un bell’uomo, di tre quanti più o meno. Barba incolta, basette lunghe fuori moda, capigliatura folta apparentemente negletta. Occhi chiari e luminosi, non ha rughe visibili, a parte le parentesi agli angoli della bocca che delimitano un sorriso appena accennato, a labbra serrate. Anche lo sguardo sembra sorridere, puntato su qualcuno o qualcosa fuori campo che forse gli fa simpatia. Il risolino è per me enigmatico, come quello della Gioconda: un po’ sornione, un po’ beffardo, un po’ triste. Può essere l’ammicco di un rubacuori o la mestizia di un’afflizione; o entrambe le cose.
Mi soffermo sull’autore perché penso che protagonista della sua narrativa sia egli stesso, talvolta con un’identificazione anagrafica d’invenzione (Lorenzo), talaltra esponendosi in prima persona come quando rende uno straziante omaggio al suo maestro (un padre putativo?), il compianto Antonio Tabucchi. Oppure si cela in un iperonimo (bambino) o in un pronome di prima persona oggettivato, come nel caso presente: IO è! La peculiarità di “Il libro delle case”[2] consiste nel categorizzare i personaggi, i quali non hanno altro tratto che un generico ruolo: Padre, Madre, Nonna, Sorella, Moglie, Bambina, Poeta, Prigioniero, guardati da un “IO” non meno categorico (ciascuno di noi è IO), un personaggio tra personaggi. Le case del titolo sono solo in parte luoghi fisici, spesso sono spazi della memoria, quale può essere un taccuino, un esoscheletro o l’abitacolo di un’autovettura. La memoria è selettiva, come per tutti, evoca ciò le conviene o che ne assolve il latore. È anche unica e non ha altri testimoni che noi stessi, a parte gli eventi traumatici che riguardano le collettività, ma anche in questo caso percepiti in maniera diversa a seconda del testimone.
Dunque, Bajani riproduce frammenti di una vicenda fortemente autoreferenziale e figliocentrica. Non è un puzzle in cui ogni tassello ha una sua precisa collocazione; è piuttosto una foto strappata, malamente lacerata, che mai si ricompone del tutto sotto lo sguardo paziente dell’osservatore. I nessi sono balzani, la prospettiva è unica e le grandi voragini possono solo confidare sulla cultura o l’immaginazione del lettore. È quasi un rompicapo per il continuo saltare di palo in frasca, di stagione in stagione. Per noi è legittimo ipotizzare che IO sia lo stesso Bajani, col quale abbiamo, apparentemente, poco o nulla da spartire. Perché ci scarica addosso tutto il suo malessere? Perché dovremmo specchiaci in lui?
Vi confesso che ho pensato a Pavese, non alla sua opera, ma alla sua fine. Dio, mi sono detto, questo si suicida! Lo avevo pensato anche per le opere precedenti e in questa, come nelle precedenti esperienze di lettura, ho tremato di spavento. Perché, se è vero che nessuno può privarci della sua esistenza, la scomparsa di una persona amata è per noi esiziale. Fortunatamente IO colloca la sua dipartita, presumibilmente per cause naturali, nel 2048. Mi è tornato in mente un romanzo di John Irving (Preghiera per un amico)[3] il cui coprotagonista, Owen Meany, prevede l’esatta data della sua morte. È la più bella storia sulla guerra del Vietnam che io abbia mai letto, anche se la guerra vi compare di straforo. Un trauma per i ventenni americani di allora, un’ipoteca inestinguibile sui sopravvissuti alla carneficina. C’entra col mio modesto argomentare, vedrete che c’entra.
Ma ho sorriso, finalmente ho sorriso. Immaginazione per immaginazione, mi sono detto, IO potrebbe anche concedersi qualche annetto in più. Che gli costa? Dopo tutto, quanti scrittori hanno prodotto grandi opere in età avanzata? Sono contento che IO sia tra noi e che intenda restarci ancora per un bel po’, magari anche di più, se vuole.
Veniamo al dunque. L’esperienza di IO mi rappresenta e, in qualche misura, mi esprime. Non posso dire che mi racconti per due buone ragioni: il redattore di queste note non è IO; Bajani non racconta un bel nulla, esprime uno status, una condizione, una generazione e lo fa nell’unico modo in cui è possibile estrinsecare l’universo interiore, attraverso una prosa lirica che evoca più che rappresentare. Le pene non si possono raccontare, il mio dolore, il tuo dolore posso evocarli solo attraverso i mezzi espressivi della poesia. Bajani mi esprime bene. Me! E gli altri? Dove sono gli altri? Senza una storia comune non possiamo capirci. Ecco, dunque, l’elemento che si intrufola di soppiatto nell’arbitrario solipsismo di IO. Che è in terza persona e che la comune storia apparenta ai consimili, sia pure sul mero piano della sincronia. IO nasce nel 1975 (come Bajani): con un po’ di elasticità sulla cronologia potrebbe ben essere un significativo esponente della generazione dei Millenials, cioè di coloro che sono nati nell’ultimo quarto del ventesimo secolo e che all’alba del ventunesimo si sono affacciati alla vita bugiarda degli adulti[4]. La generazione degli orfani. Gli hanno ammazzato i padri ancor prima che emettessero il primo vagito. IO Ha … quasi tutto, ha tutto per la vita, anzi è proprio pronto, è ormai attrezzato, anche se è ancora troppo presto: la vita lo ucciderebbe prima di dargli l’illusione che dà a tutti, quella di graziarlo, di concedergli l’eterno. Non sa, ancora non sa che…
Nelle ore del travaglio materno, all’idroscalo di Ostia, veniva barbaramente trucidato Pier Paolo Pasolini. Due anni e mezzo dopo in una Renault 4 di colore rosso verrà trovato il corpo esanime di Aldo Moro. Quel rosso, IO lo riconosce. La bocca luminosa del televisore glielo ha iniettato dentro il reticolo nervoso mentre corre nella Casa del sottosuolo. Per questo, anche se non lo ricorda. IO sente quel colore come una fitta dentro il fianco, come una specie di dolore nazionale. Lo riconoscerà per sempre e sarà indistinguibile dal sangue.
Per sempre! Uccidere due padri quasi in un sol colpo è un gran brutto affare per le generazioni venture. Solo gli incoscienti potranno elaborare il lutto; gli altri sapranno, sia pure in differita, che la morte di un padre è uno scacco troppo grande e scoprirsi figli, soli, sotto il peso del destino, significa farsi carico di mille improvvise responsabilità[5].
Sopprimendo la poesia e la politica, entrambe intese in senso ovviamente esteso, hai dato il via alla nuova barbarie del terzo millennio. Gli orfani non sanno che pesci pigliare, si muovono a casaccio, o tutt’al più restano muti, attoniti dinanzi a un silenzio mortifero.
Vedete, tutti noi abbiamo padri e madri biologici più o meno identificabili, ma non è detto che essi siano all’altezza del gravoso compito che li attende. A parecchi di noi è capitata solo la rappresentazione di una tradizione … inapplicabile a una famiglia messa insieme con pezzi di solitudine e di scarto. Se nasci all’interno di una famiglia raffazzonata, per trovare l’orientamento devi rivolgerti a guide più solide, più istruite, più esperte, più sagge. Ma, se anche queste ti vengono sottratte dalla furia cieca dell’insipienza ferina, la morte riguarda non esseri umani, ma il cammino della civiltà.
Il messaggio è tutto nella malcelata centralità dei due fatti di sangue che hanno tenuto a battesimo la generazione dei Millenials. Sono simboli del parricidio universale, ma anche emblemi dell’ultima e più recente cesura storica nel nostro paese. Pasolini e Moro sono patenti raffigurazioni dell’antifascismo etico, della discussa e spesso discutibile ricostruzione postbellica, ma anche del dibattito culturale e politico che tiene desta l’attenzione dei cittadini, ne provoca le reazioni e le scelte, stimola la riflessione, connette gli spiriti nella mitezza della civiltà. La morte di Edipo dovrebbe essere solo metaforica e significare superamento, avanzamento, qualche volta progresso. Edipo non può essere soppresso: è una necessità storica. Senza di lui smarrisci la strada, non sai da dove muovere né dove andare. Si edifica su solide fondamenta, non sulle macerie. Senza passato non c’è futuro. Oggi siamo tutti degli eccellenti demolitori; nessuno di noi conosce l’arte della progettazione. Disfacendoci dei padri, abbiamo negato il futuro ai figli. Gli abbiamo oscurato il sole.
Ah, dimenticavo! C’è anche Tartaruga nel libro di Bajani. Longeva e silenziosa attraversa tutta la raffazzonata storia, anzi la supera. L’alluce di IO e la testa di Tartaruga hanno la stessa forma, e per questo IO è convinto che la propria testa stia nel piede. E il piede muove verso non si sa dove, forse verso l’altrove.
[4] Riecheggio il titolo di un romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, E/O edizioni 2019. Anche in questo caso il richiamo non è casuale. La protagonista del romanzo è più o meno coetanea di IO-Bajani. Si tratta di un’opera fortemente figliocentrica. Gli scenari significativi sono abitazioni. C’entrano le case.
Id: 1298 Data: 02/04/2021 12:00:00
*
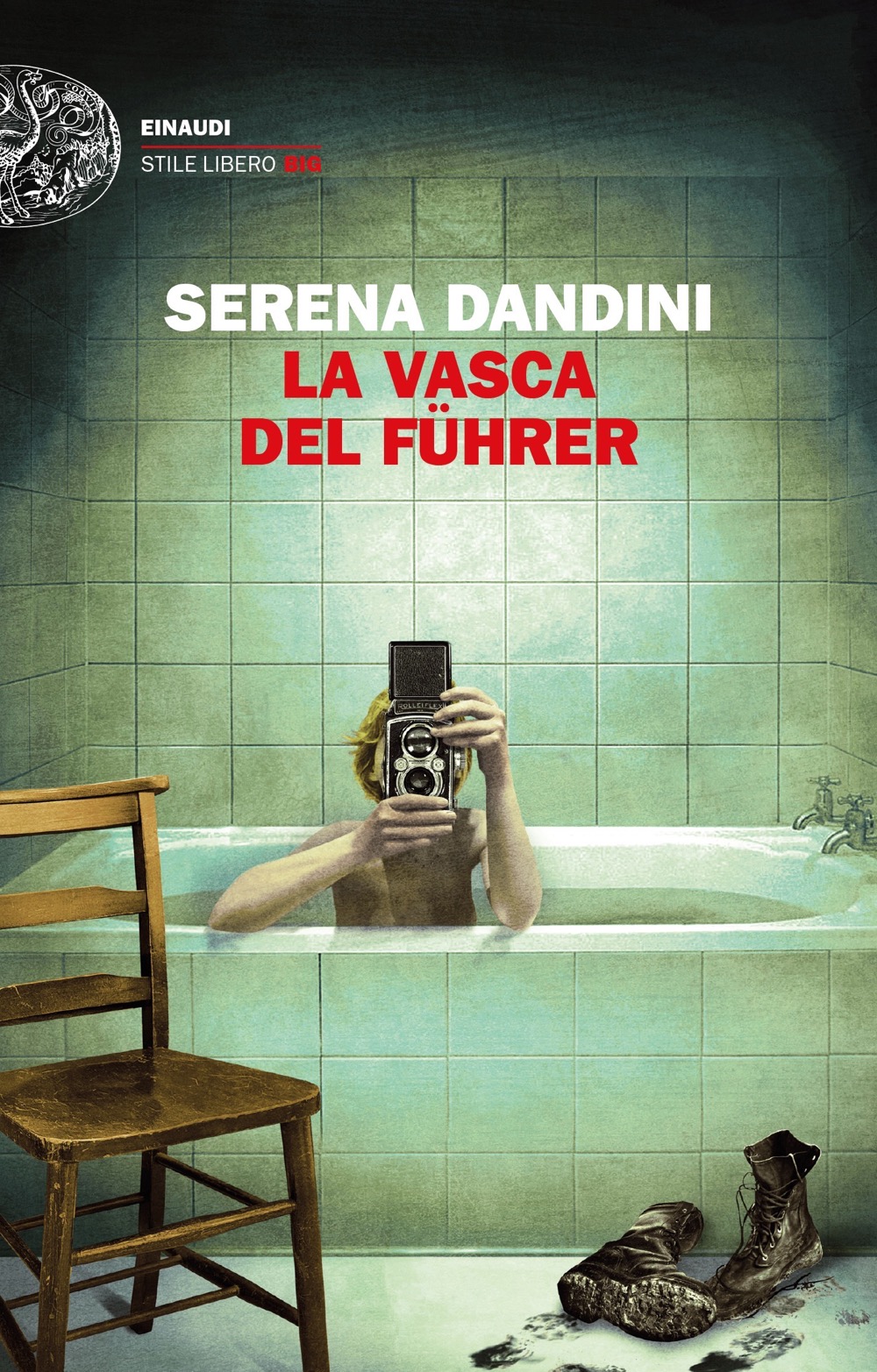 Serena Dandini - Romanzo - Einaudi
Serena Dandini - Romanzo - Einaudi
La vasca del Führer
OLTRE L’ORIZZONTE
Me ne ricordo bene. Lessi la notizia sui giornali. Un uomo ucciso da un cornicione staccatosi dal quinto piano dell’edificio in cui abitava. Non avrebbe mai immaginato, svegliandosi quella mattina, che il suo tempo sarebbe scaduto di lì a poco. Mi colpì la notizia perché passavo quasi ogni giorno per quella strada, calpestando lo stesso marciapiede sul quale l’uomo aveva trovato la morte. Pensai che fosse toccato a lui, ma qualche possibilità che capitasse a me c’era. Solo il caso aveva provocato la morte di quell’uomo. Fosse uscito un minuto prima o un minuto dopo dal suo portone, ora sarebbe vivo. Il caso determina le nostre vite. I progetti a lungo termine non ne prevedono l’incidenza.
Non è fatalismo, è solo la constatazione della dipendenza sensibile alle condizioni iniziali di un sistema complesso, il celebre effetto farfalla di Edward Lorenz. Attingo dal web una ben nota citazione di Alan Turing (Macchine calcolatrici e intelligenza, 1950): «Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza».
La possibilità che Elizabeth Miller, una mattina del 1927, si imbattesse, per mero accidente, lungo l’affollatissima Quinta Strada di New York, in Condé Montrose Nast è fatto di tale eccezionalità da spingere Serena Dandini[1] a scrivere: «Ci vuole talento per capitare nel posto giusto nell’attimo giusto…». Lei è una ragazzina di vent’anni proveniente da Poughkeepsie, una cittadina a meno di cento chilometri da New York; lui è nientemeno che l’editore del New Yorker, di Vanity Fair e, soprattutto, di Vogue. Non è la scena di un film, è un fatto davvero accaduto. All’editore basta uno sguardo per capire che a Lee non manca nulla per diventare una cover girl di sicuro successo. Qualche mese dopo il suo volto, sia pure disegnato da Georges Lepape, appare sulla copertina di Vogue. È l’inizio di un lunghissimo viaggio che condurrà la celebre modella, poi fotoreporter e giornalista, nei luoghi più disparati e a contatto col fior fiore della cultura e del jet set internazionali fino all’approdo nel Sussex britannico, finalmente moglie di Sir Roland Algernon Penrose, pittore, collezionista e critico d’arte. La sua biografia sembra un percorso ad ostacoli, così carica d’esperienze e di avventure da far pensare a vite diverse che si intrecciano, si accavallano, si confondono e si perdono nei meandri più tortuosi della storia del ventesimo secolo. Seguirla dà sgomento alla stessa sua biografa italiana, che pure è una “ragazza degli anni Settanta”, allevata col latte tonificante del femminismo militante e delle battaglie per i diritti civili. Lei, Serena Dandini, alla quale non è estraneo lo spirito d’avventura, alza le mani in atto di resa come chi mai potrà competere con la campionessa mondiale della corsa a ostacoli. Ardisce, Elizabeth Miller, oltre l’immaginabile e l’ammissibile, armata di tenacia e del più coriaceo sentimento di sé. Non è “soltanto una delle tante avventuriere, perlopiù sconosciute, che nei secoli hanno scelto la libertà di viaggiare nei modi più rocamboleschi, osando stili di vita impensabili per una donna”. No! Lei è la completa emancipazione della donna, la fattuale rivendicazione di appartenenza a sé medesima (il corpo è mio e lo gestisco io), eludendo e di fatto avversando la tutela maschile allora imperante e dominante come giogo implacabile, il medesimo che fascismo e nazismo sfoggeranno a mo’ di icona della ferinità a loro congeniale. È lei, non un uomo, a uccidere il Minotauro e lo fa con la sua totale, estrema, consapevole femminilità.
Molti di voi, se leggono o hanno letto il libro della Dandini, storceranno il naso o l’avranno storto in più punti durante la lettura. Lo capisco, non lo giustifico. È impresa titanica rimuovere dalla propria coscienza i millenni di cultura maschile che hanno costretto i nostri corpi e le nostre menti in armature metalliche dalle articolazioni rigide, meccaniche, poco oleate. Trasformare dei grotteschi automi in esseri umani non è cosa da poco, soprattutto per i pionieri della metamorfosi. Dovrei dire “pioniere”, trattandosi delle scatenate flapper dei ruggenti anni Venti, le maschiette messe in campo dalle riviste di moda con gli auspici di due celebri donne, Elsa Schiaparelli e Coco Chanel che, svestendole o accarezzandone morbidamente le forme, insegnarono anche agli uomini il valore della nudità. La scenografia è già tutta nell’opera di Francis Scott Fitzgerald. Leggere per credere! La nuova cultura è retaggio di Freud che rivelò ad André Breton e ai suoi numerosi amici e sodali una realtà misteriosa tenuta fino ad allora nascosta dentro la corazza delle convenzioni: ecco il senso della nudità, tutta espressa in quell’arte surrealista che regalò al mondo intero nuove prospettive. Degenere giudicarono nazismo e fascismo quest’arte. Certo, perché smascherava la loro perversione ancor prima che si esprimesse. E si espresse in maniera così feroce e violenta da sconvolgere il mondo intero e da ipotecare la storia futura fino ai giorni nostri. Il sadismo estremo e la cieca violenza ebbero buon gioco su uno sterminato gregge ridotto alla cieca obbedienza entro il grottesco tralignamento di una liturgia cannibale e coprofaga. Quando una malattia della psiche si erige a regime siamo alla vigilia dell’estinzione della specie.
Lee Miller, già allieva del famosissimo e acclamato Man Ray, nonché sua appassionata amante, stanca di essere una fotografia, estenuata dalla trappola mortale della sua stessa bellezza, impugna la macchina fotografica e si trasforma prima in apprezzata fotografa, poi in fotoreporter. Amerà e sarà amata da molti uomini, fino a sposare Aziz Eloui Bey, un ricchissimo imprenditore egiziano. Lo seguirà in Egitto, punterà l’obiettivo della sua macchina fotografica sull’immensa distesa del deserto, sulle piramidi, lasciandoci foto memorabili. Il frivolo ambiente del Cairo e di Alessandria la stancherà presto. Sentirà il bisogno di muoversi, di mettersi di nuovo in gioco. Il tollerante e benevolo Aziz ne asseconderà la forsennata sete d’altrove. Parte, viaggia, fotografa, incontra il suo futuro e definitivo marito, Roland Penrose. Dovrà separarsene presto allo scoppio della guerra. Dopo un breve ritorno negli Stati Uniti, la ritroviamo fotoreporter di guerra per Vogue, invadendo un campo tipicamente maschile. Documenta i bombardamenti di Londra, riceve il placet dell’esercito americano quale corrispondente di guerra per il suo editore Condé Nast. Fotografa lo sbarco in Normandia e la liberazione di Parigi. Entra, tra i primissimi, nei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau. Vincendo nausea a orrore, con la sua Rolleiflex comprova, a beneficio e memoria della posterità, l’inimmaginabile spettacolo della ferocia nazista. Il telegramma spedito a Vogue con i rullini recita: «Credetemi, è tutto vero!». Dubita che una rivista di moda abbia il coraggio di pubblicare su carta patinata l’incubo a cui lei ha assistito: montagne di corpi che erano scheletri già prima di morire, senza più nome né dignità, spinti a fatica dalle ruspe verso una fossa comune per scongiurare le epidemie. Lei stessa non potrà mai dimenticare. È esausta. Vorrebbe cancellare, dalla coscienza più che dai sensi estenuati, la sozzura della divisa a lungo indossata, il fango dagli stivali, il fetore dei cadaveri, lo sguardo spento dei sopravvissuti. Il caso vuole che, a Monaco di Baviera, le diano alloggio in una casa su Prinzregentenplatz. È nientemeno che l’appartamento privato di Adolf Hitler, una dimora che avrebbe potuto accogliere il benessere discreto di un impiegato comunale, o di un prelato in pensione con un’inclinazione per l’arte classica e le sue mediocri imitazioni. … Una sobria dignità borghese trasuda da ogni dettaglio. La banalità del male!
Lee si libera degli stivali fangosi, degli abiti e si immerge ne “La vasca del Führer” per un caldo bagno ristoratore. È lì che David Scherman, suo collega e compagno di ventura, la ritrae, nuda, lo sguardo perso, il sudiciume degli stivali sul tappetino, la divisa ripiegata su una sedia. Sulla sinistra, adagiata sul ripiano della vasca, è una fotografia di Hitler.
I due colleghi finiranno a letto, l’una cercando conforto tra le braccia dell’altro. È, il loro, un amplesso furioso, disperato, probabilmente vissuto come terapeutico o consolante da entrambi. Mi piace l’essenzialità dei tratti con cui la Dandini dipinge Dave, un giovanotto un po’ goffo e impacciato al cospetto di una donna imperscrutabile e risoluta, che tuttavia gli si concede come una grazia non richiesta. Capisco il riserbo di Scherman; Lee Miller puoi amarla solo così, a distanza di sicurezza, all’interno di una discreta contemplazione più che di un’irredimibile passione. Lei è una fortezza che non si espugna; la si visita con la discrezione e il rispetto del turista che si aggira per un museo e ne ammira deferente la collezione.
Serena Dandini imperla con brevi camei il discorso narrativo. Ce ne sono tanti; uno, in particolare, mi ha commosso più degli altri. Nel suo lungo peregrinare tra i ruderi della guerra appena finita, Lee approda a Vienna, una città devastata nel corpo e nello spirito. Mentre cammina da sola nella notte viennese, è attratta da un falò in fondo a una strada. Alcuni soldati russi bivaccano insieme a un vecchio signore che accenna per loro timidi passi di danza, pieni di grazia nonostante l’età. Lee si avvicina, e scopre di trovarsi in presenza di Vaclav Fomič Nižinskij, il più grande ballerino del mondo.
Chi conosca la vicenda personale dell’étoile dei Balletti russi, magari per averne letto i diari[2], sa quale stridente contrasto possa intravedersi tra la grazia del danzatore di un tempo e l’uomo fuori di senno che sorride felice agli astanti. L’autrice chiosa: «Chi sarà più in grado di riconoscere e proteggere la bellezza?». In questo conciso quadretto è il senso del conflitto che cancellò per sempre la speranza di un futuro migliore. Un mondo incapace di apprezzare la bellezza è preludio di morte. Il calderone del kitsch che ferisce oggi, qui ed ora, i nostri sguardi ci dice che i massacratori dei disabili, dei dissidenti, dei rom, degli omosessuali e di sei milioni di ebrei sono pronti ad altre carneficine. Il Minotauro non è mai stato ucciso e non mi pare che bazzichi per i nostri musei, semmai per i centri commerciali. Per altro verso, la paccottiglia non è neutra, credetemi; è solo banale e inquinante, come la natura del male.
In margine a quanto ho fin qui detto e col rischio di scantonare, mi viene da fare qualche riflessione su alcuni aspetti del temperamento della Miller quali essi emergono dalla penna della sua più recente biografa. Uno che colpisce e che dà un certo sconcerto è certamente la sua scarsa propensione alla maternità. Lee fu una pessima madre. Ebbe da Roland un figlio che oggi, anch’egli fotografo, dirige l’archivio di sua madre e la collezione d’arte paterna (un museo, in altre parole) presso Farley Farm House, l’avita dimora. Anthony Penrose, da bambino, ricevette scarsa o nulla attenzione da sua madre; affetto da dislessia, fu amorevolmente accudito dalla tata, Patsy Murray.
“Era una madre senza speranza. Era priva di naturale istinto materno”, dirà Anthony di Lee. Intanto mi chiedo se questo naturale istinto esista davvero o sia una delle tante leggende che ci siamo inventati per salvarci dalla dannazione. La seconda, credo, non solo perché ho conosciuto altre donne prive dello sbandierato istinto, ma anche perché oggi rinvengo in tanti padri i comportamenti “materni” che un tempo furono pertinenza esclusiva delle donne: tenerezza, amorevolezza, benignità, spirito di sacrificio, corporeità. Sono gli atteggiamenti che osservo in alcuni maschi contemporanei e che spesso sono fatti oggetto di satira sottile da parte dei loro detrattori, maschi anch’essi, che presumibilmente soffrono l’angoscia di castrazione. Finisco col pensare che al comportamento materno si venga educati più che indotti da spontanea inclinazione, che esso sia prodotto di cultura più che di natura e che la femminilizzazione del maschio sia l’effetto di un’evoluzione culturale alla quale non sono del tutto estranee le “ragazze degli anni Settanta”. Certamente non tutti i maschi sono “materni”, ma è perché il machismo è duro a morire, l’ostentazione dei muscoli è tuttora spettacolo ben remunerato (pensate a quanta esibizione di virilità c’è nel cinema, in televisione, in letteratura e come la più celebre creatura di William Moulton Marston, Wonder Woman, abbia avuto fama mondiale solo in tempi abbastanza recenti).
Ciononostante, non voglio escludere la possibilità che le due intense cesure presenti nella biografia di Lee Miller non abbiano influito sui comportamenti e il carattere della puerpera futura: l’abuso sessuale subito in tenerissima età e la traumatica esperienza della guerra vista e vissuta in primissimo piano. E, se è vero che “… la forza che conquistiamo da adulti non serve a proteggerci dalle ferite del passato…”, è altresì vero che la medesima forza schiva le esperienze che le evocano e ci schermisce dai loro assalti. Ognuno elabora il lutto come può, altrimenti il mondo sarebbe popolato di zombie. L’esperienza di guerre feroci continua a lacerare l’anima di tanti, tantissimi nostri simili, mentre l’abuso sessuale è lo sport più praticato dagli antichi come dai moderni invasori, senza dimenticare che le società agro-pastorali di sempre hanno insita la pratica di concedere fanciulle impubere al miglior offerente, un bestione bene adulto aduso ad acquistar vergini immacolate con la stessa disinvoltura con cui rimpingua la mandria. Detto tra noi e senza malevolenza alcuna, mi azzardo ad affermare che Gesù Cristo, dopo tutto, fu figlio di una moglie-bambina. Pare che la pedofilia sia stato un apprezzato passatempo tra le eccelse divinità e che i loro umani ambasciatori, segnatamente negli aridi deserti, ne abbiano seguito il buon esempio. Per altro verso e in termini ben meno giustificabili, tutta la storia del colonialismo andrebbe riscritta alla luce di simili misfatti. Da chi credete che fosse costituita la soldataglia europea inviata a massacrare popoli e stuprar fanciulle che nulla avevano fatto di terribile se non ignorare, per forza di cose, l’incarnazione di un dio estraneo al loro pantheon? Mica a quei tempi c’era internet! Pensate davvero che i vigorosi colonizzatori di un tempo disdegnassero i culetti dei fanciulli quando null’altro s’offriva a raffreddare i bollori a lungo repressi? E cosa mi dite della pratica del madamato ben nota e esperita dai “gentiluomini” del nostro fascismo? Andiamo, lo saprete che la piccola Destà aveva sì e no tredici anni!
Una sana cultura dell’infanzia e dell’adolescenza è acquisizione storicamente recente. Ha attecchito su una minima parte del mondo civile. La spiccia pedagogia del “Qui parcit virgae, odit filium suum” regola ovunque i sistemi educativi e, malauguratamente, dietro la verga si cela l’accondiscendenza all’abuso. La maggioranza dei bambini e degli adolescenti del mondo subisce senza parlare. I pochissimi casi di abuso che arrivano alla ribalta della cronaca sono più un modo di fare spettacolo che di alimentare responsabilità. Si legga la bella, recente denuncia di Garrard Conley[3] per capire che qualche ragione da vendere ce l’avrei; oppure si dia una scorsa all’altrettanto recente romanzo di Marieke Lucas Rijneveld[4], una giovane scrittrice olandese che ci offre uno spaccato inedito e insospettato del suo paese. Libro duro, durissimo, che stride come smerigliatura sulle nostre coscienze! Ma non vi private della lettura di Noi siamo infinito[5], Mysterious Skin[6] o La diseducazione di Cameron Post[7], così, giusto per avere una visione generale delle questioni che pongo. Le batoste subite da bambini e adolescenti sono esiziali, non meno dei sistemi educativi che le infliggono. E mi si conceda venia per questa mia fuga nell’extratesto. Mi aiuta a capire, non senza raccapriccio, chi sono gli elettori di Donald Trump o da dove tragga linfa il suprematismo europeo. Infine, da quali madrase provengono gli odierni kamikaze? A quanto pare, Cristo non si è mai mosso da Eboli.
«Il fisico guarisce, – scrive la Dandini – l’anima sotterra il dolore in un luogo inaccessibile e la vita è costretta ad andare avanti».
Molti di noi hanno avuto genitori latitanti o madri disamorate, ma l’età adulta, corredata da una sana cultura e da generosa intelligenza, ha inclinato al perdono. Così, se ho sofferto la biografia di Lee Miller con viva partecipazione, non posso proibirmi di stimare suo figlio Antony, il quale oggi è il più fervido custode delle memorie materne.
Un nostro antichissimo antenato, tanto tempo fa, ebbe il coraggio di ergersi sugli arti posteriori e dirigere lo sguardo all’orizzonte, oltre il quale l’altrove ci attende.
Id: 1291 Data: 26/02/2021 12:00:00
*
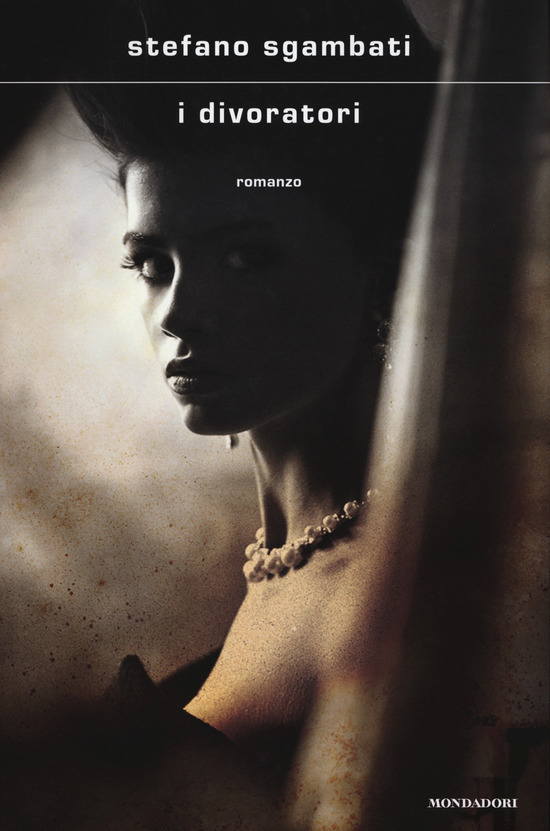 Stefano Sgambati - Romanzo - Mondadori
Stefano Sgambati - Romanzo - Mondadori
I divoratori
C’è poco da fare, lui è fatto così! Ne ho letti più d’uno di libri suoi e sono sempre giunto alla stessa conclusione: va bene, ma poi? Nulla. Non c’è un prima né un dopo. C’è la nudità della scrittura, il groviglio della parola, l’arzigogolo delle similitudini. Ti devi districare tu, lettore, nel ginepraio dell’intreccio del quale non sai la direzione. Avanzi a casaccio, pedini la voce narrante, la quale muta e ti confonde perché ignori il battistrada: questo chi è, da dove è uscito? Poi, con un po’ di buona volontà, ne vieni a capo, ma sei stato anche deviato dal percorso che avevi in mente di seguire. Un casino. Ti sembra di guardare uno di quei quadri cubisti nei quali la scomposizione della figura ti disorienta, anche se non puoi impedirti di guardarla. È attraente proprio perché è sfuggente, inafferrabile, spigolosa come una geometria stratificata.
Sono stato spesso sul punto di rinunciare; poi, non so come, non so perché, una vocina mi diceva di proseguire. Mi trovavo all’interno di un incubo, desideravo venirne fuori ma… più mi affannavo, più mi impaniavo. Bere o affogare? Bere! Col risultato di ritrovarmi infine con la pancia gonfia e il cervello andato in pappa. Vabbè, che posso farci? I sogni sono così: alla luce della razionalità non ci capisci un cazzo: che ci azzecca mio nonno con Cristoforo Colombo? Vattelappesca!
Gesù, questi sono numeri! Perché trovo attraente qualcosa che non mi piace? Mi sento un ossimoro. Dopo aver letto il libro avevo voglia di Victor Hugo, di Jane Austen o roba del genere, a mo’ di antidoto o emetico, fate voi. Invece la mia mente tornava maniacalmente alla mappazza appena ingurgitata.
Di cosa tratta il libro[1]? La copertina lo definisce romanzo. Tu pensi che dovrebbe raccontare una storia, organizzata in maniera tale da tener desta l’attenzione del lettore, con tanto di intreccio, climax, spannung, scioglimento finale. Cose del genere. Invece non viene raccontato nulla. Ti trovi dinanzi a una specie di ambiente situazionista in cui le passioni umane trovano libera espressione entro un contesto ludico o, quanto meno, della sua parodia. È un lussuoso ristorante milanese nel quale convolano a cena diversi gruppi di persone, chi per caso chi per essere testimone dell’evento mondano che vede al centro dell’attenzione degli astanti e presumibilmente dei media una celebre coppia di attori hollywoodiani, entrambi famosissimi, ricchissimi nonché bellissimi.
Non posso raccontarvi la trama perché non c’è alcuna trama. Ci sono i personaggi che agiscono come marionette della coreografia di un gigantesco orologio a cucù. La finzione narrativa ci fa conoscere qualche loro pensiero, ci mostra qualche tic o gesto studiato, svela qualche retroscena più o meno indicibile e ben nascosto dai paludamenti e dal convenzionalismo del ruolo. C’è la chiacchiera salottiera, talvolta intrisa di secondi fini; c’è la liturgia della forma che il luogo prescrive. Dietro le maschere, ci sono i volti grotteschi di un’umanità sacrificata all’altare delle apparenze. Qualcosa accade e crea il gran trambusto finale. Alimenterà per qualche settimana o qualche mese il gossip globale, poi tutto tornerà come prima. Non è un caso che ad aprire e chiudere il racconto ci sia lo stesso taxi. A guidarlo è il medesimo tassista, l’uomo qualunque, uno di noi. Dopo tutto, non è successo nulla e ciò che è accaduto sarà presto dimenticato a vantaggio della prossima pagliacciata da sbandierare ai quattro venti.
Siamo messi male, chiusi perennemente in un circolo vizioso. Giriamo in tondo per ritrovarci, infine, al punto di partenza. È così che ci appartiene questo mondo, divoratori gli uni degli altri, attori dello Show business globale. Volendo possiamo riconoscerci nel campionario di umanità che Sgambati mette in scena.
Saverio e Elena finiscono a letto dopo essersi incontrati per caso al funerale di una comune conoscenza, una certa Irene della quale il primo fu un tempo amante: Eros e Thanatos in un Minstrel show. Non meno grottesca è la coppia Giordano Tirreno e Frida Astori, lui anziano intellettuale, lei quasi una ragazzina. Galeotto fu il web. Il personale del ristorante ha bollato il professore, già ospite televisivo di Fabio Fazio, come pedofilo. Per la verità la letteratura e il cinema sono pieni di simili accoppiate. Philip Roth è maestro nel darcene conto; Woody Allen, nell’immaginario collettivo, è quasi l’emblema dello sporcaccione matricolato. Suvvia, siate generosi, bisogna pure che il corpo esulti in qualche modo e, se il citrato di sildenafil della Pfizer (sì, la stessa casa farmaceutica del famoso vaccino) può restituirci antiche esultanze, ben venga a dispetto del decoro del quale restiamo fieri.
Al centro della scena ci sono loro, i divi di fama internazionale, Daniel William King e Sally Parson, marito e moglie, due fossili della bellezza da rivista patinata. Sorridono, ammiccano, scrutano con discrezione i presenti secondo un copione che li vuole protagonisti ben oltre il set cinematografico. Gli obiettivi degli smartphone li scrutano dovunque vadano. Ogni loro gesto vale una pioggia di dollari, per gli editori e le emittenti televisive. Lo scrittore si è probabilmente ispirato alla coppia Brad Pitt e Angelina Jolie. Per dirci che dietro le maschere ci sono volti tormentati. L’avevamo capito. Pirandello docet! L’autolesionismo è un atto di disperata ribellione. È sterile, non serve a nulla. Se Daniel, puta caso, morisse, ci sarebbe già pronto l’emulo di pari o maggior valore. Anche la morte è un ottimo affare per il burattinaio del momento. D’altronde Narciso annegò nella pozzanghera in cui si vide riflesso. Non mi pare l’unico e la storia ha proseguito il suo corso. Oggi forse la storia è al palo, ma il gossip avanza ovunque e fa circolare parecchio denaro.
Tra il personale del prestigioso locale emergono da un lato il proprietario, lo chef Franco Ceravolo, dall’altro il maître Carlo Di Martino, un gradasso napoletano che sa come tenersi il ben remunerato impiego. Il primo forse allude a Carlo Cracco, cocaina a parte, e non saprei dire se sia volontario o accidentale il link che rinvia al romanzo precedente dell’autore, dove, se non ricordo male, il nome di Cracco è fatto esplicitamente a proposito di un format televisivo. Forse a Stefano Sgambati piacciono i programmi di cucina oppure vuole semplicemente dirci che la gastronomia fa più audience di altre arti.
A prescindere dalle prerogative del ruolo, la biografia del maître oscilla tra due tavoli, uno che ospita la sua chiassosa famiglia napoletana, parenti e affini inclusi, l’altro al quale siede una tal Vesta, un tempo prostituta delle cui prestazioni Di Martino ha fruito, oggi apprezzata e ben remunerata ballerina con tanto di rinomanza televisiva. Significa che chi mostra le cosce in televisione deve la sua carriera alla previa professione? Non lo so e non mi interessa. Vorrei soltanto interpretare il gesto della ballerina che, per tutta la serata, finge di ignorare il cliente di un tempo, ma infine gli lascia sul tavolo una busta con cinquecento euro, il corrispettivo del sovrapprezzo della pattuita marchetta, per una sua prestazione “speciale” non inclusa nel prezzo base. A me non sembra tanto orgoglio femminile quanto vendetta, dispetto. Se lui non è Petrarca, lei non è certamente Laura. Entrambi si crogiolano nella deiezione di quella che un tempo fu detta civiltà.
A me sembra che Sgambati voglia offrire ai suoi lettori un campionario di umanità quale essa appare agli occhi di un millennial di sicura competenza e lo fa osservando il mondo attraverso l’enfasi dell’universo mediatico nel quale tutti siamo protagonisti, comprimari o comparse di un colossale Truman Show. Ma poi le falle della scenografia ci rivelano la verità di ciò che siamo. La realtà virtuale è tutt’altro idilliaca. Come difenderci dalla pania degli algoritmi che rendono goffi i nostri gesti?
Teresa, la madre di Carlo, sembra afflitta da un principio di demenza senile; se ne sta lì, noncurante del trambusto che la circonda. Cos’è, stoica apatia, la divina indifferenza … del falco alto levato? È una risposta al male di vivere del terzo millennio?
Sembrerebbe di sì, a giudicare dall’inefficacia del gesto di Daniel. Clamoroso, scellerato, sacrilego, tanto più che dettato da un impulso non contemplato dal copione. Nulla di male, a tutto c’è un rimedio: si modifica il copione. Quante volte la sceneggiatura è stata emendata in corso d’opera? Il pubblico neppure se ne accorge e lo show business, in fin dei conti, attinge a un nuovo e più ricco filone aurifero. Al tramaglio non si sfugge!
Id: 1288 Data: 29/01/2021 12:00:00
*
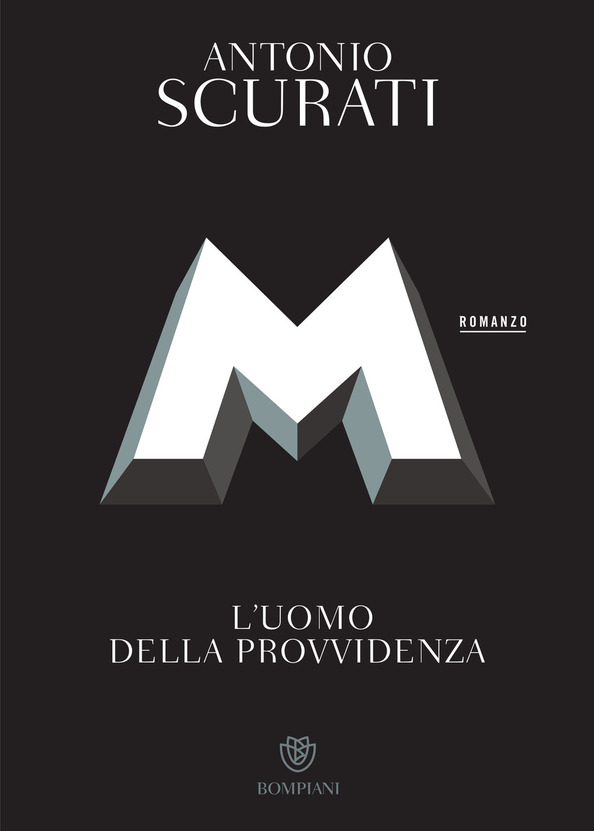 Antonio Scurati - Romanzo - Bompiani
Antonio Scurati - Romanzo - Bompiani
M. L’uomo della provvidenza
«In che modo si debbino governare le città o principati li quali, innanzi fussino occupati, si vivevano con le loro legge».
«Coloro e’ quali solamente per fortuna diventano, di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengano; e non hanno alcuna difficultà fra via, perché vi volano; ma tutte le difficultà nascono quando sono posti».
Sono entrambe citazioni da “Il Principe” di Machiavelli. La prima è il titolo-compendio del quinto capitolo; la seconda l’incipit del settimo.
Tra la lezione del segretario fiorentino e l’azione di Benito Mussolini decorrono ben quattro secoli, che non costituiscono uno iato, ma un continuum storico e culturale da tener presente. Non è il caso, in questa sede, di ripercorrere i dettagli dell’articolato dibattito filosofico intorno alla politica. Limitiamoci a ricordare il fondamentale De l'esprit des lois di Montesquieu, opera nella quale si discetta dei tre poteri dello Stato e degli argini che a ciascuno di essi vanno posti per evitarne gli abusi. Sì, perché chi esercita un potere è spontaneamente portato ad abusarne, a meno che la Legge non glielo impedisca. La Legge per antonomasia, senza troppi preamboli, nello Stato contemporaneo, è la norma fondante dello Stato stesso, cioè una cosa che chiamiamo Costituzione o, se preferite, Statuto. Siamo alle democrazie liberali nella quali i poteri sono divisi, il loro esercizio è rigorosamente regolamentato, la loro legittimità deriva dal consenso espresso dal popolo-corpo elettorale.
Le democrazie liberali sono fragili perché aborrono l’uso della violenza, se non intesa come coercizione finalizzata a ripristinare e/o a mantenere il rispetto della legalità. Gli organi coattivi, essi stessi sottoposti alla Legge che ne regola tempi modi e circostanze d’azione, operano a tutela di tutti e di ciascuno. Nessun privato cittadino, singolarmente preso o in associazione con altri, può pretendere da chicchessia comportamenti altri dal rispetto delle norme giuridiche. La libertà di pensiero e espressione non ha altri limiti che quelli imposti dalle stesse norme. Valga ora e sempre la massima di Evelyn Beatrice Hall (erroneamente attribuita a Voltaire): «I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it» (Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo).
Questi sacrosanti principi sono fatti a pezzi dal Fascismo e dal suo capo-padrone. L’umanità regredisce di secoli e interpreta alla lettera la dottrina machiavelliana secondo la quale il potere (il principato) si può conquistare con la violenza delle armi. Di bande armate si serve il “principe” per arrivare ai vertici dello Stato. Intimidazioni, torture e ammazzamenti seviziano un popolo già prono alla cavezza, per ignavia forse o per sgomento. Tutto questo è raccontato e documentato da Antonio Scurati nel suo ottimo “M. Il figlio del secolo”[1], premio Strega 2019.
Ora leggiamo il secondo volume della progettata tetralogia sulla figura e l’opera di Benito Mussolini, “M. L’uomo della Provvidenza”[2]. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, dichiara Pio XI il 13 febbraio 1929 all’Università Cattolica di Milano, legittimando l’ideologia e l’opera del Fascismo, non diversamente dalla stampa internazionale dell’epoca che ne celebra il successo politico. Mussolini si atteggia a grande statista; ha appena sanato un conflitto durato quasi un sessantennio. La netta separazione tra trono e altare che, riconoscendo l’assoluta libertà della religione, rivendica l’autonomia della politica e la laicità dello Stato, riceve il suo colpo di grazia, riportando indietro l’orologio della Storia. Il Concordato e i Patti Lateranensi sono il capolavoro machiavellico di un regime senza Dio, gli procacciano la “simpatia” del potente mondo cattolico in aggiunta alla mitografia che ha già fatto del duce un miracolato, per essere scampato, in un solo anno, a ben quattro attentati le cui dinamiche sono ancora tutte da chiarire, ma le cui eco mediatiche hanno già originato il mito. Uomo solo Mussolini, in questa sua opera di normalizzazione che dura otto anni, quanti gliene servono per asservire un paese, domesticarlo e dargli la parvenza di normalità, beninteso una normalità autocratica e autoreferenziale il cui unico strumento di dominio è la sferza di una doppia polizia, una pubblica, l’altra di partito, che scova dovunque nemici veri o presunti, li neutralizza o li sopprime, li diffama o li umilia pur di lusingare il narcisismo di un uomo solo. Esemplare il caso di Augusto Turati, il fedele segretario del partito vittima della sua stessa intransigenza. Fa addirittura pena vederlo infamato dal più feroce degli “intransigenti” di regime, il corrotto Farinacci che lo stesso Mussolini teme. L’estromissione di Turati è solo la più spettacolare disfatta della guerra in seno al partito fascista. Già, un dittatore deve guardarsi le spalle quotidianamente. I nemici esterni sono in qualche modo prevedibili, quelli interni sono subdoli e di difficile controllo. Il Fascismo non crollerà, collasserà per opera di una competizione interna che non ha eguali, per la corruzione e il clientelismo, per la miopia a cui il narcisismo patologico induce.
L’immagine che Scurati offre del regime è quella di una malattia eretta a governo di un popolo. I narcisisti sono molto pericolosi, per sé e per coloro alla cui adulazione si affidano. L’inganno consiste in questo: nessuno ama i dittatori, ma tutti li lusingano, per convenienza o per paura. Ma saranno pronti a tradire alla prima occasione. D’altronde il narcisista patologico non è capace di empatia, traduce in ricatto e terrore la sua dappocaggine. Quanto può durare un potere nato dal banditismo e dall’autoreferenzialità? I dittatori finiscono quasi sempre male, una volta che circostanze impreviste gli strappano la maschera e ne rivelano il volto avvizzito. Dietro la sembianza seducente di Dorian Gray si cela la morte, siatene certi.
Adesso andate a leggere le storie di tutti i personaggi di questa commedia degli orrori; ne ricaverete qualche utile insegnamento. Non è un noir, benché ne abbia tutta l’apparenza. È storia narrata. Valgano per tutti due personaggi femminili: Mafalda di Savoia, al cui sontuoso matrimonio Mussolini prese parte. Morirà, lo sapete, in un campo di concentramento non diverso da quelli che gli italiani costruirono in suolo libico. Non meno pena fa la figura di Margherita Sarfatti, la più celebre amante del duce, ebrea, sì, ebrea, colei che lo aveva ripulito e introdotto nei salotti buoni. Guardatela fare anticamera quando, invecchiata ed abbandonata da tutti, le varrà negato l’accesso allo studio di Palazzo Venezia. Mussolini cerca carne fresca per la sua libidine vampiresca. Ma si sta anche scavando la fossa, credetemi. Lui teme, ma non può completamente tacitare quell’Azione Cattolica in seno alla quale va formandosi un’opposizione di pensiero pronta a farsi classe dirigente appena le circostanze glielo consentiranno. E non dimenticate che a prenderne il posto di capo del Governo, dopo l’approvazione, in seno al Gran Consiglio del fascismo, dell’ordine del giorno Grandi, sarà quel Pietro Badoglio che aveva governato Tripolitania e Cirenaica negli anni in cui Rodolfo Graziani massacrava con l’iprite intere tribù libiche e ne deportava un numero spaventoso nei diciotto campi di concentramento ivi costruiti. Mirabili le pagine in cui Scurati ci dà conto del genocidio del quale il regime non risponderà mai. Nessuna Norimberga è stata celebrata per il fascismo. Che, proprio per questo, è sopravvissuto a se stesso nei vari ducetti che, dal dopoguerra ai nostri giorni, ogni tanto galvanizzano consistenti gruppi di nostri connazionali, tra i quali piccole bande criminali pronte a servire il narcisista politico di turno.
Guardateli negli occhi i nostri politici, provate a capirne le reali intenzioni dietro la magniloquenza dei gesti o la retorica dello sbraitio. Vogliono la nostra anima, non il nostro consenso. Noi, per loro, siamo animali da soma, carne da macello. Credere, obbedire, combattere e … figliare: a questa si riduce la politica demografica del duce e dei suoi accoliti, mentre l’istruzione dei giovani è affidata al grottesco militarismo dell’Opera nazionale Balilla. Solo chi ha visto e capito si è sottratto all’inganno. Solo chi sa, vede e capisce salva la civiltà da un tremendo baratro. Questa seconda fatica di Antonio Scurati suona per noi come un monito o un campanello d’allarme.
Noi non abbiamo bisogno di cavezza, ma di cultura, partecipazione e responsabilità, i corollari della libertà. È così che garantiremo un futuro alle nuove generazioni.
Id: 1278 Data: 08/01/2021 12:00:00
*
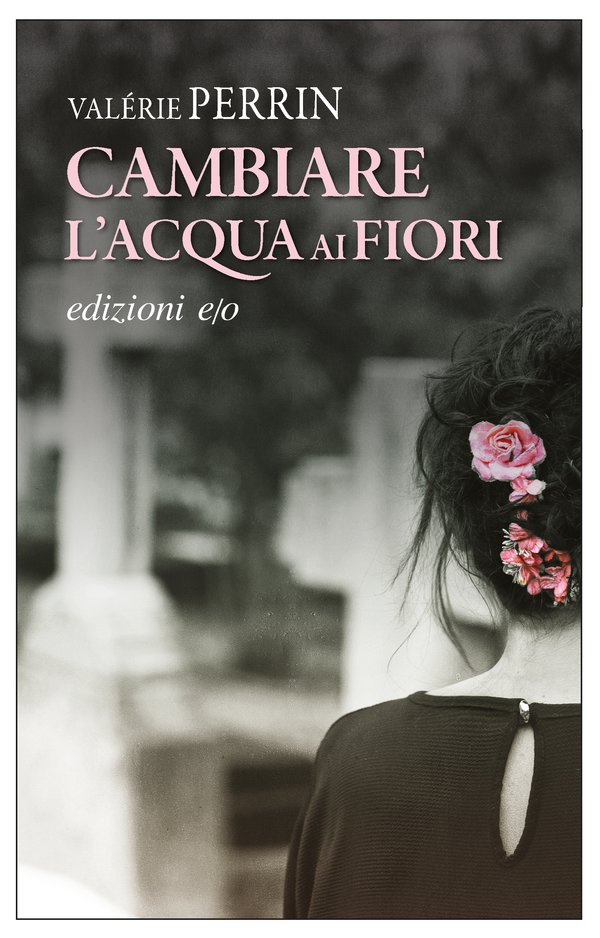 Valérie Perrin - Romanzo - edizioni e⁄o
Valérie Perrin - Romanzo - edizioni e⁄o
Cambiare l‘acqua ai fiori
«Se tenant par la main
L’air émerveillé
De deux chérubins
Portant le soleil
Ils ont demandé
D’une voix tranquille
Un toit pour s’aimer…»
[Claude Delécluse- Michelle Senlis, Les Amants d'un jour][1]
È una maliarda questa Valérie Perrin, della quale, fino a un mese fa ignoravo l’esistenza. Scrive: «Perché si va verso certi libri come si va verso certe persone? Perché siamo attratti da determinate copertine come lo siamo da uno sguardo, da una voce che ci sembra conosciuta, già sentita, una voce che ci distoglie dal nostro percorso, ci fa alzare gli occhi, attira la nostra attenzione e cambierà forse il corso della nostra esistenza?».
Avevo letto qualcosa relativa al successo improvviso e, a prima vista, inatteso del libro. Neppure avevo badato al nome della sua autrice. Corre voce che l’imprevista notorietà sia frutto del passaparola. Poco ci credo. Non al passaparola, che è possibile, ma al successo. Non sono un esperto di statistica, ma suppongo che, tra i pochissimi che leggeranno queste note, magari uno o due compreranno il libro. Si crea una minima catena di Sant’Antonio e lì si ferma. Le mie storte sillabe non arrivano né arriveranno al pubblico dei grandi media. Dunque, mai sarà mio merito il successo di “Cambiare l‘acqua ai fiori”[2].
Entro in libreria per acquistare altri libri, tutti di autori che usualmente seguo. Il romanzo della scrittrice francese compare in un angoletto del mio campo visivo, all’estremità sinistra. Invoca la mia attenzione, cioè la invoca il suo portavoce, non l’autrice, né l’editore, né il titolo. Giro la testa, metto a fuoco, prendo il libro e ne guardo la copertina con attenzione. Ah, mi dico, ecco il libro del passaparola! La foto in bianco e nero ritrae, in primo piano sul lato destro, il mezzobusto di una donna inquadrata di spalle. Lo sfondo è sfocato. Mostra un paio di croci marmoree che non si fa fatica a identificare come sepolcri. La mia mente va immediatamente alle memorie scolastiche. Già, i sepolcri non servono ai morti, servono ai vivi! La macchia di colore salta agli occhi. Il rosa del titolo e i fiori tra i capelli della donna (mi paiono begonie) sono un chiaro messaggio. Qui si celebra la vita, non la morte; se questa è presente sullo sfondo, vuol dire che ha una funzione ancillare.
Il colore rosa evoca uno stereotipo: nelle nostre culture è un marchio di fabbrica. Femmina certificata! Nessuno chiede a un neonato il colore che preferisce indossare. Le femminucce vestono rosa, i maschietti azzurro. Aut aut, non si discute!
Nella fattispecie il colore, oltre all’autrice, identifica la protagonista del libro, la sua disarmante femminilità alla quale puoi associare una sorta di solidarietà per l’universo delle donne e, più in generale, per le vittime delle culture discriminatorie. È il pink pride!
I maschi ci sono, ma più sullo sfondo, che siano figure caricaturali o delle autentiche carogne. La Perrin sembra accorgersene per tempo ed escogita gli stratagemmi per darcene una versione meno pregiudizievole. Anche i maschi hanno storie da raccontare, testimonianze da offrire; persino le carogne hanno un cuore. Chi non ha cuore è la cultura che genera, indipendentemente dai caratteri sessuali, marionette agite dagli automatismi inconsci di una tradizione ancestrale di cui ben pochi conoscono le scaturigini.
In principio era la Francia, anzi il suo stereotipo. Noi europei vi abbiamo fatto i conti fin dai banchi di scuola. Chi non conosce Carlo Magno? Beh, probabilmente non il personaggio storico ma la sua leggenda, che i francesi ancora coltivano come i fiori di Violette Toussaint. Le “Chanson de geste”, l’epica cristiana, celebrano Roland, l’eroe protoromantico che muore a Roncevaux per difendere la propria fede e l’onore del sovrano. Più pregnante, ai fini di ciò che intendo dimostrare, è il cosiddetto “ciclo bretone”, cioè le belle storie di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. E qui mi viene da pensare che né Ginevra né Isotta erano donne libere. Gli amori, rispettivamente di Lancillotto e di Tristano, erano vicende adulterine. Aggiungerei che tutta la lirica trobadorica canta amori extraconiugali. Sorvolo, in questa sede, sugli emuli nostrani della lirica occitanica.
Bene, mi sento di affermare che il romanzo di Valérie Perrin trae gli auspici da questa illustre tradizione. Non celebra, ma rappresenta l’adulterio così come può essere percepito e vissuto nella nostra età volgare e presso le presenti culture di matrice illuministica. L’infedeltà coniugale è dunque un tema che ha tradizioni antichissime, sia pure ammantato da una mistica dell’amore che poco o nulla toglie all’illiceità del rapporto. In tal senso l’amore è trasgressione, se non violazione di legge e, come tale, si oppone alla morale come alla norma giuridica. Eppure, i trasgressori possono essere delle persone perbene. Si prenda il caso di Irène Fayolle e Gabriel Prudent, due personaggi del romanzo. Entrambi sposati, ci appaiono come amanti “cortesi”, si danno reciprocamente del lei, nessuno dei due abbandona il tetto coniugale. Coltivano un amore “segreto” fino alla fine dei loro giorni. È il loro modo di salvare capra e cavoli. Si illudono che il loro legame possa vincere anche la morte. Eros e Thanatos, la pulsione di vita e la pulsione di morte, sono il leitmotiv dell’intero romanzo, anche se il primo elemento del binomio sembra trionfare quando persino la reticente Violette, protagonista e prevalente voce narrante dell’opera, ne intende le istanze, le medesime trascritte nel diario della Fayolle.
«Quando un uomo va dalla sua amante deve sentirsi in vacanza, non a casa». A parlare è la contessa di Darrieux, maritata e adultera da venticinque anni. Poco prima aveva affermato: «Che me ne sarei fatta del grande amore ventiquattr’ore su ventiquattro? È un lavoro!». Poi ricorda L’amante di Lady Chatterley, il romanzo scandalo che oggi non scandalizzerebbe più nessuno. Poco oltre evoca La chanson des vieux amants, musica di Gérard Jouannest, testo di Jacques Brel, un binomio affine al connubio di musica e testo poetico (motz e son) della poesia trobadorica. Le poesie-chansons di Jacques Prévert sono il prototipo contemporaneo della canzone d’autore, un genere che, partendo sempre dalla Francia, ha raggiungo agevolmente i nostri lidi, non mancando di influenzare la produzione musicale e lirica di ben noti cantautori italiani: Lauzi, Bindi, Conte, De André, Paoli, Tenco, Fossati, Battiato e tantissimi altri.
I nomi celebri abbondano nel romanzo della Perrin. Ne ho contati oltre settanta, tra scrittori, cineasti, musicisti, attori, attrici. La loro presenza nel corpo della narrazione rinvia alla marcata ipertestualità dell’opera. Gli illustri personaggi, molti dei quali di fama internazionale, suonano come altrettanti link attinenti sia ai temi intrinseci che al contesto culturale nel quale è maturato il progetto artistico. Le poche note del risvolto di quarta ci dicono che l’autrice è la moglie di Claude Lelouch e che è stata fotografa di scena delle più importanti produzioni cinematografiche francesi. Allora i conti tornano. Il romanzo si inserisce a pieno titolo nel genere esistenziale al quale il cinema ha attinto a piene mani dal secondo dopoguerra ai nostri giorni. Mi sembra di poter intravedere nella produzione letteraria di Françoise Sagan e nelle numerose versioni filmiche dei suoi romanzi un modello di riferimento, compreso il colore rosa che si profila sopra lo sfondo di un nitido banco e nero e che allude alla sensualità e alla seduzione, il preludio del nudo erotismo, l’erotismo degli amanti. Non a caso due celebratissimi film, Un uomo, una donna di Lelouch (puta caso!) e Effetto notte di François Truffaut rinviano sia ai temi chiave del romanzo sia ai moduli espressivi ai quali la Perrin attinge a piene mani. Il cinema non descrive, fotografa; allo stesso modo l’autrice del libro evita accurate caratterizzazioni fisiche e ricorre al paragone secondo il quale il suo personaggio somiglia a qualcuno che il lettore dovrebbe conoscere. A me fa pensare al casting: che faccia dovrebbe avere Julien Seul? Probabilmente quella di Serge Gainsbourg. Allo stesso modo Philippe Toussaint, il seduttore implacabile, somiglia a Michel Berger, un celebre cantautore ormai scomparso.
Non sono esattamente bellezze classiche i supposti sosia dei personaggi maschili; volti irregolari, corpi di poca o nessuna grazia, a parte qualche particolare (le mani eleganti, ad esempio) fascinoso. Eppure, sono oltremodo attraenti e, in qualche caso, irresistibili. Hanno capelli spettinati e barbe incolte, sanno di tabacco e bevande alcoliche, poco curano l’abbigliamento. Alludono a una virilità d’altri tempi, un po’ bohémien un po’ sfrontata, qualche volta cinica. Ma hanno una marcia in più, un congenito sex appeal che li rende irresistibili. Le donne, il cui fascino o la cui bellezza sono qualità poco o per nulla magnificate, si abbandonano all’impulso irrefrenabile del congiungimento carnale. I segnali che le coppie di amanti si lanciano senza esplicita o consapevole intenzione hanno la forza di un imperativo categorico. Il sesso ne è l’imprescindibile corollario.
L’istintualità prevale sulla ragione; per quanti vincoli i partner dell’amplesso possano avere, l’attrazione spontanea dei corpi è travolgente. A giudicare dalla casistica del romanzo, non c’è vincolo matrimoniale che tenga di fronte al bisogno di appagamento dei sensi; e tuttavia può anche darsi il caso in cui l’adulterio consolidi il rapporto coniugale, ma traducendolo in sodalizio amicale, con quanta struggente pena per uno dei coniugi non è difficile immaginare. Può darsi anche il caso contrario, un’irredimibile frattura che approda al dramma, se non proprio alla tragedia. Si prenda il caso di Geneviéve Magnan, una donna non più attraente, con alle spalle il disastro di una famiglia sbilenca. Il suo bisogno di sesso è struggente fino alla degradazione di amplessi implorati, forse rubati a un uomo la cui sessualità ha le caratteristiche della compulsione. Qui siamo alla sciagura di un’esistenza subumana, all’annientamento della dignità.
È lo specchio della società contemporanea, delle sue insicurezze, delle sue contraddizioni. C’è uno stridente conflitto tra ciò che siamo e il ruolo che il contesto ci impone, per lo più col nostro consenso. Stipuliamo un contratto che ci lega, finché morte non ci separi, a un altro essere umano col quale siamo obbligati, per legge, a condividere oneri e onori. Il problema è che, goduti gli onori, restano solo ed esclusivamente gli oneri, vale a dire il tedio di una quotidianità che spegne slanci e entusiasmi, l’amarezza di vedere i nostri corpi avvizzire nell’assenza di desideri, il grigiore mortifero di un lavoro che poco o nulla ci appaga. Il compagno o la compagna di vita, parimenti afflitti dalla medesima apatia, sono sempre più silenziosi e distanti. Non c’è soluzione allo scorrere inesorabile del tempo. Se si vuole sfuggire alla lenta attesa della morte, occorre trovare un motivo per vivere e questo lo si trova lontano dalla gabbia delle relazioni legali. Compare l’amante, la sua sessualità prorompente e trasgressiva. Ci appaga, ci appaga di più e ci fa sentire vivi. Ormai cinema e letteratura celebrano il dato di fatto, proponendoci modelli comportamentali addirittura più seducenti della realtà, il web ci procura misteriosi partner occasionali, i club come “L’indirizzo” frequentato da Philippe Toussaint sono disseminati ovunque. «Quando un uomo va dalla sua amante deve sentirsi in vacanza, non a casa».
È questa la soluzione alla crisi della coppia tradizionale? Non lo so, davvero non lo so, soprattutto se penso alle conseguenze non sempre accomodanti delle nostre fughe: minori disorientati, depressione del partner abbandonato, violenze domestiche ai danni di donne supposte adultere. Senza considerare la grande disparità sociale tra benestanti e nullatenenti. Il divorzio consensuale non possono concederselo tutti: bisogna regolare i rapporti patrimoniali e ben pochi hanno un patrimonio da ripartire.
Qui entra in ballo l’ambientazione del romanzo. L’azione si svolge tutta in provincia, anzi l’autrice ci conduce in luoghi poco bazzicati dal turismo: dalle Ardenne, alla Provenza, dalla Borgogna all’Alvernia, dalla Bretagna al Midi. I luoghi sono piccole città o paesini, se si eccettuano le fugaci apparizioni di Marsiglia, Lione, Aix-en-Provence e, di sfuggita e per motivi drammaturgici, Parigi. I personaggi sono provinciali di modesta estrazione sociale, a parte l’avvocato Prudent per il quale occorre fare un discorso diverso. Credo che sia proprio lì, in provincia, che si radichi il peggior conservatorismo, il comportamento che più alimenta il pettegolezzo e lo scandalo, l’ambito culturale in cui maturano le grandi tragedie e divampano i conflitti più cruenti. È probabile che gli ambienti gauche caviar delle metropoli, dove una certa sicumera è funzionale ai ceti sociali che ne sono latori, mai imbastirebbero la tragedia di immani proporzioni alla quale assiste il lettore. Guardate che tutto avviene per l’ottuso tradizionalismo di Chantal Pelletier che, col marito cattolico baciapile, esprime un cinismo ributtante presto tradotto in cieca impudenza ben oltre i confini della perfidia. Ci troviamo dinanzi all’innocenza di chi non sa perché non vuole sapere. E non c’è nulla di più deleterio ed esiziale del perbenismo che non vuole contaminazioni di sorta. Esclude chiunque dalla propria angusta sfera mentale, ha la subdola e paziente integrità della faina («In questo paese appena uno sconosciuto varca una porta, un cancello o portico viene guardato con diffidenza»). Nessun tribunale condannerà simile genia, per mancanza di prove. Può farlo solo uno scrittore, il quale sa e disvela anche senza le prove perché conosce gli intimi moventi del crimine commesso. Nel nostro caso, se il lettore non è disattento, i delitti sono tre, ciascuno dei quali ha la parvenza dell’incidente, ma ben riconoscibili responsabili.
Ecco dunque affiorare l’annoso tema del rapporto tra legge e giustizia. La legge ha il dovere di fare il suo corso, ma difficilmente realizza la giustizia. Spetta a noi, a ciascuno di noi perseguirla e praticarla con la paziente investigazione del segugio che fiuta il fatto oltre l’inganno delle apparenze. La verità non è mai immediata e costa sudore della fronte.
È così che l’avvocato Gabriel Prudent, un degno figlio della cultura libertaria, affronta i casi giudiziari come la farragine della vita. Per celebrarne la figura e tramandarla alla posterità si cita un ben noto umo politico francese, Robert Badinter, il promotore della battaglia politica che, nel 1981, portò all’abolizione della pena di morte. Badinter è ebreo. Perse il padre e molti componenti della sua famiglia in un campo di sterminio nazista. Non è un caso isolato. I personaggi famosi citati nel libro hanno tutti un grosso vissuto alle spalle; molti di loro sono ebrei, discendenti dei sopravvissuti alla shoah, eredi dell’haskalah più che del sionismo; vale a dire che, integrati o assimilati che siano, sono parte della cultura e dell’identità europee. Valérie Perrin, senza volerlo, condivide l’accorata e argomentata lezione del suo conterraneo George Steiner, scrittore e saggista francese recentemente scomparso. Ne dissemina qui e là temi e argomenti. “Finalmente giustizia”, afferma Gabriel Prudent a proposito dell’estradizione di Klaus Barbie, il boia nazista di Lione. I riferimenti all’esperienza del Front populaire, alla guerra civile spagnola, alla resistenza e alle numerose famiglie francesi che nascosero e protessero gli ebrei durante gli anni dell’occupazione nazista ci dicono di che panni vesta l’autrice del libro. È degna figlia di quella cultura mitteleuropea progressista e inclusiva che, con l’impegno civile e politico, col paziente lavoro della formica, si è battuta per conciliare le libertà individuali con la giustizia sociale, che diffonde messaggi di tolleranza e inclusione e che ancora rappresenta l’unico credibile baluardo alla barbarie dei negazionismi e complottismi dilaganti, dell’ostinata ignoranza del popolo del web. Ciliegina sulla torta è il simpatico personaggio di padre Cédric Duras, il prete cattolico amico e confidente di Violette, il quale accoglie e adotta una giovane coppia sudanese di recente immigrazione, alla quale concede affetto, protezione e lavoro. La ragazza è incinta; Violette le carezza il ventre con atto benaugurante. La futura Europa è in questa carezza. Se il gesto a fatica raggiunge le nostre metropoli, è imprescindibile che ne conquisti le estese intercapedini, laddove si annida la ferocia dell’ignoranza e della miseria morale. Servono istruzione e libri come questo, ma l’una e l’altro sono probabilmente alle corde.
Non potevano mancare una casta storia d’incesto e una di omosessualità, entrambe scivolate dalla penna della scrittrice come per caso. La prima mi fa pensare alla struggente passione di Annabella nella tragedia 'Tis Pity She's a Whore di John Ford, il drammaturgo inglese di epoca elisabettiana che pare essersi ispirato a Julien e Marguerite de Ravalet, due fratelli accusati di incesto e giustiziati in Francia nel 1603. Non escludo che la Perrin abbia visto la più recente versione cinematografica dell’antico misfatto, se non altro perché la previa sceneggiatura del film fu scritta da Jean Gruault per François Truffaut, anche se poi il noto regista non diede seguito al progetto. Solo nel 2015 Valérie Donzelli realizzò il film, riscrivendone l’adattamento con Jérémie Elkaïm e chiosando la vicenda con forti simbologie. I cavalli selvaggi, i boschi, le parrucche, i volti petrosi dei giudici e le decapitazioni finali rinviano all’imperturbabilità del giudizio morale dinanzi al perenne rinnovarsi della vita. Le metafore visive possono apparire fuorvianti. Ma, se mi ci concede l’azzardo, a guardar bene la scrittrice e la regista mettono in scena lo stesso mileu, con modalità affini per certi versi, benché la regista indulga al pessimismo della rappresentazione metastorica attraverso la fissità dei ruoli (come in una favola) e la scrittrice, al contrario, storicizzando gli eventi, apra uno spiraglio sul futuro. Nel film la legge e la morale hanno lo stesso volto fossile; nel libro la legge ha il volto rassicurante dell’avvocato Gabriel Prudent o del commissario Julien Seul, mentre la morale ha l’espressione arcigna e sprezzante di Chantal Pelletier.
Quale delle due artiste ha ragione? Allo stato presente e in epoca di pandemia attorno a me vedo piuttosto ardere i roghi mediatici piuttosto che echeggiare le requisitorie e le arringhe delle asettiche aule di tribunale. La circostanza mi spaventa e non poco. Ma questo è affar mio.
Qualche riserva avrei sul caso di Sasha, un anziano omosessuale nei cui trascorsi la Perrin va a ficcare il naso. Sgomberandogli il cammino dagli ostacoli di un matrimonio fecondo, con ben due figli messi al mondo, la scrittrice ne appiana la drammaticità. Si tratta pur sempre di adulterio, benché Sasha tradisca la moglie con uomini e non con donne. Nella realtà, di omosessuali coniugati e con figli ce ne sono molti e dubito che approdino all’equilibrio dell’omologo immaginato dalla scrittrice. Può capitare che abbiano mogli sprovvedute che poco investigano sulle loro fughe verso altri lidi; oppure, più consapevoli, abbozzino per salvaguardare la pace domestica. Tuttavia, non si può escludere che la magagna venga a galla e proprio non saprei dire con quali effetti sull’equilibrio di ciascuno dei membri della famiglia. Che io sappia, qualcuno paga e non è raro il caso che paghi pesantemente. Aggiungerei la circostanza che presso le culture più tradizionaliste la vita di un omosessuale maschio è tutt’altro che allegra. Per evitare lo scherno e l’esclusione, questi poveracci sono costretti a sposarsi e a fare figli. È difficile pensare che tutto fili liscio come l’olio. Gli effetti di una simile coercizione potrebbero essere esiziali.
Al netto di simili questioni, il personaggio di Sasha appare come l’ideale figura paterna (una sorta di Jean Valjean contemporaneo), allo stesso modo in cui Célia adombra la madre amorevole che la sventurata protagonista del romanzo non ha mai avuto.
Non c’è dubbio che l’omaggio a Victor Hugo, un nome che appare nel corpo della narrazione, sia pari ai numerosi altri debiti qua e là esplicitati. Per molteplici che siano le fonti, letterarie, cinematografiche, cantautorali, il felice impasto appartiene all’autrice del romanzo. La storia è appassionante, l’organizzazione della materia avvincente, la prosa adoperata di disarmante immediatezza. Il gioco vale la candela e, a prescindere dalla mia cavillosità, c’è quel colore rosa che spicca sul bianco e nero del nostro presente. È lo spiraglio di luce in fondo al tunnel.
Id: 1264 Data: 27/11/2020 12:00:00