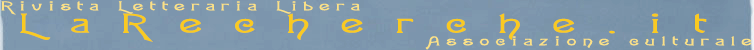https://www.academia.edu/128950469/Is_Poetry_Dead
Calliope, musa della poesia epica era del pittore Carlo Maynier in 1798. La fine 220 la versione originale di un anno ha le seguenti dimensioni Complessivo: 275 x 177 cm (108 1/4 x 69 11/16 in) ed è stato realizzato sul mezzo olio su tela. Oggi, l'opera d'arte si trova nella collezione digitale del Cleveland Museum of Art, che è uno dei principali musei al mondo che costruisce, conserva, studia e condivide le sue eccezionali collezioni d'arte di tutte le epoche e parti del mondo, generando nuova borsa di studio e comprensione, mentre funge da centro sociale e intellettuale per la sua comunità. Questo dominio pubblico capolavoro è incluso con la cortesia di Il museo d'arte di Cleveland. La linea di credito dell'opera d'arte è: Severance e Greta Millikin Purchase Fund. Inoltre, c'è l'allineamento della riproduzione digitale ritratto formato con un rapporto di 2: 3, Il che significa che la lunghezza è del 33% più corta della larghezza. Charles Meynier è stato un pittore, disegnatore, incisore di nazionalità francese, il cui stile artistico può essere attribuito principalmente al neoclassicismo. L'artista francese è nato a 1768 a Parigi, Ile-de-France, Francia e morì all'età di 64 nell'anno 1832.
E' morta la Poesia?
La poesia che in passato era composta in metrica e rima, è stata volutamente - a partire dagli esordi del secolo scorso, in particolare durante e dopo le due guerre mondiali - avviata verso una forma di scrittura prosaica. Unica invariante, ma non sempre, l'andata a capo come a mimare una sorta di metrica o rima, ovvero uno stile poetico cadenzato come per gli antichi greci e latini.
...“Per gli antichi le cose andavano diversamente. L'accento tonico della parola e la durata delle sillabe costituivano due aspetti coesistenti e autonomi. L'accento tonico, che poteva cadere sia su sillabe lunghe che su sillabe brevi, doveva essere fatto sentire con un innalzamento dell'intonazione vocalica sulla sillaba accentata, che pertanto risultava più acuta rispetto alle sillabe non accentate. Questo doveva accadere sia nel parlare quotidiano che nella recitazione poetica.
Dovremo quindi concludere che per gli antichi la lettura di un brano poetico non comportava nessuna difformità rispetto ad una normale lettura, né nella pronuncia di chi recitava né nella percezione dell'ascoltatore. La ritmicità della recitazione era l'inevitabile risultato dell'alternarsi regolare di sillabe lunghe e brevi che costituivano il testo poetico.
L'abilità del poeta consisteva dunque nel produrre un testo significativo, espressivo e nello stesso tempo costituito da una successione di sillabe lunghe e brevi coerente con lo schema metrico di volta in volta prescelto. Le lingue classiche, sia il Greco che il Latino, si differenziano dalle nostre lingue, oltre che per molti altri aspetti, in particolare per il fatto di distinguere consapevolmente, nell'ambito delle parole, sillabe brevi e sillabe lunghe. Come dire che le singole sillabe hanno una durata che di volta in volta è determinata da vari fattori: la durata della vocale che costituisce la sillaba, il fatto che si tratti di sillaba aperta o chiusa, terminante cioè in vocale o consonante, ecc…. Quello che importa è il fatto che ogni parola è costituita da una sequenza di sillabe, ciascuna delle quali è lunga o breve. In una normale sequenza di parole, quale potrebbe essere un qualsiasi brano in prosa, il susseguirsi di sillabe lunghe e brevi è inevitabilmente irregolare, con la conseguenza che la lettura di un brano in prosa non dà come risultato nessuna percezione di ritmicità.
Diverso il discorso per la poesia, che proprio in questo si distingue dalla prosa: la successione di sillabe lunghe e brevi deve presentare una qualche regolarità, tale da garantire la ritmicità della lettura di un brano poetico. Per metrica si intende appunto lo studio sistematico dei ritmi della poesia, determinati da una successione regolare di sillabe lunghe e di sillabe brevi. Da queste premesse risulta chiara la peculiarità della poesia classica rispetto alle nostre più recenti forme di poesia, la cui musicalità è determinata dalla presenza della rima, o dal susseguirsi di versi caratterizzati da un identico numero di sillabe o dalla collocazione degli accenti tonici della parola su sillabe prestabilite.
È per questo che si parla di poesia quantitativa e accentuativa per indicare rispettivamente la poesia classica e le altre forme di poesia”... Tratto da”Metrica greca e latina”.
Da Dante e dal Dolce Stil Novo (1200) in poi c’è una sostanziale evoluzione del linguaggio poetico che avrà conseguenze anche sul linguaggio successivo.
Ad esempio, la rima " incatenata " (ABA BCB CDC …) si ha nelle terzine dantesche (schema usato da Dante nella Divina Commedia) così come su “La riva del Serchio, a Selvapiana” di Giovanni Pascoli o anche in Pier Paolo Pasolini ne "Le ceneri di Gramsci", con connotazione alquanto diversa e più popolana (metrica e rima non sempre vengono rispettate).
Dopo l’Ermetismo del 1900, in cui il poeta si chiuse in sé stesso, naufrago da un mondo squassato da conflitti e senza apparente redenzione, si diventò inclini a perseguire nuove forme e sperimentazioni artistiche in tutti i campi delle Arti.
Prima e dopo la Grande Guerra, c’è stata una riscossa in tutti gli ambiti artistici, un desiderio di rinnovamento, la rottura dei preesistenti schemi.
Al giorno d'oggi imperversa l’uso o abuso di nuovi stilemi: haiku (è un componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo, composto in genere da tre versi), aritmie del verso, parole a volte senza senso buttate là per sorprendere e stupire il fruitore della poesia, non per rappresentare un’emozione.
Nell'epoca digitale, ci si sente quasi obbligati ad usare frasi brevi, un gergo conciso e stringato.
L’aforisma è molto in voga, anche se non sempre nel linguaggio comune che si lascia spesso andare a contrazioni linguistiche, nel gergo telefonico abbreviato, costituite da “xchè” o “ke”.
Si brucia tutto in fretta: amore o poesia, poco importa! Quest’ultima viene avvertita sostanzialmente come malinconia, una forma di tristezza, sgradita ai più, giovani o meno giovani.
In quest’epoca di sfrenato edonismo, in cui si cerca di rimuovere ogni sofferenza distogliendo lo sguardo da ciò che non ci appaga, è importante consumare tutto in fretta dal sesso alla lettura, dai sentimenti alla pratica di vita.
La poesia, quella vera, risulta troppo impegnativa, rendendo le persone più riflessive e tristi, anche quando canta la gioia che, però, non vibra più tra le pieghe di anime ormai anestetizzate.
E’ morta dunque la Poesia? Eppure c’è, oggi più che mai, una proliferazione di poeti, veri o sedicenti. Evidentemente, è innato nell’uomo quel sentimento di natura e di bellezza con tutti i suoi fardelli di sofferenza, che induce a riflettere sul proprio destino e a cercare un riscatto anche attraverso il dolore.
***
Is Poetry Dead?
Poetry, which in the past was composed in metrics and rhyme, has been deliberately ̶ starting from the beginning of the last century, especially during and after the two world wars ̶ directed towards a form of prosaic writing. The only invariant, but not always, is the line break as if to mimic a sort of metrics or rhyme, or a cadenced poetic style as for the ancient Greeks and Latins. ...“For the ancients, things were different. The tonic accent of the word and the duration of the syllables were two coexisting and autonomous aspects. The tonic accent, which could fall on both long and short syllables, had to be made felt with a raising of the vowel intonation on the accented syllable, which therefore appeared more acute than the unaccented syllables. This had to happen both in everyday speech and in poetic recitation.
We must therefore conclude that for the ancients, reading a poetic passage did not involve any difference from a normal reading, neither in the pronunciation of the person reciting nor in the perception of the listener. The rhythm of the recitation was the inevitable result of the regular alternation of long and short syllables that constituted the poetic text.
The poet's ability therefore consisted in producing a meaningful, expressive text and at the same time constituted by a succession of long and short syllables consistent with the metrical scheme chosen from time to time. The classical languages, both Greek and Latin, differ from our languages, in many other respects, in particular by the fact that they consciously distinguish, within words, between short and long syllables. That is to say that the individual syllables have a duration that is determined from time to time by various factors: the duration of the vowel that constitutes the syllable, whether it is an open or closed syllable, ending in a vowel or consonant, etc. What matters is the fact that each word is made up of a sequence of syllables, each of which is long or short. In a normal sequence of words, such as any piece of prose, the succession of long and short syllables is inevitably irregular, with the consequence that reading a piece of prose does not result in any perception of rhythm. The situation is different for poetry, which is precisely in this respect that it is distinguished from prose: the succession of long and short syllables must present some regularity, such as to guarantee the rhythm of reading a poetic piece. Metrics is the systematic study of the rhythms of poetry, determined by a regular succession of long syllables and short syllables. From these premises, the peculiarity of classical poetry is clear compared to our more recent forms of poetry, whose musicality is determined by the presence of rhyme, or by the succession of verses characterized by an identical number of syllables or by the placement of the tonic accents of the word on pre-established syllables. This is why we speak of quantitative and accentual poetry to indicate respectively classical poetry and other forms of poetry”... Taken from “Greek and Latin Metrica”.
From Dante and the Dolce Stil Novo (1200) onwards there is a substantial evolution of poetic language that will also have consequences on subsequent language.
For example, the “chained” rhyme (ABA BCB CDC …) is found in Dante’s tercets (a scheme used by Dante in the Divine Comedy) as well as in “La riva del Serchio, a Selvapiana” by Giovanni Pascoli or even in Pier Paolo Pasolini in “Le ceneri di Gramsci”, with a rather different and more popular connotation (metrics and rhyme are not always respected).
After the Hermeticism of 1900, in which the poet closed himself off, castaway from a world shaken by conflicts and without apparent redemption, people became inclined to pursue new forms and artistic experiments in all fields of the Arts. Before and after the Great War, there was a revival in all artistic fields, a desire for renewal, the breaking of pre-existing patterns.
Nowadays, the use or abuse of new stylistic devices is rampant: haiku (a poetic composition born in Japan in the 17th century, usually composed of three lines), arrhythmias of the verse, words sometimes without sense thrown in to surprise and amaze the user of the poetry, not to represent an emotion. In the digital age, we almost feel obliged to use short sentences, a concise and terse jargon.
The aphorism is very much in vogue, even if not always in common language that often gives in to linguistic contractions, in abbreviated telephone jargon, consisting of "xchè" or "ke". Everything burns quickly: love or poetry, it doesn't matter! The latter is essentially perceived as melancholy, a form of sadness, unpleasant to most people, young or old.
In this age of unbridled hedonism, in which we try to remove all suffering by looking away from what does not satisfy us, it is important to consume everything quickly from sex to reading, from feelings to life practice.
Poetry, the real kind, is too demanding, making people more thoughtful and sad, even when it sings of joy that, however, no longer vibrates in the folds of souls that are now anesthetized.
Is Poetry Dead? Yet there is, today more than ever, a proliferation of poets, real or self-styled. Evidently, that feeling of nature and beauty with all its burdens of suffering is innate in man, which leads to reflecting on one's destiny and seeking redemption even through pain.

I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Franca Colozzo, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.