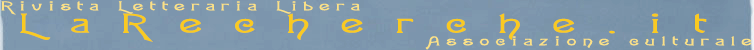Se mi capita davanti agli occhi una carta dell’Africa, il mio sguardo si posa in maniera automatica sull’Africa orientale, l’Eritrea e l’Etiopia, ed in particolare, sul lungo percorso che congiunge Massaua sul Mar Rosso, con Addis Abeba. Dalle informazioni raccolte da varie fonti, posso dire di avere una certa conoscenza delle tappe principali di questo percorso e delle regioni attraversate. Nella prima parte si incontra il caldo torrido di Massaua, antica “Perla del Mar Rosso”, “ rasa al suolo nel corso della recente lotta di liberazione”, poi il passaggio brusco, in soli cento chilometri, dal livello del mare ai 2350 m. di Asmara, la capitale dell’Eritrea, posta sul bordo orientale dell’altopiano etiopico, con un clima “montano tropicale”, mite e temperato, con “cieli tersi per otto mesi l’anno”. Superata, idealmente, la frontiera fra i due paesi – oggi chiusa, dopo l’ultimo conflitto, a tempo indeterminato – è possibile raggiungere con un autoveicolo in un giorno e mezzo Addis Abeba, posta a 2400 m., la terza capitale del mondo per altitudine.
Lungo questo tragitto, o con brevi deviazioni, il turista incontra ambienti che offrono “le migliori opportunità in Africa per praticare il trekking e per avvistare le più interessanti specie di animali”; per visitare, d’altra parte, luoghi che conservano un patrimonio unico nella storia dell’umanità. Basti ricordare Yeha, l’antica capitale dell’Etiopia che conserva testimonianze antiche di 3000 anni, Aksum, la città santa, dove si trovano tombe precristiane ai piedi di splendide stele risalenti a 1800 anni fa, Lalibela, dove undici straordinarie chiese scolpite nella roccia e una miriade di gallerie, “hanno cristallizzato nella pietra l’Etiopia del XII e del XII secolo”.
Questo stesso itinerario compì, con uno sguardo ben diverso da quello del turista di oggi, mio padre nel 1935/1936, che partecipò, richiamato alle armi, alla guerra d’Etiopia. Il suo racconto, ascoltato quando ero ragazzo, di reduce dalla guerra ha lasciato tracce indelebili nella mia memoria.
Il “viaggio” cominciò da Firenze, la sua città, in maniera improvvisa, nell’estate del 1935. Alla partenza non vi fu il saluto entusiasta di una folla di concittadini, come ci mostrano molte riprese dei cinegiornali dell’epoca. Una cartolina precetto – i voucher più alla moda in quell’epoca – raggiunse la casa popolare del quartiere di Rifredi, dove viveva con la famiglia. La trovò di ritorno dal lavoro. Proprio non se l’aspettava. Aveva 28 anni e aveva già dato ventiquattro mesi della sua giovinezza al regio esercito, in un reparto di cavalleria, e credeva che la partita ormai fosse chiusa con la vita militare. Da pochi mesi aveva trovato un posto di lavoro come operaio in una fabbrica di confezioni presente nel quartiere, diretta da un proprietario noto nella zona per il buon rapporto con i dipendenti. Sia detto per inciso, che questa persona finirà nei forni di Mathausen, per le sue origini ebraiche. Il nuovo lavoro era un sostegno prezioso per la famiglia che attraversava periodi nei quali non era facile mettere insieme il pranzo con la cena.
La cartolina precetto portava l’ordine di presentarsi immediatamente a Pisa, in una caserma, senza indicare la destinazione finale. Arrivato a Pisa apprende, insieme ai nuovi compagni, che la destinazione era l’Eritrea dove avrebbe preso parte alla spedizione contro l’Abissinia: “L’imbarco sarà a Napoli fra tre giorni”. Nella notte Bruno, con altri compagni, scavalca il muro di recinzione della caserma e salta su un treno in corsa per Firenze, per evitare di essere fermato dalla polizia militare. Arriva la mattina dopo a casa ed ha appena il tempo di raccontare alla famiglia cosa l’aspetta che per le scale risuonano i passi di una pattuglia di carabinieri. E’ prelevato e condotto a Napoli, all’imbarco per l’Eritrea, senza che subisca alcuna condanna per la fuga: “Intanto, peggio che in Africa …”, si sente dire dai superiori.
Nel racconto di mio padre il primo motivo che mi colpisce, è quello della scoperta, della meraviglia. La partenza da Napoli in mezzo ad una miriade di bandiere e ad una folla festante ai piedi di un enorme piroscafo bianco, con il nome di un duca della famiglia Savoia, poi il viaggio di sette giorni per mare, l’incontro con i colori dell’Oriente a Porto Said, in Egitto, la nave circondata da un bazar di barche, cariche delle merci più strane, i ragazzi che si tuffano in mare per ripescare le monete gettate dai soldati, il bianco accecante delle due sponde desertiche del Canale di Suez.
Il continente africano era pieno di sorprese, di meraviglie che balzavano fuori dalla visione di un paesaggio vario e grandioso, dalla sensazione nuova dello spazio, dall’ampiezza degli orizzonti, della limpidezza dell’aria sugli altipiani, con lo spettacolo sempre nuovo delle albe e dei tramonti, con la magia delle notti africane splendenti di vivissime stelle, notti abitate spesso dall’urlo delle iene e degli sciacalli. Mi sembrava che le parole di mio padre prendessero spesso il tono della malinconia.
Il racconto poi dei dieci mesi trascorsi in Africa, si snodava attraverso una trama fitta di episodi, di sensazioni, della quale mi sono rimasti nella memoria solo alcuni flash, un numero limitato di tracce sufficienti, tuttavia, per ricostruire alcuni capitoli di questa storia.
Da Massaua i protagonisti di questa storia diventano due, mio padre e il mulo che gli viene affidato per il trasporto delle salmerie da parte di una compagnia. Il mulo ha un nome, Paciuk, diventa l’amico con cui si parla, ci si confida, risponde prontamente agli ordini, le sue reazioni sono importanti per avvertire il pericolo di un nemico in agguato; rappresenta un riparo per spostarsi durante gli scontri, è un sostegno nelle marce più dure, ci si attacca alla coda quando i sentieri in salita, per raggiungere gli altopiani, sono più aspri o si tratta di affrontare percorsi aperti su profondi dirupi. Era vivo il ricordo, quando la paura, l’ansia era più forte, delle reazioni dell’animale, il suo sguardo, il movimento delle orecchie, il restare, a volte, immobile davanti a fruscii, ombre, rifiutando di andare avanti.
A momenti spuntavano nella narrazione alcune parole in aramaico, fra le più semplici, come acqua, cibo, lo scambio di saluti. La sensazione che percepivo era quella di una costante diffidenza nei confronti degli abitanti dei villaggi attraversati, spesso di paura specie quando i tucul apparivano disabitati e sembrava, tuttavia, di essere seguiti dallo sguardo di qualcuno. La paura raggiungeva il suo apice nei casi in cui doveva andare, da solo, a prendere l’acqua per la compagnia da un torrente, presso uno stagno, una pozzanghera. L’acqua, in questo caso, era fliltrata mettendo il fazzoletto sulla bocca delle borracce.
Le parole ripetute con più frequenza erano quelle dei luoghi degli scontri, tutti con nomi scoppiettanti, come Sellaclacla, Taccazzè, compresi i nomi dei capi abissini, come quello di Ras Immirù. Era costante il ricordo delle armi primordiali dei soldati abissini, spesso si trattava di lance, spade, scudi. Percepivo tuttavia nelle parole del racconto l’ammirazione per il coraggio di questi soldati nel combattere.
La narrazione è ritornata infinite volte su una battaglia – mi sembra di ricordare nella zona di Sellaclacla – che vide il battaglione di cui faceva parte mio padre, circondato sulla cima di un monte dalle truppe di Ras Immiru. La battaglia durò tre giorni e tre notti. I soldati abissini si lanciarono a più riprese, sguainando sciabole e pugnali, contro gli italiani asserragliati sul monte. “Arrivavano a ondate, davanti ai fucili e alle mitragliatrici che spazzavano il terreno circostante. Più volte qualcuno riuscì ad afferrare la canna delle mitragliatrici, prima di cadere, dilaniato dai colpi. Sembrava proprio, questa volta, di essere arrivati alla fine! Alla terza notte, l’assedio cessò, i soldati abissini scomparvero nel nulla”.
Poche volte il racconto si è fermato – quasi per pudore – su un episodio di feroce atrocità. La compagnia arrivò ad un villaggio immerso nel silenzio, i tucul vuoti. Mio padre scorge nell’erba alta uno strano batuffolo, lo alza, è la testa di un bambino. Il giorno precedente era passata una squadra di camicie nere e aveva fatto scempio degli abitanti del villaggio, un gioco al tirassegno su tutto quello che si muoveva.
Cosa mi rimane di questo racconto? I frammenti di memoria che ho riportato, una croce di guerra di ferro al valor militare ornata da un nastrino bianco e azzurro, una fotografia dell’epoca che mostra un giovane – mio padre – magrissimo, curvo, con un sorriso stanco, la pelle scura bruciata dal sole. A questa immagine mi è naturale unire il ricordo delle cicatrici che aveva sulle gambe, per le punture delle zecche e delle “pulci perforanti”.
Più volte ho cercato di ripercorrere idalmente questo percorso da Massaua ad Addis Abeba attraverso le pagine di libri di storia e di guide turistiche, per cercare di fare rivivere questi frammenti di memoria nel loro contesto geografico e storico.
Un libro utile per la mia ricerca è stato il recente libro di Angelo Del Boca “La guerra di Etiopia” (Longanesi, Milano 2010). Ho colto dalla ricostruzione storica dell’autore lo sguardo ansioso, assillante di Mussolini, sull’avanzata italiana lungo la direttrice da Asmara ad Addis Abeba, la volontà di alimentare la macchina del consenso nazionale, di procedere rapidamente nell’avanzata per mostrare al mondo risultati vittoriosi e rispondere alle pressioni della Società delle Nazioni. Effetto immediato di questo, la chiamata alle armi di un enorme contingente di soldati, l’invio spasmodico di ulteriori rinforzi dopo le difficoltà incontrate nei primi mesi di guerra e le pressanti richieste di ulteriori forze da parte dei comandanti in capo, Del Bono e poi Badoglio.
Da Roma partono anche le autorizzazioni per il massiccio impiego di gas velenosi, dell’iprite in particolare, specie nelle fasi decisive della guerra. Dalle fonti storiche del libro, emergono le testimonianze di episodi atroci di fanatismo, di rappresaglie; valga per tutte, quella del figlio di Mussolini, Vittorio, aviatore: “ Una bella sventagliata e l’abissino era a terra. era dunque una caccia isolata all’uomo, come al solito, e ogni apparecchio, per conto suo, frugava ogni buco annusando l’abissino”, “ Era un lavoro divertentissimo e di un effetto tragico ma bello. […] Bisognava centrare bene il tetto di paglia e solo al terzo passaggio ci riuscii. Quei disgraziati che stavano dentro e si vedevano bruciare il tetto saltavano fuori come indemoniati” ( V. Mussolini “Voli sulle ambe”, Sansoni, Firenze 1936).
Nel libro di Del Boca si trovano testimonianze poi diffuse sul valore dei soldati abissini, sul modo di cambattere con armi primitive, quasi privi di armi moderne. In una battaglia nella zona Abbi Addi, un ufficiale italiano riferisce che gli abissini calano dalle alture ad ondate successive, usando più le sciabole che le armi da fuoco, abbattono i serventi sulle loro mitragliatrici, arrivano a pochi passi dai pezzi di artiglieria (pag. 136). La stessa immagine, dunque, delle parole di mio padre “arrivavano ad ondate”, quando parlava dell’assedio del suo reparto sulla cima di un monte.
Il libro di Del Boca, attraverso i documenti di fonte etiopica e le interviste ad alcuni portagonisti, ci presenta cosa succedeva sugli altipiani e le montagne etiopiche oltre le linee italiane. Emerge la figura dell’imperatore Hailè Selassiè, la sua voce forte che si alza all’inizio della guerra per invocare l’aiuto della Società delle Nazioni e delle maggiori potenze, che diventa sempre più flebile, inascoltata. La sua abilità strategica di ricorrere, specie nelle prime fasi, alla guerriglia per sfruttare le capacità naturali dei soldati, e impegnarsi, alla fine, al comando del suo esercito, in battaglie campali, per tentare di rovesciare le sorti della guerra. Nel racconto dell’imperatore è forte la denuncia degli effetti dei bombardamenti aerei, dell’impiego massiccio in ogni regione dei gas velenosi. “La guerra chimica non ci ha causato soltanto un gran numero di morti e di feriti, ma ha avuto innanzitutto l’effetto di distruggere la forza morale e la capacità di resistenza delle truppe etiopiche. Senza l’impiego di questo inumano mezzo di combattimento, la decisione dei nostri soldati non sarebbe mai venuta meno …” (pag. 149).
Queste testimonianze si intrecciano con i frammenti del racconto di Bruno, mio padre. Penso che la sorte della battaglia di Sellaclacla a cui prese parte– “Alla terza notte, l’assedio cessò, i soldati abissini scomparvero nel nulla” – sia da legare all’assalto continuo dell’aviazione italiana. Mi sembra che nella mia ricerca riesca a ricomporre i pezzi di un puzzle, a dare respiro a memorie personali nel contesto di fatti generali, fatti che segnarono come cicatrici indelebili il volto dell’Africa e, per altro verso, la storia del notro Paese.
L’interesse ad approfondire i caratteri del percorso da Asmara a Addis Abeba e la loro traformazione, mi ha portato a consultare la prima guida che uscì nel 1938, in 500 mila copie, a cura della Consociazione Turistica Italiana: “Guida dell’Africa Orientale Italiana”. Quali gli scopi per preparare in tempi rapidi una guida così complesa di quasi 700 pagine, a solo due anni dal giorno nel quale “il Duce da palazzo Venezia proclamava al mondo il ritorno dell’Impero ?”. Quello di rendere omaggio alla vittoria italiana e ai suoi protagonisti e di mostrare come l’Italia abbia saputo rispondere alle “sanzioni di 52 Stati coalizzati contro un popolo risoluto a trovare il proprio posto al sole”. La strada che porta ad Addis Abeba, riferisce la Guida, è indicata come “la grande strada della Vittoria” che scavalcando “eccelse quinte montane, traversa i luoghi sacri alla memoria degli Italiani: Macallè, Amba Aradàm, Amba Alàgi, Mài Cèu”. E’ una terra che “racchiude in sé tali possibilità da alimentare le più ardite speranze e da permettere le più audaci previsioni” per il turismo, per le intraprese economiche”. Al turista che desideri “farsi un’idea abbastanza completa dell’Impero e che disponga di un autoveicolo ( meglio se un autocarro leggero con tenda, riserve di carburante, acqua e viveri)” si raccomanda un itinerario da compiere in 60-80 giorni, dei quali 22 per raggiungere Addis Abeba partendo per Massaua. Quale contegno deve tenere il turista, secondo i consigli della Guida della Consociazione Italiana? “L’Abissino è di carattere chiuso, molto orgoglioso, volubilee, come tutti gli orientali, dissimulatore e accorto parlatore. .. Gl’Italiani, con il loro carattere umanissimo e con l’istintiva penetrazione psicologica, hanno già stabilito un equilibrio nel rapporto con gl’indigeni: non altezzosità e separazione assoluta, ma superiorità e comprensione. Occorre trattare con giustizia e bontà, ma senza debolezza; diffidare è buona regola; troppa familiarità è fuori luogo” (pag. 20).
Le guide di oggi pongono da parte, naturalmente, ogni diffidenza ed invitano con calore a visitare l’Etiopia e l’Eritrea, “diverse da qualunque paese che abbiate mai visitato. Chiese monolitiche scolpite nella roccia, bazar brulicanti e terre incontaminate: il Corno d’Africa è davvero unico”.
I libri di viaggio ci invitano ad immergerci in un mondo di ricche testimonianze storiche, culturali, etnografiche, ambientali, da scoprire direttamente, anche, facendo riferimento in più casi, a strutture turistiche spartane, tipiche di Paesi segnati ancora dalla povertà. A queste testimonianze legate al passato, le guide ci presentano le vie di ricerche artistiche nuove, animate dai giovani, che in maniera originale progettano la visione del futuro di una terra che ha vinto il “drago del colonialismo”, come nelle immagini dell’artista Afewerk Tekle, presenti nella monumentale vetrata istoriata dell’”Africa Hall” di Addis Abeba.
Non lontana da questo monumento, si innalza la Cattedrale della Santissima Trinità dove i dipinti murali ritraggono l’imperatore Hailè Selassiè a Ginevra mentre pronuncia davanti alla Società delle Nazioni, nel 1936, il suo famoso discorso contro la guerra e per i diritti di tutti i popoli della terra. Nelle vicinanze della cattedrale, il monumento eretto in memoria delle migliaia di etiopi uccisi dagli italiani in segno di rappresaglia per l’attentato contro il vicerè Graziani del 19 febbraio 1937.
Debellato il “drago del colonialismo” lungo il percorso di cui abbiamo parlato, legato per me a ricordi familiari, emergono le recenti ferite del “mostro della Guerra”, dalle città eritree bombardate nel corso del conflitto con l’Etiopia, i campi di mine antiuomo sul confine, i numerosi cimiteri di guerra. La lotta contro questo mostro è decisiva per il futuro del Corno d’Africa e dell’intero continente.
Testo in corso di pubblicazione sulla Rivista Testimonianze
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Roberto Mosi, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.