Abbiamo già avuto modo con voi di lasciarci coinvolgere dalla poesia di Francesco Lorusso, musicista e poeta barese, con diverse pubblicazioni all’attivo e testi su varie riviste del settore. Ricordiamo tra l’altro di lui da queste pagine la resa prima de L’ufficio del personale e di Maceria poi, quest’ultimo su LaRecherche.it anche nella analisi attenta di Paolo Polvani. Il lavoro che invece oggi andiamo a raccontare ha meritato, in qualità di finalista alla IX edizione del Premio Nazionale Editoriale di Poesia “Arcipelago Itaca”, della pubblicazione da parte della casa editrice di Osimo. Diciamo subito allora che il dettato dell’autore pugliese viene confermato in pieno nella capacità non comune di saper riportare storie e disagi, non solo personali evidentemente, entro la cronaca minuziosa delle incertezze e delle crepe che via via nell’animo, nel corpo vanno ad accumularsi fino a quel senso di straniamento, anche da se stessi, caratterizzanti rapporti e legami sempre più sfilacciati, quando non divisori. In questo caso però nella centinaia di brani, divisi in cinque sezioni, che vanno a comporre il testo in sorta di diario l’assordante silenzio che gradualmente andrà a dominare tra le righe è quello della crisi del proprio rapporto d’amore fino alla separazione nella debordante solitudine dei versi finali. Pregevole così è che il lutto che è al centro dell’opera sia agente già nell’alleggiamento dei primi versi, in quella corrosione e stordimento dei sentimenti che ruotando dai cuori e dagli spazi dei protagonisti coinvolge il lettore nella sospensione di elementi- strade, piazze, indifferenza anche di colori, cieli, piante che più non arginano- cui per compressione l’animo inizia più a non corrispondere. Lo scenario dunque è quello di parole, gesti, motivi che iniziano a perdere consistenza, sapore; soprattutto di tracce che poco a poco vengono a segnare i volti nella leggibilità dei dolori, e fors’anche degli equivoci. La terra nei suoi vagiti disarticolando certezze, la speranza a scemare “di ricucire ancora/la nostra dorsale morente al cielo” - entro un “gelo che non va più via”. La familiarità data anche dal riconoscimento di piccole tracce, di intimità corrisposte ha ora la scomposizione di un respiro bloccato, fermo nella rottura di se stesso. L’aria, segnalandosi non più a due, si fa insolvenza, maschera di volti nel palpitare di un non amare. L’affanno sproporziona, frammenta alle figure e alle cose, e smarrisce tra parole feroci, morsi, corpo a corpo, lontananze. La seconda sezione, “Ripassera Valéry”, ce lo racconta bene nell’arcato dipingersi delle sue orbite che ha a tratti l’evaporante dissolvenza di Francis Bacon. La pena è condanna, saturazione del buio- “implosione che allarga ancora di più il nostro vuoto” - nell’infinità di occhi “custoditi ora nell’incavo del vano”; freddi, assenti, come fossili, “o monili umidi dispersi nel fango”. Un titolo in questo senso è esemplare, “Conviviamo bloccati per contrasto”, “in una condizione senza corpo” però sulla soglia delle porte e degli addii, in una disunione con l’altro che è disunione da se stessi. Poi “ciò che portava valore gonfiandosi alle sorprese” muta in disabitazione, connessione interrotta, dimora sfitta tra macerie di stagioni irreplicanti se non nella soluzione dell’impaccio, di giorni i cui tramonti davvero non sono più gli stessi (“come si muove male la mia presenza nella tua assenza”). Solo “adattarsi a quel che resta” allora? Perché il possesso del tempo è quello che porta a casa, nella chiave dolorosa che Lorusso chiede di condividere con noi e che ora piuttosto nella memoria, nel suo simbolo, non è che cenere e reliquia della smisuratezza di ciò che è stato. Il tempo ora è quello di una casa infatti i cui interni, i cui oggetti sembrano fermi al teatro delle loro sfide, in cui stratagemmi, stanchezza, ossessioni e pensieri non possono avere risposta. L’abilità, la dura abilità del dire di Lorusso è di saper restare nel pantano di un tempo appunto adesso inestricabile e di restituirlo in tutta la sua immobilità, non passività però, come di rosa pronta ancora a sbocciare improvvisa su pietra dura, in fondo non arresa, allora seppur battuta, allo stadio di stagnazione cui nella parte finale il lavoro va a chiudersi. Stagnazione che ha l’interrogante volto della concretezza di un dolore che va ascoltato e attraversato in tutta la nudità di uno stato senza rete, dove anche il levare preghiera dalla liturgia dei suoi acquitrini potrà non arrivare. E dove in fondo il senso ha ancora “valore pieno di redenzione” o della sua possibilità almeno. Particolarmente significativo è allora l’ultimo testo in cui più che la quinta dell’amore è quella di sé che nell’affido evoca e invoca nel segno del ritorno una possibilità nuova di essere riplasmati. Prima però bisogna sapersi guardare: “Tu trattieniti nel tempo in tempo per trovarci/nella forma ferma che rifinisce anche la sedia”.

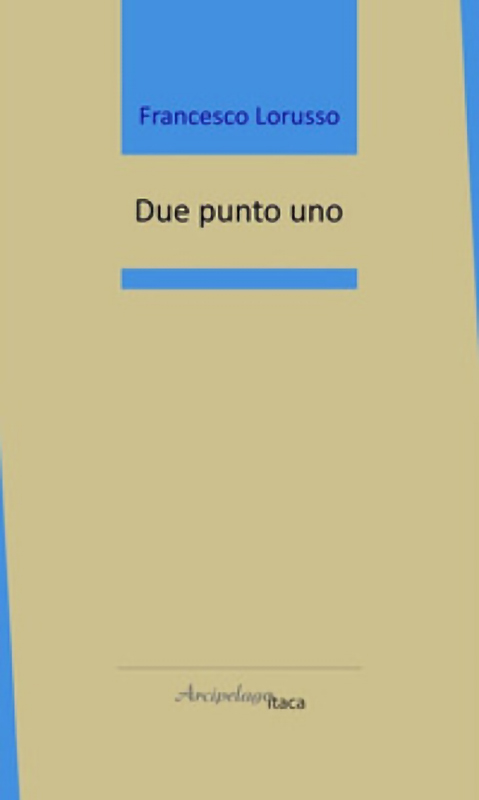

 ::
::  ::
::