chiudi | stampa
Raccolta di recensioni scritte da Roberto Maggiani
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
 Mickaël Launay - Narrativa - La nave di Teseo
Mickaël Launay - Narrativa - La nave di Teseo
Il grande romanzo della matematica
Quest’anno ho cambiato scuola, insegno matematica in un liceo classico e in un liceo artistico. È una esperienza molto bella, sono contento. Prima insegnavo in un altro tipo di scuola, avevo altre priorità e un altro modo di affrontare la materia; quest’anno ho deciso di approfondire l’aspetto più umano della matematica. Sì, perché una cosa è certa, la matematica è stata fatta (e tuttora lo è) da uomini e donne, e questi hanno un nome e un cognome, hanno un aspetto, un carattere, una storia. Quando a scuola si studia la letteratura, si parla di nomi e di cognomi e si studiano le biografie degli autori mentre, invece, quando si studia la matematica ben poche volte si citano nomi e cognomi, tanto meno si studiano le biografie degli autori. Però anche la matematica ha i suoi autori, e sono tantissimi, tuttavia a scuola ci fanno conoscere a malapena i nomi di quelli più noti: Pitagora, Archimede, Tartaglia, eccetera.
Ebbene, quest’anno ho riflettuto su questo fatto e ho assegnato, a ciascuna ragazza e a ciascun ragazzo, un matematico (donna o uomo, tantissime le donne che hanno sfidato i tempi avversi in cui hanno vissuto, quando non era loro concesso di frequentare i corsi universitari), da conoscere studiandone la vita e le opere, per poi presentarlo alla classe. Questa serie di conferenze, interne a ciascuna delle mie classi, è stata avviata con la proiezione di un film sulla vita del matematico indiano Srinivasa Ramanujan, il titolo del film, uscito nelle sale nel 2015, è “L’uomo che vide l’infinito”, i ragazzi lo hanno molto apprezzato. Sarebbe mio intento concludere, questo ampio lavoro, invitando un matematico (possibilmente donna) in classe a presentarsi e a raccontare la propria esperienza. Sperando che questi giorni “coronali” finiscano quanto prima, proverò a farlo.
Ma non finisce così, nel cercare materiale adeguato sulla matematica, per avvicinare i ragazzi a questo mondo che è spesso uno spauracchio, specialmente in un classico, ho iniziato a cercare tra le pubblicazioni divulgative e ho trovato questo bellissimo libro: “Il grande romanzo della matematica – Dalla preistoria ai giorni nostri”, scritto dal giovane matematico francese Mickaël Launay, edito in Italia da La nave di Teseo nella collana i Fari, tradotto da Sergio Arecco, introdotto da Piergiorgio Odifreddi che scrive: “Nel 2007, da giovane laureato alla prestigiosa École Normale Supérieure, apre il fortunato sito di matematica ludica Micmaths. Nel 2013 passa su YouTube e nel giro di pochi anni il suo canale raggiunge i 335.000 iscritti e posta più di 150 video di matematica, con ascolti stellari che in genere sono riservati ai divi della musica o del cinema. Ma a differenza dei grandi divulgatori di successo, che spesso allargano il volume d'utenza a scapito della profondità dell'esposizione, Launay è riuscito a trovare la proporzione aurea tra successo e qualità.” Ed è vero, Launay è capace di tenere il lettore incollato non solo ai suoi video, per quanto siano in lingua francese (d’altronde la matematica è un linguaggio trasversale alle lingue parlate), ma anche alle pagine di questo libro che parte dal Paleolitico (“È l’età della pietra tagliata. Il modello è il bifacciale”), per passare dall’VIII millennio a.C. in Mesopotamia, e avanti fino a egiziani, greci, cinesi, arabi e ancora avanti fino ai nostri giorni.
La cosa interessante è che il libro traspira la passione del suo autore, essa si rivela nelle sue osservazioni del mondo che lo circonda, nelle sue visite a musei e luoghi in cui sono nascosti elementi matematici che ai più possono sfuggire. Ad esempio, nel capitolo iniziale, “Matematici loro malgrado”, l’autore ci invita a fare con lui una visita al Louvre, tra il vasellame di terracotta prodotto proprio lungo la Mezzaluna fertile: “[…] in una zona che copre approssimativamente quello che un giorno si chiamerà Iraq, è in pieno svolgimento la rivoluzione neolitica. […] La ceramica è la prima arte del fuoco, ben anteriore rispetto al bronzo, al ferro o al vetro. […] Oltre a produrre vasellame di lunga durata, ci si preoccupa anche della sua bellezza.” Ed è proprio tra i fregi delle ceramiche decorate che l’autore ci invita a cercare e a scorgere simmetrie, rotazioni e traslazioni, spiegandoci come si possano ricondurre tutte a sette tipologie “che corrispondono proprio a sette gruppi di trasformazioni geometriche differenti che possono definirsi invarianti. […] è una cosa che i mesopotamici ignoravano […] la teoria in questione troverà una formalizzazione solo a partire dal Rinascimento!” È in questo modo che il nostro bravo autore procede nel suo romanzo matematico, inducendo curiosità nel lettore per qualcosa che ha a che fare con la nostra storia, la storia di ognuno di noi, del nostro pensiero umano, che non è solo una storia filosofica, letteraria o scientifica ma è anche matematica (ho volutamente staccato la matematica dalla scienza che la usa come lingua); in questo libro l’autore riesce a far risaltare, dallo sfondo delle vicende umane, la storia del pensiero matematico come una esigenza di conoscenza vera e propria; per quanto, almeno all’inizio, scaturisca da esigenze di vita pratica dell’Homo sapiens, anche semplicemente amministrativa, per poi inerpicarsi nel mondo dell’astrazione.
Dal primo capitolo si procede verso “E il numero fu”, in cui Launay mostra, in modo chiaro e affascinante, come i numeri si siano palesati nella mente umana. Poi si procede con la geometria e il capitolo “Il tempo dei teoremi”, per spiegare i quali (i teoremi) l’autore ci porta, a mezzogiorno di un giorno di maggio, a fare una passeggiata al Parc de la Villette, nella zona Nord di Parigi, fino alla Cité des sciences et de l’industrie: è il momento dei solidi platonici e oltre: “Non si tratta più soltanto di trovare soluzioni che funzionino. Vogliono [i matematici greci] essere sicuri che niente possa sfuggire loro. E proprio per questo eleveranno l’arte dell’esplorazione matematica ai massimi vertici.” Dopodiché si va a passeggio, attraverso il capitolo del metodo e dei paradossi, fino al pi greco (e siamo con l’autore al Palais de la Découverte): Launay espone in modo chiaro e semplice il metodo di Archimede per calcolare il valore numerico del pi greco, il numero irrazionale, dunque a infinite cifre decimali non periodiche, usato da tutti gli studenti delle medie per calcolare la lunghezza della circonferenza. Ma andiamo ancora oltre, incontriamo i vari Tolomeo, Eratostene di Cirene, Euclide, Diofanto, eccetera, e arriviamo al capitolo “Niente e meno di niente”: i numeri negativi. E poi ancora avanti, avanti in questo bellissimo mare, attraverso “I mondi immaginari” del capitolo 11 fino alla formalizzazione di un linguaggio per la matematica, e siamo arrivati in pieno Rinascimento. Qui capirete, in veri e propri collegamenti spaziotemporali, che l’autore intesse abilmente tra le varie parti del libro, perché l’Algebra si chiama proprio così e chi l’ha formalizzata. Scoprirete, in un modo nuovo, che molte delle nostre abitudini matematiche derivano dai greci, dagli arabi, dai cinesi.
Ed eccoci giunti ora, ancora camminando allo stesso piacevole passo di Launey, nell’infinitamente piccolo, nella probabilità e nella “Matematica a venire”. Insomma, si tratta di un viaggio entusiasmante, fatto per chi è appassionato di matematica, di storia e di curiosità, ma anche per chi ha sempre pensato la matematica come un fatto distante e di altri.
A un certo punto del percorso, l’autore spiega anche come si possa costruire una propria matematica e lì individuare i propri teoremi: viene la voglia di costruire (portare all’esistenza) mondi nuovi, fatti di nuove regole, similmente a un artista che, con la propria arte, crea o ricrea la realtà. Anche se nel capitolo “L’alfabeto del mondo” egli dice, con un tipico sarcasmo francese: “Che significato ha allora il verbo ‘esistere’ se dobbiamo applicarlo a oggetti che non hanno nulla di materiale? Per abbozzare anche un minimo accenno di risposta, non contate su di me.” Ma anche ci incoraggia: “La matematica dispone di un potenziale formidabile per diventare una disciplina festosa, popolare”.
Un’ultima cosa, finalmente ho trovato, in questo libro, una spiegazione semplice ed esauriente del famoso teorema d’incompletezza di Gödel: una disgrazia per tutti coloro che vogliano trovare “una super-teoria della quale le varie branche della matematica, dalla geometria alla probabilità, dall’algebra al calcolo infinitesimale, [possano essere] solo casi particolari. […] Come sarà la matematica del futuro?” Un bell’interrogativo! E non manca neppure un bella spiegazione, pulita, dell’insieme di Mandelbrot: una meravigliosa figura geometrica che nasce da una regola estremamente semplice, ed è bello l’interrogativo che Launay espone: “Una scoperta del genere rilancia inevitabilmente il dibattito sulla natura della matematica: è in’invenzione umana o vanta un’esistenza indipendente?”
Eccoci in chiusura. I miei ragazzi, questa estate, avranno i loro compiti di matematica, fatti di ragionamenti, formule e calcoli, ma prima di tutto avranno il compito più importante, appassionarsi, e questo libro (manco avessi una percentuale sul libro) potrebbe essere capace di aiutarli in questo percorso, svelandogli un mondo che, molto spesso, noi insegnanti teniamo nascosto. Buona lettura.
Qui il canale Youtube di Mickaël Launay
Id: 1218 Data: 20/03/2020 12:00:00
*
 Eugenio Scalfari - Poesia - Einaudi
Eugenio Scalfari - Poesia - Einaudi
L’ora del blu
Il titolo del nuovo libro fuori collana di Einaudi (disponibile dal 2 aprile 2019), “L’ora del blu”, è bello, ha carattere, è evocativo: echeggia in sottofondo la prima pellicola della celebre trilogia dedicata dal regista polacco Kieślowski ai tre colori della bandiera francese e, di conseguenza, al motto della Rivoluzione: “Liberté, Égalité, Fraternité”; ma sto andando oltre, si tratta, invece, del blu marino di “Una finestra sul mare”, titolo di una bella poesia presente nella raccolta di versi di Eugenio Scalfari, la sua prima raccolta di versi.
Il mio primo ricordo
è una finestra sul mare,
il cesso sul balcone
e la ringhiera di ferro
le navi che partivano e arrivavano
il suono delle sirene del postale
e i gabbiani che volano maestosi
e all’improvviso
cadevano a picco sui pesci del mare.
Da quella finestra
cominciò la mia vita,
la mia memoria, la mia malinconia
e anche il mio risentimento
e la voglia di compensare
non so quale torto subito.
La poesia evoca i versi oceanici di Sophia de Mello Breyner Andresen quando scrive:
La cosa più antica di cui mi ricordo è una stanza di fronte al mare dentro la quale stava posata in cima di un tavolo una mela enorme e rossa. Dal luccichio del mare e dal rosso della mela si sprigionava una felicità irrifiutabile, nuda e intera. Non era nulla di fantastico, non era nulla d’immaginario: era la presenza del reale che io scoprivo.
Nella pagina del libro, sul sito dell’editore, si legge: “I ricordi della giovinezza, la passione ardente, la natura pulsante tra mito e realismo, l’incalzare del tempo, la ricerca di una quiete: attraverso il calore del verso Eugenio Scalfari svela il suo più profondo sentire. Tra il blu del mare e il blu del cielo si muove lo scrittore poeta, in una grandiosa e commovente dichiarazione d’amore per la vita.”
Metto adesso l’accento sulle parole: “lo scrittore poeta”. Riguardo allo “scrittore” sono d’accordo ma non riguardo al “poeta”. Se per chiamarsi poeta bastasse una pubblicazione allora io sarei Dante, visto il mio numero di pubblicazioni in versi, il fatto è che tutt’oggi, dopo più di trent’anni di faticosa scrittura in versi dello scrivente – ho iniziato nell’adolescenza – ecco che ancora stento a pensarmi poeta. Tuttavia, esistono casi di persone per i quali, fin dalla loro prima pubblicazione si ravvisa un certo carisma nella scrittura in versi, Einaudi stesso ha, nella sua nota collana di poesia, autori che hanno pubblicato per la prima volta e hanno avuto riscontri molto positivi, manifestando così la loro vocazione per la scrittura in versi (ma non faccio nomi). Ciononostante, a mio avviso – e ad avviso anche di una cospicua parte dell’ampia comunità di poeti con cui sono in contatto –, non è il caso di Eugenio Scalfari e di questo suo libro.
La narrazione poetica parte dalle riflessioni di un io bambino per poi evolversi verso una maturità tematica. Il problema è che i versi non corrono parallelamente verso la stessa maturità. Se queste poesie, che invito a leggere per rendersene autonomamente conto, mi arrivassero come proposta di pubblicazione per la collana “Libri liberi”, che curo per LaRecherche.it, non penserei mai a pubblicarli e invece Einaudi lo ha fatto, buon per l’editore che venderà moltissime copie a causa del nome da cui è firmato (la prima è quella che ho acquistato io). Questa pubblicazione, a mio sindacabile giudizio, è la dimostrazione che il nome conta, in poesia come altrove. Ma quello che più mi incupisce è la recensione lusinghiera di Alberto Asor Rosa pubblicata su Repubblica.it, di cui riporto qui il link, anche se a me, in essa, pare evidente un abile tentativo, non facile, di estrapolare il positivo del libro per quanto riguarda la forma, non mi riferisco ai temi che sono quelli propri dell’umana esistenza. Per chi legge abitualmente poesia e la scrive e ci lavora di cesello da molti anni, e siamo in molti a farlo seriamente, questi versi appaiono decisamente banali, mi si perdoni la schiettezza, sembrano tratti dal diario di un poeta adolescente, in tal caso sarebbe fatto lodevole, ma ci sarebbe da lavorarci sopra: “È inarrestabile / la corsa del tempo / fino all’ultimo appuntamento / con la Signora Velata / che porta con sé il senso / del tuo vissuto. / […]” (La Signora Velata). “Il tempo corre e non si ferma mai, / fuori e dentro di noi che lo sentiamo, / fa crescere i bambini, i giovani, gli anziani, / coi vecchi cambia giro e li deprime / e poi li uccide con sorella Morte. / […]” (Il tempo). “[…] A lui piace / quella stagione e avaro me la ruba, / mi regala il passato ma m’ottunde / la memoria ed è questa / la fatica del vivere. […]” (Corre il tempo). “Quando penso l’Universo / m’assale la paura, / non so che cosa sia, / tutto contiene / compreso Dio che l’ha creato / e ne fa parte: / Creatore dentro Creatura, / schiacciante immensità / confinante col nulla. / […]” (Paura dell’Universo). L’unica parte in cui trovo una certa intensità è quella della poesia dal titolo “Vita amore e poesia”, in cui cita alcuni versi di poeti ma senza riportare il nome degli stessi, si tratta di una sorta di mini antologia che si conclude così: “[…] / L'antologia poetica è terminata. / E spero sia di vostro gradimento. / Io non scriverò / un romanzo sulla mia vita. […]”. Ci sono testi più lunghi come “La ribellione dei poveri” che avrebbero maggior fortuna se fossero trasformati decisamente in prosa: “Un giorno un povero si ribellò. / La sera aveva smarrito pane raffermo ed una verde mela / […]”. Insomma, a ognuno il suo mestiere, se si vuole cambiare mestiere va bene ma è necessario un lungo periodo di affiancamento e impegno per acquisire le giuste competenze, è il mio parere. La cosa interessante è che sul sito di Einaudi il libro si trova nella sezione “Narrativa italiana contemporanea”. Segnalo inoltre un passaggio che non mi è chiaro: “[…] / Penso a te, penso al tangasso arabadero / che tante volte abbiam ballato insieme: / […]” (La chitarra innamorata): so che esiste la parola “arrabalero” (conosco il tango dal titolo “Bandoneón arrabalero”) e poi ho sempre sentito pronunciare la parola “tangazzo”. Non so.
Il libro è proposto persino in edicola con Repubblica, non mi stupisco ma, mi si conceda, mi innervosisco. Il fatto è che noi “poeti minori” siamo stanchi di essere presi in giro dai poteri editoriali e dai loro interessi che spesso non fanno cultura letteraria ma solo una scialba cultura d’interesse immediato. Da anni i poeti della comunità poetica italiana contemporanea cesellano versi e si confrontano tra di loro e con un pubblico che stenta a esserci, si arrovellano su cosa sia giusto pubblicare e cosa non lo sia, cercano riscontri, si incontrano nei reading, si danno forza l’un l’altro in un mondo in cui la poesia sembra solo relegata agli involucri dei cioccolatini, alla ricerca di un supporto, informatico o cartaceo o altro, che possa veicolare ciò che sentono come urgenza e necessità da esprimere in versi. Il gioco editoriale di questo libro non mi piace.
Concludo dicendo che un editore può pubblicare chi vuole, anche uno scrittore dal nome noto che si improvvisa poeta, però si sappia che in tali pubblicazioni, a mio sindacabile giudizio, ravviso una profonda mancanza di riguardo verso gli “invisibili” poeti che scrivono da anni, essi chiedono un po’ di rispetto e “L’ora del blu” – se sul risvolto di copertina leggo: “[…] incastona sulla pagina versi intensi […]”, riferito all’autore – mi pare che manchi di tale riguardo, sempre a mio sindacabile giudizio. Questa è la sensazione che provo come (ebbene sì, ora lo dico) poeta.
Id: 1176 Data: 05/04/2019 12:00:00
*
 Domenico Cipriano - Poesia - L’Arcolaio
Domenico Cipriano - Poesia - L’Arcolaio
L’origine
Poeta sapiente dalle molte sfaccettature, Cipriano incanta con questo suo lavoro, capace di evocare multiformi percezioni e consapevolezze: con versi strutturalmente liberi, tratteggia relazioni che dal reale si innalzano verso spazi figurativi in cui cerca rappresentazioni del presente, definendo una sorta di relazione biunivoca tra lo spazio empirico e quello eidetico per comprendere-interpretare la storia personale e globale: “[…] / C’è un giorno da cui non possiamo separarci. / Così / fremiti angoscianti seguono ancora e altrove / in altra veste / raschiando la grazia celestiale / da questo grumo sedimentato del cosmo. / […]” (pag. 35); “[…] / È tutto reale / nulla da consegnare alla surreale immagine del pensiero. / […]” (pag. 36) – per poi ricadere come pioggia sul terreno della memoria facendo germogliare nuove occasioni – “[…] / Un’ultima occasione / per avvinghiarci alla bellezza. Un risarcimento / al sentimento di sentirci vivi. La speranza di riavere dalla vita / l’ultima sostanza. / […]” (pag. 44). Cipriano è un tessitore di istanti, la sua mente guizzante “[…] Fissa cardini / innanzi a precipizi, / con lo sguardo sulla valle spoglia / che copre i sedimenti del passato. /…/ E assumiamo il profilo della terra incolta / se non ricominciamo.”
Nella raccolta c’è una sorta di piacevole mestizia soffusa, preannuncio di una promettente arrendevolezza – alla quale le poesie, a tratti, s’intonano – porta d’ingresso a un climax del pensiero a cavallo di versi snelli calcanti sentieri di montagna che culminano su vette poetiche a ridurre la distanza tra la scrittura e i multiformi significati dell’esistenza, dove si acquieta, in qualche modo, la sofferenza del poeta – “Soffro la distanza dalla scrittura […]” – e il lettore ritrova speranza a motivo della gradevole empatia che si instaura con il poeta stesso.
Nel gioco di questa scrittura sono rilevanti i suoni e, di conseguenza, le distanze dalle quali essi giungono; modulati in volume e timbro, depositano suggestioni e memorie, oltreché nostalgie, che nutrono la voglia di scrivere o di leggere: “[…] Il mutare dei suoni in lontananza / preclude / la voglia di scrivere che immutabilmente assale. / […]” (pag. 33).
“[…] / Sono vividi e sospesi i monti / e anche le case cedono all’eternità / ora che è opale il fotogramma /nei corrugati della memoria. / […]”.
Si delineano, in modo esplicito o implicito, paesi e paesaggi, vivificati dalla memoria e dai sentimenti, passati o attuali, talvolta scoloriti o sfocati da variabilità meteorologiche inserite ad hoc nella composizione poetica; tali mutevolezze paesaggistiche sono adeguate alla ricerca dell’artista di quel “foro” montaliano*, portale d’ingresso al mondo delle relazioni perfette, al quale il poeta sembra anelare, che fa capolino fin dall’infanzia e non vuole in nessun modo materializzarsi nel reale: “Dei paesi vivete / il silenzio, il respiro / affannoso d’inverno, / la nebbia che sfoca / i contorni, le ore / fredde d’assenza, / […]” (pag. 51).
Nella bellissima poesia di pagina 25, l'autore tratteggia l’unitarietà della storia evocando un fondamentale senso di appartenenza alla categoria umana; “un sasso” diventa memoria di noi stessi, in ricerca di chi eravamo e di chi saremo, con la speranza che qualcosa potrebbe andare meglio di come, fino ad ora, è andata: “[…] / un sasso di cui non avremmo premure né interesse / se creature che ci hanno germinato / non avessero lasciato una traccia, senza / sapere del futuro, cercando di resistere / alle successioni del loro presente inesplorato. / […].” C’è tenerezza verso l’intera umanità: “Con delicatezza, dopo millenni di abbandono, / transitano tra le mani i resti / di una nostra esistenza sconosciuta, da ricostruire / o inventare nelle ipotesi più sognanti. / […] / Avremo la stessa cura (credendo illusi a un futuro eterno) / di tramandare un legame duraturo / con quanti attraverseranno questo spazio / e l’aria respirata da chi l’ha vissuto, / ora che lo sguardo ci rivela chiari / i segni illuminanti del paesaggio?”
In ogni caso: “Per legge fisica e per dinamica del tempo / dovrà accadere che questo sterminato fiorire di stelle / verrà a riflettersi nel vuoto oscuro / restando sottopelle. […]” (pag. 26). Ed è quello che succede ad alcuni di noi che hanno fiducia in un futuro migliore, la poesia apre alla speranza e non illude.
Una raccolta che mi sento decisamente di consigliare. Fin dal titolo evoca una genesi, un punto di partenza, un concepimento, una evoluzione che ha le sue ere, di pochi millisecondi, come sono le rapide percezioni dello spirito umano, quasi veggente davanti al formarsi dell’attimo, o ere di giorni-mesi-anni in cui gli attimi si uniscono come cellule a formare la creatura che è la vita umana e il suo fine.
* “[…] / fu così e fu tumulto nella dura / oscurità che rompe/ qualche foro d’azzurro finché lenta / appaia la ninfale / Entella che sommessa / rifluisce dai cieli dell’infanzia / oltre il futuro - / […]”, da “Accelerato”, Eugenio Montale.
Id: 1129 Data: 28/09/2018 12:00:00
*
 Massimo Del Prete - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Massimo Del Prete - Poesia - Giuliano Ladolfi Editore
Soglie
“Soglie” è la raccolta poetica d’esordio di Massimo Del Prete, nato a Taranto nel 1993, laureato in Ingegneria Chimica nel 2015 e attualmente frequentante la Facoltà di Lettere Moderne di Milano, come si legge nella biografia riportata nel libro. Siamo dunque di fronte a un giovane scrittore che manifesta, in modo molto marcato, già con questa prima opera in versi, la sua indole di poeta (non è scontato che da un libro scritto con andate a capo si sveli tale indole), esibendo un versificare di carattere, ben strutturato nella forma e personalizzato nei contenuti, vivace e con una nota di tradizione romantica che nella poesia, se tenuta a bada, non guasta mai e, anzi, la rende “appetitosa”. Già nel primo componimento, “Onda/corpuscolo”, della prima sezione del libro, il cui titolo è “Qualche esempio”, troviamo un testo che reputo tra i migliori della raccolta, si tratta di una poesia semplice ma ben architettata, pulita, scritta con un linguaggio che definirei giovanile: “Quando eravamo pischelli / leggevamo insieme Hawking / in biblioteca. / Ci piaceva la sua storia: / paradossi e buchi neri / in un romanzo. // […]” Fin da questo testo Del Prete esprime e armonizza le due anime che lo contraddistinguono, messe in evidenza dalle scelte formative universitarie fatte, quella scientifica e quella letteraria: nel corso della sua carriera, che sicuramente realizzerà come poeta, potrà attingere a un serbatoio di metafore esistenziali messo a disposizione dalla sua formazione scientifica, si tratta di un tesoro che non tutti hanno a disposizione, tuttavia, se usato male, ad esempio in modo troppo didascalico, potrà risultare catastrofico.
Egli coinvolge la scienza per marcare il terreno della sua relazione con l’altro, ad esempio: “[…] / Dopo tutti questi anni / vieni a dirmi / che sai risolvere l’equazione di / Schroedinger, / che la metrica di Riemann / la capisci proprio bene, perdio! // […]”. Ma come una benedizione la letteratura appare all’orizzonte, sorge dall’orizzonte del linguaggio e del pensiero scientifico: “[…] / Eppure (non so come) / continuo a fare / il tuo lavoro / a risolvere / i tuoi conti // come se tu / volessi dire a me / dov’è che ha messo male / una virgola / Fitzgerald.” Siamo forse di fronte a un redivivo Novalis che in altri tempi ha saputo veicolare in modo esemplare la sua formazione scientifica-filosofica nelle sue opere in versi? Sicuramente Del Prete è portatore di una sua peculiare novità ma l’autore tedesco è un ottimo esempio e spunto per chi attinge fervore artistico dalla propria multipotenzialità filosofica, scientifica e poetica.
Nel libro vive e guizza una freschezza lieta e solare, scaturente dalla giovane età dell’autore; a ben pensarci non è ovvio che un giovane realizzi una scrittura di tale fatta, qualche volta mi capita di leggere giovani autori impantanati in una pesantezza aulica o decadente derivante da una cattiva digestione dei classici, non è questo il caso. “Da secoli s’avvera il sogno della carpa / che guizza contro il fiume / e segue il proprio corso, fino al monte – / […]”.
Leggere queste poesie è come avvicinarsi alla zona temporale dell’universo adolescente, una nuova opportunità per chi ormai, come me, è su una traiettoria in allontanamento dal proprio. Del Prete porta con sé, ancora integra, tutta quella sfera delle relazioni umane che, nella giovinezza, imperla le giornate e permette di vivere la vita con una sana leggerezza quasi ingenua: si tratta della sfera dell’amicizia, che in Del Prete (mi riferisco alle poesie), con estrema naturalezza può spingersi oltre, nello spazio riservato e solare dell’amore, senza sottrarsi a qualche delusione. “Anche tu non hai mai rotto il cerchio / dove tutto assume un nome / dove tutto si conosce, si somiglia. / Resterai con me, come chi s’è cercato in un / tutt’altro, custodirai questo sgabello / io e te di fronte, ancora per vent’anni / ‘mi lasceranno sola’ già sapevi, col / ricordo che riflette alcune ciocche bianche, / troppi, troppi scatti oltre noi stessi. // Tardi. Ti do un appuntamento vago / stanco ‘una birra, sì, uno di questi giorni’ / – ma tu che non sei salva, tu sai ridere / ‘puoi ancora opporre il bello alla miseria / confina fuori il tempo, il giorno è adesso’.” (pag. 71).
L’amicizia e l’amore, nei versi di Del Prete, si sovrappongo, non si disgiungono mai perfettamente, hanno quasi una dualità tipica dei sistemi quantistici, “onda” o “corpuscolo” a seconda di condizioni al contorno che lo scrittore ha la facoltà di determinare, è un po’ come se amicizia e amore fossero componenti di una funzione d’onda che descrive il sistema complesso delle relazioni umane. In ogni caso ciò che caratterizza l’intera raccolta è la sua forma per nulla solipsistica ma totalmente dialogica: “Stasera potrei versarti il calice estremo / offrirti l’ultima sigaretta; stanotte / forse l’ultima parola – […]” (pag. 73). Il poeta vive l’amicizia-amore pronto, in ogni momento, ad una sorta di sacrificio salvifico. “La mia voce deve avere il calore / dell’estate, se t’incanta col nome / dei quasar, […]” (pag. 53).
Un vago sentore di petrarchesco o di leopardiano, di tanto in tanto, si subodora vagamente nella lettura: “Arliana, a te direi tutto / e lo farei così, mea sponte, / senz’attendere nient’altro che il lume / intenerito dei tuoi occhi / verdeoro, il sopracciglio / esattamente teso e le domande / che senza un fiato fai cadere / nella schiuma del caffè alle nocciole / dove getta, il mio cuore, le tagliole. // […]” (pag. 48).
Tuttavia mi permetto di annotare a gusto personale che ci sono, sparse qua e là, alcune piccole ingenuità, ma tutte perdonabili, talvolta i versi si allungano in qualche parolina di troppo e alcuni troncamenti mal giocano tra i versi: “Rincasando a passo svelto, ti scorgo / contro il muro a mangiucchiar pistacchi, / […]” (pag. 46). Quella “e” finale a “mangiucchiar” ci sarebbe stata, a mio avviso, proprio bene, avrebbe eliminato quel sentore di aulico un po’ stantio in una scrittura snella come questa. Trovo anche qualche rima che, a mio avviso, rovina la naturale armonia delle assonanze nascoste tra i versi: “[…] / nella schiuma del caffè alle nocciole / dove getta, il mio cuore, le tagliole. // […]” e “[…] / ma come spettro senza forma / che tutto trapassa e non lascia orma. // […]”. Oppure qua e là si incontrano delle inversioni aggettivo/nome che rovinano, quando eccessive, tanta poesia contemporanea di sprovveduti, talvolta improvvisati, poeti; non è questo il caso, in cui tali inversioni sono raramente presenti e sempre discrete: “[…] / ma l’anima è un gonfio lenzuolo / […]”: visto lo stile generale della raccolta, forse sarebbe stato meglio dire “lenzuolo gonfio”; ma è anche vero che bisogna tenere conto del contesto della poesia da cui i versi sono tratti, il cui titolo è “Ballando con Arianna” (pag. 48): l’intento del poeta è forse quello di dare al componimento il senso di una ballata.
A conclusione di questa breve e non troppo approfondita riflessione posso affermare, con una forte dose di gusto personale (l’intento di questa nota di lettura non è quello di fare affermazioni oggettive), che Del Prete, tarantino che ha da sempre vissuto a Martina Franca, come lui stesso scrive nella biografia, con questa sua opera prima, ha dato ottima prova di sé, dando lustro, mi si lasci dire, alla poesia meridionale, sono certo che lo leggeremo ancora e con piacere. I miei vivi complimenti.
Leggi alcune poesie tratte da Soglie
Id: 1127 Data: 20/07/2018 12:00:00
*
 Ester Cecere - Poesia - Wip Edizioni
Ester Cecere - Poesia - Wip Edizioni
Non vedo, non sento e…
“Non vedo, non sento e…” è un libro di attualità che fotografa, di verso in verso, il nostro tempo fatto di lavavetri, di attentati, di carrette del mare, di una umanità migrante, col corpo o con la mente, verso luoghi altri, divisa tra Maometto e Cristo, tra ricchi e poveri, tra omosessuali ed etero tra chi si trova di qua o di là di un confine; è una poesia di analisi e di denuncia nutrita dalla sensibilità dell’autrice.
“Squassa il boato / l’aria e le coscienze. / All’unisono tremano / la terra e i cuori. / Incredulo scheletro / fuma disperazione l’autobus. / Schegge di vetro / in occhi accecati. / Di sangue urla mute / su bocche atterrite. / Fantocci smembrati / e chiazze vermiglie / sull’asfalto annerito.” (“Attentato”, pag. 39).
Ciò che mi convince di questa raccolta in versi sono i contenuti e la sua struttura complessiva in quanto alle tematiche trattate. Il poeta deve assolutamente essere presente al proprio tempo, la sua attenzione deve essere attiva, egli deve denunciare, come nessun giornalista o opinionista sa fare, i disagi della propria epoca in modo fulmineo: il lettore deve provare una scossa e in qualche modo svenire nella poesia e risvegliarsi con una visione della realtà decodificata proprio dallo spirito sapiente e puro del poeta.
La poesia è essenzialmente politica, non può non occuparsi degli affari umani, in quanto sia la poesia che la politica sono, appunto, affari umani; entrambe, poesia e politica, sono protese ad armonizzare l’uomo nel suo stare al mondo fatto di relazioni, con sé stesso, con le altre persone, con i luoghi in cui abita e vive le proprie necessità e speranze.
Per quanto detto, la poesia di Cecere è politica, perché è sociale, si occupa dell’uomo, essa guarda dentro e fuori dall’universo umano. Di più, la poesia di Cecere guarda, soprattutto, le distorsioni, le aberrazioni, indotte o spontanee, di un sistema sociale che sta raggiungendo il parossismo di insensati conflitti. Il poeta non può tacere.
Tra i vari testi di denuncia, ne troviamo uno dedicato ai popoli privi di libertà:
“Ricresceranno le remiganti / amputate nei giorni della notte. / Il volo riprenderanno / tra raffiche di maestrale / e correnti lievi ascensionali. / Planeremo sicuri / sulla dilagante azzurrità. / Ancora e ancora / ci riempiremo gli occhi / delle meraviglie / […]” (“Ancora in volo”, pag. 46).
Il poeta cerca, con uno sforzo sfrontato, quasi impossibile, ma è necessario provarci, di dare voce al disagio di chi voce non ha perché perso nella massa, negli eventi, nella morte; come questa poesia dedicata ai migranti deceduti nella stiva di un barcone:
“Temevi lo schiaffo del salmastro, / l’umido gelo di notti senza luna, / la vastità senz’orizzonte che spaurisce, / il mutare subdolo dell’onde. // […] // In un antro buio / s’è spento / di terrore pazzo / il tuo respiro. // […]” (“Non t’ha salvato l’alito del mare”, pag. 54).
Molte poesie hanno dediche molto significative che rivelano la natura della raccolta: “Alle donne africane”, “A una prostituta senegalese”, “Alle spose-bambine”, “A tutte le donne che temono per la loro vita”, “Alla bimba usata come kamikaze in Nigeria”, “Ai bimbi deceduti in Siria a causa del gas”, “A un bimbo siriano” e altre ancora. Si tratta di poesie attraverso le quali l’autrice esprime il suo personale disappunto ed esercita il diritto di denuncia; soprattutto, attraverso i suoi versi, cerca di farsi prossima a chi è più debole e indifeso, in qualche modo stabilisce un legame che annulli la solitudine o la dimenticanza del sacrificio di molti.
Tra i più deboli, quali donne e bambini in balia del male, l’autrice trova parole anche per un “collega”, il poeta iraniano Hashem Shabaani, pacifista impiccato, arrivato al culmine del sacrificio a causa della propria parola:
“Per sempre parlerai”: “[…] / Ma parlerai / Parlerai ancora / Parlerai sempre / Nei secoli / per secoli / le tue parole diranno… / […]” (pag. 45).
La poesia, oltre che di contenuti, è fatta anche di forma. In generale, il poeta, attraverso un uso sapiente delle parole, costruisce una sorta di impalcatura, fatta di rimandi e assonanze all’interno del componimento poetico, i cui significati rendono viva e bella la poesia.
Ed è proprio riguardo alla forma che mi permetto di fare alcune annotazioni, sapendo che l’autrice tiene a un parere sincero. Personalmente avrei lavorato diversamente la maggior parte dei testi, trovo debole la scelta dell’inversione tra il nome e l’aggettivo, una scelta che pone la raccolta un po’ decentrata, sul versante del passato, rispetto alle forme poetiche contemporanee. Se fossi stato l’editor avrei proposto un ammodernamento dell’opera, che trovo, invece, pervasa da un vago afrore di “superato”, stridente con i contenuti attualissimi di cui si tratta: una scelta di scrittura più vivace e moderna, meno aulica, avrebbe giovato all’incisività della raccolta.
Alcuni esempi: “[…] / delle sorelle tue orientali / […]”, forse sarebbe stato più adatto: “delle tue sorelle orientali”; oppure “Sulla battigia, / dalle onde accarezzato, / […]” forse sarebbe stato più adatto scrivere il secondo verso così: “accarezzato dalle onde”; eccetera.
Inoltre, ho trovato, sparse qua e là, alcune parole che, personalmente, trovo desuete, come ad esempio la parola “leggiadro”, sostituibile con molti sinonimi.
Concludo dicendo la solita banalità, la poesia è un percorso che richiede allenamento, molta lettura, confronto e capacità di mettersi in discussione… ma dà le sue soddisfazioni, anzi, trovo che la soddisfazione maggiore nel fare poesia venga proprio dal lavoro di cesello sui testi.
Id: 1126 Data: 06/07/2018 12:00:00
*
 Annamaria Ferramosca - Poesia - Arcipelago Itaca
Annamaria Ferramosca - Poesia - Arcipelago Itaca
Andare per salti
L’universo femminile ha una sua personale dimensione poetica, alla quale la parte maschile dell’umanità sembra non poter partecipare, se non di riflesso. Quando una donna riesce a stabilire il misterioso contatto con la propria Musa – per formazione, per capacità ascetica, per cultura, per volontà, per destino, eccetera –, accade qualcosa di simile a una fecondazione e a un parto, silenzioso e non necessariamente doloroso: in modo naturale la donna è predisposta alla poesia, le nasce dall’interno, come se ella stessa si trasfigurasse nella Musa, laddove, invece, l’uomo deve avviare un processo macchinoso di inseminazione e attesa del “nascituro”, la poesia, che arriva, dunque, per intermediazione, dall’esterno.
Leggendo la raccolta di Annamaria Ferramosca si partecipa, in modo eccelso, alla dimensione poetica femminile, ma la poesia che ne scaturisce, come per ogni parto il nascituro, diventa un soggetto reale facente parte dell’universo condiviso da tutta l’umanità – soggetto bello oltremisura, indipendente dalla madre.
L’arte poetica di “Andare per salti” dà piena soddisfazione al lettore voglioso di verità – ad essa non si può non aderire con anima e corpo –, è fisica e biologica, è insufflata di alito scientifico ma, al contempo, è imbastita da un fil rouge di misticismo; di più, siamo di fronte a un’arte poetica che porta in sé i semi della tradizione, ha radici nel classicismo. Per la sua forte aderenza a una sorta di naturalismo (molti sono i rimandi alla natura) prende forma, attraverso di essa, la dimensione del mito, è come se tutto il meglio dell’antichità classica si ravvivasse e riprendesse vigore nel nostro tempo ma usufruendo di parole e concetti moderni: il classico si incarna e manifesta in un linguaggio tendenzialmente scientifico. Pertanto, lo ribadisco, trovo, in questa raccolta, a mio avviso, una simbiosi perfetta tra classicismo, modernità e contemporaneità.
La poesia che qui si legge non tralascia mai di stupire a ogni verso, non c’è nulla di lasciato al caso o al cattivo effetto della ricercatezza fine a sé stessa o, peggio ancora, di parole banali, ma tutto è perfettamente calibrato e in equilibrio. L’autrice, come una sarta esperta, sa intessere finemente un abito che, quasi magicamente, si adatta alla corporatura poetica di ogni lettore, sicuramente di ogni lettore raffinato. Mi capita raramente di essere felice durante la lettura di un libro di poesia, è questo il caso, ma la mia è una felicità i cui sinonimi sono gratificazione e piacere: gratificazione per l’intelligenza; piacere per l’anima.
Queste poesie sono il frutto di una mente pensante e ispirata ma che non prende l’ispirazione e, brutalmente, la spiattella sul foglio, invece la demodula filtrando la portante ad alta frequenza e traendo, per il lettore, il solo messaggio modulante, che è poi il vero lavoro del poeta, captare e demodulare – volendolo pensare come se fosse un apparecchio ricevente segnali elettromagnetici dall’etere della dimensione poetica.
Annamaria Ferramosca si conferma, a pieno titolo, con questa sua raccolta – distillata dall’esperienza e da anni di scrittura, lettura e confronto a ogni livello –, appartenente alla parva acies dei poeti italiani di più alto livello (che non è equivalente a notorietà), cioè coloro che hanno conquistato l’appellativo di poeta come artigiani che dopo anni di mestiere raggiungono la libertà della perfezione nell’uso delle mani e degli strumenti del mestiere. La cosa interessante è che la Ferramosca non ha alle spalle le grandi case editrici ma editori di media statura, se non addirittura piccoli; la raccolta “Andare per salti”, ad esempio, è stata pubblicata perché vincitrice del Premio Arcipelago Itaca, ma è una poesia che potevamo tranquillamente trovare sugli scaffali della Bianca Einaudi o dello Specchio Mondadori e mi stupisce il fatto di non leggerla in quelle collane. In ogni caso si trova in buona compagnia, con molti altri poeti misteriosamente esclusi dalle grandi case editrici, mi sovviene, ad esempio, la poesia di Mariella Bettarini, anch’essa esclusa – forse volutamente da lei stessa, in ogni caso per me misteriosamente –, dai giochi commerciali dei grandi editori. Non cito a caso la Bettarini, infatti tra le scritture delle due poetesse trovo importanti punti di contatto, in parte nella forma del versificare, in parte nella capacità, magistrale, di utilizzare e giocare con le parole, soprattutto nell’uso delle loro assonanze e dei loro significati all’interno dei versi; ma trovo somiglianza, anche e soprattutto, nel fatto di essere donne emendate dall’insana sudditanza verso il mondo maschilista che spesso, anche in poesia, fa scempio della sensibilità femminile; esse, piuttosto, accolgono il miglior universo maschile e lo arricchiscono. Ricordo i numerosi incontri avuti con Mariella Bettarini, durante i quali la poesia prendeva forma sotto i miei occhi. Questo secolo sarà ricordato per la poesia al femminile.
“Andare per salti” è prefato da Caterina Davinio, è dedicato a Nicole, ha un esergo di Milo De Angelis ed è suddiviso in tre abili sezioni: “Per salti”, “Per tumulti” e “Per spazi inaccessibili”. Se dovessi riportare, qui di seguito, ogni poesia che mi ha colpito, dovrei ledere i diritti d’autore e trascrivere tutta la raccolta, cosa che ovviamente non faccio e invito invece ad acquistare il libro, è possibile farlo online. Tuttavia ho voglia di segnalare qui, a conclusione, due poesie che inconsciamente mi sono rimaste attaccate: “un fiume di latte corre nella mia notte” (pag. 40), con il bellissimo esergo tratto da una lettera di Marina Cvetaeva a Rilke (“Caro, lo so, tu mi stai leggendo / prima ancora che io scriva.”): “[…] // un fiume che cola albume sulle labbra / e nutre ogni altra bocca in terra / e ridepiange a ogni crescita // così l’osmosi in terra / inarrestabile destinoamore / che lega l’erba alle mandibole del verme / la vena d’acqua al sangue // […]”. E un’altra bellissima poesia sulla poesia e le sue parole necessarie come pioggia: “sembra che cadano dall’alto le parole” (pag. 45): “[…] // hanno esili braccia come leve di luce / a sollevare la grave pietra umana / non vanno per salti loro ma / per larghissimi voli / sulla nostra laguna sconsolata / a intercettare il centro innocente / la forma fetale del cuore // è vero è un pulviscolo di parole / che invade l’universo lo informa lo plasma / se ti metti in ascolto puoi avvertire / le onde d’urto nel bosco / il colpo secco dalla corteccia / il tuffo della rana di Basho / un chiamarsi tra loro – pianissimo – delle cose // e quella nostra stramba contentezza / nell’ascoltare […]”.
*
Leggi alcune poesie proposte nella sezione Poesia della settimana:
www.larecherche.it/testo_poesia_settimanale.asp?Id=465&Tabella=Poesia_settimanale
Id: 1124 Data: 29/06/2018 12:00:00
*
 Salvatore Contessini - Poesia - La Vita Felice
Salvatore Contessini - Poesia - La Vita Felice
La cruna
Scrivo di quest’ultima raccolta di liriche di Salvatore Contessini, trasportato da un impeto di entusiasmo che sempre più raramente sento scaturire dalla lettura dei libri di poesia, per una sorta di trasandatezza nella forma e nel linguaggio che sembra avere contagiato molti testi che mi trovo tra le mani.
Che cosa c’è nelle pagine de “La cruna”, da indurmi il desiderio di alzarmi dalla poltrona e recarmi al computer a scrivere le poche righe che seguono?
A mio avviso, le poesie proposte da Contessini si compongono, unitariamente, in bellezza formale e contenutistica, a partire da elementi grezzi che fanno da sfondo ai versi e che rassomigliano molto a quelli che ho trovato nei quadri di un pittore come Monet, quando dipingeva paesaggi avvolti dalla nebbia o i fumi di falò nei campi la sera o roseti e glicini sul ponte giapponese del suo giardino. In tali opere, uno sguardo ravvicinato e puntuale mostra la materia grezza, essiccata, che compone fisicamente le pennellate, ma uno sguardo a distanza compone tale materia nella bellezza sconcertante dell’opera. Monet riportò sulla tela, con una ben determinata modalità pittorica – in analogia, Contessini riporta sulla pagina, con una ben determinata modalità linguistica – quella parte di realtà che lo aveva “impressionato” (la sua visione del mondo, le suggestioni, le intuizioni e le comprensioni), evidenziando un realismo autografato tutto personale, lo fece con pacata urgenza e decisione nel gesto del pennello – Contessini con la sua “penna”. Monet si rese conto che erano necessarie nuove modalità espressive, atte a pronunciare al meglio la varietà delle sfumature delle nuove sensibilità, che si stavano delineando nella società contemporanea, ma senza dimenticare le esperienze primarie dell’uomo di natura, stretto dalla modernità dirompente della società industriale che stava iniziando ad avanzare impetuosa; allo stesso modo Contessini sembra rendersi conto, e come lui altri poeti, della necessità di una nuova lingua atta ad esprimere la contemporaneità e ciò che l’uomo sperimenta nello sviluppo del suo stesso pensiero, dal punto di vista sociale, scientifico e tecnologico: se da una parte è necessario tenere stretta a sé la propria umanità, intesa come elemento che ha radici evolutive ben precise, dall’altra è necessario penetrare nell’oggi scientifico e nei nuovi paradigmi proposti dalle nuove interpretazioni della realtà che la scienza propone nel suo procedere. Nei versi di Contessini trovo l’anelito, allo stesso tempo pacato e compulsivo, a forzare il blocco della tradizione per espandersi in diversi fraseggi che possano rendere giustizia a un mondo in rapido cambiamento, a ogni livello. In verità, per contrappeso, qua e là nei suoi versi, il poeta occhieggia alle proprie spalle verso la tradizione, si tratta cioè di uno sguardo a tergo nella certezza che tutto torna, anche la fine, e, dunque, tutto riparte, ciò che è stato ce lo ritroveremo davanti come antico e nuovo guado necessario, si tratta di qualcosa di già visto, come ad esempio l’amore, ma inevitabilmente immerso in nuovi paradigmi e rinnovato dall’anima del poeta.
Contessini fa parte di quei poeti che non si arrendono davanti all’evidenza del fallimento della poesia nella società contemporanea e cavalca versi la cui incertezza semantica è la loro stessa forza, come in una sorta di principio di indeterminazione tra semantica e forza espressiva: siamo di fronte a un sistema poetico, a mio avviso non destinato a diventare un “campo morfico” a se stante ma uno dei passaggi possibili verso nuovi “campi mentali”, adatti a descrivere, nella visione d’insieme, “le nebbie e i fumi” che avvolgono i paesaggi individuali e sociali contemporanei.
Per concludere, esprimo la mia soddisfazione a Contessini per i temi e il coraggio del linguaggio che, come una corrente elettrica, attraversa tutta la sua bella raccolta e la illumina (ma questo non vuol dire che i versi siano puntualmente perfetti, a gusto personale, qua e là, li rifilerei, soprattutto dove a sbalzi succedono in rima, a vantaggio semmai di assonanze più ampie).
In una struttura linguistica, che a tratti riecheggia aulica, si riconoscono i piacevoli tratti di un idioma scientifico come un “occhiello di chiarore”: “[…] cruna d’ago da ricamo // o flebile lucerna di memoria.”
Per la lettura di alcuni versi de “La cruna”, rimando alla pagina della sezione “Poesia della settimana”, sempre su LaRecherche.it.
*
Leggi anche l'articolo di approfondimento di Roberto Maggiani su "La cruna" di Salvatore Contessini, La Vita Felice:
https://www.larecherche.it/testo.asp?Id=2257&Tabella=Articolo
Id: 1115 Data: 18/05/2018 12:00:00
*
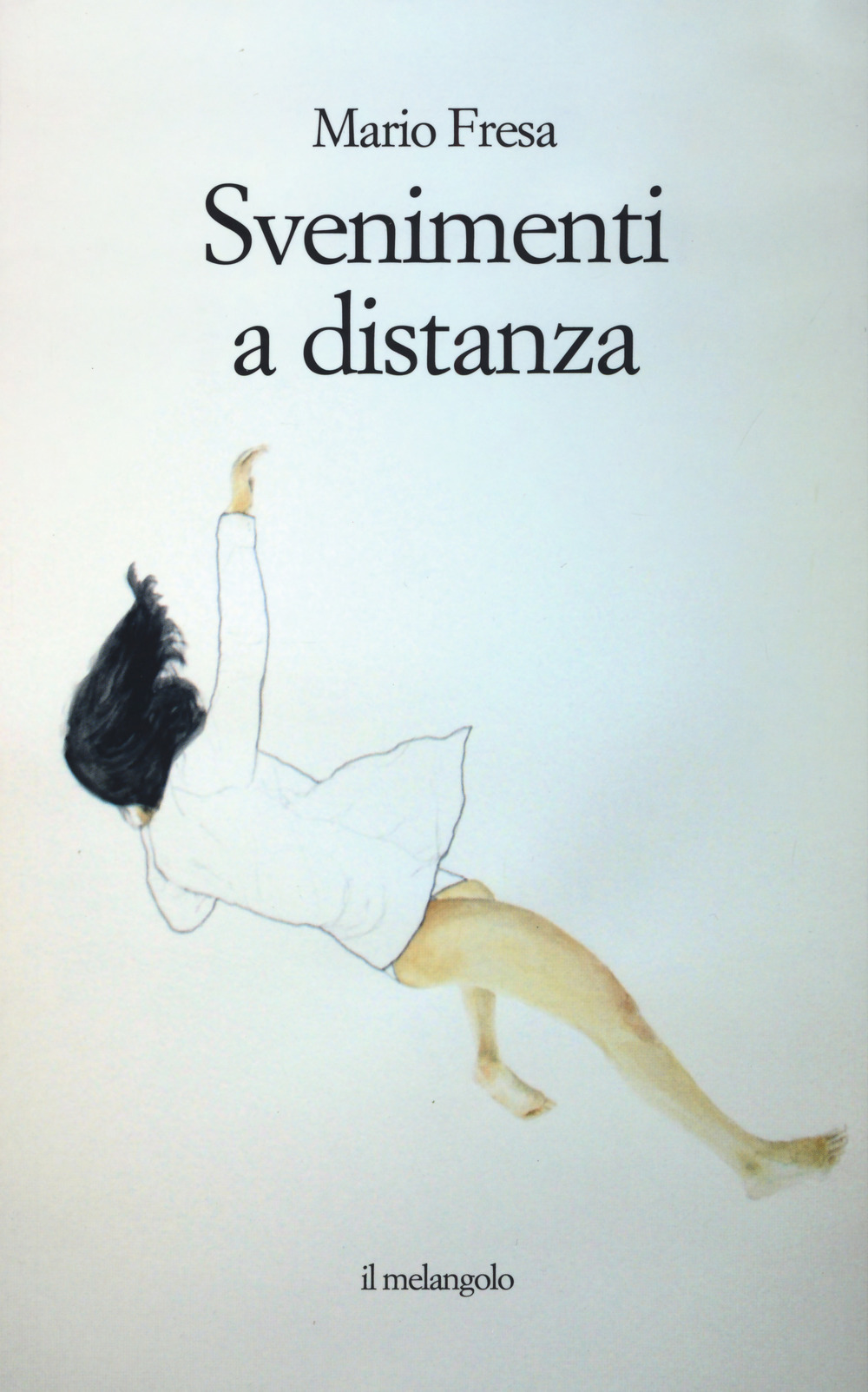 Mario Fresa - Poesia e Prosa - il melangolo
Mario Fresa - Poesia e Prosa - il melangolo
Svenimenti a distanza
Mario Fresa è tornato sugli scaffali di poesia con una nuova raccolta intitolata “Svenimenti a distanza”. Addentrandomi tra le centoquaranta pagine del libro ho trovato versi ben strutturati, al contempo solidi e fluidi, talvolta frizzanti, che procedono con agio nel solco della migliore tradizione della prosa poetica e della poesia in prosa ma con l’eccellenza della contemporaneità del linguaggio e delle tematiche, abbracciando la quotidianità con modalità personalissime e coinvolgenti. Mai retorico, Mario Fresa è lucido e fluente: colpisce la pregevole perfezione delle parole e del loro incastonarsi a modellare frasi, coadiuvate da un abile uso della punteggiatura. Il libro è un raro capolavoro di scrittura che sintetizza, magistralmente, racconto e poesia – un’opera che ci riguarda, da non sottovalutare in nessun andito.
La lettura è coinvolgente ma non siamo di fronte a una scrittura facile. In ogni pagina, e di pagina in pagina, una sapiente narrazione intreccia pensieri, intessendo il libro di una pregnante unitarietà, simile a quella di una storia che ha un inizio e una fine, densa di personaggi che con i loro ragionamenti e rimandi, a volte in prosa, altre volte in poesia, materializzano, davanti al lettore, le scene dei fatti, queste ultime, dunque, deducibili dai pensieri, dagli oggetti, dalle relazioni narrati. In ogni testo un soggetto intelligente sa osservare, dedurre, contrapporre, confrontare ed esporre fatti, a tratti rimugina e si interroga. L’io narrante è fluido e si mimetizza, evapora e si condensa da un testo all’altro; leggendo non sappiamo se si tratti di esperienze dirette dell’autore: Mario Fresa è riuscito a purificare la sua scrittura e a renderla emozionale tanto quanto basta, senza strafare e cadere così nel banale sentimentalismo; il leitmotiv di Fresa sta in perfetto equilibrio tra l’emozione dell’intelligenza e l’emozione dello spirito. Quando di una poesia, magari a commento sui Social network, si scrive o si dice: “Mi ha emozionato”, quasi sempre evito di leggerla, perché ho verificato che, con alta probabilità, si tratta di una cattiva poesia – penso che una poesia debba essere in grado sì di emozionare ma, in modo preminente, l’intelligenza, o, ancora meglio, deve essere in grado di dare alimento all’intelligenza e stimolare a quest’ultima riflessioni ben più ricche del semplice “mi ha emozionato” – il sentimento è facile da alimentare ma l’intelligenza no, per farlo ci vuole sapienza: è proprio ciò che possiede la raccolta di Mario Fresa.
Conoscendo l’autore, perché lo leggo da sempre, sono stato felice alla notizia della sua nuova pubblicazione, così come lo sono alla notizia di pochi altri poeti, come ad esempio la Cavalli, una delle mie preferite, cioè di quei poeti che si caratterizzano per il fatto di essere capaci di nutrire proprio l’intelligenza, diversamente da tanta poesia solo emozionale che si ferma al livello della pancia, perché non penetra veramente il reale.
Amate la vostra famiglia?
[…]
Infatti l’uno vicino all’altro,
contando gli alberi, si fanno sempre, alla fine,
un poco turbolenti; decidono, com’era prevedibile,
di passare alle vie di fatto e avvertono l’ossigeno
fuso nel corridoio di non poterne più;
chiediamo soccorso
ma ancora non ci tocca.
(pagina 71, sezione Galateo per un abisso)
Nel percorso di lettura, tra le nove sezioni (i cui titoli allettanti sono scelti con un piglio di felliniana memoria) di “Svenimenti a distanza”, si scorge un lavoro meticoloso di scalpello e di cesello che, a mio avviso (sarà l’autore, eventualmente, a smentirmi), normalmente, richiede molti mesi di letture e riletture.
1.
Perciò il fratello disse alla sorella: voglio andare
per il mondo per cercare giusto un po’ di fortuna.
Dimenticandosi, però, della Costituzione.
Allora, gli ordinai di ritornare, presto,
nel sacco; perché era maligno e prepotente.
[…]
2.
Così rispose, gentilmente, prima di chiudersi tutto
in un disastro che si apriva da lontano.
[…]
Saranno sufficienti giusto due colpi, gli dicevo,
oppure uno, dieci, duecento?
(pagina 54, sezione Medusa della specie)
Ora oso dire qualcosa di più sulla poetica di Mario Fresa e lo faccio usando una similitudine fisica, d’altronde sono un fisico e non un letterato. A mio avviso, specificatamente con questo libro, Mario Fresa ci mette di fronte a un sistema poetico complesso come può esserlo, in fisica, un sistema dinamico in cui sia necessario rinunciare alle assunzioni di linearità.
Un sistema complesso (il clima, per esempio, lo è) è composto da più parti o sottosistemi che interagiscono tra di loro, a cui ci si approccia in maniera olistica, e non dunque riduzionistica, essendo l’olismo basato sull’idea che le proprietà di un sistema non possono essere spiegate, esclusivamente, tramite le sue singole componenti, ovvero come risultato dei comportamenti delle singole parti e delle loro reciproche interazioni, per quanto le singole parti del sistema si suppongano essere descrivibili analiticamente.
Questo libro di Mario, per quanto ogni testo sia in qualche modo descrivibile a sé stante, ha proprietà che trascendono i singoli testi che lo compongono, tutto il libro è intessuto di relazioni, talvolta non subito evidenti, tra proposizioni, strofe, versi, così come tra una sezione e l’altra, tra un capo e l’altro del libro.
L’ho spiegato per bene, ho raccontato tutto alla portiera, anche se da questa gente c’è poco da sperare, perché lei stessa mi ha sorriso e non ha detto niente in quanto, forse, non ha capito proprio un bel nulla: gliel’ho detto, saranno i figli di M. che sono d’accordo con i miei genitori per farmi cadere, ogni volta che scendo per le scale. […] Anche mio fratello è stregato e non è più padrone della sua persona; non può venire a trovarmi con la sua macchina, perché sua suocera glielo proibisce sempre, minacciando di ucciderlo al volante. […]
(pagina 120, sezione Falsa testimonianza)
Ancora. Maggiore è la quantità e la varietà delle relazioni fra gli elementi di un sistema, maggiore è la sua complessità, a condizione che le relazioni fra gli elementi siano di tipo non-lineare. È dunque di centrale importanza il concetto di linearità.
In generale, un sistema è lineare se lo si può scomporre in un insieme di sotto-sistemi indipendenti tra loro. Ciò è possibile, in prima approssimazione, con “Svenimenti a distanza”, pervaso da una apparente linearità, tuttavia ad un esame più attento si scorgono, tra i testi, relazioni di non-linearità: i vari sotto-sistemi (alias testi) interagiscono gli uni con gli altri così da renderne impossibile la loro separazione senza perdere qualcosa.
Un sistema complesso può produrre un comportamento emergente, cioè un comportamento non prevedibile e non desumibile dalla semplice sommatoria degli elementi che compongono il sistema. Ed è esattamente la sensazione che rimane al termine della lettura di questo libro tra prosa e poesia.
Sul cumulo della testa riesco a malapena a dare
una certa età; ne puoi pagare il conto col termometro
fisso sulla parete: sono lo stesso nuotatore
che cerca di salvare tutte le macchie, di sparire
nell’emicrania come un bicchiere d’acqua.
Lo porto a riva con l’inganno di dirgli
che è solo un corridoio,
una grazia che vive nella sua stretta intimità.
Lo so che non ti piace l’autocritica.
Se dici “piano”, mi lascerai la tua bellissima
schiena afrodite da baciare
ancora un po’?
(pagina 37, sezione Alta stagione)
Tutto questo apparato teorico possiamo veramente applicarlo al libro di Fresa? Penso di sì ma con le precauzioni del caso. Tenendo conto che la complessità di un sistema non è una sua proprietà intrinseca ma si riferisce sempre ad una sua descrizione e dipende, quindi, sia dal modello utilizzato nella descrizione sia dalle variabili prese in considerazione. Pertanto, richiamando alla mente il concetto di indeterminazione poetica, da me altrove esposto, si può ben dire: è possibile che utilizzando altri modelli e prendendo in considerazione altre variabili, per esempio cambiando persona-lettore, il sistema possa apparire molto meno complesso, addirittura approcciabile in maniera riduzionistica, governato, cioè, da una poetica lineare e ben prevedibile – modalità, a mio avviso, meno affascinante, per quanto il sistema poetico sarebbe, in tal caso, sostenuto da una struttura trasparente e poeticamente inscalfibile come la bellezza sa essere.
Queste poche righe sono semplicemente un invito alla lettura, affinché ogni lettore possa rendersi conto di quale modalità di osservazione-lettura possiede, come interagisce col sistema poetico dell’autore, se lo vede complesso o semplice, riuscendo a descriverlo con molti o con pochi parametri, dipendendo questo dalla diversa sensibilità e formazione e tenendo conto che non c’è un meglio o un peggio ma una preferenza.
Infine, è evidente, e lodevole, che Mario Fresa adotti per la sua scrittura la seguente modalità:
Il fuoco ci toglierà tutta la tristezza, la tua bocca cercherà con distrazione un nuovo nome da ricordare, in futuro, con una stupita malinconia. Come ci riusciremo, allora? La risposta è nella solita raccomandazione: quando suoni qualcosa, qualsiasi cosa, non preoccuparti mai di chi ti ascolta.
(pagina 29, sezione Convalescenza, paragrafo 21).
Buona lettura.
[ Leggi alcuni testi, tratti da "Svenimenti a distanza", proposti nella sezione Poesia della settimana ]
Id: 1090 Data: 23/02/2018 12:00:00
*
 Alberto Pellegatta - Poesia - Mondadori - Lo Specchio
Alberto Pellegatta - Poesia - Mondadori - Lo Specchio
Ipotesi di felicità
Ipotesi di felicità. Un poeta, la sua poesia, che cosa colpisce il lettore? Penso che, soprattutto in questi tempi, in cui molti scrivono e pochi concludono poesia, sia proprio l’originalità. Non sono un critico ma un lettore che apre e chiude i libri in base all’interesse che l’autore riesce a suscitarmi – interesse uguale curiosità. Non c’è scampo, tutti noi lettori, che scartabelliamo tra gli scaffali delle librerie o delle biblioteche, fisiche o online, siamo rimasti quei ragazzi sui banchi di scuola che eravamo, curiosi e irrequieti, chetati, cioè attenzionati, solo dall’originalità. Lo vedo con i miei alunni, nei loro occhi è scritto: “Cosa c’è di nuovo oggi?” “Cosa c’è di originale?” Se in ciò che gli si racconta a lezione, colgono un barlume di novità, allora ti seguono, altrimenti vanno altrove con i loro pensieri e ti lasciano. Così siamo noi lettori, se tra le righe non ravvisiamo un tocco di originalità, chiudiamo il libro annoiati e lo lasciamo sullo scaffale. Tanto più se si tratta di poesia. La banalità della scrittura è sempre pronta a balzare fuori da ogni pagina.
Che cosa ci aspettiamo dai versi? Una rapida ascesa in un vagheggiato ma totalmente indefinito parnaso poetico? No, le muse ce ne scampino, direi piuttosto una rapida espansione in un volume del cosmo – letterario, immaginifico, umano, psicologico, fisico, eccetera – ben definito che la nostra mente e la nostra sensibilità non riuscivano a localizzare, forse solo vagamente.
Molta poesia, di questi tempi, è priva della capacità di dare aria ai lettori, che sono simili a polmoni, si trovano invece molto spesso asfissiati da poca originalità e maldestra fantasia di una pletora di presunti poeti che farebbero bene a lasciare la penna e a farci respirare. Non è il caso di questo autore, Alberto Pellegatta. Si evidenzia immediatamente una originalità nella sua poetica, per quanto i versi non siano subito afferrabili ma non importa, perché quello che questo poeta riesce a fare è proprio incuriosire per l’espansione rapida, che lo spirito del lettore avverte, in un luogo originale prima latente.
Ecco la prima poesia della prima delle sei parti “autonome e parziali” (come scrive l’autore in una brevissima intro) di cui è composto il libro, si tratta della parte denominata PENSARE MALE:
Due grossi pesci puzzano in salotto
mentre sfoggi un sorriso balneare.
Oppure ecco la prima poesia della parte denominata L’IMPRONTA DELLA SPECIE:
Aspetterò il mio turno, non ricordo
come dare fuoco ai sogni. Batte
sui balconi delle case che ho cambiato
sui vetri che rispecchiano le facce
fatte in altri tempi e in altri specchi
approssimate, finché suona al citofono.
E via così.
Il poeta sembra quasi “buttare là” le sue riflessioni: “Tiè, beccati questa… questa e quest’altra”. Nella stessa breve intro si pronuncia così: “La confezione di questo libro, come la costruzione della muraglia cinese descritta da Kafka, procede per parti autonome e parziali. Perché il lavoratore, preso dalla smania di terminare il progetto, non fosse sconfortato dall’impossibilità di intravederne la fine. […]” Ebbene, è proprio questo “buttare là” riflessioni in apparente ordine sparso che a me piace moltissimo e dona al libro, a mio avviso, una nota di originalità. Avviene un po’ come per un pittore che dipinge una parete usando il pennello in modo fantasioso lanciando spruzzi qua e là, a forza di spruzzare riesce a dipingere tutta la parete. Se trovassi un pittore del genere mi fermerei a osservarlo incuriosito e penserei: “Ce la farà?” Spruzzo dopo spruzzo, in breve, sarei coinvolto e direi: “Lì, guarda lì… ci riesci a buttare un po’ di pittura lì?” Pellegatta è simile a quel pittore, pittura le pareti e rende l’ambiente confortevole ma lo fa a suo modo; ciò che conta, nella relazione con il lettore, non è il fine, che forse nel caso del poeta non c’è, quanto la modalità originale di lavoro: verso dopo verso si termina il libro e la stanza è perfettamente imbiancata, la poetica è delineata. Nel percorso di lettura i versi possono apparire slegati dal contesto ma, nell’insieme del lavoro, ognuno diventa pietra di sostegno della muraglia, per rientrare nell’analogia proposta dallo stesso autore.
Ma c’è un altro aspetto che viene in luce, ed è l’essenzialità della poesia di Pellegatta, a tratti telegrafica:
Le barche battono le loro nacchere
nuziali. Spingono il cielo a est e
tra non molto ciò che avvistiamo
sarà un allattamento a Vienna.
Il cielo si abbassa sotto l’abbaiare dei cani.
Alla seconda passeggiata e alla terza lunazione
mi sono annoiato:
acqua nei laghi, penisole di lepri, troppo.
Di quattro cose al massimo ho bisogno.
L’ultimo verso, sopra riportato, rivela forse il carattere dell’autore, ma non lo conosco personalmente, sicuramente rivela la sua modalità di lavoro poetico: nella costruzione dei versi è essenziale, forte e mite al contempo. Sa innestare una scrittura più prosastica al punto giusto ma senza abbandonare la sua linea di lavoro poetico: “di quattro cose al massimo ho bisogno”. La poesia, quando eccede e non riesce a farsi essenziale, pulita, sfrondata dall’inutile, ben calibrata e lontana dall’estemporaneità, diventa insopportabile dopo appena pochi versi. È quello che non accade in questa raccolta di versi.
Porto adesso l’attenzione su un titolo che ho molto apprezzato: “LA MOLTIPLICAZIONE DEI COMIGNOLI, O DOVE ACCOMPAGNARE IL LETTORE”. L’incipit di questa poesia è degno di un romanzo di Murakami (che amo):
Non pioveva da mesi quando ho iniziato a scrivere.
Facevi qualcosa nell’altra stanza. Aggancio la cella
di un caso di cronaca nera. Ogni tre respiri
ti faccio spazio. Aggiungerei del gin.
[…]
Quando trovo uno scrittore che sa dosare l’aspetto narrativo nei suoi versi, viceversa, sa dosare l’aspetto poetico nella sua prosa, senza banalità ma con la semplice capacità di calibrare le parole, sceglierle e concatenarle con sapienza, allora mi ritengo soddisfatto di quella lettura, e molto. È questo il caso. Nella stessa poesia l’autore continua:
[…]
I tonni addormentati su una lista
il sale grosso e il contrario della legge.
Chiunque conosca le frequenze umane sa che
l’acqua ritorna alla costa e che ogni tanto
una sedia non è altro che una sedia.
[…]
“Una sedia non è altro che una sedia”, trovo questo verso fantastico, l’ho letto varie volte scorgendo in esso una sorta di mantra capace di trasportare in un’aria più rarefatta dove la verità pura e semplice delle cose umane sembra voglia rivelarsi, per quanto diafana – se non altro se ne ha la sensazione.
[…]
Non posso scrivere meglio di così, se no sarei già morto.
Togliti la giacca per entrare in questa poesia
siamo qui solo per l’italiano e avremo aerei sufficienti.
Nel corso della lettura ho trovato diverse poesie per le quali ho avuto il pensiero: “Eccola, questa avrei voluto scriverla io!” Quando succede allora è fatta, il poeta è “assunto”. Per adesso ho assunto pochi poeti contemporanei alle mie “dipendenze” di lettore esigente – strizzata d’occhio. Come ho già detto altrove, parlando della plaquette di un poeta “assunto”, basta una sola poesia a giustificare l’impresa della scrittura e della pubblicazione di un libro.
Si potrebbero dire molte cose ancora ma la poesia, per quanto oggettiva, come l’arte in genere, ha una componente di soggettività nel lettore (si veda l’indeterminazione poetica accennata in “Quanti di poesia”, Edizioni L’Arca Felice e trattata in “Poesia e scienza: una relazione necessaria?”, Edizioni CFR) che non può essere espressa se non come esperienza personalissima di fronte al dire poetico. Pertanto chiudo, invitando però alla lettura integrale di “Ipotesi di felicità”, e propongo la parte finale di una poesia che si trova proprio nella sezione omonima:
[…]
Il dolore esce oleoso dal rubinetto chiuso male.
Nell’incavo del ginocchio dove prude.
Per questo le scariche, il trauma, non per ritrovare
l’equilibrio, non per formare piazze o tendenze
ma per disobbedire alla natura, che a poco a poco
diventi libertà. Dolci sparatorie rischiarano la notte.
Per ogni forma il suo contrario. Andare in pezzi
per migliorare.
Buona lettura.
Id: 1071 Data: 03/11/2017 12:00:00
*
 Marco Amendolara - Poesia - La Vita Felice
Marco Amendolara - Poesia - La Vita Felice
Il corpo e l’orto
A Marco, in ricordo, con amicizia
Conobbi Marco per posta tradizionale cartacea, alla fine degli anni Novanta, quando la posta elettronica non l’aveva ancora sostituita e facebook e i social network non avevano ancora influenza sulle comunicazioni interpersonali. Non ricordo chi mi diede il suo indirizzo né il motivo per cui mi decisi di inviare a lui il mio primo libro di poesie, ricordo solo che rispose alla mia prima lettera con cordiale amicizia, inviandomi a sua volta i suoi versi.
Con Marco instaurai una relazione epistolare, non assidua ma piacevole e cordiale. Leggevo con molto interesse i suoi versi e, quando potevo, ne parlavo, così lui faceva con i miei, ma non era uno scambio, si trattava invece di una reale voglia e volontà di evolvere insieme in poesia, a Marco piaceva fare corpo di poesia, per Marco la poesia era un corpo, era una comunità, era un modo di vivere il mondo e di ascoltarlo e goderne o soffrirne, così come un corpo sa fare. Dico questo basandomi sulla mia esperienza personale ma potrebbe darsi che altri abbiano avuto con lui altre esperienze, dunque non voglio qui affermare degli assoluti riguardanti Marco Amendolara ma solo relativi. Ci penseranno i biografi a rendere merito alla vita di Marco, lo spero vivamente perché è un poeta che lo merita. E di ciò mi sono totalmente convinto leggendo questa sua ultima postuma raccolta: “Il corpo e l’orto”, edita da La Vita Felice.
Da molto tempo l’ho ricevuta, e di questo ringrazio la famiglia, ma non sono riuscito a scriverne subito, ritenendomi inadeguato a parlare di un poeta che mi è tanto caro, anche affettivamente. Ho letto e riletto le sue poesie non riuscendo a trovare parole bilanciate per esprimere le sollecitazioni che esse hanno indotto nel mio spirito in quanto uomo e in quanto amante della poesia.
In questa raccolta leggo versi all’apice della sua maturità poetica. Essi spandono compressioni e rarefazioni nell’animo del lettore, dunque, in analogia con il suono che si produce per compressioni e rarefazioni d’aria, i versi di Marco sono Parola significativa non solo come suono, che pure mai cede a semplificazioni né a complicate involuzioni né a ricercatezze astratte, ma, soprattutto, la poesia di Marco è significante e significato (forma e contenuto) di un mondo interiore universalmente umano e di esso narra e lo esprime con fragrante e autentica passione. Questa Parola è incapace, nel senso che non è capace di lasciare il lettore immutato, anche un lettore distratto, come lo ero io, per vari motivi, in alcune letture iniziali, così come il suono non può passare indisturbante nelle orecchie di una persona che si trova nel suo raggio di azione, a meno che questa non sia sorda o totalmente distratta e indifferente agli eventi che la circondano chiusa in una sorta di grave autismo sociale e artistico.
Non è raro trovare nelle poesie di Marco accenni a una Fisica del Cosmo usata come metafora chiara e/o chiarificante del suo pensiero:
Un’orrenda pioggia di isotopi
colpisce violenta i giardini
e gli orti.
Nell’ombra avvengono mutazioni:
la natura si apre come
un fiore velenoso,
colori venèfici si spargono
in ogni dove; noi stessi,
ormai entità prenatali,
ridotti a oggetti mostruosi,
perduta anche la paura…
Marco esprime, nelle sue poesie, una Weltanschauung, nei suoi versi c’è un riflesso cosmico simile a quello delle opere leopardiane: una sorta di pessimismo caratterizza il suo animo, c’è una sopra-natura, come se un qualche evento soprannaturale iniziasse a smembrare indifferente il mondo e l’uomo, ormai mutato nella sua stessa umanità. Marco ci vuole additare le responsabilità della contemporaneità che ha il potere di deformarci in quegli “oggetti mostruosi” che hanno perso anche la paura: tronfi dei successi scientifici e tecnologici che ci hanno allontanati dalla natura, quella degli orti e dei giardini, cioè dei tempi lenti della crescita, del contatto con la terra, spazi a misura umana necessari al sostentamento (gli orti) e alla bellezza (i giardini). Una contemporaneità complessa che ha smembrato le comunicazioni e le necessità del corpo riportandoci nello spazio “prenatale” dove eravamo isolati, singole “entità” non in relazione sociale, inesistenti. La contemporaneità come epoca di isolamento e chiusura in comodi spazi personali, talvolta di egoismo sfrenato, nei propri confini, nazionali o di proprietà privata: si diventa oggetti mostruosi se privati delle relazioni che ci fanno essere umani. Contemporaneità che ricade dall’alto, come una sorta di sopra-natura capace di colpire i giardini e gli orti: “Un’orrenda pioggia di isotopi”.
Lo sguardo, due coltelli, luce in buio.
Coincidi veramente con il tuo corpo,
o sei altro, sei in altro,
e non lo sai?
Marco denuncia, neppure troppo velatamente, la schizofrenia dei tempi odierni. Ciò che sei coincide “veramente con il tuo corpo”? Ciò che pensi di essere è veramente ciò che sei? Ecco il male moderno, di cui la televisione è il monatto, l’untore capace di portare la malattia nelle case, spargendo e imponendo immagini di modelli sia verticali (spirituali dell’essere) che orizzontali (materiali dell’uso) in cui ci identifichiamo ma essendo solo ologrammi, immagine immateriale di un pensiero, creando uno sdoppiamento-slittamento delle personalità, dunque disagi, malumori, malori personali e sociali che si riflettono in brutture di razzismi e egoismi che smembrano la comunità umana come conseguenza dello smembramento delle singole persone:
I corpi fanno natura, sono natura,
chiusi in quel carcere buio senza conoscersi,
aspettando l’uscita, la resurrezione.
Il corpo con nessun corpo coincide.
[…]
Che cosa pensi, tu che leggi, di questi versi? Li lascio qui sospesi perché sono eloquenti nel loro nitore di speranza e meravigliosa chiamata a ritrovare la propria unicità. Ma anche terribili, lì sospesi in attesa di una resurrezione che già potrebbe essere ora e qui, davanti al loro risuonare nella nostra mente.
I versi di Marco sono infiniti proprio come lo è la natura, sono un canto alla bellezza dell’uomo, in corpo e spirito:
Quando non hai corpo ti conosci meglio,
scorre e dice l’acqua
mentre si specchia in te;
[…]
C’è un sovvertimento delle funzioni naturali e dei principi fisici, che coincide con il tentativo di Marco di rimettere nel giusto ordine le dimensioni del creato. Il corpo è centrale perché è natura (“tu sei natura”), e difatti Marco ne parla con grande affezione, però lo spirito umano, la coscienza dell’uomo, è qualcosa di più rispetto alla natura del corpo, per quanto essa sia innestata nella natura corporale, da essa scaturisce come un di più, la trascende:
[…]
quando non sei corpo
susciti ogni meraviglia
e, meravigliato, sei sbigottito
dalla conquista.
La natura ti annulla, è niente
e tu sei natura.
Queste mie poche righe sono un reale invito a leggere questa raccolta, ne trarrete vantaggio come poeti, se lo siete, o come uomini e donne, se vi ponete, come si dovrebbe, domande sul senso dell’esistere in un corpo, questa fantastica unione di elementi chimici organizzati in modo così sorprendente da diventare capace di contenere la coscienza di esistere e, di più, di replicarla; ecco una delle poesie, a mio avviso, più belle ed elevate del libro:
L’iperbole l’ha inventata lui,
si può dire, quando si andava al fiume.
All’improvviso si voltava col cazzo in mano
e quel crescere del sesso
veniva paragonato agli oggetti più strani
e non era che l’umana espressione,
divenuta carne, del desiderio
di non morire e di replicarsi,
all’infinito.
Forse in ricerca di qualcuno che possa risolvere il nostro enigma esistenziale:
[…]
Ti cercavo implacabilmente,
l’avrei fatto anche
se non fossi esistito.
Invece il mondo è la Tua
lettera rubata:
sei talmente manifesto,
che gli sguardi
non Ti indovinano.
E concludo (ma senza concludere realmente poiché di cose da dire, su questi versi di Marco, ce ne sarebbero veramente molte e con maggiore scavo, e forse lo farò) dicendo che trovo, in questi ultimi versi, ancora una volta, la spiegazione di tanta simpatia a empatia poetica che avvertivo, e avverto, con Marco, la nostra ricerca, mi si conceda, ha dei punti in comune, oggi come allora. Leggendo: “sei talmente manifesto, / che gli sguardi / non Ti indovinano”, mi sono venuti alla mente questi miei versi: “Sei come un albero / che nella sua totale presenza / si assenta nell’abitudine / dello sguardo”. tratti da una poesia che vorrei qui riportare integralmente e dedicare a Marco:
Ho imparato a evocarti
dai colori e dalle forme delle cose.
Per riconoscere la tua presenza
mi bastano la soglia di una porta
sempre aperta su un patio
e una tenda
che nella brezza sappia danzare
lentamente.
Sei come un albero
che nella sua totale presenza
si assenta nell’abitudine
dello sguardo.
Io invece sono come il mio gatto
che parla ai corvi lontani:
vedendoli piccoli
vorrebbe farne un boccone –
li prega di scendere
con versi inconsulti
non sapendo della loro grandezza.
Ti cerco instancabilmente
ed è solo per la nostalgia che ho di te
che scrivo poesie.
[Dio, da La bellezza non si somma, Italic]
Id: 907 Data: 05/06/2015 12:00:00
*
 Gian Piero Stefanoni - Poesia - Edizioni Gazebo
Gian Piero Stefanoni - Poesia - Edizioni Gazebo
Da questo mare
“Da questo mare”, è il titolo dell’ultima raccolta di versi di Gian Piero Stefanoni. Un titolo che ci è caro fin dall’aprile 2013, mese in cui fu pubblicato, nella collana “Libri liberi” de LaRecherche.it, l’e-book omonimo contenente la sola sezione “Da questo mare”, delle tre contenute nel libro a stampa sapientemente edito da Gazebo del quale qui parliamo, le altre due sezioni essendo: “L’amore che ti manca”, “8, o la città”.
La sezione che dà il titolo all’opera, parte da “Il fatto”, così riportato da Stefanoni:
“Gli scafisti li abbandonano in mare. Ma un 16enne non sa nuotare e annega. Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Un immigrato, di 16 o 17 anni, è morto dopo essere stato gettato in mare dagli scafisti. […]”
Questo fatto di cronaca, una delle, ahimè, molte tragedia ben note a tutti noi, è il principio ispiratore da cui prende avvio la bellissima elegia dell’autore, nello sviluppo della quale Stefanoni riporta, a tratti, sapientemente integrati nei propri, brevi versi di altri autori; a tal proposito, in una sua nota, afferma:
“[…] Infatti una delle corde della poesia a cui ogni autore nel momento della scrittura tende, tenendo presente, è il dialogo, è il dialogo sempre aperto con gli autori che lo hanno preceduto e/o con quelli a lui coevi. Infatti, ancora, nella realtà concreta con cui il dettato poetico si misura e si scontra anche, naturale è spesso il riferimento, in assenso o rovesciamento appunto, ad incisi e orizzonti di discorsi altrui che in qualche modo persistono e richiedono un’interrogazione, uno scioglimento diverso forse all’interno dello sfondo in cui il nuovo testo muove. […]”
Un bell’atteggiamento, quello di Stefanoni, il quale, nella lettura, trova stimoli e riferimenti per la propria scrittura. Mi piace qui riportare una poesia di Giuseppe Ungaretti che il nostro autore riporta integralmente in Appendice accompagnata da alcune sue parole di presentazione: “[…] mi è apparsa subito incredibilmente vicina, per l’impronta che è atmosfera e carattere, al lavoro di scavo della mia elegia. […]”:
Notte
Il ragazzo
che nelle vene ha i fiumi
di tante umanità diverse
è scappato
dalle cornici dove
adornava
il suo dolce temjpo perduto
e nell’ora uniforme
smarrisce
la sua ombra tra le altre.
(Giuseppe Ungaretti)
Nella prima sezione del libro, “L’amore che ti manca”, troviamo invece un percorso poetico che si sviluppa davanti alle “Crocifissioni” di Giacomo Manzù. Si tratta di otto poesie meditanti:
Tre
Quale canto, quale verso
nell’incanto della notte romana?
Tu che devi tornare in poesia, Tu
che nelle piazze hai provato, e provi
ancora il crimine, respirando
nel lenimento la costanza della fine.
[…]
Nella seconda sezione, “8, o della città. pregando con l’angelo”, leggiamo versi scritti in un percorso cittadino. Stefanoni in una sua nota scrive: “Si intende la linea tranviaria 8 di Roma nel suo percorso dei capolinea Casaletto/Largo Argentina, dall’estate del 2013 Piazza Venezia.”
È molto significativo l’esergo di Jack Kerouac a questa sezione, tratto da “Sulla strada”:
“Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina, il Tuo volto attraverso i vetri polverosi della finestra, fra il vapore e il furore; devo sentire la tua voce sopra il clangore della metropoli.”
Di questa sezione riporto “Via Vitellia”:
Come voli basso, come Ti rendi
alla terra sfiorando i balconi.
Ci dici, forse, che non è
ancora il tempo della salita
pur ora che all’imbrunire risalgono
i passi di questo Venerdì Santo presso gli altari.
Non è adesso quel tempo
mentre nuovi fiori si ricompongono agli occhi
due giorni al sepolcro prima che rompano.
Con piacere ravviso, nella scrittura di Stefanoni, un percorso autorevole, responsabile e chiaro, sia nella forma poetica sia nei contenuti elevati, proprio perché profondamente umani. Il lavoro poetico di Stefanoni, mi sento di affermare, è un lavoro di “co-incidenza”, nel senso che nella propria opera riesce a far coincidere, in modo mirabile, la nostra umanità dolorante, ma fiera, e l’amore presente di un Dio che siamo liberi di accogliere e amare nelle sue varie rivelazioni che l’autore, abilmente, sa mostrare-rivelare, per quanto talvolta non subito evidente. La ricchezza umana di Stefanoni, fatta di sensibilità agli eventi individuali e sociali dei nostri tempi, è l’anima speciale di tutta la sua raccolta fino in ogni suo recondito angoletto.
Il libro si pregia della bella postfazione di Franca Alaimo, dunque non mi dilungherò ulteriormente nella presentazione, vi consegno qui alle parole della splendida Alaimo:
"Raramente accade di constatare una così grande coerenza fra le dichiarazioni poetiche di un autore e la sua scrittura: “Vorrei - mi scrive Gian Piero Stefanoni - che si pensasse alla mia poesia come a una lunga, costante preghiera ( almeno a un suo tentativo) con tutto ciò che implica nel dialogo quotidiano con il divino, con la sua infinita presenza di misericordia e sostegno del peso”. E, di fatto, i testi di Gian Piero Stefanoni aderiscono a questo programma poetico con una straordinaria compattezza che si rivela perfino nei dettagli: gli exergo, le dediche, i luoghi, le note, le date, i numeri. La devozione della parola ai temi sacri, che si esplica nella lode e nella celebrazione della bontà divina, nella sua presenza inesauribile che, per citare ancora le parole dell’autore, “si confonde e ritorna nelle dilatazioni dei nostri incontri e rapporti quotidiani con gli altri”, se da una parte riporta la poesia ad un suo compito strettamente etico e quasi “sacerdotale”, dall’altra sottolinea il divario fra la sua “impotenza” (nonostante il “dovere” di dire, nonostante i suoi tentativi di fondare una religione delle cose umane e delle relazioni fra gli uomini), e la forza fondante e fecondante della Parola divina, sola motrice della Vita e della Storia dell’Uomo. Una siffatta distanza diventa colmabile soltanto attraverso l’esercizio dell’Amore, ed è per questo motivo che l’arte perde se stessa, se non è mossa da tale sentimento.
È significativo in questo senso che Stefanoni dedichi le otto poesie della prima delle tre sezioni del suo lavoro poetico alle “Crocifissioni” di Giacomo Manzù. Di fronte ad esse, infatti, egli non si pone come un semplice osservatore, ma ritenta lo stesso percorso emozionale del maestro, condividendone l’idea che l’opera d’arte debba scaturire “da un moto d’amore” che, nel caso delle Crocifissioni, è diretto al Cristo e allo stesso tempo all’uomo, simboleggiando il Crocifisso la stessa sofferenza umana. Identico è anche il loro modo di stare di fronte alla tragedia della Storia, e, se per Manzù, nel volto del Cristo si cela quello del partigiano o quello delle vittime delle guerre mondiali, Stefanoni può intravvedervi quello dei tanti extracomunitari (ad uno di loro dedica l’ultima sezione del libro) morti nel tentativo di approdare in una nuova terra, per sottrarsi a quella povertà causata anche da un nuovo e più subdolo conflitto, spesso invisibile e apparentemente non violento, giocato dallo strapotere dell’economia sulle sorti del mondo contemporaneo.
Nel testo “cinque” Stefanoni si sofferma a lungo sulla figura dell’obeso che sta ai piedi del Cristo ripetendone il significato simbolico che il celebre scultore volle darle: quello del “sazio” potere che venera i falsi idoli, che allontana gli uomini dalla pietas, dalla fraternità, dalla fede autentica. Il tema dell’allontanamento dell’umanità dalla fede è uno dei più presenti nella poesia di Stefanoni, in quanto ad esso è attribuita la presenza sempre più dilagante del male e soprattutto quella “accettazione/ oscura che poi il cuore confonde, divide, possiede”, in altre parole, il sentimento che papa Francesco ha definito recentemente il peccato contemporaneo più allarmante: “l’indifferenza globale”.
Vorrei sottolineare come Stefanoni attui sempre questo processo di identificazione con i modelli, così come con i destinatari dei suoi testi: che siano altri artisti o personalità di fede o uomini e donne comuni, vittime di violenza. Così, nell’organizzare i ventotto testi della seconda sezione, che corrispondono, in un percorso di andata e ritorno, alle varie fermate della linea tranviaria 8 di Roma, l’autore passa dalla narrazione della via crucis di Cristo nella prima sezione a quella della via crucis dell’umanità (non è casuale, allora, che il numero ventotto sia esattamente il doppio delle stazioni sacre). Stefanoni, osservando e riflettendo anche sulla storia che i luoghi, raggiunti dal tram, trasudano, traccia una sorta di mappa parallela del dolore che dispiega sotto i suoi occhi il calvario dell’umanità: Campo del sangue, Largo Dunant, Piazza delle cinque scole, Quattro Cape rievocano la tragedia della shoah, altri luoghi affidano alla memoria i martiri del passato, altri denunciano le condizioni di vita di molti extracomunitari, e un altro (Monteverde nuovo) la morte sconcia e violenta di Pasolini.
L’intenso affresco delle umane tragedie trova però spesso una sorta di bilanciamento attraverso la memoria di alcuni destinatari, operatori luminosi del bene, come Dunant, Elio Fiore, San Camillo (implicitamente chiamato alla nostra memoria attraverso l’ospedale che gli è dedicato), Marco Guzzi; e in questo dialogo fra Male e Bene si inserisce la parola poetica che, facendosi soprattutto preghiera, prepara il riscatto.
Inoltre, la seconda sezione “8, o della città”, evidenzia un’altra delle idee portanti della scrittura di Stefanoni, non solo di questa silloge, visto che anche quella che la precede, “Roma delle distanze” ha una medesima struttura: trasformando, infatti, il cammino quotidiano in una preghiera incessante, l’autore intende comunicare al lettore l’idea della vita come di un itinerarium mentis in Deum.
L’appassionata qualità lessicale dei testi, fitti di simboli e allegorie, talvolta oscuri per eccesso di profondità e per limite naturale della parola di fronte all’urgenza metafisica, la veemenza dell’ardore immaginifico, non è dissimile dalla complessità dei testi mistici. La memoria dei passi biblici, quella dei poeti più amati, la rielaborazione in chiave sacra delle umane vicende, le riflessioni personali, il sovrasenso di molti passaggi, più che ubbidienti ad una consequenzialità logica, seguono una traiettoria interiore che infiamma la parola, costringendo l’autore quasi ad imporla e gridarla attraverso l’uso delle lettere maiuscole o del corsivo.
Nella sezione successiva, all’interno del poemetto dedicato all’extracomunitario sedicenne morto sulla spiaggia di Licata il 28 aprile del 2012, viene citata una dichiarazione del pittore Lorenzo Vespignani a proposito del suo approccio con la realtà a partire da un giorno di luglio del 1943, quando aveva assistito ai bombardamenti su Roma: “Da quel giorno la realtà, sempre più spesso, cominciò a ferirmi come un’annunciazione”.
Anticipo questa affermazione perché servirà a capire meglio il sottotitolo di questa seconda sezione che, apparentemente, non ha nulla a che fare con il titolo “8, o della città”, che è “pregando con l’angelo”. L’autore, infatti, mentre viaggia col tram, osserva i luoghi e le persone che sfilano davanti ai suoi occhi: il vetro del finestrino sembra costituire una sorta di diaframma che lo pone nella condizione di cogliere le immagini della realtà con una disposizione d’anima che sconfina nello stupore, quasi che egli le veda per la prima volta: in questo modo egli può intuire in esse qualcosa che le sovrasta e le trasforma in segni parlanti, in presenze epifaniche, quasi in una serie di annunciazioni angeliche sulla necessità di un dialogo intimo fra Dio e l’uomo, di un accoglimento amorevole della presenza divina nelle fibre di carne e sangue delle creature, attuabili solo attraverso un assenso senza paura, senza viltà, simile a quello pronunciato da Maria al cospetto dell’arcangelo Gabriele. Se si impara a guardare in questo modo la quotidianità -è il messaggio del poeta-si prega in ogni momento della propria vita con l’angelo.
La terza parte della silloge, “Da questo mare” (che le dà il titolo) è, come più volte anticipato, un lungo poemetto su una delle tante tragedie di morte per mare, che così spesso continuano a verificarsi nel Mediterraneo da molti anni a questa parte. È ovvio che il ragazzo a cui i versi di Stefanoni sono dedicati, assommando in sé tutti gli altri morti per acqua, ne rappresenti l’infinita tragedia. Anche quella degli emigranti è una via crucis celebrata, però, sull’acqua, acqua troppo spesso senza scampo e senza arrivo, senza futuro.
Questa è anche la sezione più drammatica: la narrazione della vicenda è interrotta da molte citazioni, da digressioni alimentate da altre tragedie storiche molto lontane; il tessuto lessicale s’infittisce di ossimori, di climax ascendenti (per esempio: “E dove la negazione / per occlusione agisce, abusa, oscurità/ spargendo / e spregio”, di iterazioni, di metafore forti ed ardite, di espressioni proprie del linguaggio biblico contrapposte ad altre di taglio cronachistico, imprimendo alla successione dei versi una dinamicità incalzante e senza respiro. La raffigurazione del Male è affidata a immagini intense e cupe: i traghettatori hanno “ occhi di lupo”; la morte dell’annegato, che incombe come “LA RUPE, / o il crinale / che nella crepa ci attende e riversa/ nei luoghi dove il buio si compie”, diventa per gli indifferenti, i corrotti, i già annegati nella “malattia del mondo” “ (…) una maschera / o un acconto da gonfiarsi sulle buste, / un impiantito che nessuno vedrà pareggiare”; ma ad esse altre vengono contrapposte di tenera pietas: così il “ pallore di un fiore che non ha campo,/ nel corpo e nell’anima deposto” colora il cadavere del ragazzo e ricorda un passo commosso dell’Eneide virgiliana; e, più sacralmente, il suo destino d’innocente condotto alla morte richiama il Cristo come agnello sacrificale, con un rimando all’iconografia del Crocifisso che aveva dominato nella prima sezione e che conferisce all’intero lavoro poetico una circolarità di idee e di sentimento, tenendo sempre vivo lo sguardo misericordioso di Dio che si dona all’umanità nel sacrificio estremo del Figlio.
Alla parola dell’uomo (ed in specie del poeta-sacerdos) è, infatti, dato frantumare gli errori, crepitare come una fiamma per bruciare il male, ed irrorare la terra di bene, secondo il comando dell’evangelizzazione, cioè della diffusione della buona notizia, dell’annunciazione, appunto, come più volte puntualizzato. La virulenza con la quale Stefanoni spesso adopera il verso corrisponde in modo inversamente proporzionale all’accensione del cuore, all’anelito verso l’Assoluto Bene.
Molti sono i poeti citati dall’autore: Dante, Ungaretti, Sereni, David Maria Turoldo e il contemporaneo Roberto Maggiani, nostro comune e stimatissimo amico.
Ma, tra tutti, l’impronta più riconoscibile mi sembra quella lasciata da Turoldo e non tanto per gli esiti stilistici, quanto per quell’attitudine ad innestare la poesia nella storia, che la connota quale “poesia civile”, ma senza mai snaturarne la natura sacrale (né, va aggiunto, quella estetica, intesa come ricerca di stile), in quanto nella storia con tutte le sue miserie e le sue tragedie permane sempre l’umano; così che la contingenza si trasforma in epifania del divino e in volontà orante. Si manifesta, così, la parabola del mistico che vive nel mondo anche se non appartiene al mondo.
Mi piace, a questo punto, citare le stesse parole di Turoldo: “Uno dei luoghi comuni più stolti e funesti è che la preghiera sia “alienazione”, fuga mundi, abdicazione delle proprie responsabilità. Chi parla così è gente che non sa nulla di cose spirituali: che, se c’è un uomo da temere, se c’è un autentico rivoluzionario, se c’è uno pericoloso, questi è l’uomo di autentica fede e di vissuta preghiera”.
Come Turoldo, Stefanoni sa donare, infatti, al lettore la più grande ed autentica utopia; cioè non quella che agita ideali spesso impossibili, ma quella che si ancora alle virtù teologali, in modo particolare alla Speranza, l’unica in grado di opporsi al processo di disgregamento valoriale e al cammino sempre più diffuso verso il nichilismo. La rivoluzione operata da Stefanoni sta nell’energia con cui intende volgere il cuore dell’uomo da una tentazione di rinuncia e di isolamento ad una volontà di scommettere sulla poesia come possibilità di rinnovare la parola e di riportarla al suo valore nunziante, quasi profetico.
Mai, infatti, la consapevolezza delle tragedie storiche, dei falsi idoli dell’uomo, della corruzione allontanano questa scrittura dalla Speranza, che aleggia come l’angelo più luminoso e sorridente tra le pagine di questa silloge." (F. A.)
*
Leggi l'e-book “Da questo mare”
Id: 870 Data: 23/01/2015 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Rivista - LaRecherche.it
Aa. Vv. - Rivista - LaRecherche.it
LaRivista n. 2-2014
Editoriale dell'eMagazine LaRivista n. 2/2014, anno II
a cura di Roberto Maggiani
L’opzione del dubbio
Di recente mi è capitato di essere invitato, come poeta e fisico, a un incontro tra poesia e scienza organizzato da un Liceo, è stato il culmine di un lavoro scolastico svolto dagli studenti. I ragazzi hanno individuato alcuni brani e, dopo averli letti e approfonditi insieme ai loro professori, hanno elaborato una vera e propria relazione critica, con tanto di agganci alla tradizione, che hanno esposto pubblicamente durante l’incontro. La fluidità del loro pensiero e della loro parola, insieme a una evidente onestà di esposizione, mi ha commosso, iniettandomi una buona dose di fiducia verso i giovani, il loro futuro e la scuola che li educa. Ci sono delle eccellenze, esistono! Scuole che propongono, alle giovani generazioni, riflessioni sulla ricerca poetica contemporanea.
Invitato come autore dei testi, nonostante me, sono andato con il solo intento di ascoltare, e ci sono riuscito, rimanendo molto, dico molto, edificato; ho potuto rivolgere ai ragazzi delle domande, verificando la loro genuina passione e preparazione.
A conclusione dell’incontro non sono però riuscito a trattenere una riflessione. Ho avvertito la spinta a dire loro, e al pubblico presente, che la poesia è di tutti perché tutti siamo poeti (non è però equivalente ad affermare che tutti sappiamo scrivere poesie), con ciò ho voluto appianare il podio sul quale mi sembrava fosse stato messo, sottilmente, il poeta. Ciascuno di noi ha la necessità, velata o manifesta, sopita o desta, della ricerca e dell’esplorazione.
Il genere Homo, da quando apparve lungo la Great Rift Valley, in Africa, e in particolare a partire da circa duecentomila anni fa con la specie Sapiens, avvertì la necessità di esplorare, cioè di cercare camminando. Si mosse dalla terra di origine raggiungendo tutti gli angoli del pianeta, fino a quelli più impervi, acquisendo conoscenza ed esperienza. E da allora non è finita, l’esplorazione continua, ci aspetta il Cosmo, Marte sarà la nostra prossima importante tappa esplorativa. Siamo, in sostanza, una specie “camminatrice”.
Ai ragazzi ho sottolineato che la poesia è la continuazione di quell’istinto esplorativo, una sua evoluzione; la ricerca appartiene loro in quanto esseri umani, ce l’hanno nel dna, e non potranno mai farne a meno: l’essere poeti ha radici proprio nel nostro essere costitutivamente camminatori-ricercatori. Ciascuno di quei ragazzi, come noi qui su LaRecherche.it e chiunque altro in ogni dove, nella vita percorrerà diverse strade ma la poesia sarà sempre quel passaggio aperto davanti a noi che rallegrerà, se non altro rasserenerà, la nostra esistenza, spogliandola della menzogna con il piacere della novità della scoperta: è una congenita ricerca della verità e, dunque, della bellezza… ma la bellezza ha una forma, pertanto anche la poesia deve averne una e chi tra noi scriverà esplicitamente poesie dovrà lavorare per cercare con serietà la propria, quella che esprime al meglio il cammino e la meta: armonia di forma e contenuto.
Ho detto ai ragazzi che alla base della ricerca c’è il dubbio, sia nella scienza che nella poesia. Senza il dubbio non c’è progresso né scientifico né artistico. Un poeta deve avere il dubbio sotto braccio, ogni suo verso deve esprimere dubbio. La certezza non appartiene al poeta né allo scienziato (ed ecco uno dei punti di contatto tra scienza e poesia). Chi scrive poesie deve dubitare che i suoi versi siano scritti in una forma che esprime bellezza. Il poeta, ma più in generale lo scrittore, non può essere succube dell’arroganza: né l’artista né lo scienziato possono permetterselo. La certezza è arroganza: la ricerca soffoca nel pozzo a basso potenziale dell’arroganza, la scrittura muore, tutto si ferma nell’autocompiacimento.
È importante, per chi scrive, in particolare su LaRecherche.it nella sezione “Poesia”, confrontarsi e fidarsi di chi scrive da più anni e ha un’esperienza comprovata di seria e riconosciuta ricerca poetica. Chi scrive nella sezione “Poesia” del sito non può permettersi di giustificare la propria scrittura con il solo metro, parziale, del proprio gusto, deve accettare la critica costruttiva che gli può essere mossa e mettersi in gioco, organizzare la propria intelligenza e sensibilità artistica al fine di comprendere dove “migliorare”, altrimenti potrà sempre pubblicare nella sezione “Pensieri”. Un pensiero è libero e soggettivo, una poesia non può essere libera né soggettiva ma, manifestandosi in una forma di bellezza rigorosa, oggettiva! E qui si scatena il finimondo.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la Narrativa.
Anche quest’anno, con LaRivista, proponiamo alcuni testi pubblicati nel corso del 2014, che auspichiamo possano muoversi e muovere verso il dubbio coloro che li leggono e coloro che li scrivono. Esiste l’opzione del dubbio, una manna dal cielo. Da non confondere però con la sfiducia, al contrario, il dubbio di cui parlo porta con sé la fiducia. I testi e gli autori qui pubblicati non sono necessariamente i migliori, non lo sono senz’altro in senso assoluto, ma sono una selezione di testi e autori che ci danno un’idea della scrittura su LaRecherche.it, che può essere apprezzata o meno; si consideri che noi qui ci riteniamo in cammino, non già arrivati.
Chi non è presente nell’antologia non è escluso volutamente, non ci sono motivazioni personali, o di altra natura in senso negativo, ma solo pratiche, talvolta sicuramente di svista.
Da quest’anno abbiamo il Premio letterario “Il giardino di Babuk – Proust en Italie”. Vincere un Premio non significa essere il più bravo; ovviamente è tutto molto relativo alla giuria, alla fortuna di essere conosciuti e avere relazioni (e ciò non è da vedere in modo negativo). I gusti e le tendenze delle giurie non sono assoluti ma relativi. Per il nostro Premio abbiamo una giuria di tutto rispetto, molto diversificata e che legge i testi in concorso in modo anonimo, ciò dovrebbe far tendere a un giudizio il più oggettivo possibile… ma vedremo.
Infine, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche nel 2014, redattori, collaboratori, amici e non, a rendere LaRecherche.it un luogo di confronto sereno e in divenire, così come dovrebbe essere.
Nel solo 2014 LaRecherche.it ha raggiunto e superato il milione di visite. Invito a visionare le statistiche in fondo a questo e-magazine. Grazie e buone feste.
R. M.
§
§
Id: 862 Data: 23/12/2014 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Poesia - Scuderi Editrice
Aa. Vv. - Poesia - Scuderi Editrice
Ifigenia siamo noi
Ifigenia condotta in sacrificio,
Tra le grida acute di coloro che la piangono,
Serenamente cammina con la luce,
Il suo viso voltato verso il vento,
Come vittoria a prua di una nave,
Intatta distrugge tutto il disastro.
Parto da questa poesia di Sophia de Mello, poeta donna portoghese del Novecento, per introdurre l'antologia poetica, tutta al femminile, curata da Giuseppe Vetromile.
Le autrici antologizzate sono sedici: Lucianna Argentino (Italia), Victoria Artamonova (Russia), Gaetana Aufiero (Italia), Floriana Coppola (Italia), Ulrike Draesner (Germania), Federica Giordano (Italia), Anila Hanxhari (Albania), Giovanna Iorio (Italia), Amalia Leo (Italia), Ketti Martino (Italia), Vera Mocella (Italia), Rita Pacilio (Italia), Regina Célia Pereira da Silva (Potogallo), Monika Rinck (Germania), Anna Tumanova (Russa), Vanina Zaccaria (Italia).
Non riporto qui poesie delle autrici né stralci della bella presentazione del curatore poiché, appena apro il libro, trovo scritto: “È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di questo libro o parte di esso senza l’autorizzazione della casa editrice.” (Riguardo a simili avvisi, per quanto leciti, esporrò il mio pensiero in altro contesto).
Pertanto uso la mia traduzione del testo di Sophia (tratta dalla raccolta “Coral”, Editorial Caminho) per introdurre il tema di questo lavoro corale in versi.
“Serenamente cammina con la luce”, “Intatta distrugge tutto il disastro”. Ebbene, in due versi, Sophia, mette in luce la grandezza della donna Ifigenia, con la quale le sedici autrici sopra citate, come il bel titolo “Ifigenia siamo noi” lascia intendere, in qualche modo si identificano. Una sintonia di voci si eleva dalle belle pagine dell'antologia ma i versi di queste donne capeggiano altre voci al femminile, non solo poetiche, che mi risuonano dentro, voci importanti e note ma anche voci sconosciute, vive nella nostra epoca o in altre, che hanno saputo indicare e percorrere, talvolta con enormi sacrifici, la strada verso l’uguaglianza dei diritti, civili e intellettuali, al di là dei generi. Penso anche ai molti uomini che le hanno accompagnate, spalleggiate, sostenute, imparando, anche da esse, a esprimere forza, vigore, tenacia, dolcezza. La storia umana ha visto numerose donne di tale fatta, sono molte le immagini che ci accompagnano e scuotono le nostre coscienze, senza limiti di età o condizione sociale; donne bambine o donne anziane, talvolta piccole e piegate nel fisico ma, in ogni caso, potenti nella volontà, autorevoli sul “campo di battaglia” della vita.
Vetromile, un uomo, ci presenta, con rara finezza selettiva, sedici donne diverse e uniche. Si leggono versi che non abbassano mai lo sguardo, sono vigili, non presuntuosi ma sinceri; chi li ha composti procede, nella diversità culturale, nazionale e cittadina, con “il viso voltato verso il vento”, “Come vittoria a prua di una nave”, verso il destino che la quotidianità loro riserva. Non ci troviamo a navigare in grandi sistemi esistenziali ma nella vita di tutti i giorni, nella fedeltà verso un intento, quello di raggiungere terra veleggiando con la poesia, talvolta esposte alle intemperie ma placando il mare, come Ifigenia, con il proprio sacrificio, piccolo o grande, che il raggiungimento di ogni meta richiede.
Penso al bel testo “What is poetry?” di Ulrike Draesner, uno dei più emozionanti, almeno per me, dell’intera selezione poetica, in cui si toccano vette sublimi di poesia a partire dall’esperienza di una donna intenta alle faccende di casa. Così come le poesie, dal gentile e tragico sapore mitologico, di Vanina Zaccaria che incontrano Ifigenia nel luogo del suo inganno e sacrificio, dove le figure maschili sono colpevoli della violenza, un dettato a cui fa eco e rimando la poesia di Federica Giordano, che dà il titolo all’antologia o al cui titolo, viceversa, si è ispirata per comporla (non so), in cui si denuncia la retorica dei gesti e si denunciano i sacrifici che ancora avvengono nell’indifferenza. Scorrendo attentamente i componimenti delle poetesse ci si imbatte in primizie poetiche salde come le due già citate o come “Le dodici pietre” di Giovanna Iorio, o le quasi preghiere-riflessioni insistenti di Lucianna Argentino, rivolte a un Tu che si spera ascolti: la donna rivela sé stessa, quella parte sconosciuta e personale che può sfuggire forse anche a un dio. E poi ancora Gaetana Aufiero con la sua “Per le tessitrici del Nepal”, in lotta per la vita, i cui corpi sono offesi. Per passare poi alla russa Victoria Artamonova che percorre lembi di terra e confini in cerca di una casa che sia pace. Floriana Coppola, col suo poema alla maternità, “Non sono che la madre”, tesse meditazioni in fluidi simbolismi. Anila Hanxhari, dai cui versi trapela la sottile rabbia femminile per costrizioni subite e ferite. Amalia Leo ci regala, invece, tra le altre, le poesie “Ritratto” e “Donna” che sono favolosi autoritratti di donna: desiderio e rivendicazione di azione, lotta, forza, consapevolezza e non temuta debolezza. Ketti Martino, con la sua “L’Io rifugio”, dichiara l’incolpevolezza della donna, annientando quel maledetto e inopportuno senso di colpa arcaico legato al frutto proibito, un invisibile tormento che può essere annullato nella luce della ragione. Vera Mocella sancisce la debolezza del tempo e nell’eternità trova il vero gioco dell’esistenza umana. Rita Pacilio, con la solennità rovente del suo “Il mare tracannato”, mette in scena la tragedia dell’esodo e del naufragio in strofe cadenzate di tre versi.
Da una poetica all’altra leggiamo questi poeti donna con la gioia e la tragedia che la poesia è capace di condurre anche nello sguardo, infatti, le scelte compositive s’intrecciano, si rassomigliano ma si diversificano nel carattere personalissimo di ogni autrice. Alcune di loro le conoscevo, altre no, così, di sorpresa in sorpresa, procedo e incontro la portoghese Regina Célia Pereira da Silva, compaesana della mia amata Sophia de Mello i cui versi hanno aperto questa mia lunga nota di lettura. Pereira da Silva ci regala poesie a cavallo della modernità e della classicità, in cui ragione e anima rimandano l’una all’altra ma alla fine è l’Amore che va liberato e seguito-perseguito per congiungere l’uomo alla verità; per quanto riguarda l’arte, essa è l’unica realtà oggettiva, i pensatori-critici generano idee molto soggettive, destinate talvolta al nulla.
La russa Anna Tumanova, afferma l’unicità di ciascuna persona umana su questa terra, con la sua poesia “La preghiera” eleva la voce (ma forse sarebbe più appropriato dire il canto) sulla terra degli uomini, non chiede di cambiare molto, chiede unità e pace per ciascuno ma nelle varie e diverse realtà sociali e personali in cui ognuno si trova a vivere, per scelta o destino che sia; non una pace astratta o una unità vaga ma incarnate nel personale stato esistenziale di ognuno: il viaggiatore possa trovare la casa del riposo notturno, il vagabondo la sua fetta di pane. Infine, eccoci a cavalcare la poesia della tedesca Monika Rinck con la sua finemente elaborata poesia che si sviluppa in versi estesi, quasi prosa; in “Sense” ci dona una sottile meditazione sulla libertà e i limiti dell’azione umana – per capirci, non potendo riportare esplicitamente i suoi versi, che peraltro scendono molto nel concreto, generalizzo in questo modo: non posso darti o fare questo o quello ma posso permetterlo o non permetterlo; in questo o quello metteteci tutto quello che volete, tipo: libertà, morte per fame, eccetera.
Concludo ringraziando il curatore Giuseppe Vetromile per questo ottimo lavoro antologico e anche l’editore per averlo pubblicato. Auspico un secondo volume.
Id: 858 Data: 05/12/2014 12:00:00
*
 Saverio Bafaro - Poesia - La Vita Felice
Saverio Bafaro - Poesia - La Vita Felice
Poesie del terrore
Dalla lettura di “Poesie del terrore”, alla scrittura di queste mie impressioni sul lavoro di Saverio Bafaro, sono passati alcuni mesi. È un’opera che mi ha messo in una condizione di profonda riflessione riguardo al lavoro di ricerca poetica dell’autore.
Abbiamo letto Bafaro nella sua raccolta “Eros corale”, LaRecherche.it, 2011, caratterizzata da una sorta di spregiudicatezza, fine e talvolta ironica, che troviamo anche in “Poesie del terrore” ma leggermente domesticata, in forza di una maturazione personale e poetica che inizia a bilanciare il fervore dell’età giovanile con la saggezza che naturalmente si afferma nella vita di un artista.
Bafaro realizza, con questo nuovo lavoro poetico, un progetto ambizioso. Più facile osservare il reale dall’angolatura suadente dell’Eros e legare a sé il lettore in rielaborazioni del reale, più difficile farlo dall’angolatura molto particolare del terrore, non avendone mai fatta l’esperienza diretta. Ho chiesto a Saverio il perché di una tale scelta: “Hai mai fatto l’esperienza del terrore?” Si tratta di qualcosa che va molto oltre la paura, di cui la maggior parte di noi, per fortuna, non ha fatto esperienza diretta. E nemmeno Bafaro ne ha fatta, almeno a sua risposta, e ciò si nota nei suoi versi, ma la raccolta non vuole certo essere la narrazione di una esperienza, per quanto certa poesia persegua con successo tale linea, ma semmai la rielaborazione personale e originale della sensazione latente di forte paura incontrollata che dalla superficie della nostra vita reale permette di scendere in profondità vertiginose e archetipiche.
In “Eros corale” il punto di vista del poeta, sulla realtà particolare che si prefigge di elaborare interiormente, rimane legato a una piacevole modalità descrittiva-esperienziale, nel senso che si tratta di situazioni più facilmente esperibili, se non altro immaginabili. In “Eros corale” la poesia di incipit è la seguente:
Avvenne la potenza
superlativa paura d’estasi
che spinse oltremodo
il prepuzio dell’Essere
insorto, dilatato nelle pareti
a varcare la soglia
conoscendo ogni voglia
disegno, volontà, foga
In questi versi, il poeta, accenna il manifestarsi di un’ombra sottile di paura, ma subito sublima in piacere, allontanandosi decisamente da quella strada bieca verso il terrore, per porsi nel gioco della gioia amorosa ed erotica dei corpi.
Conosciamo Saverio per la brevità dei suoi testi, per la fermezza e l’audacia che li caratterizzano, la sua è una scrittura esatta, nell’assenza quasi totale di punteggiatura, per tali motivi, ad un lettore sprovveduto, potrebbe passare per la testa che si tratti di una scrittura immediata, ma è invece cesellata e sotto ogni parola ribolle un significato, o forse più. Saverio elabora il mondo attirandolo nel suo vortice interiore (psicologico), i suoi testi hanno una funzione di trasferimento, rispondono a un codice precisamente elaborato dal poeta, un vero e proprio algoritmo attraverso il quale Bafaro prende l’inconscio del lettore e lo lega al proprio, poi si cala nel sottosuolo attraverso il pozzo in cui siamo abituati solo a calare, di tanto in tanto, un secchio per abbeverarci nella siccità del quotidiano, Saverio in quel pozzo ci si cala di persona per mezzo del corpo esteso della propria poesia, ed è disposto a portarci con lui; si tratta di una esperienza poetica non sempre agevole. Nel sottosuolo il perbenismo si deteriora, sgretolandosi insieme alle più asfissianti sovrastrutture; le intime pulsioni, i serpenti che vivono nel nostro sottosuolo, vengono a raccolta, c’intimoriscono, ma poi ci rendiamo conto che ci appartengono, noi siamo anche quello, il poeta ci sta donando una opportunità di conoscenza.
La poesia d’avvio di “Poesie del terrore” è:
Al mondo
la mia peggiore delle doléance
subito seguita, nella pagina successiva, da quest’altra:
Figure in negativo appaiono
nel retro oscuro delle mie palpebre
Il poeta avvia cioè il suo nuovo lavoro poetico con una accusa al mondo (la mia peggiore delle accuse) e chiudendo le palpebre stabilisce una divisione da esso; ribalta la visione andando a cogliere, del mondo, il pieno negativo, entra in quella che è la prospettiva del terrore: un mondo terribile è proprio quello in cui viene invertita ogni positività e privato del simbolismo della sua luce. È infatti proprio la luce ad allontanare la paura dall’uomo, generatrice del primo angosciante panico necessario al primo passo verso il terrore. Si sa che i luoghi, nel buio della notte, diventano instabili, poiché dentro di noi scompaiono i riferimenti luminosi dei simboli che li rappresentano, privati della loro luce assumono un velo di ignoto, davanti al quale il nostro inconscio diventa instabile e facilmente scivola nel dirupo dell’incubo.
Saverio, chiudendosi dietro le palpebre, annulla i simboli che la luce crea e, con essi, la certezza, quel qualcosa di rasserenante che mette insieme la realtà rendendola vivibile, tutto sommato tranquilla – la parola “simbolo” proviene infatti dal greco e significa “metto insieme” (Syn, insieme, Ballo, metto). Cercando tra le varie definizioni di “simbolo” trovo scritto: “Il simbolo mette insieme linee di pensiero e di esperienza, idee, moti, sentimenti – una sintesi che funziona non in maniera esauriente in sé, ma come funziona una chiave: il simbolo è un’immagine che apre le porte di tutto ciò che lo compone, ad ogni livello. Una luce bianca che significa e comprende tutti i colori.” Ebbene, Bafaro, con le sue poesie, tende a scardinare proprio la stabilità del mondo simbolico, propone al lettore una nuova linea di pensiero e di esperienza.
Noi che abbiamo scelto il Brutto
e letto al contrario il libro dello Stagirita
conosciamo i risvolti
dell’armonico divenuto sghembo
del calmo divenuto irrequieto
del limpido divenuto oscuro
dell’ordine divenuto caos
del simmetrico non più tale
delle proporzioni volutamente saltate
(pagina 15)
I versi di Bafaro non incutono terrore, ovviamente, ma riescono a delineare nuovi paradigmi esistenziali che possono posizionarsi alla base del principio naturale del terrore.
I corpi avanzano
nella loro prima esperienza
dell’acqua
E muoiono annegando
venuti meno
a conoscenze umane
(Annegamento, pagina 76)
E ancora:
Nell’ora crepuscolare
più lento
scorre
il mio sangue
e gli occhi terreni
intravedono
altri mondi
(pagina 77)
Nelle architetture esistenziali, che il poeta mostra lungo il suo percorso, non abbandona però il lettore, è vero che lo allontana dal mondo della luce e dei suoi simboli, ma lo riporta, al termine, proprio lì da dove è partito, dietro le palpebre, sulla soglia del suo mondo di certezze, in cui gli oggetti e le azioni hanno chiarezza nella simbologia della luce. Sta al lettore la scelta: “Quale mondo scegli?” Sembra chiederci Bafaro. “La Fine del mondo o il Paese delle meraviglie?” (Mi capirà chi ha letto il romanzo di Murakami, “La Fine del mondo e il paese delle meraviglie”).
Il libro è integrato (non dico arricchito perché non c’è bisogno di arricchire la poesia) dalle suggestive opere grafiche di Piero Crida, 17 tavole tra le quali segnalo: “Bagno di sangue”, acquerello e matita, 61 x 40 cm; “Gigantesco demone”, acquerello e matita, 61 x 46 cm; “Figure in negativo”, acquerello e matita, 59 x 44 cm, si tratta di due differenti opere che portano lo stesso titolo, una apre il libro, l’altra lo chiude – silhouette umane ben definite, presenti nella prima, scompaiono nell’opera in chiusura, rimanendo però gli stessi colori rimescolati, così come accade quando, appena chiuse le palpebre, rimangono impresse le silhouette del mondo circostante appena scomparso, ma dopo del tempo, continuando a tenerle chiuse, esse scompaiono, lasciando spazio ad un più uniforme miscuglio di indistinte forme e colori; infine segnalo “Le case attendono”, acquerello e matita, 61 x 46 cm, si tratta dell’opera in copertina, in cui la finestra accesa nella notte di una qualche periferia, con gli scuri sfasciati e cadenti e la luce che sale dal basso della stanza, danno l’idea di un luogo poco raccomandabile in cui trovarsi di notte, l’insieme rende sospetta quell’unica finestra accesa.
La prefazione di Roberto Deidier, che per certi versi propone una lettura dell’opera in altra direzione rispetto alla mia, introduce con scorrevole sapienza alla lettura di “Poesie del terrore”. Ne riporto qui poche righe: “[…] Il tema diviene invece una cornice, una prospettiva, un suggestivo brainframe. La realtà nel terrore, il terrore nella realtà: per questa via, le poesie di questo libro disegnano una geografia ulteriore, intima e relazionale, avvertendoci che siamo già, con un certo margine di sicurezza, su quel sentiero inatteso che conduce ‘dall’altra parte’ e che all’improvviso traspare nel buco di una foglia autunnale. Non è la morte, o solo la morte, prima fonte di ogni possibile terrore: è piuttosto quella ‘lingua oscura’, necessariamente oscura, che ci invita sulla ‘spiaggia inviolata’ del nostro io originario.”
Guarda il booktrailer di “Poesie del terrore”
Id: 845 Data: 31/10/2014 12:00:00
*
 Antonio Spagnuolo - Poesia - Kairós Edizioni
Antonio Spagnuolo - Poesia - Kairós Edizioni
Oltre lo smeriglio
“Oltre lo smeriglio” è la nuova raccolta poetica di Antonio Spagnuolo, prima edizione settembre 2014. Essa è divisa in due parti: “Ricomporre”, “Memorie”.
L’uscita di un libro di Spagnuolo è sempre un evento molto gradito, almeno da parte mia, per l’efficacia della sua scrittura. In che cosa consiste tale efficacia è presto detto se pensiamo alla poesia come a un luogo, situato in qualche parte dell’esistenza interiore dell’uomo, in cui vi è un’attività energetica potentissima ma silente, invisibile agli occhi ma solo perché sommersa-custodita in strati esistenziali inferiori (non in grado ma in posizione figurata), cioè in camere magmatiche la cui presenza si rivela, con chiarezza, a chi frequenta la poesia nelle sue varie manifestazioni laddove essa decide di emergere con forza e destrezza, come dalla lettura di un libro o di un blog, dall’ascolto di una voce che declama o legge, o altro.
Il “magma” interiore di ogni persona è una durezza rocciosa fusa da forze vigorose, resta lì quiescente nell’intimo finché, spinto in superficie, fuoriesce da tali silenziosità sotterranee e, come lava, scivola con decisione verso il mare dell’emozione e della ragione, portando con sé ogni sorta di minerali: elementi umani quali virtù nascoste, memorie segrete, passioni sopite, intelligenze inaspettate; spazzando via, nel fluido più o meno viscoso rossore, prassi, passività, pigrizia, torpore, indifferenza, insensibilità, inerzia, rassegnazione. Tale è l’effetto efficace della poesia di Spagnuolo, smuove, anche in un momento di apatia esistenziale. Si tratta di una scrittura forse non subito esplicita e chiara nei suoi intenti, così come non lo è un terremoto, che non si sa cosa annunci, da quale direzione arrivi e come o quando finirà, ma alla sua forza scuotente non si sfugge.
La poesia di Spagnuolo è dunque fluida e misurata nelle parole, scorre, ma talvolta, come lava a contatto col mare, sembra solidificarsi superficialmente in un simbolismo che solo in apparenza pare raffreddare il flusso poetico. Le parole, singolarmente prese all’interno del dettato poetico, così come talvolta anche i singoli versi, non sono sempre di immediata comprensione, non rispondono cioè a un logico accostamento di senso, talvolta vien da chiedersi: quale sarà l’intento del poeta? Se ci si ferma nel puntuale si può rimanere stupiti dalla scelta linguistica, da una sorta di inesattezza latente (la intendo qui nella sua accezione positiva, un po’ come il dubbio – leopardianamente parlando – è la strada verso la verità), ma seguendo il percorso di salita del magma si arriva nel luogo in cui le singole parole e i singoli versi si compongono in una meravigliosa eruzione di senso e significato compiuto, la montagna diventa spettacolare, infiammata e potente, bella, quasi sorridente, pur nella tragedia che mette in scena. Proprio in questo si evidenzia, a mio avviso, la grandezza del poeta Antonio Spagnuolo, nella sua capacità di trasmutare l’insieme delle parole, e dei versi da esse composte, in eccitante poesia, nonostante il simbolismo, più o meno marcato, tenda a criptare le informazioni. Volendo rimanere nell’analogia vulcanica, l’azione che compie il poeta Spagnuolo, è simile a ciò che avviene durante una eruzione, i singoli elementi che la compongono, lava, ceneri, gas, vapore, bombe, riescono a rendere l’insieme uno spettacolo ineguagliabile che dà al contempo timore e vigore.
In “Oltre lo smeriglio”, Spagnuolo, cammina nel solco di una sua personale esperienza, tra memoria e presente, nostalgia e proposito, dolore e gioia. Ma solo un poeta che vive senza menzogna, perché fermo nella verità della poesia, può, con la sua voce, in calibrate sottigliezze e lavorazioni attente sul verso, deviare l’attenzione del lettore dai suoi personalissimi dolori e gioie a quelli universali, coinvolgendo, in tal modo, il lettore stesso, nel gioco della poesia; caricandolo di fervore poetico esistenziale lo porta, per successive riflessioni, a scorrere i versi come una pista di decollo, un mantra o una preghiera che eleva a più importanti affari di quelli piccoli e corruttibili in cui normalmente sguazziamo.
Infine. Mi hanno colpito i titoli delle due già citate sezioni, Ricomporre e Memorie, a mio avviso azzeccati in relazione al titolo dell’opera: Oltre lo smeriglio. Lo smeriglio è un minerale che può essere utilizzato per smerigliare, appunto, il vetro, al fine di renderlo opaco. La sua opacità nasconde ciò che avviene nella stanza al di là del vetro, pur rimanendo visibili eventuali luci, colori, ombre. Il poeta cerca qui, probabilmente, di ricomporre un passato nella sua memoria, di guardare oltre lo smeriglio del tempo presente. Ma guardare nel passato, così come nel futuro, significa ravvivare il presente, e non invece allontanarsene, come si potrebbe facilmente pensare. Il poeta ricompone e prevede-precede i tempi del suo personale passato-futuro… ma anche del nostro, se il poeta è capace di universalizzare la sua voce, e Spagnuolo lo è grazie alla sua maestria, affinata in anni di ricerca poetica, di osservare ombre e luci oltre lo smeriglio.
Propongo qui in lettura tre poesie.
Da “Ricomporre”:
VI
Rispondi l’orlo
slombato a perdere distanze.
Sparita al crepuscolo
quando gli sguardi attoniti
tornano a recitare
lentamente minuti.
Eccoti nuda come sogni
scalcati all’impazzata:
rimani interdetta negativa
declinando bisbigli,
consumandoci rincula la vecchiezza.
Quasi scopri paura
a colonne di menzogne:
giri la tana
da oltre cinquant’anni.
VIII
Altre figure hanno violenze col remoto,
scompaiono a carpire le improvvise
ambrosie,
troppo lontane per questo infinito,
riavvolgi occasioni
impre/disposta.
Regole d’ossa
trascino mezza tacca,
dispensa schisi d’intervento
finché bocco/ni
rugo moti a macchie.
Ormai piaga d’un giogo
trapana la rena.
Non sapremo nome
mediando la scena,
brandi gavatta,
alle finzioni inoculi
meridiano logorio.
Da “Memorie”:
Talvolta
Così, attendo talvolta nel tramonto
il riflesso leggero di un colore
che mi stupisca,
come allora il bisbiglio
delle tue labbra rosate, nelle sere.
Ora potrei contare le tue ossa
e inorridire al buio della bara.
Immagino i tasselli della notte
che ripetono il volto nel tormento,
piegato ad invocare l’infinito.
Non posseggo memorie di parole
e svanisco giocando contro il tempo.
Id: 844 Data: 24/10/2014 12:00:00
*
 Aa. Vv. - Rivista - LaRecherche.it
Aa. Vv. - Rivista - LaRecherche.it
LaRivista LaRecherche.it n. 1 - 2013
Il disegno che raffigura Marcel Proust sulla copertina della rivista è di Lisa Merletti
Editoriale della rivista
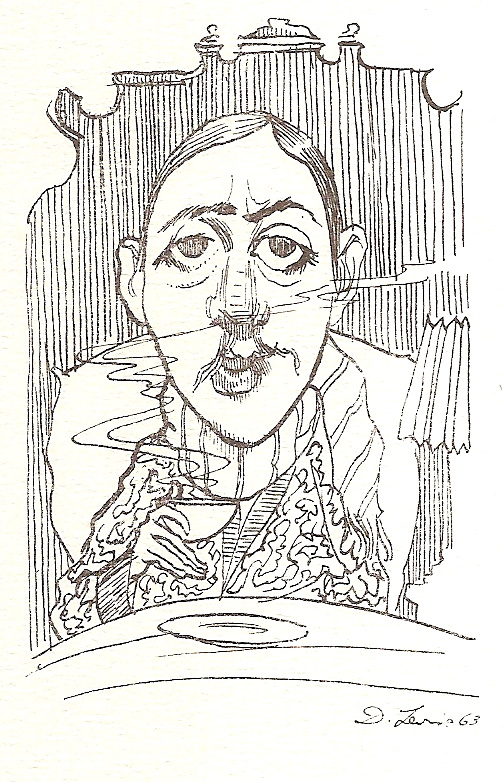

Perché la scelta di raccogliere, in formato eBook, alcuni tra i testi pubblicati on line su LaRecherche.it negli anni che vanno dalla sua fondazione, dicembre 2007, alla fine, più o meno, del 2013?
È presto detto, la scelta è dettata dalla volontà di ripresentare, all’attenzione dei lettori, i testi e il loro valore, per quanto non assoluto, per contrastare la corrosione della dimenticanza, favorita dallo stesso “marchingegno” internet in cui i testi navigano come su una zattera. La Rete, anche a causa della spiccata tendenza dei navigatori ad utilizzarla in modo autoreferenziale, è un tritatutto che pian piano fa poltiglia di ogni proposta, omogeneizzando, nel suo abisso multimediale, idee, forme e contenuti. Ma è indubbio che Internet abbia la grande potenzialità di donare visibilità a chiunque, è un piano zero da cui chicchessia può innescare un processo di crescita, talvolta anche esponenziale, nelle proprie attività e proposte. Ciò è potenzialmente possibile, ma non è detto che avvenga, infatti, da soli, in internet, è molto difficile prendere forza e crescere, ci vuole una comunità che sostenga una data proposta, la accolga e la amplifichi, rendendola visibile; insomma, ci vuole una comunità che faccia da serra, attuando un luogo in cui crescere sani e robusti capaci di reggere il vento della dimenticanza. Una tale comunità ha anche la forza di stabilire una oggettività, parola che, di questi tempi, equivale a salvezza dall’estremamente labile e inquietante soggettivismo che rende ogni proposta una melassa insapore. Troppi sono coloro che proponendosi si dispongono all’inizio e alla fine di un percorso, unici corridori in piste create ad hoc, mistificatori autoreferenziali, sospesi nelle nefaste logiche dell’arrivismo (arrivare dove?).
Eccoci dunque a offrire i frutti di un nostro raccolto, i virgulti, le pianticelle, gli alberi, che immaginar si voglia, coltivati nella nostra comunità, una tra le comunità virtuali che, a ragion veduta, possiamo anche serenamente chiamare reale, si tratta dei frutti di ciò che è stato a suo tempo seminato.
I testi pubblicati hanno un valore? Letterario? Civile? Sociale? Sicuramente umano. Ma che cosa intendiamo qui per valore dei testi? Tale affermazione è da valutare in relazione allo scopo specifico de LaRecherche.it, esso campeggia fin dai nostri inizi nella pagina “Chi siamo”: Questo è, prima di tutto, un luogo di partenza, di aiuto reciproco, di lavoro comune e di confronto sulla scrittura: da qui si parte, non si arriva; o meglio, qui si arriva soli per partire insieme...
Dunque, il valore di un testo è, in questo contesto, essenzialmente in relazione a ciò che l’autore ha saputo mostrare di sé nel gioco della scrittura, in relazione alla propria maturazione in quanto scrittore.
Forse alcuni testi non saranno eccelsi, ma in ogni caso fanno parte di un percorso, e questo è il loro valore, essi sono situati su un sentiero che sale verso il Parnaso, si può dire? Ma sì, diciamolo con serenità, parliamo pure di un luogo della poesia, dove alberga e sorseggia la sua meritata eternità, lì sì che vorremmo arrivare. Tuttavia l’albergo della poesia è lo stesso dell’arte, ed esse si sovrappongono dando vita alle molteplici espressioni della creatività umana, e anche in questo luogo, chiamato LaRecherche.it, vorremmo accogliere, come la stalla di Betlemme, le luminose manifestazioni del rapporto dell’umano con l’assoluto mistero che ancora, per fortuna, ci sovrasta.
Personalmente cerco di tenere bene a mente quanto dice la mia amata Sophia de Mello in una sua poesia: Ebbene, bisogna sapere che la parola è sacra / Che da lontano molto lontano un popolo la portò / E in essa pose la sua anima fiduciosa. E noi vogliamo riconoscere nelle parole quest’anima, perché crediamo che le nostre origini stiano nelle nostre parole, ed ogni parola non accolta o disgregata nel capitalismo di parole del demagogo, sia un delitto contro il popolo e la sua anima fiduciosa (è un pensiero che fu caro alla poetessa, espresso nella sua poesia Con furia e rabbia).
Collegandomi a un concetto utilizzato per esprimere la bellezza dell’opera proustiana, dico che la raccolta di testi qui proposta è una piccola cattedrale – oh, che presunzione –, una architettura di vite e di idee che si solleva nello scorrere del tempo che ci è dato, fatto di presente e ricordo, ma anche di futuro, di denuncia di ciò che ne insidia le fondamenta, e cioè il tentativo continuo di uniformare tutto al solo interesse economico; noi lottiamo, contro questa e altre nefaste ideologie, contro la monetizzazione di ogni cosa, del sapere, delle competenze, noi siamo il popolo del gratuito. Si tratta di centinaia di autori, una parva acies che resiste nell’impero dell’economia letteraria in cui poche voci si rimbalzano l’un l’altra glorie e profitti.
Ma, ahimè, la nostra piccola schiera di autori è ben più ampia di coloro che abbiamo mandato al fronte per mezzo di questa rivista, nella quale non siamo riusciti a inserire tutti gli autori, dunque è una raccolta per forza di cose parziale e non rende pienamente l’idea del lavoro, dello sforzo e della ricchezza di un luogo, di una comunità o di un singolo. Nessuna esclusione è voluta, mi si creda; siamo andati a selezionare con libertà, senza timore di fare torto ad alcuno, perché di torti non ne vogliamo proprio fare; chi tra gli autori non si trovasse in questa selezione ci sarà nella prossima… forse, se sarà necessario, se il destino lo vorrà, non siamo abituati a fare calcoli, ci muoviamo con serena tranquillità, certi della comprensione di tutti. In ogni caso ci tengo a rimarcarlo: chi non è qui proposto non vuol dire che non abbia scritto testi di grande valore, semplicemente c’è da tenere conto che su LaRecherche.it sono pubblicati, a oggi, più di sedicimila poesie e più di cinquemila testi in prosa – date un’occhiata in fondo alla rivista, troverete interessanti statistiche –, qualcosa ci è sfuggito, lo sappiamo.
Concludo informando che questa rivista vorrebbe avere una cadenza annuale. Grazie e buona lettura.
Grazie e buona lettura: LaRivista LaRecherche.it n. 1/2013
R. M.
Id: 779 Data: 23/12/2013 12:00:00
*
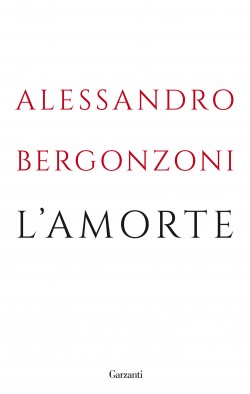 Alessandro Bergonzoni - Poesia - Garzanti
Alessandro Bergonzoni - Poesia - Garzanti
L’amorte
Mentre attendevo l’ora per un appuntamento di lavoro, sono entrato in una libreria di Testaccio, a Roma. Come solitamente faccio, ormai da molti anni, quando entro in una libreria, mi sono recato al reparto dedicato alla poesia, ma chiamarlo reparto, in quella particolare libreria, è come confondere il mio gatto con una tigre, infatti, più che di reparto si tratta di due mensole con la stessa estensione di quelle che ho a casa e sulle quali stanno, appena appena, tre teiere e altrettante tazze. Inizio la mia solita scansione dei libri e tra gli sparuti titoli, e la monotonia degli stessi autori, tra tutti cito la Merini, ecco che trovo una novità, ho un sussulto: L’amorte, edito da Garzanti; poi leggo l’autore, Alessandro Bergonzoni, e penso: guarda guarda, si sono sbagliati, hanno messo un autore di prosa tra la poesia. Invece no, apro il libro ed ecco che trovo proprio una scrittura in versi. Garzanti, mi dico, una casa editrice importante; normalmente tali case editrici pubblicano pochi titoli di poesia, quando ne pubblicano uno dovrebbe essere garantita una buona lettura. Bergonzoni? Non ho mai letto sue poesie. Vado subito a cercare il riferimento biografico, nel secondo risvolto di copertina leggo:
È artista, autore e attore teatrale. Ha scritto e interpretato 14 spettacoli con i quali ha vinto i principali premi teatrali. Al cinema ha partecipato al Pinocchio di Roberto Benigni e al Quijote di Mimmo Paladino. Ha collaborato con Radio 2 e Radio 3 Rai, raramente con la televisione e con varie testate giornalistiche. Attualmente collabora con «il Venerdì di Repubblica». Dal 2005 espone la sue produzioni artistiche in gallerie e musei. Tra i suoi libri ricordiamo: Le Balene restino sedute (Palma d'oro di Bordighera 1990), È già mercoledì e io no, Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, Opplero - Storia di un salto, Nel (tutti editi con Garzanti); Silences - Il teatro di Alessandro Bergonzoni (1997), Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna bambino animale o cosa(2005) e il libro di disegni-scrittura Bastasse grondare (2009).
Con una biobibliografia di tale portata la speranza e l’attesa salgono. Torno al primo risvolto di copertina e leggo:
Il primo libro di poesia di Bergonzoni può essere la dimostrazione che, a forza di «praticare l'inesistente che c'è», non ci si riduce, anzi, ci si spande e si dilaga.
Con quest'opera infatti riparte, ancora, per una delle sue prime incalcolabili volte.
Una scrittura piovana, anfibia e incrociata, di chi si sente «più autorizzato che autore, più scritturato che scrittore, perché il pensiero è frequenza e a noi è concesso captarla, accoglierla, farla abitare».
Le attese salgono ancora di più. Decido di leggere il libro… ma già dopo le prime pagine: puff! Mi sgonfio e mi chiedo: si può decidere di diventare poeti? Basta aver scritto molti libri in prosa, essere attori, aver vinto vari premi, essere personalità note e riconosciute, o non so quale altra astruseria, per essere poeti? La mia risposta è ovvia, ma non sembra altrettanto ovvia per tutti, specialmente per chi sta nel mondo dell’editoria.
Questa poesia non decolla, il verso risulta riluttante, forse non gli sto simpatico, in ogni caso non entra, non rimango convinto. Mentre leggo mi sgonfio sempre di più, solo poche poesie, a mio avviso, hanno in se stesse la delicatezza e la forza dell’arte poetica.
Trovo versi scomposti, ma forse è ciò che l’autore vuole, forse nella mente dell’autore c’è una musicalità incerta e trasgressiva che essi devono avere, forse andrebbero ascoltati dalla sua viva voce, rimane il fatto che nella mia lettura li trovo senza esigenza, non hanno voglia di emergere, il suono si disperde nella pagina stessa del libro, non entra in risonanza con il mio spirito di lettore, in cui risuona, invece, una eco discordante. Forse l’effetto voluto da chi ha composto questi versi è proprio quello di mettere in mostra “l’inesistente che c’è” nella vita moderna, tutto l’effimero e sentenziato modo di vivere in questa società schizofrenica, fatta di paure immotivate e poi di gioia ingenua, di accuse e poi di perdoni spudorati, di amore come fosse una morte e di morte come fosse un amore; forse si tratta di una denuncia: siamo ancora capaci di morire per amore o di amare da morire? Forse è tutto questo, o molto, molto di più. Non so, forse dovrebbe rispondere l’autore stesso, ma non penso proprio che lo farà. Ciò che io semplicemente rilevo è che la sua scrittura comica e surreale, di successo in altri suoi libri di narrativa, non mi convince nel contesto del verso. È un mio limite? Può darsi.
Mi perdonino l’autore, l’editore e chi altri ha scelto di pubblicare L’amorte; perdonino il mio pensiero, qui esposto così schiettamente, tutti coloro che leggono queste righe, ma penso che se un qualsiasi autore sconosciuto avesse inviato questi versi ad un editore, anche allo stesso che li ha pubblicati, probabilmente, non sarebbe stato minimamente preso in considerazione; ovviamente si tratta di un mio libero pensiero, fondato su una ventina di anni di esperienza nella lettura e scrittura in versi.
Sono d’accordo sul fatto che Bergonzoni si senta “più autorizzato che autore, più scritturato che scrittore”, chi l’ha scritto nel risvolto di copertina avrà forse voluto in qualche modo sottilmente giustificarsi per aver pubblicato il libro?
Sicuramente non mi farò amico Alessandro Bergonzoni al quale, come avviene alla maggior parte degli scrittori ai quali muovo una critica, andrò di traverso, ma a lui basterà un colpo di tosse per tirarmi via e deglutirmi (lo dico con la segreta speranza di sbagliarmi).
Per concludere faccio un invito: leggete il libro e venite a esprimere i vostri pareri, convincetemi, ve ne prego, che mi sto sbagliando, sarei più felice, lo giuro, nel sapere che ogni poeta riceve la sua giusta mercede.
Id: 765 Data: 26/11/2013 12:00:00
*
 Franca Alaimo - Poesia - LietoColle
Franca Alaimo - Poesia - LietoColle
Sempre di te amorosa
Franca Alaimo torna in libreria con una proposta di lettura di poesie capace di coniugare grandezza e levità, e di sostenere il confronto, perché anche di confronto in arte si deve parlare, con i maggiori poeti suoi contemporanei; anche se, ahimè, Franca, pubblica con questo pur ottimo editore, al quale rendiamo merito per avercela proposta, ma la cui distribuzione non può certo competere con i più grandi editori, quali Einaudi e Mondadori, che attualmente sostengono il carico poetico dei più noti (non per questo più importanti) autori italiani. Il nuovo lavoro poetico di Franca contiene venti poesie ed è un vero fiore di poesia dalla bellezza incontaminata nel giardino della poesia italiana, un libro che, ne sono certo, potrebbe letteralmente andare a ruba, se posto ben in vista sugli scaffali di una libreria molto frequentata.
Il titolo già ci svela il filo conduttore dell'opera, il ganglio emotivo di tutta la raccolta – la quale è introdotta da una bella prefazione di Anna Antolisei (curatrice della Collana Et Nunc Imprimatur) e da un bel racconto di Stefanie Golisch tradotto dal tedesco da Mimma Albini –, si tratta della madre, quella di Franca, e del rapporto profondo instaurato con ella, nonostante la sua scomparsa prematura quando la l'autrice aveva soli quattro anni. Si può dunque intuire l’intensità sonora-emotiva delle parole con cui l’autrice intesse versi, per lo più lunghi, definendo una struttura narrativa di tutto riguardo in un dettato poetico ovviamente sostenuto da sostantivi e verbi, ma illuminati e armonizzati con le scale cromatiche degli aggettivi, sapientemente innestati nella costruzione pittorica (o fotografica) che ciascuna poesia sembra essere, infatti ne basterebbe una sola per dare il senso e la profondità della realtà poetica irradiata da Franca; pur tuttavia, sfogliando le pagine, di poesia in poesia, ci si accorge della bellezza e dell'unitarietà del viaggio che si è iniziato in questa galleria di sentimenti e ricordi e immaginazioni, ogni poesia diventa cioè essenziale e desiderio della successiva, l’insieme delle venti poesie è un unico poema, una elegia all’amore materno/filiale. Mai, in questi versi, si cade nel dirupo dell’ovvietà, non è facile parlare del rapporto materno senza caderci dentro (all'ovvietà) almeno in un verso, cosa che non accade mai, a mio avviso, in queste poesie che sanno stupire nell’intreccio minuzioso delle parole accostate l’una all’altra in modo semplice ma impensato, innestando nella poesia stessa quel quid che fa di un poeta un grande poeta; traluce un’anima che sa dire della propria esperienza fisica/spirituale/sentimentale in modo unico ed esemplare ma tale da far esclamare al lettore la sua sorpresa per quella sequenza di parole che mai aveva pensato potessero l’un l’altra elevarsi in un canto tanto armonioso, è il miracolo delle parole che, come colori, si armonizzano e donano un sorriso quieto ed aggraziato al lettore.
Nonostante ciò, dice bene Maria Grazia Calandrone in quarta di copertina: “La poesia di Alaimo è di natura strabordante e attraversata da sismi di commozione molto ferma; capita raramente di leggere una poesia così fitta, febbrile e volponianamente corporale quanto allo stile […]. Ci vuole coraggio ad essere così nude senza nessun antiveleno d’ironia, per eporre così coerentemente la propria ferita […].”
Mi pare utile riportare qui una parte della Nota dell'autrice:
“Questo libro è dedicato a mia madre, Johanna Becker, che morì quando io non avevo ancora quattro anni.
Ho raccontato tutto quello che so e ricordo di lei alla scrittrice Stefanie Golisch, la quale ne ha ricavato un racconto in lingua tedesca, Tortorici, (tradotto da Mimma Albini) aggiungendo, ovviamente, particolari da lei immaginati, ma straordinariamente verosimili.
Ho pensato che questo bellissimo racconto, che è stato presentato e letto a Berlino il 24 novembre del 2011, nel salone della scrittrice Erna Fizner, potesse essere una necessaria cornice alla comprensione del lettore e alle mie stesse poesie.
[…]
Alcune di queste [poesie] sono state pubblicate sulla rivista Poesia (Anno XXIV – Giugno 2011 – N. 261) nella rubrica Cantiere Poesia, curata da Maria Grazia Calandrone.”
Ed ecco tre poesie:
La visitatrice
Ecco la mia visitatrice che ritorna e mi offre
Le mani di latte, odorose di capra. I fiocchi
Di neve, cadendo uno ad uno sul capo
Le fanno stellari trasparenti di ghiaccio.
Nelle tasche della ruvida gonna conserva
Le bacche più amare, ma il suo petto canta
Le canzoni aurorali della sua prima giovinezza.
Lei cammina sulla strada del sogno nella luce
Sgorgata dalle palpebre chiuse e mi sembra
Che i suoi passi leggeri tra gli arbusti innevati
Mi parlino una lingua straniera. O notturna –
La chiamo – O mia perduta! Ma lei tace chiusa
Nella sua saggezza. Ha il ricordo delle cose
Anteriori e di una bimba fresca distesa
Sotto gli alberi di noccioli. Poiché lei è fatta
Di sogno, di nebbia e di soffi di cielo, e non più
Possiede un corpo, ma una chiarità di madreperla.
Però anche così, la silente, la purissima, è
Tra tutte le visioni la più dolce da guardare.
Quando andavamo al fiume
Sì, c’era, dopo i cespugli fitti,
Ma prima il canto e un fruscio in movimento
E il vento ora assente ora veloce e finalmente
Come la visione di un altrove veniva il fiume
Correndo verso il mare lontano e già dilagante
Nell’ansia e nel cadere verticale da una balza muschiosa.
Per ore contemplando tra ardori d’erba alta
Aggrovigliata e i gigli selvatici esplosi
Da tuberi infossati nella terra intenerita d’acqua
Fra radici e sassi levigati. Di fronte alla sua forza,
In sovrabbondanza di grazia, stavo muta,
Accoccolata come un dolce animale,
Con le mani sporche e la menta selvatica tra i denti.
Lei nel pensare, assorta, al fiume che trascinava il passato
E il luogo lontano, cantava una canzone
Nella sua lingua natale di suoni misteriosi
Come quelli attraverso i rami e le foglie del bosco.
Andiamo dove, andiamo dove? cantavano - era già sera -
Gli uccelli notturni e il fiume diventava un drago con tanti
Occhi aperti e dardeggianti. Lei mi custodiva la mano
Come una colombella nella gabbia per paura che mi perdessi,
Che affondassero i piedi. Scoppiavano in ogni albero alto,
Solenne, inni rituali, cerimonie nascoste, e le ombre
Scrivevano geroglifici sacri sull’aspro delle cortecce.
Le caviglie graffiate, le foglie infilate fra i capelli,
Le tasche come culle di corolle già esangui,
Foglie aromatiche e il giorno morto tra i ricordi.
Le nostre braccia allargavano il mistero e passo dopo passo
Sul sentiero conquistavamo ancora il ritorno alle cose:
Una brocca di argilla bianca con l’acqua della fonte,
Il pane caldo lievitato nel forno di pietra e tre pere mature
Posate sul tavolo di legno grezzo, prima del sonno.
O madre bellissima del parto
Mentre ti sfioro il ventre gonfio come una susina
Torna improvviso il tempo del giardino
Che s’infolta e aggroviglia d’erbe selvatiche:
Qui crescono i giri e i cardi spinosi,
Là cespi di borragine e i fiori gialli della cardella,
Fruttificano i noccioli sotto il cielo autunnale,
O madre bellissima del parto,
E le tue gambe sono ingioiellate di sudore
E i capelli biondissimi fanno sul cuscino
Quel movimento delle spighe al vento estivo,
Mentre il lenzuolo si consuma tra le dita
Ondeggiando al ritmo delle doglie.
Poi, nel guardare fuori, tra i gemiti,
Ti scivolano negli occhi piccole foglie
E le nuvole fuggevoli dell’alba così fioca
Di novembre che il vento, per ninnarti,
Fa entrare dalle finestre tra sibili e fischi.
E infine ecco la tua intima rosa tutta dischiusa
Per dare alla vita un’altra freschissima vita.
Somigli ad una morbida giumenta sfinita dal dolore
Quando dai lombi mi doni alla luce,
Ancora scintillante e tiepida d’umori,
Con un grido alto che, adesso, balza fuori
Dai margini ingialliti della foto, come una gazza
Impaurita da uno sparo dal folto di un carrubo,
Ed io dalla tua bocca con la mia bocca lo raccolgo
In comunione d’anima e d’amore.
Nel giorno del mio compleanno, 24 Novembre 2010
*
È senza timore, di sembrare un venditore ambulante, che dico ai lettori di queste poche righe da me scritte di procurarsi, quanto prima, questo libro del costo di soli 13 euro, sicuramente lo dovrebbero fare coloro che già conoscono Franca e l’apprezzano, e su LaRecherche.it siamo in molti.
Id: 751 Data: 27/09/2013 12:00:00
*
 Sandro Montalto - Poesia - La Vita Felice
Sandro Montalto - Poesia - La Vita Felice
Il segno del labirinto
La poesia di Sandro Montalto non è comoda, è indubbiamente impegnativa; volendomi attenere a un aggettivo derivante dal titolo, direi che è labirintica. E con ciò ho allontanato il dubbio che si tratti di cattiva poesia, soprattutto se andiamo a considerare che Montalto non è nuovo alla scrittura in versi e all’ambiente della poesia, ben conosce gli stili e le scritture che l’hanno preceduto e che gli sono contemporanee; l’autore non è uno sprovveduto e la sua scelta di complessità compositiva e contenutistica è una scelta di poetica ben precisa e ragionata. Dunque il lettore che si avvicina a questo libro è un tipo di lettore che, a una prima e forse casuale apertura, rimane incuriosito dalla complessità preannunciata dall’immagine di copertina; è una scrittura che va scelta, così come si sceglie di riflettere su sé stessi e su ciò che accade alla nostra esistenza o all’esistenza di chi abbiamo vicino, in ogni caso si tratta di una scelta ragionata, voluta, talvolta coraggiosa, quando si tratta di una riflessione capace di mettere a fuoco le conseguenze di valori e disvalori.
In questo libro la scrittura scorre sull’orlo dell’esistenzialismo e scandaglia a fondo le principali tematiche umane, tra cui l’amore e l’incapacità di congiungersi veramente, talvolta, con il soggetto del proprio interesse affettivo, o, molto di più, con l’esistenza stessa, la quale, con le sue dinamiche, che tutti ben conosciamo, crea disagio. L’autore fa questo ricorrendo a costruzioni simboliche e figurative, sono vere e proprie architetture di pensiero, innalzate ricorrendo ad equilibri ed incastri tra aggettivi e sostantivi, i verbi ne sono una parte meno evidente, ma ovviamente sostanziale, gli architravi.
Nel suo dire simbolico, la poesia, non deve mai abbandonare la strada della realtà e, dunque, dell’esperienza umana, quest’ultima va posta, semmai, a fondamento di tutta la costruzione. Infatti, una poesia eccessivamente scollegata da una soggettiva interpretazione della vita, o che in qualche modo non si agganci all’universalità di una particolare esperienza di vita, in modo tale che possa consegnare ad ognuno, ogni lettore, una chiave immediatamente deducibile dalla propria consapevolezza esistenziale, non può essere considerata, a mio avviso, poesia – con ciò dichiaro la necessaria e oggettiva universalità del verso poetico. Non è certo il caso di Montalto, il quale in questo libro, affondando i paletti soggettivi/oggettivi della poesia nel minimo comune terreno (per prendere in prestito il concetto matematico del minimo comune multiplo) in cui avviene l’esistenza di ogni individuo, indica al lettore la strada nel proprio labirinto interiore di visioni, esperienze e ricordi, costringendolo, come se sulle pagine del libro roteasse un vortice, ad entrare nella sua (di Montalto) multiforme proposta cognitiva, ma fornendogli una via di uscita: basta rimanere fissi su un segno, che è la chiave di risoluzione del labirinto, e cioè sulla poetica dell’autore, intendo cioè affermare che è sufficiente tenere nella mente l’idea che stiamo viaggiando nel mondo della poesia, e dunque, a causa della sua universalità, essendo essa peculiarità di ogni individuo umano, per mezzo di un misterioso processo di osmosi, si passa dal labirinto dell’autore al nostro personalissimo labirinto, di cui sappiamo venire a capo per la familiarità che ne abbiamo; ecco così che la soggettività di queste poesie è anche la loro universalità, e diventa la nostra sola possibilità di salvezza e di uscita dal labirinto; l’esperienza dell’autore diventerà magicamente la nostra, basta rimanere al suo fianco, come se fosse il fianco del Sommo Virgilio, in tal modo il viaggiatore/lettore attraversa i versi fino alla soave levità della Poesia. Giunti a conclusione della lettura del libro si ha la sensazione di aver affrontato un viaggio impegnativo e rischioso, ma al termine del quale si allinea allo sguardo il fiorire di una rinnovata dolcezza. Il poeta ha come scaricato il fardello del proprio disagio esistenziale e lo depone sulla soglia d’uscita del labirinto, e noi con lui; non ci vorrà molto ad accorgersi di aver viaggiato nell’universale bellezza della poesia attraverso, come sopra detto, un nostro personale labirinto che il poeta ha magistralmente costruito per noi; questo, a mio avviso, è il compito dello scrittore: costruire la scena in cui il lettore possa andare in scena.
*
Così t’inventi un viaggio
ubriaco timone delle tue notti
in cui gli occhi impazziscono di moto
e di vuoto di realtà.
I sogni non bastano,
dicono di scatole aperte
di esistenze ad ogni costo.
Così, accartocciata montagna cerebrale
non hai più motivo d’essere
in questo mondo appeso ai fili
protetto dal sipario
crollato in nostalgia.
(bilancio)
L’importante, oggi, è questa mosca sul vetro
e non so se percepisce la morte,
se immagina la fine del vetro, l’altra faccia,
o se si sfreghi solo le zampette
per fuggire l’idea della trasparenza.
Vaccino sono io, che assisto,
che potrei donarle la realtà,
ma le lascio il mondo come desiderio.
Id: 734 Data: 13/09/2013 12:00:00
*
 Teresa Ferri - Aligi Sassu - Poesia - Interlinea edizioni
Teresa Ferri - Aligi Sassu - Poesia - Interlinea edizioni
Precipizi di luce
Dialoghi con Aligi Sassu
Il titolo, “Precipizi di luce”, ben rappresenta la sensazione iniziale che si ha prendendo in mano questo libro; tutti noi, appassionati lettori, sappiamo bene l’importanza che hanno la vista e il tatto in relazione al libro che andremo a scegliere, almeno come impatto iniziale. La veste grafica è uno degli elementi importanti di un libro, insieme al titolo. Ebbene, questo libro attira sia per il titolo che per la veste, se lo si prende in mano e lo si sfoglia, anche distrattamente, si rimane intrappolati nella propria curiosità, trascinati dentro le pagine dai variegati, in tonalità e temi, disegni/pitture che fanno capolino dalle sue pagine: si tratta della riproduzione di 50 tavole del maestro Aligi Sassu (rimando a wikipedia per la biografia del maestro). Ma se lo sguardo si sposta sulla pagina a fronte, rimane attratto dalle poesie, veloci e incisive, di Teresa Ferri, altrettanti quadri in versi che accompagnano le tavole di Sassu, imbastendo con esse un vero e proprio dialogo. Ed ecco il punto di forza del libro, il fatto che si tratta di un dialogo tra due anime che si esprimono nelle pagine per mezzo di due discipline artistiche diverse, senza cadere in una sudditanza di una rispetto all’altra o di un artista rispetto all’altro. Ho avuto varie esperienze dirette riguardo alla scrittura di testi poetici su immagini, in particolare su immagini fotografiche; non è una cosa semplice scrivere a partire da immagini che sono, di fatto, già arte e poesia di per sé stesse – così come non è facile scrivere un libro di poesia a quattro mani –, senza rischiare di cadere in un banale inseguimento di temi, stili e contenuti. Non mi pare il caso dell’eccellente lavoro di Teresa Ferri, la quale riesce a scrivere prendendo l’ispirazione di avvio dalle tavole pittoriche, come se iniziasse a meditare su di una realtà che ha di fronte e di cui sta facendo esperienza diretta, riuscendo ad estraniarsi da ciò che la circonda, ciò si percepisce dai confini che stabilisce nella sua composizione in versi, da tale estraniamento percettivo ella si proietta all’interno della pittura, donando a tutti noi eccitanti momenti di extraterritorialità esistenziale (si può dire?). Mi sovviene l’esperienza del ballo in cui due ballerini, in perfetta sintonia, per quanto indipendenti nell’interpretazione e nel seguire la musica, donano ciascuno sé stesso all’altro unendosi ad esso, pur mantenendo la propria peculiare bellezza e bravura diventano, insieme, nell’abbraccio, qualcosa d’altro e di nuovo nell’unione perfetta che scaturisce dal comune intento, il ballo. Così in questo libro si raggiungono tali perfezioni altre, ciascuno dei due artisti ha la propria peculiarità artistica, ma uniti creano ed entrano in un nuovo schema di bellezza, dando vita ad un’opera d’arte ben definita, apprezzabile e distinta dalle singole parti che la compongono.
I tratti del maestro Sassu, in alcune tavole, sembrano soltanto abbozzati, è come se prelevasse una realtà recondita, invisibile, restituita alla visione degli occhi del mondo. I colori in alcune tavole sono solo accennati, come a far sì che non abbiano il sopravvento sul tema dettato dalle linee. Altri quadri hanno invece colori forti ben contrastati, due o tre colori, non di più, a voler segnare delle differenze e dei confini nei pensieri dei soggetti narrati. Insomma un pittore eclettico nel tratto e nella colorazione dei propri soggetti, ma senza dubbio con un carattere deciso e uno stile riconoscibile. Teresa Ferri ci accompagna in questa galleria proponendo i suoi altrettanto decisi colori in versi, con acume e decisa ispirazione poetica.

Le sorelle 1965, di Aligi Sassu
Dissonanze
Di uguale colore i capelli corvini,
diversi i volti, gli sguardi,
ma entrambe parlano lo stesso linguaggio,
oscure dolcezze ad arte stillate,
bufera di rose spiumate tra note.
Di pietra il dolore negli occhi dell’una
immoti e fissi su un punto impreciso,
la vita o forse il nulla
la smorfia esagnato su labbra carnose.
Forse di mondi intravede foschie.
D’onice arguto le pupille dell’altra,
voraci di vita le labbra,
come ape golosa di un cuore di fiore.
Fughe per cieli e biscrome tradisce
lo sguardo sagace, del filo d’erba
curioso e dell’intero rosaio.
Id: 733 Data: 23/08/2013 12:00:00
*
 Sami Modiano - Narrativa - Rizzoli
Sami Modiano - Narrativa - Rizzoli
Per questo ho vissuto
«Quel giorno ho perso la mia innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi addormentai come un ebreo.»
Non ho letto questo libro, sottotitolato: La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili.
Tuttavia ho voluto proporlo all’attenzione dei lettori perché questo pomeriggio, 24 gennaio 2013, di ritorno da una gita scolastica con un gruppo di ragazzi adolescenti, dopo aver pranzato, mi sono seduto per un attimo in poltrona a riposare, ho acceso la radio e mi sono trovato fortunosamente ad ascoltare l’intervista a Sami Modiano – autore del libro qui proposto – su Radio 3, nel corso del programma Fahrenheit. Sono rimasto incollato all’altoparlante per tutto il tempo del suo racconto, anche l’intervistatrice ha pensato bene di farsi leggermente da parte e di lasciarlo parlare a ruota libera; dire che le sue parole siano state commoventi sarebbe come svilirle, sminuendone il messaggio, parole che sono la ragione stessa della sua vita e che, infatti, ritroviamo nel titolo del suo libro: “Per questo ho vissuto”. Un titolo che riassume il senso di un’esistenza.
Sami stesso ha detto, durante l’intervista, che non aveva la benché minima intenzione di raccontare la sua dolorosa esperienza, proprio perché il farlo avrebbe riattualizzato il suo dolore, come una condanna che si ripete, ma anche per la paura di non essere compreso nella portata della sofferenza sperimentata. Così per molti anni ha scelto il silenzio, finché, otto anni fa, sotto pressione di alcuni amici e della moglie, ha deciso di provare a raccontare la sua vita, di adolescente tredicenne deportato in un campo di concentramento, a un gruppo di ragazzi; alla radio, la sua voce pacata ma ferma, ha detto che quella notte non riuscì a dormire e, finalmente, capì perché era sopravvissuto a tanto male, abbandonato durante la “marcia della morte” ai lati della strada, svenuto in uno stato simile alla morte, salvato dai russi, in particolare da una dottoressa che si era ostinata a rimetterlo al mondo, era sopravvissuto per raccontare, perché l’orrore non si dimenticasse e non si ripetesse.
E’ la prima volta che propongo un libro senza averlo letto, ma essendo un libro autobiografico e avendo io ascoltato l’autore e la sua originale e sincera testimonianza dalla sua viva voce, non posso che pensare che questa sarà una lettura adatta a ragazzi e adulti, un modo per non dimenticare, un modo per dare voce a un uomo sopravvissuto per ognuno di noi.
Riporto la descrizione del libro tratta dal sito dell’editore:
“Come tanti sopravvissuti all’Olocausto, per molti anni Sami Modiano è rimasto in silenzio. In che modo dare voce al dolore di un’adolescenza bruciata, di una famiglia dissolta, di un’intera comunità spazzata via? Nato nella Rodi degli anni Trenta, un’isola nella quale ebrei, cristiani e musulmani convivono pacificamente da secoli, Sami non conosce la lingua dell’odio e della discriminazione. Ma quando le leggi razziali colpiscono la sua terra, all’improvviso si ritrova bollato come “diverso”. E a tredici anni, nell’inferno di Auschwitz-Birkenau, vedrà morire familiari e amici fino a rimanere solo al mondo a lottare per la sopravvivenza. Al miracolo che lo porta fuori dal campo non seguono tempi facili: Sami si ritrova in prima linea con l’esercito sovietico ed è poi costretto a fuggire a piedi attraverso mezza Europa per poi giungere in un’Italia messa in ginocchio dalla guerra. Dopo due anni di lavoretti malsicuri e pessimi alloggi, ma rallegrati dagli amici e dalla scoperta dell’amore, appena diciassettenne Sami sceglie di nuovo di andarsene, questa volta in Congo belga. Qui gli arriderà il successo professionale ma lo attendono nuovi pericoli, allo scoppio della guerra civile.
La storia di Sami Modiano è una trama intessuta di addii e partenze alle quali lui ha sempre opposto la determinazione a riappropriarsi delle sue radici, a dispetto di chiunque abbia provato a strapparle. Ecco perché oggi, a settant’anni dal suo arrivo al campo di sterminio, Sami sente di essere sopravvissuto proprio per essere testimone di quegli orrori e raccontarli. Lo fa con un libro semplice fino all’asperità, commovente perché portatore di una lingua universale. Figlia delle ferite che dividono i popoli e della speranza che li vorrebbe unire.”
*
Notizie biografiche sull’autore
Sami Modiano è uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Da otto anni porta nelle scuole medie e superiori di tutta Italia la sua testimonianza ed è più volte stato protagonista dei Viaggi della Memoria, grazie ai quali ha accompagnato numerosi gruppi di studenti nei luoghi dell’Olocausto. Da tempo si occupa della sinagoga di Rodi per tenere in vita la storia della sua comunità. Questo è il suo primo libro.
Guarda un breve video: Sami Modiano, ad Auschwitz, racconta la sua esperienza…
Leggi i commenti di alcuni ragazzi che hanno potuto ascoltare il raconto di Sami Modiano
Id: 657 Data: 25/01/2013 12:00:00
*
 Franco Buffoni - Romanzo - Fazi Editore
Franco Buffoni - Romanzo - Fazi Editore
Il servo di Byron
“Per indole il padrone era istintivamente portato a ribellarsi, a provocare; persino a dire in faccia alle persone la verità nuda e cruda su se stesso e i suoi desideri. Ne so qualcosa, vi assicuro. Anche alla moglie, alle amiche e alle amanti fu tentato in varie occasioni di manifestare sinceramente il suo pensiero circa il ‘nameless crime’. Il pericolo di essere pubblicamente smascherato e punito per il ‘crimine senza nome’, però, era troppo reale e incombente. Allora my Lord si concedeva anche ai desideri femminili.” (Dal capitolo 3, Beckford, pagina 20).
Franco Buffoni torna sugli scaffali delle librerie italiane in qualità – e che qualità – di narratore, con un romanzo-saggio ambientato temporalmente nella prima metà dell’Ottocento, nel periodo in cui visse Lord Byron, il poeta e politico inglese, membro della Camera dei Lord, autore di opere quali: “The Corsair”, “Manfred”, “Childe Harold’s Pilgrimage”. Buffoni narra le vicende del poeta, mettendo in scena, in modo avvincente, il percorso bio-bibliografico di Lord Byron, ed è Fletcher a farlo, una volta morto il proprio padrone: “Sono Fletcher, signori, il servo di Lord Byron, e scrivo. Scrivo! Il padrone mi credeva capace di fare la mia firma, o poco più. Rideva quando mi vedeva con un libro in mano. Credeva che fingessi di leggere. Lui preferiva avere al suo servizio individui nature. E io la natura gliel’ho data. Quella buona, quella di Scozia.” Così nell’incipit.
Il romanzo, che a tratti assume la connotazione di saggio, è storicamente documentato, e procede di tappa in tappa da un punto noto della vita di Byron all’altro – dal suo primo viaggio all’estero, insieme all’amico John Cam Hobhouse, come era usanza nell’aristocrazia britannica, all’esilio, alla sua morte, avvenuta a Missolungi, in Grecia, il 19 aprile 1824 –, permettendosi, tuttavia, tra una tappa e l’altra, invenzioni, supposizioni più che plausibili, comprovabili. Buffoni ricama, in una sorta di ricamo letterario, sul tombolo della bio-bibliografia byroniana, ipotizza, agganciandosi ai riscontri di opere e fatti, con l’inventiva del narratore, ma anche con l’autorità del professore-ricercatore; ricostruisce la vita di Lord Byron, invita ad osservarla dal suo punto di vista, quello di Fletcher. La scelta di far narrare la storia dall’intimo servo di Byron, è uno stratagemma narrativo intelligente e ben riuscito, che aiuta il lettore a “vedere meglio”, dico io, spostando il proprio baricentro nello spazio storico d’azione di Byron. In realtà è Buffoni che si impossessa, per noi lettori, del punto di vista privilegiato di Fletcher, si insinua, oserei dire, nel suo corpo per convalidare la sua rilettura della vita del poeta inglese e della sua Opera, alla luce della sua omosessualità, il famoso nameless crime. Per il quale, all’epoca, ma anche per molto tempo dopo, erano previste la pubblica gogna e la pena capitale per impiccagione (si legga il primo capitolo del romanzo).
Interessante il punto di vista di Fletcher, che presenta la bravura di Byron come scrittore anche come fonte di guadagno per la vita di agi che il servo stesso, per quanto “schiavo” del Lord, andava gustando; il loro sostentamento nei lunghi viaggi all’estero, poi in esilio, dipendeva dalle royalties che gli spettavano per la vendita delle opere, opere di grande successo che spediva all’editore Murray. Nella sua vita, Byron, nelle varie peregrinazioni – molto sostò anche in Italia, a Venezia e Pisa ad esempio – imbastì relazioni con donne, ma soprattutto con ragazzi, di alcuni dei quali si innamorò perdutamente.
E’ interessante il lavoro che Buffoni fa, sempre per voce di Fletcher, di mettere varie opere di Byron in relazione alle sue avventure amorose omosessuali, anche se nelle opere si parla di storie di amore eterosessuale, spesso i personaggi nascono dai suoi amori, così come avviene in “The Deformed Transformed”, “rimasto incompiuto, e basato sul ‘gioco’ faustiano dell’acquisizione da parte di un essere deforme delle sembianze eroiche di Achille” (pagina 114), in cui, secondo Fletcher/Buffoni, Patroclo è Pietro, il suo amore carbonaro. E’ ovvio che in un clima in cui il solo essere sospettati di sodomia significava perdere per sempre il proprio onore, o essere costretti all’esilio, o addirittura, in caso di flagranza, significava finire alla gogna e condannati a morte, era d’obbligo usare prudenza, e Byron la usò anche nelle sue opere; i suoi più stretti e confidenti amici, gli consigliavano moltissima cautela, anche se la sua fama di scrittore e di amatore tra le dame dell’epoca gli faceva da scudo: “Mentre il corteggiamento di Lady Constance avvenne in pubblico, in salotto. Byron in sostanza mise in atto la sua consueta ‘tattica digressiva’, come la definiva Hobhouse: ‘Sei tranquillo, adesso? Hai raggiunto la certezza che Londra lo verrà a sapere? Missione a Malta compiuta, dunque! A Londra si saprà che cosa fa Byron nel grand tour!’” (Pagina 29). Il rischio era reale, le notizie da Londra non erano incoraggianti: “Nella stessa prigione, per la stessa retata, erano finiti anche altri due amici di Byron, Paul Fox e Paul Lane, che riescono a incrociare brevemente i visitatori. ‘Sembra davvero di essere nel girone dantesco dei sodomiti, con Dante e Virgilio brancolanti nella penombra, sub specie di Matthews e Scrope’, commentò il padrone con una smorfia di disgusto, mentre mi accarezzava.” (Pagina 37).
Nell’ultimo capitolo “Lettera dell’autore”, si esce dalla narrazione, Fletcher scompare, Buffoni torna Buffoni e parla del suo lavoro, dà lo spessore storico-documentale necessario per far capire che il romanzo non era pura invenzione, chiarisce il suo percorso di ricerca: “La verità su Byron non poterono certo rivelarla Thomas Medwin […], né gli altri contemporanei del poeta […]. Le rivelazioni sincere e personali stavano soprattutto nelle Memories del poeta stesso, distrutte in gran parte da Hobhouse e Murray [l’editore]. Restavano delle tracce nell’epistolario, nelle testimonianze dirette e soprattutto nelle opere, a saperle leggere. Tracce che nessuno volle (o poté) mettere in luce praticamente fino alla metà del Novecento.” (Pagina 149)
Per lungo tempo c’è stato il tentativo di occultare la “consistenza omoerotica delle inclinazioni sessuali di Lord Byron”, lo stesso autore, Buffoni, che nel 1984 venne accolto a Lontra dai membri della Byron Society, dopo l’uscita della sua edizione italiana del “Manfred”, poema drammatico composto da Byron nel 1816-1817, provò un “glaciale abbandono” quando disse che intendeva continuare la sua ricerca su Byron “studiandone l’omosessualità”.
Byron si sposò con Annabella Milbanke, un’ereditiera dedita a studi di matematica. Dall’improbabile unione nacque Augusta Ada, destinata a diventare Lady Lovelace e intima di Charles Babbage. Ma vide ben presto, dopo soli undici mesi, la moglie e la figlia abbandonare la sua casa, sotto l’ombra di fondatissimi sospetti di una relazione incestuosa con Augusta Leigh, figlia di un precedente matrimonio del padre. Ma fu G. Wilson Knight, con la sua pubblicazione “Lord Byron’s Marriage: The Evidence of Asterisks”, nel 1957, a ristabilire una importante verità: “La vera ragione del fallimento del matrimonio fu l’omosessualità di Byron, non il legame ‘incestuoso’ con la sorellastra Augusta Leigh. Quella fu la ragione che il poeta stesso contribuì a divulgare perché non si parlasse del nameless crime”. (Pagina 153)
Nel romanzo non mancano i pensieri di Buffoni, quelli che egli inserisce nel corso della narrazione, magari tra parentesi, o nelle parole di questo o quell’altro personaggio; emergono dal testo dettando una sorta di manifesto i cui punti vorrebbero denunciare/smantellare la terribile omofobia ancora presente nel tempo odierno e in particolare nel nostro Paese, di qua dalle Alpi. L’Italia, ai tempi di Byron, era luogo di rifugio per sodomiti, a causa del fatto che non c’erano leggi che ne determinassero la condanna, a differenza del Regno Unito. Oggi, invece, al di qua delle Alpi è rimasta una dose imbarazzante di omofobia, mentre di là dalle Alpi è diventato il luogo dove conviene migrare se si vuole respirare aria di uguaglianza dei diritti. “‘Tra noi e loro’ [richiamo alla raccolta poetica di Buffoni, “Noi e loro”, edita da Donzelli ], sussurrava my Lord, ‘c’è di mezzo the Channel, e poi tante e tante miglia, e poi ci sono le Alpi che ci difendono’. Lo vedo come se fosse qui ora: stava in piedi con il calice in mano; il suo profilo puro si stagliava nella luce del crepuscolo filtrata da uno splendido tendaggio ricamato che avevamo comprato insieme a Burano. I suoi occhi luccicavano come il vino nel bicchiere…” (Pagina 44). Non posso non riportare qui una bellissima poesia tratta da “Noi e loro”, che mostra il fil rouge nell’Opera buffoniana:
Una lunga sfilata di monti / Mi separa dai diritti / pensavo l’altro giorno osservando / Il lago maggiore e le Alpi / Nel volo tra Roma e Parigi / (Dove dal 1966 un single può adottare un minore). / Da Barcellona a Berlino oggi in Europa / Ovunque mi sento rispettato / Tranne che tra Roma e Milano / Dove abito e sono nato.
Per quanto riguarda i pensieri dell’autore tra parentesi, di cui sopra accennavo, ecco qua: “(la sodomia tra persone adulte e consenzienti non danneggia alcuno; ben peggiori danni sociali vengono dalla ‘fornicazione’ extramatrimoniale con le nascite illegittime, i tentativi di aborto finiti in tragedia e gli infanticidi; e malthusianamente il vero pericolo è semmai la sovrapopolazione, piuttosto che la sterilità conseguente ai rapporti gay; infine bisognerebbe cominciare a parlare dei ‘piaceri del letto’ così come, con indulgenza, si parla dei ‘piaceri della tavola’)” (Pagina 41). Purtroppo, come Buffoni fa notare, “l’avversione si ergeva su una matrice di ordine religioso – dunque irrazionale e dogmatica –”, e a tutt’oggi pure! E ancora: “Un punto essenziale, insisteva Shelley, era la costante menzione della condanna biblica: la pena capitale era prescritta dal Levitico (20,13). Un versetto che veniva sempre citato dai giudici nel momento in cui infliggevano la pena. Al punto che si faceva vanto della superiorità cristiana nei confronti di altre religioni, proprio per mostrare quanto coerenti fossero i giudici che condannavano i sodomiti.” (Pagina 77).
Si pensi che “Se nel 1967 l’Inghilterra entrò finalmente nella modernità, la Scozia mantenne in vigore il reato di omosessualità tra adulti consenzienti fino al 1980. […]. sarà soltanto nel 1990, per esempio, che il più grande poeta scozzese del Novecento, Edwin George Morgan (1920-2010), avrà il coraggio di fare coming out, dopo decenni di allusioni poetiche all’io narrante e al ‘suo tesoro’ che si rincorrono tra i boschi attorno a Glasgow”. (Pagina 152).
Personalmente non sapevo molto delle persecuzioni riservate agli omosessuali nel Regno Unito dell’Ottocento, e anche del Novecento. La lettura di questo libro mi ha aperto un mondo in gran parte sconosciuto. Della schiavitù so tutto (si fa per dire) ma di questa altrettanto grave forma di razzismo, che è l’omofobia, sapevo poco. Mi ha stupito il numero 1980 che ho riportato poco sopra! Era ieri…
Quello che mi preoccupa è che so, per conoscenza diretta, che ci sarebbe qualcuno in Italia (ovviamente nell’ambiente cristiano-cattolico) che non ci penserebbe due volte a far sì che l’omosessualità tornasse ad essere un reato!
Consiglio vivamente la lettura di questo libro.
Id: 607 Data: 20/07/2012 12:00:00
*
 Daniele Santoro - Poesia - La Vita Felice
Daniele Santoro - Poesia - La Vita Felice
Sulla strada per Leobschütz
Qualche volta succede che la poesia – magari attraverso il dono inaspettato del libro di un poeta – arrivi a prenderci sottobraccio e porti la nostra attenzione su argomenti che non erano nelle corde del pensiero, e del sentimento, sino al momento di iniziare la lettura.
Sulla strada per Leobschütz, è il libro inaspettato, l’argomento è l’Olocausto o, se vogliamo, la persona umana, nella duplice veste persecutrice-aguzzina / perseguitata-vessata; ma, forse, definirei il leitmotiv della raccolta con le parole: assurdo, insensato, inconcepibile, irrazionale, irragionevole, eccetera.
Il libro raccoglie una quarantina di poesie che, come fotografie, scene in bianco e nero, immediate, rievocano eventi reali e storicamente documentati, si vedano i riferimenti bibliografici in coda al libro. Santoro inscena, qui, un percorso ineluttabile, doloroso, disperante, che incalza l’assurdo nel dispiegarsi dell’orrore, che prende la sua tetra evidenza nell’atteggiamento cinico degli aguzzini, nella paura dei sottomessi, nelle vittime – sfinite e inermi –, nell’assenza di senso, nell’eclisse della dignità della persona umana. Le poesie sono schiette, limpidi ritratti, costruite con versi narranti ma brevi, efficace innesto di prosa in poesia. Impossibile non girare pagina, impossibile stancarsi in questa lettura in cui germina l’esigenza di raggiungere l’ultima pagina; forse per uscire in fretta da quell’orrore, o, se non altro, per la speranza di trovare, al termine, un riscatto, una giustizia... che purtroppo non arriva, ma, anzi, sulla strada per Leobschütz, si incontra la pazzia al femminile, ed il resto è storia (La pazza sulla strada per Leobschütz, pagina 55):
era appoggiata a un tronco d’albero e cantava
stringendoselo al petto, ancora strofinandogli
la punta del nasino bianco
come la neve, come la sbandata
carovana dei morti (pure loro)
allora lei s’alzava in preda a gioia e diceva
«guarda, a mammina, guarda il carosello»
Santoro ha, a mio avviso, realizzato un ottimo lavoro storico – esiste il genere poesia-saggistica? – sono infatti poesie che evidenziano, in modo fin troppo puntuale, per chi è debole di stomaco, la vita nei Lager, ed è inevitabile che il pensiero vada ad altre opere note, come ad esempio Se questo è un uomo, di Primo Levi, in cui, come nel libro di Santoro, si respira l’assurda azione disumana dell’uomo su se stesso, l’umanità che si macella e mangia il proprio cuore; la narrazione ha lo stampo di una sorta di rapporto/resoconto di un sopravvissuto.
Ben venga la poesia storica e sociale come quella di questo ultimo lavoro di Santoro, ce n’è bisogno. È un libro che dovrebbe essere usato nelle scuole – si dice così di molti libri, anche di questo. È leggibile in due ore di lezione e permetterebbe di sviluppare argomenti di rilevanza sociale e storica, un modo per discutere e superare non solo la xenofobia ma ogni sorta di fobia, e iniziare a ragionare seriamente con i nostri ragazzi, per mostrare loro l’assurdità di ogni tipo di persecuzione, e convincerli della bellezza dell’accoglienza del diverso, in una parola, della pace. Il mio invito alla lettura è, quindi, rivolto, in particolare, agli insegnanti delle scuole: che cosa ne pensate della possibilità di usare la forza evocativa e attualizzante della poesia con i vostri ragazzi, anche nell’insegnamento della storia, almeno a tratti nel corso del programma? Perché non seguire un percorso storico basato su testi poetici, sunto ineguagliabile di esperienze personali di coloro che ne sono gli autori?
Termino questo rivolo di personali impressioni sul libro, Sulla strada per Leobschütz, con le parole finali della bella prefazione di Giuseppe Conte: […] Alla fine il lettore apprezzerà l’energia di questo libro. Una energia etica che ribalta il male mentre lo inscena, e ne mostra l’intollerabile, banale disumanità. Esco da questo libro grondante orrore con una percezione vitale più forte. Non è questo il miracolo costante, catartico della poesia?
Leggi due poesie tratte dal libro...
Id: 595 Data: 22/06/2012 12:00:00
*
 Alessandro Ramberti - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Alessandro Ramberti - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Paese in pezzi? I monti e i fiumi reggono
Con questa plaquette è stata avviata, dalle Edizioni L’Arca Felice – direzione editoriale e artistica di Ida Borrasi – una nuova collana di poeti tradotti da poeti, a cura di Mario Fresa. Nel comunicato stampa che la accompagna si legge:
La casa editrice L’Arca Felice inaugura Hermes, una nuova collana che ospita brevi raccolte di poeti stranieri tradotte da poeti italiani contemporanei. Il primo titolo è dedicato alla figura di Du Fu (712-770), straordinaria voce poetica della Dinastia Tang, i cui testi appaiono per la prima volta in versione italiana grazie all’impegno sensibile di Alessandro Ramberti, poeta, editore, orientalista. La selezione offerta nella plaquette ci consente di conoscere una scrittura fondata su di una misura perfetta che unisce l’energia di uno sguardo eticamente alto, forte e puro alla morbidezza di una lingua cristallina e sfumata, sempre lontana dai toni assertivi e percorsa, costantemente, da una calma e delicata luce interiore. L’impeccabile lavoro di studio e traduzione operato da Alessandro Ramberti presenta i testi nella loro trascrizione letterale e, contemporaneamente, nella più mobile e aperta forma di una interpretazione che ricostruisce lo spirito del pensiero poetico di Du Fu tenendo conto della necessità di ricalcare il più possibile le peculiarità espressive, metriche e sonore dell’impianto linguistico originario.
La plaquette contiene quattro poesie nella traduzione di Alessandro Ramberti, ognuna delle quali è accompagnata dal testo in lingua originale e da una traduzione letterale. Il confronto con la traduzione letterale rileva l’ottima traduzione di Ramberti, sono scelte di vocaboli e di costrutti che mettono in evidenza lo stile, percorso da una calma e delicata luce interiore, di uno tra i più grandi poeti cinesi. Nel corso della propria vita, Du Fu, cambiava il tenore dei componimenti con l’adattarsi alle condizioni ambientali che lo circondavano, passando, come afferma lo studioso Stephen Owen, da opere di decisa semplicità, del suo periodo Qinzhou, a opere leggere, spesso finemente rispettose, del suo periodo Chengdu, a opere con densità e potere di visione del tardo periodo Kuizhou.
Poche poesie, quattro, che bastano, da sole, a dilatare un breve intervallo temporale personale di lettura sulla misura di un tempo di meditazione che mitiga, in qualche modo, per la pacatezza delle sue descrizioni/visioni paesaggistiche – che metaforicamente rimandano a più personali paesaggi interiori –, penose personali ansie per l’esistenza.
Riporto, per esteso, il testo poetico che contiene il verso che dà il titolo alla plaquette:
Paese in pezzi? I monti e i fiumi reggono.
In città è primavera e il verde è intenso
Commossi i fiori propagano lacrime
Soli gli uccelli fan fremere il cuore.
Fuochi di guerra duran da tre mesi
Lettere da casa valgon più che oro.
Mi gratto la canizie ormai si rada
Che è appena in grado di reggere la spilla*.
* Per fissare il copricapo dei funzionari
Le edizioni de L’Arca Felice sono caratterizzate non solo da un’ottima qualità dei testi proposti, ma anche, e in modo netto, rispetto ad altre pari pubblicazioni di qualità, da un’ottima qualità grafica e di scelta della carta con cui è confezionata la pubblicazione; le carte sono infatti scelte da un artista, Bruno Conte. Inoltre l’opera è resa ancora più preziosa per la sua proposta limitata in 110 esemplari numerati a mano. Fuori testo una litografia di Francesco Ramberti: Du Fu (China, 2011). Da notare il tocco di classe del filo di rafia, esso avvolge la pubblicazione come a raccogliere le pagine.
Id: 521 Data: 10/02/2012 12:00:00
*
 Maura Potì - Poesia - Stilo Editrice
Maura Potì - Poesia - Stilo Editrice
Il tempo non è un aspirapolvere
Maura Potì è architetto, nata a Brindisi, vive e lavora a Bari. Così si legge nella terza di copertina: “La sua esperienza poetica nasce sul web, prima modalità di scambio letterario con altri scrittori, per soddisfare un’insopprimibile necessità di condivisione dei suoi scritti. Apre anche un blog con l’intenzione di coinvolgere nella sua ricerca espressiva artisti di ogni forma d’arte, ma presto non resiste al fascino della carta stampata e decide di percorrere la strada della pubblicazione.” Il suo primo libro è del 2009, Tra respiro e sospiro, Aletti Editore.
Un’autrice, quindi, rappresentativa di una esigenza comune a molti, anche di tempi diversi, ma che negli ultimi anni, grazie a internet, soddisfa la necessità insopprimibile di condivisione dei propri scritti, ed è facile, nel via vai di informazioni sulla rete, trovare indicazioni di editori che possano affascinare con la loro carta stampata. Un percorso lecito, plausibile, intrapreso con convinzione di necessità.
Ebbene queste sono le basi di partenza delle quali, con onestà, la Potì ci rende partecipi. Non sappiamo però, dalle sue parole, la necessità che la spinge quale senso ontologico abbia, quale sia il volto dell’esigenza profonda che la spinge a voler scrivere e a scrivere proprio in poesia. Tuttavia, dalla lettura di questa sua seconda raccolta di versi, si evince una poetica, una radice che unisce alla terra della tradizione poetica, la chioma dell’esigenza di condivisione espressiva rivolta al cielo. La poesia della Potì segue i percorsi della sua vita quotidiana, delle sue esperienze affettive ed emotive rimescolate nel vento, nei fiori, nelle ombre, nel mare, nelle nuvole, nelle foglie, nei nastri d‘argento, tra le dita, nell’uva passa, nei catini, nei colori, nelle labbra e nei capelli, nel tramonto, nella luce, nella fiamma, eccetera, insomma la sua è una poesia delle emozioni e delle sensazioni che esplodono sugli oggetti e le circostanze e grazie ad essi tornano amplificati e poetizzati, se così si può dire, al lettore. Nella sua poesia non c’è fretta di raggiungere una conclusione, ma semmai la lentezza del volersi spiegare assaporando il fluire di sé stessa verso l’altro da sé; anche se qualche volta tale flusso è perentorio, deciso, quasi tagliente.
[…]
Serragli il becco con fermezza
e lascia che parli il cielo con la luna:
la mia mano sarà ben stretta nella tua
quando il furioso vortice del silenzio
attraverserà la nostra mente.
Non serve opporre resistenza,
lascia che passi come una cometa:
nell’etere perderà subito la coda
e s’alzerà polvere dalla chioma.
Potrai aprire i tuoi occhi nei miei
e in un istante sarà tutto finito.
[Da La cerimonia del silenzio, pag. 21]
E tu allora dimmi:
cos’è la solitudine
se non questo silenzio
di voci inascoltate?
[…]
[Da Ripensamento, pag. 25]
Il parere personale, ovviamente, è che il soffio della poesia sia passato attraverso la penna della Potì, di strada ne ha fatta e gliene aspetta. Devo ammettere che nella raccolta trovo perle di scrittura a macchia i leopardo. Pertanto il lavoro da fare sarebbe proprio quello di rendere uniforme questa sapienza e scrittura, via le macchie di leopardo insomma. Ravviso cioè la necessità di un ulteriore lavoro di pulitura dei testi, facendo moltissima attenzione a non cadere nella banalità del troppo detto e della eccessiva aggettivazione, suggerisco inoltre un più attento utilizzo delle metafore evitando di accostare troppi aggettivi a troppi nomi in pochi versi. Attenzione inoltre al voler creare frasi ad effetto, talvolta è meglio dire meno, considerando maggiormente la musicalità, lavorando sull’asciuttezza dei versi. Ad esempio, a pagina 76, la poesia Himalaya, l’ho letta e riletta, l’ho trovata molto bella, ma l’avrei ridotta di molto, limandola non avrebbe perso di significato ma avrebbe acquistato maggiore incisività – ma è un parere personale. Non me ne voglia l’autrice, come sempre sono suggerimenti di un lettore, non di un critico, un lettore che riconosce, come già detto, una enorme potenzialità nell’autrice, mai sedersi sugli allori e sempre ricercare, mettersi in discussione e semplificare.
Finisco proponendo, da pagina 48, una poesia che a me è molto piaciuta:
Viaggio a ritroso nel tempo
E passi un dito sulla pelle
sfiorando i lembi rosa
di cicatrici gemelle
- inferte per leggerezza
più che per crudeltà –
Non ho la stessa tua destrezza
e con il soffio di un respiro
solletico la labbra chiuse
- come in una carezza –
a schiudere un sorriso.
Quel treno si è perso
nel sottovuoto di un bicchiere capovolto
tra azoto liquido e ossigeno sottratto.
Ricordi? Divampava un incendio
e squadre di volontari in doppio petto
domarono l’assedio con prontezza.
Ah, quei capelli tra le nuvole,
li riconoscerei tra mille
- e a mille altri mirerei al bersaglio –
per rompere catene di assiomi
e strappare ogni inutile bavaglio.
Non dire niente
- nulla è quel che sembra –
il vento è l’occasione persa
che soffia appena il treno passa.
Lascia idranti e l’elmetto:
attenderò paziente sul binario
che si sviluppi un altro incendio
- non porterò neanche l’ombrello –
sarà la pioggia a spegnere l’inferno.
Buona lettura.
Id: 513 Data: 10/01/2012 12:00:00
*
 Francesco De Napoli - Poesia - Osanna Edizioni
Francesco De Napoli - Poesia - Osanna Edizioni
Carte da gioco
Francesco De Napoli opera da circa un trentennio presso l’Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale di Cassino ed è autore di numerosi volumi, tra poesia, narrativa e saggistica, è curatore di diverse antologie, si presenta a noi lettori con una nuova raccolta, ben prefata da Mario Santoro, dal titolo Carte da gioco, sottotitolata Trilogia dell’infanzia. L’opera è divisa in tre parti: L’attesa (1987), La casa del porto (1994 – 2002), Carte da gioco (2001).
Seguo quest’autore da ormai diversi anni e ho sempre trovato in lui una personalissima ricerca poetica che ben è espressa nella nota critica di Massimo Grillandi posta al termine della raccolta: “La poesia di Francesco De Napoli nasce da una genuina tensione interiore, dalla necessità di recuperare con il proprio passato anche il profumo inconfondibile dei sentimenti, che lo hanno alimentato e ne costituiscono l’essenza più vera. Le radici del poeta formano quindi la ragione prima della sua ispirazione e muovono accortamente, ma anche in modo appassionato, le acque di una nostalgia, che non riesce a farsi rimpianto, ma resta sempre sottesa alla necessità di instaurare, con se stesso e con gli altri, un colloquio che abbia un significato inteso a trascendere il privato e a farsi discorso universale e universalmente accettabile”. In fondo al libro si può anche leggere una bella testimonianza di Giorgio Bàrberi Squarotti.
Personalmente ho trovato varie perle, legate tra loro dal filo d’oro che percorre il dettato poetico dell’autore. La memoria si fa miracolo attualizzante, con un gusto di proustiana forza evocativa, “[…] / Respiro il silenzio di quei giorni, / miracolo di memoria.” (Pag. 24).
Il viaggio, l’arrivo, la partenza, il ritorno, la crescita, lo stupore del mondo, il sapore della genuina semplicità delle relazioni e la loro cifra di verità, la ricerca di una serenità, guadagnata dall’aver profuso sangue, sono solo alcune delle suggestioni:
[…]
Ciascuno ha sempre riservato
il posto più adatto
alla sua sorte.
Così, l’aver profuso ovunque
sangue e vigore
ti fece approdare infine nell’arcana
martoriata Cassino.
Lo sguardo mite e sorridente
dei tuoi giorni migliori
evocava ricordi di vite già vissute
altrove.
(Pag. 25)
Ti promisi che sarei diventato me stesso
uscendo insieme, una sera d’estate.
[…]
(Pag. 29)
Ma crescere, diventare se stessi, adulti, significa anche fare esperienza del malessere esistenziale e della morte; riporto qui, semplicemente, due poesie che trovo di grande valore umano ed estetico:
L’ho provato anch’io
questo malessere, questo groppo
in gola, questa voglia
di sparire, di dissolvermi.
E ad ogni delusione
seguiva una volontà nuova, ferma,
di studiare questi volti
sempre diversi, misteriosi,
perciò delle mie ingenuità
ingannatori.
E fissavo ogni ruga, ogni mossa
che potesse essermi d’aiuto
domani, andando incontro a nuovi
tradimenti.
Placato nell’orgoglio dell’attesa
che prosciuga le venerdì come i campi d’estate:
perché non vale il rifiuto,
vana è la fuga.
(Pag. 35)
Il giorno in cui morì mio padre
m’ero bagnato per l’ultima volta,
nudo, sfidando la sorte,
nell’azzurro totale, profondo, amaro,
smisurato, sordo a ogni preghiera,
vile, crudele del dolore.
L’appuntamento era stato rinviato
troppe volte, per troppo tempo
avevamo respinto il male.
Mi sembrava d’essere invitato
all’atto finale.
M’immersi implacabile
per lui, che non lo vide neppure,
il mare.
(Pag. 36)
La poesia di De Napoli è totalmente concreta, esperienziale, libera da sovrabbondanze di aggettivi e verbi, è quasi un racconto che intesse storie personali ma che irradiano universalità, potrebbe essere la storia del lettore. A tratti è prosa modellata in canto; difatti ci si può trovare a leggere cantilenando tra qualche assonanza che incalza l’andare del pensiero per vie di fanciullesca memoria.
[…]
Sento il profumo della mia terra:
ulivi e granone, arance e cicoria.
Ma come sanguina il seme della memoria.
- Ride la cicala, premonizione amara
[…]
(Pag. 18)
Non posso, infine, non complimentarmi con l'Editore per la bella copertina.
Perché Carte da gioco? Beh, dovrete leggere il libro.
Id: 510 Data: 13/01/2012 12:00:00
*
 M. G. Cabras e L. Mattonai - Poesia - Edizioni Gazebo
M. G. Cabras e L. Mattonai - Poesia - Edizioni Gazebo
Fuochi di stelle dure
cinque ballate e un attittu[1]
Ecco un'altra pregevole plaquette della casa editrice Gazebo di Firenze. Si cimentano, in una scrittura a due mani decisamente riuscita – sia per incastro metrico e contenutistico che per la salvaguardia della personalissima poetica di ciascuno dei due autori –, due voci contemporanee che si allineano nelle fila di coloro che nella poesia non cercano cassa di risonanza per una qualche vanagloria, ma, semmai, per una riservata esigenza della propria personalità artistica e a completamento di essa, Maria Grazia Cabras e Loretto Mattonai.
Riporto, di Mattonai, un estratto da Lettera dal carcere dello Spielberg:
Scorgo radi uccelli passare
non vedo terra non vedo mare
qui la sedia che stanca
tra mura che serrano la vita
tra due catene attorte
E dalla finestra un filo di luce scampato a quel cielo che di continuo è di ronda
[…]
Della Cabras, un estratto da Libera:
Scorre come il fiume
corre Libera corre
scopre vie dimenticate
trecce i suoi capelli
le mani tese verso altre mani
altra carità
grida Libera grida
si leva sorella in volo
non teme croce né fuoco
[…]
Il testo è corredato da un CD musicale contenente musiche di Michele Fiumalbi e Giacomo Guerrieri costruite intorno ai testi dei due poeti.
Guerrieri è la voce e suona chitarra ritmica, flauto irlandese, cembalo; mentre Fiumalbi suona chitarra solista e bouzouki irlandese. Per entrambi la musica è una passione.
Abbiamo sottoposto tale lavoro musicale a Roberto Biagiotti, nostro consulente musicale, il quale con la consueta competenza, serietà e passione, così si esprime:
“Poesia e canzone, cugine, forse sorelle, a volte solamente lontane amiche…
Se la poesia è affine alla canzone per musicalità delle parole e ritmo sillabale – e per tali motivi, parallelamente al messaggio testuale, veicola anch’essa emozioni e vibrazioni estremamente soggettive – al tempo stesso è meno vincolata da pulsazioni di ritmo determinato ed è probabilmente totalmente libera, o quasi, dai recinti delle leggi dell’armonia sonora.
Per questa ragione, può essere un’operazione molto complessa adattare un testo che nasce “solo” poetico ad una musica vincolata da regole tonali e ritmiche.
In una canzone, secondo il mio punto di vista, l’obiettivo più difficile da raggiungere è mantenere il fuoco e la nitidezza di potenza, delicatezza, drammaticità, ironia o sarcasmo di un testo dispiegato nelle sue frasi, attraverso un sostegno sonoro mai banale, mai gratuito, mai piegato o mai prolungato un istante più del dovuto. Con ciò non voglio affermare che qualsiasi canzone raggiunga questo traguardo, semmai il contrario, solo alcune vi riescono, rare volte con perfezione.
Musicare una poesia passando per i sapori melodici dei modi[2] Ionico, Misolidio o Minore Melodico, (ma in generale di qualsiasi modo) può significare confrontarsi/scontrarsi con le loro peculiarità ed i loro vincoli, affrontare salti ed intervalli obbligati, pagare dazi imposti da inesorabili cumuli di armoniche, percorrere cunicoli e condutture che portano a risoluzioni non sempre in sintonia con l’intento poetico, con il peso specifico delle parole nel loro contesto semantico.
Al tempo stesso il confronto avviene anche sul piano dell’immaginario musicale, legato alla collocazione storica, nota o meno, degli stessi modi usati, del periodo nei quali essi sono nati, si sono sviluppati ed affermati come culturalmente dominanti. Se poi insieme a tutto ciò consideriamo le timbriche di alcuni strumenti scelti, come il flauto irlandese, il bouzouki (versione irlandese) e la voce, così italicamente familiare, ecco che l’ascoltatore può essere avvolto in un arco sonoro-temporale che giganteggia tra il medioevo e De Andrè, dove il re (inteso come nota musicale) la fa da padrone.
A questo punto mi pongo la domanda: è questo un connubio ideale, tra parole in forma di poesia libera da metriche e rime e un universo sonoro così marcatamente denotato e delineato?”
[1] Attittu in sardo nuorese è il lamento funebre.
[2] Modo è il termine che indica il particolare legame che per il nostro orecchio hanno fra loro i suoni di una scala. I modi sono regolati da strutture di intervalli precisi tra una nota e l’altra. Le note a frequenza fissa sono in relazione matematica fra loro, e sono calcolate a partire da una nota fondamentale o tonica, la cui frequenza è stabilita per convenzione e misurata in Hz (cicli al secondo).
Id: 507 Data: 13/12/2011 12:12:00
*
 Meth Sambiase - Poesia - Rupe Mutevole Edizioni
Meth Sambiase - Poesia - Rupe Mutevole Edizioni
Una clessidra di grazia
Meth Sembiase, in Una clessidra di grazia, consegna alla nostra lettura una poesia dello sguardo, fatta di quasi mappe concettuali sviluppate in versi rapidi e sciolti. Essa proviene da occhi puntati sulla realtà definita dal presente e su quella ancora in definizione, quest’ultima spiegata dalla veggenza del poeta, capace di riportare sulla carta un futuro ancora in elaborazione in qualche altrove spaziotemporale, che, avverrà o meno in questo universo, è il futuro certo che il poeta vede e spera, o dispera, spolverandolo dalla soffitta dell’inesistenza come fosse un passato ribelle mai visto e scelto a rappresentanza di un presente già passato per vie traverse.
Marea
Incustodisce la forma,
di ogni pezzo di me ne ha fatto misura,
e liquida scorre, infinita
come la libertà assoluta
che assale i sogni delle notti,
come la lanula di una pozzanghera imperfetta,
di calce grezza e pioggia.
[…]
Le poesie, pur avendo una loro musicalità, non hanno una forma metrica ben definita, sembra che la poetessa le abbia imperniate più sul contenuto del discorso che non sulla reale cadenza tipica della scrittura poetica, fatta di soluzioni talvolta veloci nella chiusura di un concetto catturato ed espresso. Alcune poesie, addirittura, sarebbero scomponibili in poesie distinte e aventi una propria autonoma robustezza. La silloge però ben funziona, è godibile, anche se talvolta ci si impasta nel troppo detto e nell’uso prolungato di aggettivi o di parole legate al dire comune. È evidentemente una scrittura in evoluzione, e questo è un grande merito e un dono per noi lettori; spero che la nostra autrice continui a lavorare con serietà, come si evince da questa lettura, e deciso rigore sulla propria scrittura e nel confronto con gli autori a lei contemporanei. In tal modo sono certo che saprà donarci altre perle poetiche come alcune presenti in questa raccolta.
Ecco una poesia:
Un battito solitario
Al conteggio dei passi
- il dismesso arpeggio
di tacchi bassi -
chiacchiero spesso
con i miei pensieri,
in una monotonia rugginosa
che attira silenzi sparsi.
Nessuna strada
porta fretta ai miei piedi
neri,
ai crocevia
mi raggiungono i mendicanti,
comprerò i loro fiori
- forse solo uno -
da lasciar seccare
nel piccolo vaso del salotto
aspettando
lo sbocciare improvviso
di una faccia,
una qualsiasi,
con cui perdere chiavi,
cani e ascensori e vergogna,
arrampicandomi
sull’ultimo scampolo vitale,
un battito solitario
nel tempo vuoto.
Id: 483 Data: 18/10/2011 12:00:00
*
 Gian Maria Turi - Poesia e Prosa - Manni Editori
Gian Maria Turi - Poesia e Prosa - Manni Editori
Acrilirico
Ecco un bel libro. Questo Acrilirico tiene fede al titolo che porta. Togliendo la quarta sillaba (ri) dal titolo, si ottiene Acrilico che è un tipo di vernice molto versatile che può essere usata a corpo con la spatola, a pennello come la pittura ad olio, o diluita fino ad ottenere un effetto acquarello. Può essere usata su tutte le superfici, dal legno alla plastica, alla stoffa, al metallo. Così questo libro, è versatile e non è facilmente inquadrabile in una tipologia di testo. La sua originalità sta nella fantasia dell’autore, fantasia che si ripercuote nello stile di scrittura e nelle idee che l’autore depone sulla pagina come un pittore su una tela, a partire dalla materia acrilica, e modificandone la densità, propone vari effetti plastico-cromatici.
Volendo trasferire l’analogia in campo culinario, vi si leggono/assaggiano testi/piatti diversi, attesi con trepidazione e curiosità di gusto nello svolgere della lettura/pranzo. Si passa dalla poesia, alla saggezza dell’aforisma, alla narrativa (dal racconto quasi autobiografico al racconto fantascientifico), all’articolo, al nucleo iniziale di un potenziale saggio, così come in un pranzo si passa dall’antipasto al dolce con continuità e calibrata degustazione di vini che accompagnano i piatti.
È un libro originale, scritto, come si percepisce nello sviluppo dei pensieri, da una persona di ampia cultura, con grazia e carismatica determinazione, qua e là raccogliendo nel testo, senza ostentazione, riferimenti alla letteratura antica e moderna. L’uso delle parole è appropriato e intelligente il loro smarcarsi dalla banalità del dire. La scrittura è al tempo stesso onesta e, quindi, integra – in quanto non ha infingimenti dettati da inutili pudori che hanno il solo risultato di falsificare una scrittura – e corrotta, se così si può dire, dalla stessa natura umana che appare qui totalmente debole nella sua alterabilità e nei suoi slanci verso relazioni che lasciano quasi sempre, specialmente quando sono d’amore, l’amaro in bocca.
Se dovessi definire questa opera di Turi la definirei il libro dell’eresia delle regole e dei significati. Ma è una eresia sana, che sa scuotere la coscienza e non si nasconde dietro il dito del perbenismo e del buonismo; se una relazione va male, e fa male, è così punto e basta, se avviene qualcosa di anormale nella propria esistenza perché non dirlo così com’è? Perché non farne motivo di slancio verso un punto più alto, e non più basso, della montagna dell’esistenza?
Narrare le proprie visioni ed esperienze, inventate o meno, reali o fantasiose, ha il suo valore di verità, ci credano gli altri oppure no. Ma la fantasia di Turi non lavora solo nei concetti e nelle visioni, essa lavora anche concretamente sui testi, i quali, deformati a piacimento, diventano al contempo scheletro e sostanza del proprio dire. Se si ha voglia di interrompere un periodo, di riproporlo a sobbalzi, di sgattaiolare via con la penna da davanti il lettore, proprio mentre sta avvenendo la lettura, perché non farlo? Ci sono regole, nel testo di Turi, che si autodefiniscono nel corso della sua scrittura, egli, scrivendo, crea il gioco e la regola del gioco. Ed ecco la meraviglia e la grazia di questo libro: una latente novità lo caratterizza, una sorta di instabilità accompagna il lettore durante la lettura, dalla prima all’ultima pagina, talvolta avviandosi, i pensieri, da una sorta di caos e nebulosità di interrogativi all’apparenza scontati, ma che presto si dimostreranno essere tutt’altro.
Riporto alcuni estratti.
*
Da Fragmento archeoillogico:
[…]
ecco. a venticinque anni io vivo di inquietudini e deliri e di collassi sociali bisestili – ogni quattro anni le fave ricrescono nei loro baccelli attaccate
?ias, oirartnoc la
e per di più ignorando il modo di doppiare il capo horn della mente
la ragionevolezza e
un’ansia di controllo tecnico che continua a fallire
e il terrore epico che l’abbandono possa sgattaiolare nell’orrore.
nel frattempo (o intanto) publio cornelio scipione ammira i pennacchi di fumo avvolgersi al cielo di cartagena in spagna e i soldati alla ronda di guardia. sorseggia massico o falerno mentre detta al suo scriba una lettera per quel suo fratello in patria, sorridendo di ogni tratto di calamo segnato sulla cera. [è potente è virile è un distruttore] trionferà a roma e su per la via sacra, e sì potrà colpire di minchia senza che l’impeto gli fiacchi le gambe.
beve, scoreggia. anche questa è fatta, pensa.
ciao e.
a presto.
*
Da Retro:
Questa è Retro, per Sele
e per quando il sole si farà più sotto.
I
Il mio nome è monaco. Monaco che sbaglia
di continuo. Teso, convulso, offeso, la lista
degli insulti che ho incassato, così debole,
non indispensabile.
A combattere contro natura la polvere del panico
nell’ansito spirale di un predatore preso – volevo dirti
non fa per me
la teoria dell’amore, la devozione astratta.
Non me ne dare più. Io sono della setta
che non dà speranza, rifiuterò gli oracoli e il ritorno
sono l’orgoglio che non chiede pace, l’amore netto
che non sa sporcarsi.
Desideravo affidarmi al tuo affetto. Me lo sentivo
forte, immunizzato.
Vederti scorticare sulle loro gambe, la
musica, i Disciplinatha, il whisky. Ho pensato:
mi sta attirando nel suo inferno di donna e
stanotte sono stato assassinato dall’arroganza della libertà.
Ci siamo contraddetti e contraddetti
ancora, prima che uscisse in luce – tu! –
l’autoamore acquisito soprannominato il niente.
Finché “occhidolci” il vuoto si specchiasse. Sono io.
[…]
*
Da Illuminazioni:
[…]
I tessuti corporei si rigenerano continuamente – ciò che dà la sensazione della permanenza è la stabilità apparente della forma, mentre la sostanza è continuamente rimescolata dal vissuto. Questo già dovrebbe significare qualcosa. Che esistiamo semplicemente perché mutiamo, ovvero perché sembriamo.
L’idea stessa della permanenza ci viene infitta solo dal ricordo che abbiamo di noi stessi.
[…].
Grazie dunque a Gian Maria Turi che mi ha fatto divertire nella lettura e al contempo mi ha condotto su vie meditative scuotendomi come un sacco di farina che deve depositare sul fondo tutto il suo contenuto.
Id: 482 Data: 21/10/2011 12:00:00
*
 Alessandra Cenni - Poesia - LietoColle
Alessandra Cenni - Poesia - LietoColle
Corpi celesti
Corpi celesti, sottotitolato Antologia di poesia spaziale. Impossibile, da parte mia, non leggerlo interamente e tutto d’un fiato. Sono un appassionato di poesia e anche un appassionato di astronomia, da tempo vado indagando, e proponendo, una sorta di letteratura universale, che s’apra cioè all’idea che viviamo in un cosmo molto più ampio dei due metri quadrati di terra in cui siamo relegati dalla forza di gravità e da altri fattori fisici non meno importanti; una letteratura che tenga conto della scienza e delle sue scoperte e implicazioni… e, perché no, inizi a pensare ai possibili altri pianeti di vite intelligenti con altre “letterature”. Pertanto sono ipersensibile a tutto ciò che si muove in tale direzione.
Ma, nonostante il mio entusiasmo, la prima lettura non mi ha convinto, forse avevo troppe aspettative, per così dire, spaziali?
Ho atteso del tempo e l’ho riletto, ma ancora non mi ha convinto; ho atteso ancora molto tempo ed è apparsa su facebook la seguente notizia: “AlessandraCenniCorpicelesti
Ebbene, si trovano nel libro splendide poesie, come quella che avvia la prima sezione della raccolta, intitolata Il cosmo in una stanza, eccola:
E il quinto angelo sonò
e vidi che una stella era caduta dal cielo sulla terra
e le fu data la chiave del pozzo abissale
Apocalisse
Una galleria profonda
in cui fugge l’universo
- ogni cosa divina e plurima
ogni realtà complessa -
oltre lo specchio ustorio
che le acceca
le cose del passato
e vidi me
ridente luminosa -
una morta felice -
era soltanto- infanzia.
Pensate tutto l’esistente -
d’un tratto -
attraversare barriere -
il nero torrente
sotto voi partorire
chimere -
rompere
nella vostra dimora protetta -
cadere dal tetto
nella fretta divina
di accadere per voi.
E mentre rovina la vostra casa
voi diventate il futuro.
È totalmente meritevole il tentativo di Alessandra Cenni di avvicinare la scienza per mezzo della poesia, o, meglio, di coinvolgere nella poesia la scienza e attraverso la poesia tentare di esprimere la meraviglia indotta nello spirito umano dalle scoperte scientifiche. Riporto un interessante pensiero di Richard Feynman, uno dei più grandi scienziati del Novecento:
I poeti sostengono che la scienza tolga via la bellezza dalle stelle – ridotte a “banali” ammassi di gas. Non c’è nulla di “banale”. Anche io posso vedere le stelle nella notte deserta, e sentirle. Ma vedo di meno o di più? La vastità dei cieli estende la mia immaginazione. Bloccato su questa giostra il mio piccolo occhio può catturare luce vecchia di un milione di anni. Un grande disegno di cui sono parte […] Qual è il disegno, o il significato, o il perché? Non sminuisce il mistero conoscerne un po’. Poiché la verità è ancor più meravigliosa di quanto ogni artista del passato abbia mai immaginato. Perché i poeti moderni non ne parlano? Che uomini sono quei poeti che possono parlare di Giove come se fosse un uomo ma se invece è una enorme sfera rotante di metano e ammoniaca rimangono muti?
Tuttavia, il voler fare poesia a partire dal mistero della natura, che la scienza contribuisce a rivelare, semplicemente partendo da alcune nozioni scientifiche, acquisite per curiosità o per passione o per studio, non è cosa facile, senza scadere in ovvie considerazioni didascaliche, più che poetiche. La straordinaria pressione esercitata su uno spirito incline alla meraviglia davanti alle “rivelazioni” tanto fantasiose della scienza, tende a investirlo come un’onda d’urto che destabilizza l’assetto di un volo, quello poetico, in questo caso.
La scienza adotta il linguaggio della matematica, esso è un linguaggio vero e proprio che attinge a un serbatoio grafico di simboli e ha regole, esattamente come qualsiasi altra lingua. Ma in essa vige una logica stringente dalla quale, misteriosamente, escono, come da un cappello magico, i misteri della natura che gli scienziati traducono in linguaggio corrente affinché possano essere compresi anche da chi non conosce la lingua della matematica. Come in ogni processo di traduzione, anche qui, si rischia di perdere alcuni significati importanti e il discorso matematico-scientifico perde il suo valore, talvolta rischia la banalizzazione.
È quello che a tratti succede, a mio avviso (e mi si perdoni se lo dico così esplicitamente), in questa raccolta poetica. Non conosco la produzione poetica di questa autrice, la mia è soltanto una analisi personale relativa a questa raccolta, che avvicino come lettore di poesia e come fisico, ma capisco che, avvicinata come lettore e non con la competenza di uno scienziato, può invece affascinare per alcune miscelazioni filosofiche e scientifiche che abilmente l’autrice riesce a proporre, come ad esempio in “L’orizzonte degli eventi”, che è un’altra delle poesie che ho molto apprezzato.
Ma tralasciando l’aspetto più strettamente scientifico devo dire che ho trovato anche debolezze di forma, là dove, ad esempio, troppo spesso si trovano aggettivazioni atte a voler eccessivamente colorire alcuni concetti scientifici; oppure inversioni tra sostantivi e aggettivi che rendono il discorso poetico un po’ vecchio, non in linea con una, mi si passi il concetto, certa modernità poetica.
Certo, potevo tacere, ma il rapporto poesia/scienza è un campo in cui mi trovo, volente o nolente, a lavorare col mio personale discorso poetico, pertanto ho preferito parlare, e anche esplicitamente, allo scopo di indurre una dialettica e una spinta di ricerca sempre più decisa e profonda in tale direzione, sicuro della comprensione dell’autrice, alla quale non manca certo la mia ammirazione per il coraggio della linea di lavoro intrapresa.
Ovviamente questo è un invito alla lettura, perché, sono certo, è un libro godibile da moltissimi lettori, che ha il pregio certo di aprire spiragli sul mistero e il senso della vita nell’universo in cui ci troviamo, nostro malgrado, ad esistere.
Infine, per riscattare dal mio dire questa raccolta, propongo una lettura di Maurizio Soldini a Corpi celesti, la trovo pertinente e mette in luce alcuni tratti essenziali che mi trovo a condividere:
http://www.lietocolle.info/it/m_soldini_su_cenni.html
Id: 479 Data: 04/10/2011 12:00:00
*
 Luca Buonaguidi - Poesia - Fermenti Editrice
Luca Buonaguidi - Poesia - Fermenti Editrice
I giorni del vino e delle rose
Parlare di poesia non è mai facile, tantomeno parlare dei poeti, ancora meno parlare degli esordienti. È il caso di Luca Buonaguidi, che si inserisce nella comunità poetante con questo suo I giorni del vino e delle rose. Non è facile parlare di un esordiente perché egli si aspetta complimenti e incoraggiamenti, non certo critiche, il rischio è quello di alimentare vanagloria o, nell’altro caso, tormento. Ho letto con attenzione questa raccolta e devo dire che c’è materiale poetico, quindi direi che, potendo esprimere un giudizio (ahimè anche la poesia si giudica) riguardo la poesia, direi bene; tuttavia, essendo il poeta agli inizi, e giovane, mi sento di dare alcune indicazioni di lavoro… infatti c’è del lavoro da fare, questa raccolta è un inizio, non solo come prima opera edita ma anche un punto da cui iniziare un cammino del buon materiale tra le mani. Non spetta a me incoronare poeti, è certo, ma quello che devo fare è essere onesto, questo, prima di tutto, per me stesso come lettore, non sono un critico, e per coloro che sono lettori attenti alla poesia.
Le poesie di Buonaguidi sono buone, ma ancora lavorabili nella forma, sicuramente. Ravviso qua e là sovrabbondanze, troppo detto, molti versi sarebbero tranquillamente eliminabili, a mio avviso, e le poesie ci guadagnerebbero in forza espressiva. Un poeta deve manifestarsi, prima di tutto, con uno stile chiaro, se vuole lacerare il velo che lo separa dal lettore più esigente, da colui che legge poesia con interesse e scelta, e non perché gli capita per caso tra le mani in libreria un libretto con versi d’amore.
Per quanto riguarda i contenuti ce ne sono e anche ottimi: l’inquietudine del vivere, l’amore, la nostalgia, la fragilità sentimentale ed esistenziale, l’anelito al bene in conflitto con il male della sofferenza, una certa calibrata trascendenza che non dispiace, insomma vi sono contenuti che sono punti di forza di questo libro e sicuramente della personalità dell’autore, per i quali devo complimentarmi e invitare alla lettura della raccolta; si percepisce un’anima piena di vita, di stupore e di volontà a comunicare e a esprimersi nell’arte poetica, nella scrittura. Tuttavia la raccolta, e anche certe singole poesie, andrebbero lavorate e rese uniformi nello stile, abbandonando decisamente certi lirismi, le inversioni tra i nomi e gli aggettivi, ad esempio, vanno calibrate, eseguite ad opera , altrimenti si rischia di dare un senso di classico ma annacquato, poiché del classico non c’è la metrica. Ravviso una tenue scia luminosa che scaturisce dai poeti maledetti francesi e un po’ della Beat generation… insomma diversi stili troppo evidenti, talvolta stridenti tra loro, non ben miscelati.
In conclusione, complimenti per l’esordio ma il consiglio è quello di lavorare per trovare un proprio stile coerente e un poco più moderno, sono certo che questo autore, se si lancia in se stesso, osando un lavoro coraggioso sulla forma della sua poesia, ci farà il dono di una grande poesia… leggere leggere e leggere, contemporanei.
Riporto qui, per contraddire me stesso, una poesia molto bella, per la quale direte ma che cosa ci ha raccontato? Eccola, da pagina 41:
I giardini trascurati della notte
Il dolore scalfisce
ogni mia nuova àncora,
il fango confuso
pervade ogni nostro
residuo di purezza
e le mie vecchie utopie
hanno smarrito
il loro giaciglio originario.
Navigo il mio corpo
spingendomi avanti
a forza di bracciate in solitudine
come il nuotatore che mira la boa
per quotidiana abitudine.
Getto àncore ovunque
come un vascello notturno
che rientra al porto
dopo una mareggiata.
L’aria che stanotte
mi pesa sulle spalle
e ha la parvenza
di qualcosa che è assente.
La notte,
coi suoi giardini trascurati
di solitudine e compassione,
con quel suo sapore
che chiede asilo
alle mie vene.
Complimenti all’autore, assolutamente da leggere per certe sue gemme poetiche.
Id: 465 Data: 26/07/2011 12:00:00
*
 Maurizio Soldini - Poesia - LietoColle
Maurizio Soldini - Poesia - LietoColle
Uomo. Poemetto di bioetica
Un corpo è un sole di meravigliosa
stoffa cucita ad arte su un refolo
di vento che spira in ogni direzione
fintanto che lo vuole il cielo.
(Pagina 17). Sono quattro versi tratti dalla raccolta poetica Uomo, di Maurizio Soldini, sottotitolato Poemetto di bioetica. La sezione centrale, dalla quale è tratta la poesia sopra proposta, è titolata In media res. Infatti l’autore, senza troppi giri di parole, entra subito nel vivo del suo pensiero. Uno dei temi trainanti la narrazione poetica si evidenzia nel corpo, cioè quella parte di noi evidentemente corruttibile perché sottoposta alle leggi della biologia, ma il corpo è totalmente correlato allo spirito umano che in esso e con esso si evolve, un corpo che Soldini presenta nell’aspetto della sua sacralità. Siamo abituati a ricevere, tutti i giorni, nel nostro campo visivo, immagini di corpi esposti in vario modo e per i più disparati motivi, talvolta ostentati e mercificati sia dai Media che da noi stessi – è ora il tempo estivo in cui i corpi sono in maggiore evidenza –, il rischio è quello di perdere il senso della bellezza e dello stupore davanti a siffatta perfezione dell’evoluzione biologica. Soldini, con una quarantina di poesie, ci toglie dall’abitudine e ci mette nella direzione del mistero dell’essere umano. Avere il corpo non è un caso (pagina 18):
La Carne che tu sei è una vittoria
se ancora ti permette di sperare
nei pieghi delle libertà giocate
a dar risposte ad ogni evento
amaro o dolce come un aeroplano
che plana sulle nuvole dorate.
La carne è cara in ogni senso
brucia di gioia e di tormento
si gonfia di ferite e di carezze
respira forte quando tira vento
la sua speranza è come un gioco lento.
Nel poemetto, Soldini, percorre la storia biologica di ogni persona, con grande rispetto e una certa calibrata devozione verso questo arcano che è l’uomo, che fin da prima della nascita egli vede come cellula cresciuta nell’amore (col pianto avresti accolto / la comparsa sulla terra nuda). È una lettura coinvolgente, poiché nei suoi versi, lievi e al contempo consistenti per i temi trattati, si ritrova ognuno di noi, nel percorso esistenziale che l’autore mostra come un’osmosi continua tra la realtà biologica e una realtà intima e cosciente della propria esistenza e del mistero a cui essa si appella (pagina 23):
Ti guardi allo specchio
e ti guardi avanzare per strade
che ti hanno portato nel tempo
di strascichi amari.
Ma vedi apparire talora
lo spettro nebbioso di gioie
che pure ti spingono a entrare
nei giochi che pure sai fare
e non smetti di stare.
L’autore immagina, con abile scrittura, di accompagnare l’uomo nella sua crescita verso il tempo della maturità, fin nel dolore e sulla soglia della morte, trattata nella sezione titolata In limine mortis, in cui, con sette poesie, c’immerge nel mistero della sparizione biologica della persona umana. La poesia che precede l’ingresso nella suddetta sezione, apre il tema molto discusso, anche in queste ultime settimane, dell’eutanasia, che Soldini affronta così, proponendo, e non imponendo, il suo personale pensiero: “[…], lasciamo accadere / gli eventi stringiamo pure i denti / ma non usiamo la falce che stride / prima che siano maturi i tempi. / […]”, pagina 47.
Le poesie finali sono tra le più struggenti della raccolta, sono composte da pochi versi, la più lunga ne ha sei. Si parla del corpo sofferente che precipita nella morte, ma accompagnato dalla serenità della fede in una eternità che accoglierà ogni uomo (pagina 54):
La carne si sfa nel dolore
ma l’anima corre veloce
una mano la scorta felice
al cospetto di Chi. Chissà chi
È chiara la matrice cristiana del pensiero di Soldini (pagina 55):
Ancora un istante di tenebra,
e quindi la luce perpetua
Egli, per scrivere questa raccolta, mette in campo tutta la sua competenza di medico e studioso di bioetica ma anche di uomo e di uomo con un grande rispetto per la vita; come detto si raccolgono nella sua scrittura le avvisaglie di una visione cristiana della vita umana (un uomo è la terra è materia / corpo vitalizzato dal vento / […], pagina 47), ma è così delicata, tale proposta, che si ha la sensazione di percorrere un tratto di strada in aperta campagna con un amico con cui si sta discorrendo della vita e della morte, non vi è in nessuno dei due il tentativo di piegare l’altro ad una visione personale delle cose, ma semmai un libero e reciproco scambio di riflessioni. Buona lettura.
Id: 459 Data: 05/08/2011 12:00:00
*
 Roberto R. Corsi - Poesia - Nessun Editore
Roberto R. Corsi - Poesia - Nessun Editore
Sinfonia n. 42
Questa settimana proponiamo la lettura di una raccolta poetica che potete immediatamente scaricare gratuitamente e leggere senza continuare ulteriormente la lettura di questa segnalazione/recensione, che è comunque volutamente breve per dare spazio alla lettura diretta dei versi. Solitamente non recensiamo eBook, ma ci sembra che non sia brutta l’idea di iniziare a farlo anche nell’ottica di favorire la buona poesia al di là della barriera editoriale a stampa che spesso preclude, per misteriose motivazioni, la strada a poeti e scrittori che non abbiano capacità scalatorie o pecuniarie. Così in questo caso riconoscendo il valore di questo giovane poeta, Roberto R. Corsi, ci sembra opportuno proporre la lettura di questa sua ultima produzione scaricabile dalla seguente pagina:
http://robertocorsi.wordpress.com/books/sinfonia42/
Nella e-mail pubblicitaria, che l’autore ha inviato per informare di questa sua pubblicazione fresca fresca (giovedì 16 giugno 2011), tra l’altro si legge:
“È online in formato pdf la mia ultima raccolta/plaquette (sono diciassette poesie) dal titolo Sinfonia n. 42.
Che dire? Solo che è la raccolta con cui almeno per ora, e credo per un bel po' (salve le cose che sono già in giro) esaurisco il mio dire. Se vogliamo, mi re-setto.”
Mi ha colpito molto “esaurisco il mio dire”. Penso che, similmente a un’ultima sospesa nota di una sinfonia, ben piazzata nel gran finale, che non sospende ma anzi prolunga il dire del compositore, così questa raccolta di Corsi è in realtà il preludio a un risonare di pensieri da parte del lettore/ascoltatore. Soprattutto, partendo dalla sua esperienza di poeta, egli lascia venire a galla, usando i suoi versi come un liquido a bassa densità, una sorta di disillusione, certamente non verso la poesia ma verso il mondo che la circonda e la pratica con faciloneria e/o presunzione:
[…]
Per tutta la vita ho succhiato luce riflessa e nervi rossi,
nuvole di bugie cosi spesse da farsi architrave,
piani sequenza d'un film che non trova piu fondi.
Nessuna coniugazione nei miei giorni – eppure scrivo
e mi difendo dai professorini della poesia vera, religiosa, popolare
con la ferocia indifferente del dio Indra o del Teseo viennese,
come chi schiaccia zanzare sul muro appena imbiancato.
(Tratta da consiglio a un Consiglio)
Certo, fare poesia solo per il gusto di dirsi poeti è minima cosa, o per la vanagloria del dire per dire:
[…]
Mi residua un ambire che non sia
nudamente gettarsi nella gola
del verso, solo per poter dire
di lasciare qualcosa (a chi poi, e per quanto?)
che non sia quella ruota di pavone
che fanno certi autori per spiegare
(recintare) il concetto di poesia?
Sarò mai tra gli eletti,
io che sempre mi scanso?
[…]
(Tratta da finale. Allegro misterioso)
Penso che Corsi, consegnandoci questi suoi ultimi versi, ci abbia fatto un bel dono, si ha l’impressione, almeno io l’ho avuta, di uscire dalla lettura come una bella salsiccia sgrassata nell’acqua bollente e di cui rimane la parte meno evidentemente saporosa, forse, ma più sana. Egli si è tolto qualche sfizio, lanciando in varie direzioni moderati strali e garbati, onesti pensieri. Riporto per intero la poesia intitolata “Lo schiaffo”:
Stridiamo entro un'aria microbica di trapianti e rigetti –
tu per anagrafe e vizio calcistico di simulare,
io per tremore e ignavia. Uscirai dalla scena
come il padre di Zeno Cosini, con odio demenza e l’applauso del giusto –
o martire d’un figlio deludente comunista interista,
senza un dio senza un campanile, poeta perditempo
reddito basso, non scava non striscia non fiuta la terra il lavoro
non venera il sedile dell'auto il padrone il massone
niente spina dorsale e ovviamente niente fica
o poca squattrinata impresentabile.
Mentre il sonno subentra alla linfa sei ogni minuto piu conservatore,
i magistrati una setta assassina che insidia governi di latte,
maltratta te la tua famiglia che io non sono non difendo mai.
Il tempo sedimenta, semplifica i composti erode il fondotinta,
rende i giorni concorso di stimmate, ma la fine imminente
(la tua, la nostra) e da sola ovattato contrappasso, non servira a nulla
scagliare per aria specchi rotti, gia dormi in poltrona.
Andate a leggerlo: http://robertocorsi.wordpress.com/books/sinfonia42/
Potete anche lasciare i vostri commenti nella sua pagina, ma se volete anche qui da noi.
Buona lettura.
Id: 442 Data: 18/06/2011 12:00:00
*
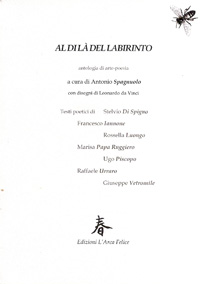 Aa. Vv. - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Aa. Vv. - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Al di là del labirinto
[ Antologia di poeti a cura di Antonio Spagnuolo ]
*
Nell’editoria contemporanea si possono trovare varie proposte di poesia, dai libri di singoli autori alle antologie. La voglio fare tragica: le grandi case editrici, assoldando feroci e tremebondi critici, pubblicano antologie dai titoli altisonanti contenenti poeti destinati agli allori, foraggiati e sostenuti dagli stessi imponenti editori nell’importante cammino verso il loro dover essere, cioè poeti eterni, inestinguibili. Ma è ovvio che molti sono effettivamente grandi poeti che meritano gli allori, ne conosciamo nomi e cognomi, di alcuni siamo anche amici. Non è certo colpa loro, forse, se i giochi di uno strano potere, ancora a me in parte ignoto, li vuole sostenere a scapito di altri che ho invece avuto modo di leggere in edizioni prive di visibilità e che reputo, nella mia veste di lettore, grandi poeti. Ma non voglio entrare qui in singolar tenzone con nessuno, perché la battaglia sarebbe persa e perché punto ad altro. In questo desolante panorama di equilibri di potere letterario, che critici, e anche poeti, sostengono nel consesso della maggiore (intendo per i soldi) editoria, si staglia, a diopiacendo, la fantastica proposta editoriale delle Edizioni L’Arca Felice che, con un progetto ben strutturato a favore della poesia contemporanea, di tutta la poesia contemporanea, di esordienti come di già vaccinati poeti, hanno avviato, nella collana Coincidenze, curata dal poeta e saggista Mario Fresa, una sorta di censimento del fermento poetico che anima questa nostra tanto amata e martoriata Italia della cultura. Ma avviene ancora di più, il progetto editoriale prevede una composizione di varie arti poetiche: poesia, pittura, fotografia, disegno, delineando una progetto/tentativo, a mio avviso decisamente interessante, di ritorno all’esperienza unitaria della bellezza delle varie espressioni artistiche che scaturiscono dal genio dell’intelletto e della sensibilità umane.
Di questi quaderni poetici, la cui veste grafica è ricercata e di elevata qualità – benché usino solo carta riciclata di alta qualità, ECF, realizzata in modo sostenibile in possesso della certificazione per i sistemi di gestione della qualità, l’ambiente e per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, come si legge nelle loro edizioni –, ne abbiamo già tre, ma quello di cui voglio qui parlare, in particolare, è il II quaderno curato da Antonio Spagnuolo, poeta apprezzato e stimato per la coerenza e la chiarezza della sua poetica. Egli ha intitolato l’antologia, da lui curata, Al di là del labirinto. Essa contiene, ben illustrata da disegni di Leonardo Da Vinci – noto per il suo eclettismo artistico-scientifico, e per il fatto che egli vivesse arte e scienza, nelle loro varie espressioni, allo stesso livello di interesse e competenza, in un contesto di esperienza unitaria–, sette poeti: Stelvio Di Spigno (nato nel
Il lavoro di Spagnuolo si avvia con una bellissima introduzione in cui, tra l’altro, si legge:
“La scrittura poetica, così come ogni manifestazione artistica che sia di notevole interesse, rompe l’isolamento dell’io ed invita al recupero del tempo, un’alterità che può essere mantenuta dal rapporto, nei confini di una pagina, nei limiti dell’opera, ove suoni e voci allestiscono la scenografia del tempo che trascorre, il suo evolversi in un ritmo incantatorio capace di stordire, il suo declinare in una pausa che stordisce ogni illusione. […]”. E ancora: “[…] Il poeta vede intuitivamente, prima e dopo la scienza, ogni filo che lega gli oggetti e in pochi casi anche il filo più tenue che lega tutte le parti dell’universo, del cosmo, nella totalità delle combinazioni prodotte dalla creatività. […]”. Spagnuolo s’inoltra in un breve ma significativo discorso sulla poesia e sulla figura del poeta: “[…] Il poeta ama la vita e le sue moltiplicazioni e non scappa anche quando non si sente corrisposto […]”. Egli si pone la domanda che assilla anche noi qui de LaRecherche.it: “Ma è poi necessario un messaggio in poesia? – ed è necessaria ancora una antologia, quando tutti sanno che la poesia è derelitta, almeno in questo nostro paese, stordito dalla televisione e dai mass media, che abbassano sempre più il bagaglio culturale dell’individuo?”. La risposta di Spagnuolo, che condivido, è semplice ma coinvolgente come forse lo fu Garibaldi con i suoi, nella sua determinata volontà di riconquista di valori unitari e alti, eccola: “Noi tentiamo il miraggio”. E in questo siamo uniti: se ci va bene, come sicuramente sarà, avremo salvato la nostra terra dalla diaspora indotta dal diaballo del conformismo culturale e mediatico e dalla grettezza dei nostri politicanti odierni.
Per quanto riguarda gli autori presenti nell’antologia, il curatore, dimostra un grande amore nei confronti della poetica dei suoi proposti, mostrandosi nella veste di un poeta-padre di ampia esperienza di letture e scritture, scrive: “[…] Voci diverse, età diverse, poetiche diverse, per un confronto che non richieda alcun impegno di selezione, ma offra uno spacco sinuoso del fare poesia oggi. […]”. Riporto, perché meglio proprio non saprei dire, alcune brevi descrizioni che Spagnuolo fa degli autori proposti:
«Voci diverse, età diverse, poetiche diverse, per un confronto che non richieda alcun impegno di selezione, ma offra uno spacco sinuoso del fare poesia oggi.
Una vertigine affabulatrice distingue Ugo Piscopo per quella sua capacità di aggregare fonemi per fulminare con passaggi sempre elettricamente vividi e sorprendenti. Il suo linguaggio ha l’andamento ondeggiante che apre lo scrigno del verso per diventare racconto.
Marisa Papa Ruggiero offre il segno rivelatore della favola, che nell’affiorare del ritmo propone ritocchi pittorici, capaci di abbagliare con le variabili intensità dei colori.
Lambire luoghi e rivelare figure è il rapporto felice con la poesia. Qualche verso di Vetromile riporta chiaroscuri di alcuni accadimenti quotidiani amplificati dalle armonie dell’esistere per quelle interiorità che si trasfigurano, tra suggestioni ed emozioni, in fertili movimenti dirompenti, quasi un colloquiare solitario, capace di indagare tra gli interrogativi filosofici che aleggiano tra le nostre circonvoluzioni.
Non sorprende il ritmo incalzante delle composizioni di Francesco Iannone, nelle quali tutto rimane sospeso sulla pelle per una trappola incandescente, nella quale ogni affanno si nasconde con sospensione.
Raffaele Urraro, non più nuovo alle riunioni antologiche, scrive con cristallina purezza, nella compiutezza dei suoi versi, profondamente incisi nella cultura che lo distingue. Altra veste per il giovane Stelvio Di Spigno, fedele al verso lungo, per una sua particolare capacità di recitazione, entro la quale il quotidiano corrodere cerca disperatamente una strada liberatoria per appropriarsi di illusioni e speranze quasi sempre sorprendenti. Non ultima la giovane Rossella Luongo chiude una serrata introspezione, che riesce ad intendere quanto di misconosciuto rimane nelle illusioni della parola, ripetuta e strapazzata.
Gli spunti di osservazione si alternano in significative figure per dare ampio spazio al ritmo.»
Siamo quindi felici in questa settimana – a cavallo della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e lo facciamo di proposito – di proporre una antologia di voci poetiche contemporanee che lavorano ed operano a sostegno di questa nostra cultura italica, talvolta nel nascondimento, senza proclami urlati a vanvera ma con il serio impegno della poesia, perché sì, è vero, siamo un popolo di naviganti e di poeti. Viva l’Italia.
Ecco alcune poesie estratte dall’antologia, una per ogni autore, per gentile concessione dell’Editore:
*
Stelvio Di Spigno
La strada dell’Essere. Poesie 1995-2010
Il mattino della scelta
Sentivo sgrondare – lento –
tra le occhiaie il mattino della scelta;
si inerpicava al posto mio nel mio
disperare, finché mi fu concesso
– cieco – di rinunciare; lo sentivo
disperare senza alcun martirio
come fa il cuore che non dà più nebbia
e il passo fino alla fermata è netto.
Aspetto l’uscita dei gabbiani
dai casermoni dismessi della periferia.
Aspetto un volo di falene
da un atollo dove non c’è mare,
forse, e non c’è via.
*
Francesco Iannone
Materia
Ora che la piazza si allaccia ai polsi come spago
appoggio bene l’orecchio ai muri
ingoio l’aria che sbuca dai fori
con la lingua cerco il vento
l’ansia dei colori sui balconi.
È bello - sai - girare il passo
dove tu cammini nella luce
che sventola come fiocco
come battere di tacco sull’asfalto
mentre corro i desideri a petto duro.
Sono conche di fiato queste braccia
io che ti respiro a gola aperta
dentro tu
che ci butti il sole.
*
Ugo Piscopo
Perversa primavera
Or che Orion declinando disimperversa da piogge e nevi
qui numquam amavit cras amet quique amavit cras amet
in seduzioni di rose e di viole sparse di tua man sui sentieri
di Mame che sale alle valli ondanti orzo odore di miele
d'Armida tu postergata panoplia che ripara in bosco di magie
o di Salomé in spirali avvolta di sapienti danze
ma sul frontespizio plissée di cerusica mano
a griglie di tane e cascami tirate e stirate
o tu cubo di freddi caldi in ghingheri e spifferi
che appendi a festoni del Sud attorno al grasso collo
di un mondo che va in sollucchero di gelatina
fatua brilli nell'aria aulente perversa primavera*
Glossa dell'Autore
Linguaggio inattuale rispetto al mediatico e mercantile, ma in accordo con quelli sommersi e dimenticati che giacciono nel deposito parlato e letterario della lingua nazionale. L'immaginario è cedevole all'intertestualità, che qui va dal latino della decadenza agli stilnovisti e a Tasso, Parini, Leopardi, Wilde. Il verso, che Carducci avrebbe definito “barbaro”, è sovresposto a esigenze narratologiche da epica moderna, che rimemora l'andamento delle chansons medievali. Il tema è dell'effetto serra, che in questa fase si nasconde dietro una maschera di falsa, ingannevole primavera.
*
Marisa Papa Ruggiero
Energie di campo
*
sciamanti fiaccole in corsa
su dispari note
eccentriche di sguardi
per nuovi appostamenti
che scambiano i percorsi
o le direzioni di marcia
per vincere i confini
del libro
senza il foglio di via senza
l’ordine del giorno
ma sale prosciugato in tasca
sale tra i denti
per altri semi a richiamo
per finti uccelli
mai nati
vivi da qualche parte
*
Raffaele Urraro
rimbalzano le mie parole
rimbalzano le mie parole
dalla terra di creta
al cielo di cristallo
e non trovano nulla:
trovano soltanto
il silenzio dell’assenza
ombra grigia
che pigia le nevrosi
del sogno
l’uomo è solo
con la mente che vola e che s’impiglia
negli spazi frantumati del nulla
e il silenzio squarcia
le pareti di pietra
è un silenzio impalpabile
come tenebra oscura
sotto le dita dell’anima
solo la parola
può uccidere il silenzio
e se svanisce nel nulla
resta l’eco trasportata dal vento
*
Giuseppe Vetromile
Regole dell’infinito effimero
nr. 1
Dimostrami mia cara
quando il giorno è una babele
il necessario appuntamento con la luna
per non regredire nei rigidi asserti di sole
:nonostante il desolato confine d’ombra
e il muro che ci separa da sempre
dalla resurrezione
non ho avuto abbastanza teoremi
e neppure corollari
per risolvermi l’arcano smateriarsi
della vita

Leggi anche l'eBook Poetica Unità d'Italia
Id: 407 Data: 18/03/2011 12:00:00
*
 Tomaso Pieragnolo - Poesia - Passigli Editori
Tomaso Pieragnolo - Poesia - Passigli Editori
nuovomondo
nuovomondo. Il titolo della nuova raccolta di poesie di Pieragnolo richiama tempi di esplorazioni e navigazioni avventurose e di scoperte di nuove terre sul globo terrestre, tempi in cui incerte terre all’orizzonte erano sorpresa e coronamento di un grande affanno, per velieri carichi di aspettative di marinai e di regnanti del vecchio mondo. La poesia di apertura favorisce la prima suggestione indotta dal titolo:
Ma oggi l’oceano mi ha portato
le sue scapigliature azzurre,
il fianco franto delle coste
che sparpagliavano nel vento,
l’equatore roco delle sue gocce
disfatte nelle anse del Sud
e correnti di convulso calore
nel cumulo del mezzogiorno;
era un guizzo vivo fra tanti uguali
guizzi e lampi come nevi disciolte
che riflettono il corpo delle nubi,
un favo di braci segrete
sciamato dove la luce apprende
l’intricato spessore abissale,
o dove l’evasione di una lingua
nell’aria dura fino a quando
bave invisibili non trascinano
al fondo della terra un peso
vuoto di pensieri, o ancora il margine
netto di un corpo inarca il limite
cospicuo sgusciando dove nessun
luogo esiste oltre l’avido millimetro
delle tue carezze, mia terra,
lungamente ingiuriata stai
tra le mie dita come una manciata
di tutto il sale,
tutto il sole e il seme
che spese il tuo corpo, aggrappata
a possibile vita ancora così
mi regali per annusare il mondo
un nuovo fiore.
(Pagina 7)
Un libro che narra una storia, iniziando da una Fine (è il titolo della poesia iniziale), con un finale che chiude su un Inizio (è il titolo della poesia finale), come ogni ricerca vera deve essere, nel tentativo di dimostrare una tesi o nel tentativo di raggiungere la meta che già il navigante vede ancor prima di partire o durante il viaggio, nella speranza di raggiungerla.
Ma è questo l’ultimo uomo o il primo
se con deteriori forme e ripartito
errore disarticola il futuro in sboccato
rumore e permanente gorgo che precario
rende l’idioma e urgente, recando
intransigente miseria che dura
comprime e senza rotta l’ultima
palpitante stella nel vuoto che balza
eccessivo devolvendo il proprio declino;
e un minimo dubito può nascere
e nascosto, alla vista inabitato
affacciarsi, andando in cerca d’ombra essere
fronda, perché imbizzarrita appare la vita
e a volte precaria scalciando striglia
l’uomo che giace inerte nel suo orgoglio.
Cerca terra per un nuovo legno o solo
il possesso di un successivo
giorno, il luogo dove nessuno uccise
la colomba o errando d’incatenare
la programmata sventura con perseveranza
sterminata, perché l’uomo sia terrestre,
terrestre l’avvenire e una memoria
che non si offuschi, perché un giorno possa
nascere in origine dell’amore
contro stridi di smodato rumore, inetta
sovranità e abulica crescita
di sola materia che per se stessa
prova compassione e rimedio.
(Pagina 43)
La storia quotidiana dell’umanità dipende, anche se talvolta può non essere evidente, dalle scelte personali di ogni individuo che ha, almeno in potenza, la possibilità di modellare le scelte della massa degli individui, a patto che l’anelito alla meta – al raggiungimento di un sogno, di un’aspirazione, di una immaginazione, di una tesi – sia tenacemente alimentato in modo quasi ossessivo, necessario. Può essere così forte la tensione all’esistenza di un’idea, un’intuizione, o di un sottile pensiero, che la realtà si modifica e l’immaginazione diventa reale, si assiste ad un atto creativo, e l’uomo raggiunge qualcosa, anche se quel qualcosa non c’era, non esisteva; tutto si costruisce, è il nuovo mondo, un mondo nuovo mai visto prima, mondo che non c’era e, forse, mai ci sarebbe stato se quel navigante, quel poeta, quell’entusiasta e ostinato uomo-cercatore non fosse partito per l’avventura, l’edificazione di una nuova terra, quella che egli vede dentro sé, prima che fuori di sé, invisibile meta, fintanto che, dalla formaggetta, all’estrema cima dell’albero maestro, la vedetta non strilla “Terra! Terra!”.
È quello che succede leggendo questo bel libro di poesie. Perseguendo la lettura del libro di Pieragnolo, che per certi aspetti, ad una prima lettura si rivela delicatamente ermetico e di non immediata evidenza, si ha la sensazione di navigare attraverso l’oceano verso una probabile nuova terra, e realmente la si raggiunge, navigando tra i versi, la si esplora, verdeggiante e primitiva, anche se già ostinatamente inclinata verso la corruzione. La poesia di nuovomondo fluisce densa, ritmata da scansioni metriche ben precise, a tratti lirica, sempre importante, ricercata nel significato e nella costruzione, somiglianza di un mare sul quale il lettore naviga in bonaccia, mai in burrasca, fino a ritrovarsi, alla fine di un viaggio che non finisce, proprio dove l’inizio aveva annunciato, ad annusare un nuovo fiore di grazia su una terra ancora intatta (ma con il seme della corruzione già nel suolo), la terra (che forse già appartiene ad altri) del verde, dell’azzurro, della poesia, della giusta relazione tra le cose del mondo (relazione macchiata, sì, ma già nel rimestio di una rinnovata libertà), dell’amore, amore che gentilmente, ma decisamente, si trasforma con
Ma lontana è la terra e senza sonno,
in improvviso stallo le acque opache
depistano scardinate chimiche e
non c’è che metallo nel futuro
frastuono, carte ignobili dalla stessa
frenesia sciupate che viaggiano colme
di elusioni silenziose, oceano
che amaro schiuma dietro l’ultima
nave, stanco di lignaggi umani;
selva vivida, disamorata e schiva,
spiegaci ancora la sintesi dell’aria,
il cavillo necessario o solo
dell’ergersi il senso, perché la rondine
dormendo sogni di cantare e gli amanti
siano sempre animali di luce
circondati e di bellezza, come si aggrappi
al corpo l’atmosfera ricordandoci
gli etimi scomparsi e le sostanze
inevitabilmente perse, perché
era un dono infine questo mondo dove tutto
nasce, questo disgregato astro,
in apparenza, di fertilità
e fermezza, prima della somma
e dell’inchiostro, prima del miraggio
e del peccato, prima di tutto o forse
solo prima di tante vite al dolore
destinate.
(Pagina 65)
V’è però un interrogativo stringente che forse sarebbe stato bene porsi anche in altri tempi, prima di stritolare nuovi mondi tra le fauci del vecchio: “[…] come aggiungere il nuovo / mondo sopra quello vecchio con tanti / malintesi in circolazione, sottotitoli / ancora eredità di dominio e / compiacimento per un latente potere / che sopprime quotidiano, come snidare / perpetua la mancanza e giungere infine / a contare tutto, mangiare tutto / il mangiabile, stipare l’avvento / in alterato turno così accalcati / ogni anno, coda morsa dal cane / che si morde la lingua e soma somma / per avere non apprendendo che sola / materia, finalizzando l’orario / per comprimere nell’agro spiraglio / del possesso un giorno.”? (Pagina 28). Interrogativo e condanna verso un sistema che prima o poi collasserà, perché forzante un sistema naturale e sociale che ha altri punti di equilibrio stabili rispetto a quello attualmente raggiunto, ch’è instabile.
Pieragnolo, nella sua etica pienamente intrisa di umano, un’etica quindi universale e piacevole, spiana la strada all’uomo, cerca di analizzarne la pesante sfida dei giorni, l’assetto storico e sociale che lo caratterizza, la pesantezza del suo presente che converge dal passato su un equivoco status quo attuale in cui “È statuario il fallimento, il giorno / di lapidari intenti quando l’odio / rimonta in ogni fronte e dissotterra / l’invasore le sue polite leghe, / il ripudio che ha scelto come elemento / e invariabile vive in trincerata / prospettiva; così non resta che attendere / il verdetto della materia e replicare / il mutante delirio, la condizione / che disoccupa o solo il tacere di un ultimo / promettente dominio. […]” (pagina 34).
L’autore è padovano, ma da ormai venti anni vive tra Italia e Costa Rica, vorrà dire qualcosa, questo, in relazione al titolo della sua opera? Traduttore ed esperto di poesia ispano-americana, quella di Pieragnolo risulta essere una voce fluida, per certi aspetti narrante e fantasiosa, libera da avanguardie e sperimentalismi, che decisa persegue la sua meta, la poesia. E attraverso di essa esprime ciò che ha vissuto, le riflessioni tratte da ciò che ha visto sull’asse Europa-America a cavallo di un oceano che per secoli ha nascosto parte del mondo all’occhio bieco degli europei: “Ma ho viaggiato, sì, in terre / denudate e so che mai termina l’esodo / e sempre volge la densa aria del Sud / il suo pudico umore in impregnate / orbite e nel sinistro umidore / tendono freschi stami e linfe stridono / in trasparente monito; ed è un lamento / di legno incrinato o d’uomo negato / all’inagibile giorno con solo / un piede accerchiato al palo, perché / il futuro è una terra d’intenti fradicia / di convenienze, […]” (pagina 36).
Vi è, nella narrazione poetica, una analisi, garbata, ma penetrante, nell’insistenza della parola, la quale è a flusso continuo, attraverso di essa prova a far prendere coscienza al lettore circa gli invisibili fili che l’uomo tende all’uomo, “[…] perché l’agguato / dell’uomo sull’uomo tende invisibile / filo e manovra la triste quantità / e necessaria contro muri che scindono / l’aria in gremite metà, se ogni nuova / gioia solo può sorgere da fredde / rovine; […]” (pagina 40); ma la speranza e l’incitamento verso un nuovo corso, un nuovo mondo, non mancano nel pensiero e quindi nella parola di Pieragnolo il quale prova a darci qualche dritta: “[…] / perché tu sia allegro in terra e apprendendo / la vita tu sia vivo.” (Pagina 42).
“[…] perché imbizzarrita appare la vita / e a volte precaria scalciando striglia / l’uomo che giace inerte nel suo orgoglio. / Cerca terra per un nuovo legno o solo / il possesso di un successivo / giorno, il luogo dove nessuno uccise / la colomba o errando d’incatenare / la programmata sventura con perseveranza / sterminata, perché l’uomo sia terrestre, / terrestre l’avvenire e una memoria / che non si offuschi, perché un giorno possa / nascere in origine dell’amore / contro stridi di smodato rumore, inetta / sovranità e abulica crescita / di sola materia che per se stessa / prova compassione e rimedio.” (Pagina 43).
Allora non posso non concludere con i miei complimenti all’autore, e all’editore, per tale lavoro poetico che ha saputo arricchirmi di una ulteriore nuova dimensione. Ci tengo, come al solito, a chiarire che qui, su LaRecherche.it, tranne qualche rara eccezione, la linea è quella di non essere criticosi recensori, ma attenti e appassionati lettori, pertanto la nostra, la mia in questo caso, è una lettura personale e totalmente scollegata dal mondo pretenzioso della critica ufficiale. Forza lettori, riprendiamoci la letteratura, buttiamo i libri da commercio, spesso sapientemente venduti dalla critica.
Id: 398 Data: 18/02/2011 12:00:00
*
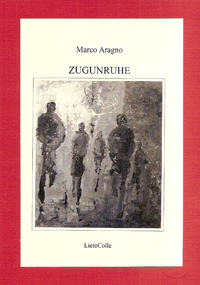 Marco Aragno - Poesia - LietoColle
Marco Aragno - Poesia - LietoColle
Zugunruhe
La raccolta si sviluppa, chiaramente, tra la poesia iniziale e finale, con decisa capacità lessicale, esse appaiono come l’avvio e l’epilogo di un’ampia poesia che si distende sulle cinquanta pagine del libro e dal cui centro scaturisce la posata ricchezza delle composizioni metriche di Aragno; o, se vogliamo, sono le due facce di una medaglia d’oro, il cui spessore è il peso, e quindi il valore, della medaglia stessa. Ecco la poesia iniziale:
Mi riempie allo stesso modo quel gesto
che ti fa chiara come le fontane
quando trasali nel vano della stanza
al suono della mia voce.
Ma ora non so dietro quale sonno
mi starai ad aspettare, se il grido
che lanciavo ha scampato gli anni
sino alle porte di questo mattino.
So solo che dalle persiane
rompono i primi picchi del giorno
e tu mi sei ancora accanto
tu che non ti svegli, dormi in silenzio
dentro quella notte che non conosco.
e la finale:
Ora che è calma tutta l’aria intorno
e un fremito lontano, come un mare,
mi sveglia fuori dalla mente
l’inizio è camminare questa terra
questo mucchio di radici strappate.
L’unica certezza sarà saperti
rifiorire improvvisa da una zolla
come una rosa, un’impronta di luce
in cui ritrovarci per sempre.
Un’aria di tristezza pervade le stanze di questi innocenti canti in versi di Aragno, imperniati, a mio avviso, sul dolore interiore generato da un evento, forse da un lutto, mi auguro non veritiero ma inteso, in senso lato, come dilatazione di un vago e intimo sentore di abbandono e allontanamento, somigliante a quello della morte. Immaginaria o reale, visto che in un poeta male si riesce a distinguere l’immaginazione dalla realtà, l’esperienza del distacco è avvenuta o avvenibile, sempre in potenza realizzabile, è il dolore iniziale dell’uomo, emergente dall’inconscio, che forse ha origine nel mito della cacciata dal Paradiso, ma che in noi, uomini di ogni tempo, vibra come un presagio di morte, orrore e tristezza. Aragno vede un mondo che, seppur immerso nella desolazione, non importa se provocata da partenza, malattia o morte, trova nella speranza, sempre ultima a morire, una spinta verticale verso la gioia della vita, una nuova possibilità di partenza, un rifiorire improvviso da una zolla, “L’unica certezza sarà saperti / rifiorire improvvisa da una zolla / come una rosa, un’impronta di luce / in cui ritrovarci per sempre.”, la vita, e la sua continuità, è alla fine ciò che conta nelle nostre esistenze, è il nostro anelito; si può fuggire dalla cupezza dei giorni “se un po’ di vento riporta la vita”:
Ancora lentamente usciamo qui
in questo mondo, usciamo dalle pale
di un ventilatore, dal suo sbuffo
quando tutto il sonno dell’ospedale
raccoglie il suo silenzio
nelle sedie verdi della sala d’attesa.
Ma troppo vaghe le mani, le porte
non hanno maniglie e qualcuno fugge
nel colore delle tende, nel rosso
degli oleandri che s’accende
dal fondo dei corridoi, in penombra,
se un po’ di vento riporta la vita.
(Pagina 40)
Infine i sogni sono il faro, la stella polare, l’intima certezza di non essersi smarriti, ecco perché “Qualche volta ritorno per capire / come guardavo il mondo / se fossero mai veri / i sogni detti ai piedi delle scale. // […]” (pagina 19). Ma chissà se sono veri i sogni e i desideri più intimi che nascono e crescono inspiegabilmente in noi, in ognuno uguali ma totalmente diversi. E forse gli antichi luoghi che sono stati i nostri ripari, nei tempi della spensierata epoca fanciullesca, oggi non lo sono più, anche se intorno ciò che era sembra rimasto uguale; dentro il poeta qualcosa è cambiato, una mestizia serale affianca la sua anima nel luogo del suo riparo, dove vive i suoi affetti, ma proprio questi ultimi sono causa della riconfigurazione delle aspirazioni personali, in quanto essi, in qualche modo, destabilizzano, finché lo spirito capisce che i propri sogni devono necessariamente innestarsi in quelli degli altri:
Forse la casa non è più al riparo
in questo tempo, anche se alla finestra
ritrovo i corsi e le strade di sempre:
Giulia ha appena finito di suonare
mi guarda dal divano, nel salone.
In qualche pozza del cortile
già si riposa il rosa della sera.
E gli ultimi passanti s’allontanano.
(Pagina 20)
Ecco qui riportate soltanto alcune suggestioni rilevate nella lettura dei testi di Marco Aragno, che, chiaramente, non sono esaustive dell'architettura e della bellezza della sua scrittura; come sempre la poesia è un fatto personale tra il lettore e il poeta, pertanto vi invito a confrontarvi, cari lettori, con Aragno.
Infine, complimenti per il titolo, molto originale, e all’editore per l’ottima scelta grafica della copertina che riporta la riproduzione della suggestiva opera di Mauro Poretti, dal titolo “Figure nella luce”.
Id: 388 Data: 28/01/2011 12:00:00
*
 Enrico Diciotti - Poesia - LietoColle
Enrico Diciotti - Poesia - LietoColle
Così si mantenevano in vita
La seconda poesia, intitolata “La baracca” (pagina 10, leggibile alla fine di questa mia scrittura), mi ha letteralmente convinto sulla poesia di Diciotti, avrei potuto fermarmi lì, quella poesia valeva già tutto il libro; come ho già avuto modo di dire altrove, una poesia da sola può giustificare un’intera raccolta poetica, se non addirittura l’intera ricerca poetica di un autore. Infatti penso che l’intera scrittura di un poeta non sia soltanto rappresentata da una somma di versi e di poesie, bensì dalla singolarità della sua scrittura, che talvolta può esprimersi anche in una sola poesia, quella che sembra scritta proprio per me lettore, quella che mi rassomiglia, quella che io avrei scritto se avessi saputo-potuto-intuito, ecco, quella è la poesia che giustifica tanta scrittura e ricerca poetica, e non davanti all’umanità dei lettori, ma al singolo lettore. Se anche un lettore/uditore non trovasse in un poeta una sola poesia per sé stesso, quel poeta non avrebbe giustificazione nella sua scrittura, perché la poesia è universale e penso che un poeta debba avere anche una sola parola valida per ognuno dei lettori/uditori. Ma proseguendo nella lettura di questo poeta ho trovato molti altri testi stupendi, animati da una sana cortesia verso la natura, ho trovato uno sguardo attento, quasi fotografico, che sa registrare colori pieni e sfumature, queste ultime espresse e ravvivate nel gioco della parola, mai ostentata, sempre snella, leggera, adatta, che si interseca perfettamente con il senso e le sensazioni che vuole evocare. C’è un’intenzione di fondo nei testi di Diciotti che è esemplare, forse non ci sono novità nella sua scrittura rispetto a quella del Novecento, così come non ci sono novità nella natura, ma nello stesso tempo la natura si presenta sempre nuova, sempre ci stupisce, ci rasserena o ci rende inquieti, mai ci stufiamo di essa, per quanto apparentemente si ripresenti uguale nelle varie stagioni. Così, allo stesso modo, nella poesia di Diciotti non c’è nulla di nuovo, ma allo stesso tempo è tutto nuovo, tutto bello, godibile, inquieta o rasserena. La sua poesia rasenta la naturale insistente presenza delle cose create, proprio perché di esse parla. E’ veramente sorprendente che una scrittura così bella sia uscita solo ora allo scoperto. Ci sono poesie scritte nel 1984 che solo oggi, nel 2010, leggiamo in questa sua prima opera, voglio riportare quella intitolata “Un cipresso” (pagina 25), scritta a 24 anni:
L’alto cipresso nero nella luce
che affoca il campo immoto lento oscilla
il suo vertice aguzzo, come se
un dio nell’antro delle fronde cave
lo sommovesse arcano.
Nell’assenza
della terra sepolta sotto il sole
non visti ci specchiamo: il mio respiro
è il suo corpo flottante, il suo inarcarsi
traccia lo spazio aereo del mio esserci.
Una poesia dal profumo esistenziale, a mio avviso notevole proprio per il suo carattere di semplicità, il poeta descrive in pochi versi la propria simbiosi con il cipresso nel quale si identifica e dal quale è rappresentato. E’ una poesia che si comprende, è universale, semplice e ben scritta, ma come sempre esprimo solo un parere personale, da lettore e amante dei versi.
Oppure a pagina 50 la montaliana poesia “Per che cosa per chi”, va a scavare nel senso del mondo e traccia e segue un percorso su quel dubbio esistenziale che affiora dall’anima che ferve sotto la responsabilità di una chiamata all’esistenza, e di quest’ultima, fatta di azioni, fatti e oggetti, cerca di trovare motivazioni e rendere conto a un Sé interiore e profondamente legato al buon senso del mondo che in un “dietro”, nella trama intessuta sul pensiero del poeta, rivela oscillazioni e tagli e sovrapposizioni e incertezze. E non a caso la raccolta termina con un climax verso un’assenza e una ricerca di segni, attraverso riti e gesti come messaggi, nel caos del conclamato non senso, attraverso i quali “cercavano di mantenersi in vita”, sperando forse in una risposta da quel “cielo bianco dell’inverno”:
in quell’assenza ogni cosa poteva
essere un segno.
e così gettavano nel vento
pugni di polvere rossa,
leggevano i rifiuti, il fango e le crepe dei muri,
pisciavano tracciando sull’asfalto
linee, cerchi e spirali.
Bruciavano bidoni di gasolio
per inviare neri
messaggi al cielo bianco dell’inverno
quanto più muto tanto più invincibile.
Fin dall’inizio del libro le poesie sfilano come fotogrammi sulla natura di colori e forme e sensazioni di colori e forme, per poi, improvvisamente, degenerare, implodendo nel non senso esistenziale: grattando, sotto sotto, ci deve essere qualcosa che dia ragione a tanta bellezza, che è l’esistenza, e al fluire dei giorni.
Complimenti, dunque, a Enrico Diciotti, attendiamo di proporre su LaRecherche.it una sua poesia inedita come poesia della settimana. Intanto dal libro riporto la poesia “La baracca”:
deflagrò all’improvviso l’azzurro divorando
la cornice degli archi. Ombre stinte passarono
confondendosi l’una nell’altra, spinte
da soffi impercettibili. Mi chiamasti, ma quando
voltai la testa non vidi che il brillio
dei tuoi occhi svanire nell’impronta di biacca
che era stata il tuo corpo.
Poi in silenzio crollò
la baracca
Id: 370 Data: 03/12/2010 12:00:00
*
 Dir. resp. Franco Buffoni - Rivista - Marcos y Marcos
Dir. resp. Franco Buffoni - Rivista - Marcos y Marcos
Testo a Fronte
TAF è una rivista di grande interesse, ben strutturata, esigente nei contenuti. Vi si leggono saggi e articoli importanti in relazione al problema della traduzione letteraria. In coda alla rivista v’è il “Quaderno di traduzioni” che ospita testi di autori tradotti da altri autori, alcuni proposti per la prima volta in italiano. Anche dal punto di vista della stampa la rivista è godibile, sia nella consistenza della carta che nel formato e nell’impaginazione, si legge con scorrevolezza, e non è poco. Altro fatto rilevante è che la rivista è una delle poche che esce con puntualità sotto l’incalzante direzione del poeta lombardo Franco Buffoni, professore ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate, ha insegnato nelle università di Bergamo, Cassino, Milano IULM, Parma e Torino.
Ma veniamo all’ultimo numero pubblicato, il n. 42 del primo semestre 2010, di cui riporterò semplicemente alcuni estratti dai vari articoli per dare un’idea dei temi trattati, senza pretesa di esaurire la complessità e la ricchezza degli studi proposti, o la bellezza dei testi tradotti. Il primo articolo è di Werner v. Koppenfels a cura di Laura Lanni, dal titolo “Intertestualità e cambiamento di lingua. La traduzione letteraria”, inizia così: “Mai come oggi la traduzione come genere di testo è oggetto di dibattito. […]”, e continua “[…] Una traduzione letteraria che meriti questo nome, cerca di rimediare alla perdita di significato, inevitabile di fronte alla differenza dei sistemi linguistici e alle distanze culturali di luogotempo, attraverso un lavoro di compensazione che trae forza dall’energia linguistica ed estetica propria del traduttore. La trasposizione creativa dell’originale deve essere preceduta da un’analisi critica dello stesso e da una gerarchizzazione dei suoi elementi stilistici adeguatamente interpretati, operazioni intrise di individualità e di storia, come accade per ogni ricezione testuale. […]”, e ancora “[…] La traduzione letteraria è eo ipso un genere secondario, ‘costruzione vincolata di un testo’, e quindi ontologicamente incompleta […]: la casualità della traduzione risulta impensabile. Quale rapporto la lega però alla modalità della propria fruizione? […]”. Interessante la quinta sezione dell’articolo dal titolo “intertestualità e teoria della traduzione: l’esempio del sonetto 60 di Shakespeare in due versioni tedesche”.
L’articolo successivo è dedicato a Dostoevskij ed è firmato da Pierluigi Cuzzolin, dal titolo “Tradurre l’incipit di ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ. Rivendicazioni sommesse di un linguista”. Per chi non fosse esperto in russo, io non lo sono, si sappia che le parole del titolo in alfabeto cirillico, si riferiscono al noto testo di Dostoevskij “Le memorie del sottosuolo”, “[…] secondo il titolo che si è imposto come quello canonico; […]”, come afferma l’autore, “[…] il titolo non è un elemento accessorio di un libro, di nessun libro, e nel caso di Dostoevskij, non si può dire che egli non abbia già subito qualche danno permanente, se mi si passa l’espressione. […]”. Tutti noi, o meglio, la maggior parte di noi lettori, quando leggiamo libri di autori tradotti in italiano, diamo per scontato che il titolo rispecchi le intenzioni dell’autore, così come espresso nella lingua originale, in realtà non sempre è così, come ci fa notare Cuzzolin, per esempio non lo è per Dostoevskij ma neanche per Tolstoj con “Guerra e pace”; infatti l’autore fa notare, con una interessante spiegazione che invito a leggere, che la traduzione più adatta del titolo sarebbe “Guerra e società”. Ma per tornare al tema portante dell’articolo riguardante l’incipit della suddetta opera di Dostoevskij, egli si esprime così “Ciò che mi preme di fare in queste pagine, invece, è di dare voce alle necessità del testo, e in primo luogo della lingua, e di rivendicarne, seppure sommessamente, le ragioni ineludibili; […]”.
Ma come va a finire per la traduzione italiana dell’opera “ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ” di Dostoevskij? Abilmente, con una serie di convincenti considerazioni, Cuzzolin conclude che sarebbe più adatto tradurre la parola ЗАПИСКИ con “appunti, annotazioni”, anziché “memorie”. L’articolo procede con tutta una serie di convincenti osservazioni, rivendicazioni sommesse di un linguista, fino alla proposta di traduzione dell’incipit di ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ, ecco le prime righe: “Io sono una persona malata… Io sono una cattiva persona. Sgradevole, ecco che persona sono io. […]”.
Altro interessante articolo è quello di Tania Baumann dal titolo “Le traduzioni tedesche delle opere deleddiane: gli ultimi vent’anni (1987-2007)”, articolo basato su una relazione tenuta dall’autrice nell’ambito del Convegno “Chi ha paura di Grazia Deledda? Traduzione – ricezione – comparazione”, presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di Sassari nell’ottobre 2007. Un lavoro che “[…] intende riprendere e sviluppare l’analisi avviata da Hirdt valutando criticamente le nuove traduzioni tedesche apparse dopo il 1986. Il metodo seguite consiste nell’integrazione dell’approccio proposto da questo autore con osservazioni linguistico-traduttologiche. […]”.
Segue l’articolo di Mathilde Vischer dal titolo “Traduzione e di stanziamento nell’opera di Fabio Pusterla”, tradotto da Yari Bernasconi. Nell’introduzione si esprime così: “Questo articolo vuole proporre una riflesisone sull’influenza della traduzione sull’opera poetica di Fabio Pusterla. […]. Studieremo, insomma, le conseguenze che una pratica intensa della traduzione può comportare sulla scrittura creativa del poeta-traduttore. […]”.
Segue ancora una bella traduzione a cura di Saverio Tomaiolo del poema “Façade” scritto dalla poetessa e critica Edith Sitwell (1887-1964). Esso “venne pubblicato quasi intero nel corso del 1918 sulla rivista letteraria ‘Wheels’. In seguito i poemi vennero orchestrati dal compositore Sir William Turner Walton (1902-1983) NEL 1922-23. Sia la poetessa Sitwell che William Walton sono generalmente associati alla corrente artistica del Modernismo. […]”. Ecco l’incipit dal titolo “Danza marinaresca (Venite marinai)”: “Venite marinai / Al suon dei tamburi / Da Babilonia; / Cavalli a dondolo / Schiumano, silenziosi / Rinoceronti celesti languono / […]”.
Segue, di Danilo Vicca, l’articolo “Sulle traduzioni italiane di ‘Du mouvement et de l’immobilité de Douve’ di Yves Bonnefoy: problemi e proposte”. Inizia così: “Tradurre Bonnefoy è un’operazione estremamente complessa nella misura in cui complessa è la poetica che l’autore ha maturato nel corso della sua carriera artistica, di critico d’arte e filosofo. Il suo traduttore si confronta con un’opera assai vasta con inevitabili implicazioni tanto positive, […], quanto negative, […]”.
L’articolo di Marco Sonzogni è in memoria di John Updike (1932-2009), traduttore di Montale in lingua inglese, il titolo è: “Dall’ombra lunga di Arsenio: Updike traduttore di Montale”:
Eugenio Montale
ECLOGA
Perdersi nel bigio ondoso
Dei miei ulivi era buono
Nel tempo andato – loquaci
Di riattanti uccelli
e di cantanti rivi.
[…]
John Updike
ECLOGUE
Losing myself in the shuffling grey
Of my olive trees was pleasant
In times gone by – the eloquence
Of birds quarrelling
And of rivulets singing!
[…]
Leggiamo, a pagina 166, da “Mandeln Atmen – Respiro di mandorla. Dialogo con Paul Celan”, alcuni versi di Elisa Bigini, accompagnati da questa nota: “Esperimento di dialogo attivo con un poeta amato: testi costruiti intorno a singoli versi del poeta tedesco, allontanati dal contesto originario e usati come micce per scatenare una nuova deflagrazione poetica”. Alcuni versi: “è la pausa dell’orologio / scarico, il HERZZAHNEN / a cui il bavero / resta impigliato, // tu, bottone infilzato.” (HERZZAHNEN, Cuore dentato).
Ed ecco il bel articolo di Franco Buffoni dal titolo “Ricordo di Edoardo Sanguineti traduttore”, in cui afferma: “Assumiamo dunque il Catullo di Sanguineti come esempio paradigmatico della possibilità di riconoscere dignità artistica al testo tradotto; ne consegue la estrema valorizzazione del momento della creazione del testo tradotto, ovvero della risonanza culturale che una traduzione in quanto testo autonomo – sortisce sul lettore. La ‘traduzione’ di Sanguineti da questo punto di vista è appunto esemplare: viene letta e ricordata, e a sua volta citata autonomamente. […] Nella prospettiva Catullo-Sanguineti, la traduzione di poesia può essere quindi definita anceschiamente come il rapporto paritario tra due poetiche. Un rapporto che toglie ogni rigidità all’atto traduttivo, facendo accantonare ogni idea di copia, di rispecchiamento, e quindi qualificandolo in tutta la sua dignità di rapporto poetico fra due processi, fra due momenti costruttivi, non fra due risultati definitivi e fermi. […]”. A seguire si legge, di Edoardo Sanguineti, per gentile concessione dell’editore Motta, “Per la storia di un’imitazione”; e, di Manuela Manfredini, “Sonetti di Shakespeare alla Sanguineti”.
A pagina 193 si leggono, nella traduzione di Franco Buffoni, una scelta di quattro sonetti di Shakespeare “Per i quattrocento anni dei Sonetti di Shakespeare”. Riporto parte del Sonetto 33:
William Shakespeare
SONNET 33
Full many a glorious morning, have I seen,
Flatter the mountain-tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green;
Gilding pale streams with heavenly alchemy:
[…].
Franco Buffoni
MOLTE VOLTE L’HO VISTO AL MATTINO
Molte volte l’ho visto al mattino
corteggiare le cime dei monti,
Baciare i prati, dare vita all’acqua
Con l’alchimia dell’oro nello sguardo
[…].
Infine, a chiudere la rivista, il “Quaderno di traduzioni – Poesia”, le “Recensioni” e le “Segnalazioni”, quest’ultima sezione è a cura di Edoardo Zuccato.
Segnalo gli autori e i traduttori del Quaderno di traduzioni: J. L. Borges / C. Recalcati; H. Hélder / R. Baggiani; J. Milton / F. Giacomantonio; J. Keats / F. Dalessandro; J. Joyce / M. Sonzogni; D. Walcott / M. Posio; C. Abani / C. Monti; G. Benn / G. Bevilacqua.
I segnalati: Derek Walcott / Franco Buffoni; Elisa Donzelli / Franco Buffoni; Douglas Hofstadter / Pietro Per conti e Paola Turina.
Ecco concluso l’excursus su questa notevole rivista di teoria e pratica della traduzione.
E’ possibile acquistarla online, su ibs.it ad esempio, o abbonarsi. L’abbonamento annuo costa, per l’Italia, 38,00 euro, per l’estero 45,00 euro. Versamento sul ccp 27180207 intestato a Marcos y Marcos, via Ozanam 8, 20129 Milano. Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ogni anno. L’abbonamento nel corso dell’anno dà diritto a ricevere il numero arretrato.
Buona lettura.
Id: 365 Data: 19/11/2010 12:00:00
*
 Francesco De Girolamo - Poesia - LietoColle
Francesco De Girolamo - Poesia - LietoColle
Paradigma
Una poesia che talvolta pare sfiorare il nichilismo dell’io, quando afferma “Con tutte le mie forze / ho pregato Dio di non esistere, / […]” (“Ultima grazia”, pagina 12), ma che in realtà è poesia che anela alle altezze della perfezione che vede in lontananza, ed è proprio questa visione fa sì che il poeta si renda conto di vivere in un abisso di non senso, “[…] / Tutto ciò che risplende è nulla / […]” (“Rosso d’Oriente”, pagina 14).
“Paradigma” è un’opera intensa, significativa, che, a mio avviso, s’innesta molto bene nel filone della poesia mistica, mi sovviene alla mente un San Giovanni della Croce o una Teresa d’Avila, quando vivono e parlano della notte oscura dell’anima: “[…] / Con tutte le mie forze l’ho implorato / di cancellare il suo nome dalla mia anima, / la mia anima dal suo paradiso, le mie lacrime dalla sua croce. / […]” (“Ultima grazia”). Un tormento intimo, uno sbilanciamento esistenziale che si ricompone nella pace interiore di uno sguardo limpido da occhi vergini: “Ad occhi vergini riappare il sole / ogni mattino come un sogno arcano; / e il tempo non offusca lo stupore / acceso da quel grande occhio lontano” (“Ad occhi vergini”, pagina 46).
Concludendo, la poesia di De Girolamo mi è parsa interessante anche perché, a tratti, recupera liricità, denotata da un importante uso degli aggettivi e, qua e là, dall’inversione tra nome e aggettivo. Ma è decisamente scrittura moderna che, specialmente negli ultimi componimenti, si snoda snella e fluente, reggendosi su un moderato uso della punteggiatura.
Completa l’elegante volumetto una acuta lettura di Giorgio Linguaglossa che sa accostarsi al discorso poetico dell’autore con piglio da Critico autorevole.
Id: 353 Data: 22/10/2010 12:00:00
*
 Laureano Albán - Poesia - Via del Vento Edizioni
Laureano Albán - Poesia - Via del Vento Edizioni
Gli infimi crepuscoli e altre poesie
“Gli infimi crepuscoli” è il titolo di una interessante, quanto gradevole, plaquette di poesie di Laureano Albán, poeta del Costa Rica, pubblicata nella collana “Acquamarina” delle edizioni Via del Vento di Pistoia, collana curata da Fabrizio Zollo. La plaquette è stampata in duemila esemplari e ciascuna copia è ad personam, cioè numerata.
Riporto, dal sito dell’editore, visitabile dal collegamento sopra riportato, la presentazione della collana “Acquamarina” che ospita la raccolta di testi in oggetto: “La collana di poesia «Acquamarina» è nata nel 1997 e riguarda liriche, quasi sempre inedite in Italia, di grandi poeti stranieri. Sulla copertina, sempre di colore ‘acquamarina’, e di sapore ‘Ottocento inglese’, non figura un’opera grafica, ma solo la strega che cavalca una scopa, tratta dal marchio delle Edizioni. Per una ponderata, e sofferta, scelta editoriale, i volumetti non riportano il testo a fronte in lingua estera (che in fondo avrebbe più senso solo nel caso di lingue largamente conosciute), al fine di privilegiare l’offerta del maggior numero di liriche di quel determinato autore e suscitare quindi in Italia l'interesse per la sua opera, che potrà poi indirizzarsi verso più compendiosi volumi con testo a fronte forse presenti sul mercato nazionale.” Vi troviamo pubblicati autori quali: Marina Cvetaeva, René Daumal, Cecília Meireles, Fernando Pessoa, Georg Trakl, Nika Turbina, Gertrud Kolmar, Hermann Hesse, Eunice Odio, Simone Weil, Arsenij Tarkovskij, Antonin Artaud, Rainer Maria Rilke, Federico Garcia Lorca, Anne Sexton e molti altri.
Per quanto riguarda “Gli infimi crepuscoli”, mi si conceda il fatto che è la prima volta che leggo testi di Laureano Albán, ignoranza dichiarata ma piacevolmente superata nella scoperta di un poeta appassionato e, di conseguenza, appassionante, i cui versi visionari e trascendenti hanno tutta la forza, come giustamente afferma Pieragnolo nella sua nota al testo, di versi romantici, ma spogliati dal “pedante classicismo”. La nota, riportata a fine plaquette, ben tratteggia, con poche ma decise pennellate, la configurazione dell’opera poetica di Albán, contestualizzandola nella vita dello scrittore. La breve biografia inoltre permette di conoscere almeno i fatti principali della vita dell’autore. Tra l’altro vi si legge che Albán arrivò in Europa, più precisamente in Spagna, nel 1978, incontrando per la prima volta la stagione autunnale. A tal proposito riporto parte di “Vestigia oltre l’autunno”, scritta a Madrid nel novembre del 1978: “[…] / Chiudi gli occhi ed entra come un bimbo / ai lenti tizzoni dell’autunno, / più in là di ciò che è puro e distrutto, / salvato dopo l’ultimo silenzio.” Ed ecco come il curatore puntualizza tale incontro del poeta con l’autunno: “[…] incontrò con stupore la stagione autunnale, sconosciuta al tropico, nell’aria austera e luminosa di Castilla (Herencia de otoño), assunta dal poeta come simbolo ispiratore per tutto ciò che era stato perso nella scoperta dell’America, segno trascendente che da quel momento diede forma a tutta la sua opera. […]”.
Una scrittura totalmente apprezzabile per la forza e la trasparenza della poesia di Albán, la quale “non ha altra motivazione che se stessa”, come Pieragnolo giustamente afferma, essendo ciò che emerge dalla libertà delle immagini che l’attraversa. Il curatore è riuscito in una ristretta rosa di poemi proposti (in tutto sono 35 pagine, unitamente alle note e alla biografia), a far passare la grandezza di questo poeta latinoamericano. Le traduzioni sono molto ben curate, i testi sembrano scritti direttamente in italiano, fatto sicuramente dovuto alla concomitanza tra l’ottimo lavoro del traduttore e la vicinanza della lingua spagnola a quella italiana.
Concludo invitando i lettori alla lettura di questo libriccino, che costa soltanto quattro euro, proponendo il pezzo finale della stupenda poesia intitolata “Scienza dell’aria”:
“[…] / Per morire si fecero, / gesto a gesto, invisibili. / Senza fretta, senza motivo, né tramonto. / Come chi si restituisce / all’aria come aria. / Affinché alla fine solo / i loro occhi persistessero / vicino alla memoria, / ogni volta più fugaci / come specchi senza luna, / fino a fondersi, alti, / nella scienza dell’aria”. Buona lettura.
Id: 349 Data: 12/10/2010 12:00:00
*
 Stelvio Di Spigno - Poesia - peQuod
Stelvio Di Spigno - Poesia - peQuod
La nudità
Altro elemento importante del libro è, quindi, l’abbinamento realtà-immaginazione, un’immaginazione che s’innesta perfettamente nella realtà in soluzione di continuità, diventando essa stessa quasi reale (così appare al lettore) quando assorbe energia dalla memoria o dagli oggetti reali davanti allo sguardo del poeta. Di Spigno sembra riuscire a mostrare empiricamente, nella sua poesia, come ricordo e immaginazione altro non siano che un prolungamento della realtà e viceversa, che il poeta è membrana di osmosi tra questi due fluidi a densità diversa di vissuto. Viviamo più spesso nella realtà o nell’immaginazione e nel ricordo? A questa domanda non so dare risposta, sta di fatto che il poeta Di Spigno, in particolare, ci rende fluidi l’andata e il ritorno tra questi due stati esistenziali della mente. (“Come un mare non ancora potato né descritto / strappa via da sé ogni alga e corallo / e resta nudo come fosse stato dragato /mentre arriva pianissimo la pagina // ma dopo è difficile parlarne / di questa creatura che dorme al sole / senza pensare a persone che hanno strappato da sé la propria vita // con un ferro rovente o una tenaglia / da criminale, senza un vero motivo, / solo per farsi più male o perché l’hanno sentita / questa voglia di annullarsi per essere obbedienti // pensiamo a negozi con la serranda a mezz’asta / a barche capovolte sotto il pelo dell’acqua / a uomini colpevoli come me, insomma, / che ancora di questa colpa chiedono ragione”. Pagina 57). Altro aspetto interessante della raccolta in oggetto è il fatto che l’autore è capace di importanti analisi, e quindi anche di auto-analisi, nello spazio di una sola poesia, o addirittura di un solo verso. Ma, nonostante questo, Di Spigno non cade mai nella eccessiva introspezione, rischiando il solipsismo, ma doma il verso tenendolo sempre ad un livello di evidenza oggettiva davanti allo spirito umano, il quale è in continuo confronto con gli atti che scaturiscono dall’azione congiunta di mente, corpo e coscienza, fatto che può ingenerare un cosciente senso di colpa nascosto nell’ombra dell’inconscio.
Ma è la descrizione interiore ed esteriore dell’uomo moderno, quella che scaturisce da queste pagine, rendendo così “La nudità” un testo antropologico. Infatti, come il titolo stesso ricorda, l’uomo dovrà porsi, prima o poi, nudo davanti a sé stesso e al resto dell’umanità, ed accogliere una diversa percezione di sé nella nudità dell’altro, prendendo consapevolezza che, in fondo, al termine di ogni atto, reale o immaginato, “siamo niente”: “[…] / Ma è in te che li porto questi fiori / come è vero che non c’è altro motivo / che farti entrare in questo libro facile e vicino / che ti cerca e ti trascina nel tuo mondo / non per restarti in cuore, come in fondo vorrebbe, / ma per dirti chi eri e cosa hai perso / per diventare qualcuno o qualcosa, / mentre siamo niente, fratello, siamo niente”. Pagina 72. Parole che risuonano quasi come un monito “Ai poeti del secolo 21” – che è il titolo della poesia.
Di Spigno è un uomo che ha “Fiducia”, una fiducia che ha radici nel passato, da dove attinge ad un’acqua sorgiva; è contagiosa, ed è oro, in un mondo moderno a volte strambo, deformato da assurde arie di competizione tra uomini “simili a noi”, e che ci mette a disagio. L’autore ci porta a recuperare forze nel mondo fantastico della fanciullezza, dove è ancora possibile essere vergini e non doversi sentire a nessuna altezza: “A volte alle spinte del vento guardo ritagliarsi / il registro di tutta la mia vita: noioso, senza senso, / […] / non è facile sentirsi all’altezza / di uomini simili a noi, non ne sono sicuro, / forse è per questo che solo di me / riesco a parlare: […] / Le foto da bambino ormai mi appartengono / ma gli amici e tutte le altre compagnie / sono troppo grandi per ora, le tengo fuori.” Pagina 60.
Molto ci sarebbe da dire de “La nudità”, soltanto a partire dal titolo. E’ una raccolta di versi che, evidentemente, nasce da un cuore umano ricco di composite esperienze sensoriali esteriori e interiori che trovano la loro bella forma espositiva nell’arte poetica. Un libro che ho voluto rileggere molte volte perché la Musa che l’ha ispirato sembra non averlo fatto a una sola voce, bensì a molte voci e su toni differenti: vi sono vibrazioni armoniche fondamentali sovrapposte a dare origine all’unico suono che è la bellezza della poesia che emerge da queste pagine. Assolutamente da leggere per contenuto e forma di scrittura.
[ Leggi, di Stelvio Di Spigno, la poesia proposta come "Poesia della settimana": Leggi » :: Visita anche la sua pagina personale su LaRecherche.it: Visualizza » ]
Id: 348 Data: 08/10/2010 12:00:00
*
 Direttore responsabile Velio Carratoni - Rivista - Fermenti Editrice
Direttore responsabile Velio Carratoni - Rivista - Fermenti Editrice
Fermenti
Nel comitato di redazione della rivista, oltre allo stesso Carratoni, troviamo Gualberto Alvino, Antonella Calzolai, Gualtiero De Santi, Donato Di Stasi, Gemma Forti, tutti nomi importanti e attivi nel panorama culturale romano e non solo. La rivista è al suo XXXIX anno, qui presentiamo il numero 235 appena stampato, di cui riportiamo più sotto il sommario. Questo numero ha 475 pagine, è quindi una rivista corposa, ma tutta godibile, soprattutto per l’ampia rosa di autori che vi contribuisce, con lavori che vanno dalla saggistica alla poesia, passando dalla musica e dal teatro, poi interviste, rievocazioni, costume, ecc. Insomma, il periodico, nel suo lungo cammino temporale, ha raccolto, e continua a raccogliere, numerosi contributi coprendo un ampio spettro di interessi sullo scibile umano, non solo letterario. Ricordo tempo fa di aver pubblicato, su richiesta dello stesso Carratoni, un saggio sull’Ambiente da un punto di vista scientifico-ecologico. Dico questo per dimostrare, avendolo sperimentato, che la rivista ha, negli intenti e nella pratica, una reale apertura informativa “d’attualità e costume”. Ed è orientata verso una teoria della conoscenza, ma anche verso una pratica della conoscenza, ponendo in evidenza aspetti umani e complesse relazioni intrapersonali e interpersonali della ricerca letteraria, in un continuo esame di senso e sollecitudine verso le smanie dell’uomo, anche nella sua contraddittoria affermazione del pensiero. L’uomo, e la sua indagine critica del mondo fisico, sociale, letterario, ecc., è qui il soggetto portante in un modo tipicamente, mi si lasci dire, “fermentiano” di esprimere il pensiero. In tale linea segnalo la sezione coraggiosa BLOC NOTES di Gualberto Alvino che inizia con una lettera aperta a Citati: “Caro Citati, non si torca così, la prego, alla sua età potrebb’esserle letale. Che male c’è a stendere la mano in un momento difficile? […] E’ evidente che Contini le fece un torto […] Il puzzo del suo rancore si sente lontano un miglio. […] Dica la verità, la dica, una volta per tutte: gli fece leggere il suo Goethe e lui arricciò il naso e le consigliò senza mezzi termini, com’era nel ssuo stile, di cambiar mestiere? […]”. Poi, sotto la penna di fuoco di Alvino, tocca passare a Franco Cordelli, il quale “riesuma per i tipi dell’editore romano Giulio Perrone L’Italia di mattina – con l’aggiunta del sottotitolo Il romanzo del Giro d’Italia benché non vi si narri nulla di nulla - , infliggendo al pubblico dei lettori l’ennesimo castigo. […]”. E Alvino ci dà dentro: “ […] Ottima idea, non c’è che dire. Sennonché il libro è quanto di più stucchevole, scombinato e indigesto sia stato prodotto nell’ultimo mezzo secolo dall’editoria non solo italiana. Periodi fluviali, caotici, spesso resi indecifrabili da deficiente controllo sintattico e da eccessi lirici tanto involuti che fuor di luogo […]”. Ora, al di là del giudizio personale di Alvino sul libro suddetto, e della sua lettura critica di avvenimenti e rapporti interpersonali, quali il su citato tra Citati e Contini, e altri interessanti Pamphlet che invito a leggere sulla rivista, bisogna dire che ciò che è interessante è il coraggio della rivista di proporre una zona “senza peli sulla lingua” in cui il lettore, abituato ad associare certi nomi ad “incensamenti”, trova qui, invece, una penna che ha il coraggio di mostrarne il lato della debolezza (coraggio di chi scrive e coraggio del direttore, che leggo come una volontà di affermare una indipendenza da “baronie” e giochi di potere letterario, diciamo così).
Proseguendo l’excursus all’interno della rivista troviamo, nella parte di saggistica, vari interessanti interventi, per esempio segnalo quello di Giovanni Fontana, dal titolo “Gian Paolo Roffi, Poesie sonore 1986-2004”; quello di Stefano Lanuzza, “Scritture & avventure”; quello di Irma Manganelli, “Non scrivo per divertire”; quello di Carmelo Vera Saura, “Le ballate della violenza di Pasolini ovvero la condanna del mondo moderno” e altri.
Nella sezione Poesia leggiamo autori importanti, come Mario Lunetta (“ […] / Questi cartoni animati che si fingono uomini / approfittando del pallore lucìvago / […]”), Domenico Cara (“In gara con i trapassi, l’estinguersi sospeso / delle sere cede al mio sonno, a labili o ciechi / intervalli; trovo malati i movimenti gonfi, / le pieghe e l’intelligenza dell’immaginarsi”), Raffaele Piazza (“Dalle televisioni sgorgano / fiumi di sangue e parole. / Il caldo invade in quella / felicità di vacanzieri in coda / dall’asfalto, allo schermo / a internet i corpi fino alle / conche di tramonti, alle sere / negli alberghi serra dove ci / trattano come persone e / […]”), Domenico Cipriano, il quale scrive testi poetici di forza narrativa per i versi ampi che propone (“Cerco la parola non meditata la sola reale dell’istinto / viva nello spirito del momento figlia di una luce legittima / e di stelle notturne – non il buio coperto dalle imposte / […]”). E ancora altri che non conoscevo, come Ariodante Mariani. Ho trovato nelle sue poesie un certo tono scherzoso, una cifra di disincanto, alcuni testi rasentano l’aforisma, la massima: “Ma dovrei proprio caricare / come una trappola i miei versi? / […] / Ho deciso: li ammucchio tutti qua / in questo bel centone / e chi vorrà verrà / a cercarseli qua. ” Tali versi risuonano come una proposta di cambio di paradigma, non il poeta a proporre ma il lettore alla ricerca del poeta, della poesia, di casa in casa. Infine segnalo Matteo Fantuzzi con il suo intenso testo intitolato “Terra”: “Sento questa sera i cani / unghiare nella terra cruda / […] / Quando attendi una notizia / il tempo è come un mostro / che piano piano dalla sedia ti sovrasta. […]”. Non posso dire di tutti per ragioni di spazio, ma invito a leggere sulla rivista per la rilevanza poetica che mostrano.
Nella sezione Teatro segnalo Marco Paladini, con “Musica Rock. Bitter Drinks. Sì, io vado a casa”. Dalla nota dell’autore riporto: “Tutto in una notte per un giro di esistenze, un cambio di vite come spifferato e dialogato all’incrocio tra un pezzo di hard rock e una ballad romantica. / Patty, una giovane, aggressiva, un po’ cinica e un po’ sfigata cocker dal torbido passato e l’incerto presente incontra in un club Loredana, una cameriera quasi coeva, appesa ad un sogno d’amore tanto fatale quanto inattuale. […]”.
Continuando sulla sezione Interviste, leggo con interesse l’incontro con Ugo Gregoretti, a cura di Alessandro Ticozzi, dal titolo “La televisione di oggi, la mia televisione di ieri”: “ […] Quando è finito il monopolio della RAI ed è nata la competizione con Mediaset, noi speravamo che la concorrenza avrebbe migliorato la qualità del prodotto televisivo sia pubblico che privato: invece è successo esattamente l’opposto, scatenandosi una concorrenza verso il basso. […]” (Ugo Gregoretti).
Ampio spazio è dato anche alle arti visive con una sezione intitolata Tavole verbovisive con cinque tavole di Giovanni Fontana: “Il principe”, gioco verbo-visivo in tre tavole; “OUI”; “NON”. Suggestioni in lingua francese, parole in diverso formato che si sovrappongono, ruotano e s’allungano su pentagrammi simili a onde.
Le arti visive si ripropongono lungo tutta la rivista in varie stampe, dipinti, tecniche miste, altro: ecco i colori screziati di Franco Verdi; le forme geometriche disuniformi con sfumature giallo-verde-rosa di Cosimo Budetta (“Arlecchino” e “Cielo di San Lorenzo”); le sospensioni di forme chiare che ricordano creature luminose in movimento su fondali oceanici oscuri, di Tomaso Binga (“Amori estivi” e bozzetto da “Scritture marine”). Nella sezione Arte trovo vari interessanti articoli ma segnalo qui soltanto, per sole ragioni di brevità, “Tilt” di Claudia Manuela Turco nel quale sono riportati interessanti stampe di acquerelli su tela di Michele Arpino: “Ad andare in Tilt nel libro di Michele Arpino (Prospettiva editrice, 2008), è la parola, mentre la realtà rimane fedele a se stessa […]. L’Autore vive da anni in Svizzera, dove è apprezzato anche come artista (disegnatore e fumettista) […]”.
Naturalmente non manca la sezione Narrativa con testi di Piero Sanavio, Mario Lunetta, Maura Chiulli, Velio Carratoni, Ignazio Delogu, Antonella Calzolai, Assia Papp, Maria Lenti, Bruno Conte. Interessanti le proposte greca e russa della sezione Traduzioni, rispettivamente a cura di Crescenzio Sangiglio e Paolo Galvagni.
La rivista si conclude con una sezione dedicata a Marino Piazzolla, del quale si celebra il centenario della nascita (1910-2010), con testimonianze e poesie…
Qui mi fermo, invitando a leggere la rivista, che si rivela essere una vera sinfonia di voci.
*
Cliccando sul collegamento qui di seguito è possibile visualizzare il Sommario del numero 235 »
*
E’ inoltre possibile proporre alla rivista testi e immagini. Per contatti e abbonamenti:
Casella postale 5017 – 00153 Roma Ostiense – e-mail: ferm99@iol.it sito: www.fermenti-editrice.it
*
L’abbonamento ordinario costa 50,00 euro dall’Italia, 60,00 euro dall’Estero. Simpatizzante euro 150,00. Sostenitore euro 250,00.
Conto corrente postale n. 25251000, intestato a: FERMENTI, Roma.
Id: 327 Data: 23/07/2010 12:00:00
*
 Direzione Gio Ferri - Gilberto Finzi - Rivista - Anterem Edizioni
Direzione Gio Ferri - Gilberto Finzi - Rivista - Anterem Edizioni
Testuale
Una rivista che fin dalle prime battute di lettura fa nascere la voglia di studiare, approfondire, sviluppare le tematiche, rispondere alle sollecitazioni,… insomma una rivista in cui riconosco un felice dinamismo intellettuale e culturale. Riporto parte della quarta di copertina, perché esplicativa degli intenti di “Testuale”: “[…] nel panorama delle riviste di ricerca letteraria, dell’area italiana, in rapporto non occasionale con altre letterature (in particolare francese e anglosassone) vuole dedicare il proprio intervento essenzialmente alla ‘critica della poesia contemporanea’, con un approccio critico-analitico e interdisciplinare”.
È un periodico di saggistica fondato nel 1983 da Gio Ferri, Gilberto Finzi, Giuliano Gramigna e attualmente sotto la direzione di Gio Ferri e Gilberto Finzi (Direttore responsabile Giorgio Ferrari), si avvale di numerosi collaboratori sul territorio nazionale e all’estero. La rivista è edita dalle Edizioni Anterem di Verona.
Nel sommario del numero 46 si leggono nomi e titoli che – di alcuni già conoscendone la nota acutezza di pensiero – destano subito interesse verso la rivista che li ospita, attirando attenzione e foga di lettura: Maurizio Spatola (fratello di Adriano Spatola), Giovanni Infelise, Tiziano Salari, Franco Romanò, Donato Di Stasi, Gio Ferri.
Il primo, Maurizio Spatola, con un saggio dal titolo “Etica, rigore, anarchismes nella poetica di Adriano Spatola”, ricostruisce il percorso teorico e critico del poeta Adriano Spatola, non avvalendosi di una “ortodossa metodologia analitica o filologica”, con l’intento “bensì di riannodare i fili di un discorso coerente ma frammentato, sia attraverso gli scritti (in qualche caso poco o per nulla conosciuti) sia tramite la connessione con la produzione poetica e le varie fasi dell’esistenza” del fratello.
Il secondo, Giovanni Infelise, con un saggio intitolato “Arthur Rimbaud nella traduzione di Adriano Marchetti”, approssima il lettore “al banchetto che la lettura delle due opere di Rimbaud – Illuminations e Une saison en enfer – tradotte da Adriano Marchetti ci offre”. Mi piace l’incipit dell’articolo: “In questo immenso campo di grano che è l’opera di Rimbaud, si può scegliere di essere umili ospiti di un frugale convito o lurchi parassiti delle sue messi”.
Il terzo, Tiziano Salari, con il bel saggio, “Poesia e critica”, affronta, nella prima parte, la poesia di Flavio Ermini, analizzando la sua opera intitolata “L’originalità contesa tra l’arco e la vita”, mentre nella seconda parte leggiamo “La scrittura critica di Giuliano Gramigna”. Per quanto riguarda Ermini, Salari traccia, in quattordici punti, le essenziali metodiche e proposte del suggestivo lavoro del poeta, “in limine” narratore di spessore filosofico. Come scrive Salari “gli accadimenti che appaiono sono continuamente diversi e gli stessi”. Per quanto riguarda la scrittura critica di Giuliano Gramigna, Salari espone, in quindici punti, i tratti dell’importante volume monografico di “Testuale” – accorpante i numeri 43, 44 e 45 – che raccoglie interessanti saggi di Giuliano Gramigna.
Ho letto alcuni saggi di Gramigna e ho trovato spunti notevoli per affrontare una lettura critica di un testo, segnalo in particolare “L’antro del romanzo”, nel quale, tra le altre cose, si legge: “ […] Anche il romanzo è un cosmo che ha il suo ventre nero – ha origine nella diversità, ‘armonia e tensione di contrari’ e la molteplicità degli interessi possibili (non dico la dualità delle porte omeriche) lo segnala”. E in “Le istituzioni del romanzo”, Gramigna enuncia quelle che “a mio avviso, sono gli elementi primari, le grandi forme semplici genetiche del romanzo. Secondo le buone regole del rasoio di Occam, possono ridursi a quattro: il nome, il luogo, il patto e l’avventura. […]”. Partendo per un excursus intelligente, analizza tratti di romanzi, tra cui la Recherche e il Don Chisciotte, mostrandoli in una chiave di lettura che li distende e li mostra un poco più docili nella loro architettura, utilizzando le quattro chiavi di lettura suddette.
Il quarto saggio è di Franco Romanò, dal titolo “Il mito, il nuovo mondo, il ponte: riflessioni rapsodiche sulla trilogia poetica di Alessandro Carrera”: “Il fascino della trilogia poetica di Alessandro Carrera, ‘La sposa perfetta’, (Book 1997), ‘L’amore del secolo’, (Book 2000), ‘Stella del mattino e della sera’, (Il Filo 2006) sta nel dialogo sotterraneo fra due diverse civiltà letterarie: l’antica Grecia […] da un lato, la terra d’adozione di Carrera e cioè gli Stati Uniti d’America, dall’altro.”
Il quinto pezzo è di Gio Ferri, il quale, con “Il gioco della traduzione”, affronta la questione, appunto, della traduzione: “Non si finisce mai […] di discutere in convegni, tavole rotonde, interventi critici di traduzione da una autentica lingua d’origine ad una inesorabilmente traditrice lingua di arrivo. E si continua a tradurre. Ma la questione è sostanzialmente inerente alla traduzione della poesia. La narrazione per lo più, la saggistica (non tutta), il teatro di prosa (non tutto) godono di una facilitazione di fondo: la predominanza dei contenuti, dei significati ed anche dei referenti (per quanto ambigui) rispetto ai significanti. ” Questione spinosa se non si vuole una “traduzione di servizio” al solo fine di “trasmettere il significato (e non altro) ”.
Il sesto è un saggio di Donato Di Stasi, la cui vasta cultura e intelligenza critica ho già avuto modo di apprezzare in svariate prefazioni a opere poetiche, tra cui la mia raccolta poetica “L’indicibile”, Fermenti Editrice 2006. Qui stende una bella nota critica dal titolo “Mille piani di scrittura. La piuma e l’artiglio (Poesie 1978-2005) di Adam Vaccaro. Ed. Spettacolo, Milano 2006”, ecco l’incipit: “Non i malefici della critica, i culturalismi consuetudinari, gli arabeschi insidiosi (estasi e algìe dell’ermeneuta) sono l’oggetto di queste note, ma il succo vitale che si può estrarre da questa scrittura antidiplomatica, filigrana del vissuto collettivo, pressa e lacrimatoio di esistenze aspre, non inclini al feuilleton mediatico. […] Mi piace pensare al carattere abitativo di questi testi: stanze scomode, spoglie, dipinte con colori primari, ma adatte a incontrare e a svelare le censure, i paradigmi, gli assiomi di questa nostra epoca così falsamente falsa. ”
Infine segnalo le sezioni finali “Letterale” e “Botta e risposta”. Nella prima troviamo lettere scritte da Gio Ferri a vari destinatari. Ad esempio: “Scritta in occasione della 53° Biennale d’Arte di Venezia al Presidente Paolo Baratta e al Direttore Daniel Birnbaum”; “Scritta ad Antonietta Dell’Arte in occasione dell’uscita della sua raccolta di poesie ‘Il tema del padre’, ed. Passigli, 2009”; “Scritta ad Alessandro Carandente, rileggendo Risveglianze, Marcus Edizioni, Napoli 2007”; ecc. Nella seconda troviamo invece un botta e risposta, appunto, tra Gio Ferri e Tiziano Salari: “Caro Tiziano, questa mia breve e ‘leggerissima’ lettera aperta (una chicchierata amichevole, piuttosto che un saggio, seppure minimo) vuole rifarsi alla lettura dei due fascinosi interventi che hai generosamente inviato, anche da noi sollecitato, alla nostra rivista: quello su Flavio Ermini (pag. 38) e quello dedicato ai saggi (quasi, ma non tutti, inediti) di Giuliano Gramigna (pag. 45) pubblicati nel numero triplo 43/45 di “Testuale”. Ti ringrazio di queste tue indagini che saranno di grande stimolo per i nostri lettori. […]”.
In risposta: “Caro Ferri, ho ricevuto la tua lettera che sarà pubblicata sul numero 46 di “Testuale”, fascicolo che contiene anche due miei interventi, dedicati rispettivamente a Flavio Ermini e Giuliano Gramigna. Certo si ripropone un vecchio dissidio sul modo di concepire la poesia, ma permettimi di segnalarti, in primo luogo, alcune incomprensioni di carattere terminologico. Mi scuso anche per la semplificazione a cui sottoporrò il tuo discorso. In primo luogo non era affatto mia intenzione ridurre l’importanza critica di Giuliano Gramigna, anche se eviterei il rischio di inutili feticismi (“superiore ‘sinfonica’ qualità, anche rispetto ad altri importanti studiosi del ‘900”), soprattutto collocando la sua figura a livello europeo, e analizzandola nel suo tempo e in questo ambito. […]”
Non posso infine non ingrandire, con una sorta di lente d’attenzione, tra i vari citati interventi, un articolo che mi ha particolarmente colpito, cogliendomi di sorpresa e convincendomi in quanto all’impronta e alla direzione critica e di ricerca della rivista. E' un breve articolo, al primo impatto fastidioso perché contro il pensiero mediatico che va per la maggiore, ma ha saputo prendere e amplificare un piccolo pensiero che albergava in me da tempo in un silenzio di riflessione. L’articolo si trova nella sezione finale “TESTUALE fuori testo” e dal titolo “Scandaloso merinismo”, che porta la firma di Gio Ferri. Egli afferma, con non poco coraggio: “Alla nostra redazione arrivano ogni anno centinaia, migliaia di versi editi, inediti. Ed osserviamo sempre, anche con una certa umana comprensione: quanti scrivono ‘poesie’ (cosiddette) e quanti, troppi, non leggono poesia! Nemmeno quelli che ne vogliono scrivere […]. Va aggiunto che non è necessario andare ‘a capo’ per affermare d’aver scritto una poesia. Certi pensierini possono essere, come pensierini, apprezzati anche, anzi, se trascritti tutti di seguito. […]”. E porta un esempio di ‘andate a capo’, utilizzando i versi di una nota poetessa, Alda Merini. E a proposito del testo citato conclude: “ […] né peggiore né migliore di tanti piagnistei che ci arrivano da casalinghe frustrate o da altrettanti frustrati insegnanti in pensione [..]”. Affermazioni forti che rischiano, anche qui, forse, su questo sito, di offendere qualcuno!? Spero di no. Si allarghi il significato di queste parole sul fatto che “ […] Sono insopportabili gli atteggiamenti decisamente incolti e strumentali […] di tanta esaltazione […]. Le pagine cosiddette culturali dei più diffusi quotidiani e periodici e i programmi televisivi se ne sono ben guardati dallo spendere tanta dovizia di riconoscimenti per importanti poeti scomparsi negli ultimi decenni quali Luzi, Porta, Gramigna, Raboni, Sanesi, Cappi, Cacciatore, Spatola,… Né i media diffondono altrettanti spazi così ampiamente ‘pubblici’ per poeti ancora energeticamente attivi […] quali, per esempio, Erba, Viviani, Zanzotto […]. Abbiamo scoperto (in realtà già lo sapevamo) che in più di un liceo si parla sovente in questi mesi della Merini, ma non si conoscono nemmeno semplicemente i nomi di scrittori che hanno fatto la storia letteraria e culturale del ‘900. ” Devo dire che ho letto la Merini, apprezzandola, finché ho iniziato a trovarne in libreria fin troppe edizioni, sugli scaffali dedicati alla poesia, già piccoli di per sé... ma è chiaro che la Merini non c’entra proprio nulla, “poveri” librai, ed editori, costretti a “basarsi” sullo scrittore di turno che va per la maggiore, per mettere da parte qualche soldino in un paese quasi analfabeta. Devono pur vendere, ma quello che si vende è un problema di cultura, nemmeno i librai c’entrano nulla! Penso invece che il problema siano gli editori! Un po’ di coraggio no? (Ma questa è soltanto una mia riflessione).
Insieme a questo numero vi è, in supplemento, il Quaderno n. 12: “Scritture”. Come afferma Gio Ferri nella prefazione: “scelta quasi casuale, fra quelle molte carte.” Sono testi di Raffaella di Ambra, in parte autografi in parte dattiloscritti, con correzioni manuali: “ […] Penso che il lettore non possa, non le voglia leggere coscientemente, ma tenti innanzitutto di apprezzarle nella loro visiva originarietà. […]”.
La rivista Testuale ha un sito dal quale è possibile leggere per intero l’ultimo numero 46, ma anche i precedenti numeri, eccolo: www.testualecritica.it
Dallo stesso sito è possibile consultare altri numeri della rivista e Quaderni e Monografie. Se qualcuno poi vorrà riceverla stampata ecco qua alcuni riferimenti:
Un numero: gratuito (rimborso sole spese vive e postali € 15,00, Estero € 20,00)
Abb. (2 n. compresi supplementi): Italia € 25,00, Estero € 30,00
Versamento sul c.c.p. 28265205 int.TESTUALE, via A.Buschi 27, MILANO
Id: 325 Data: 16/07/2010 12:00:00
*
 Giuseppe Grattacaso - Poesia - Campanotto Editore
Giuseppe Grattacaso - Poesia - Campanotto Editore
Confidenze da un luogo familiare
Che cosa succederebbe se noi tutti avessimo “[…] lo sguardo circoscritto / a poche miglia […]”?
“[…] noi sapremmo solo / il glicine, il limone marzaiolo, / il passero che salta e in un sussurro / il vento tra il ciliegio e il niente intorno, / tutto finito dopo pochi passi, / appena un po’ di cielo, un tenue azzurro / e poi più niente, solo rami bassi.” (Pagina 83).
Mi chiedo: fin dove lo sguardo umano riesce a spingere il suo vedere? A che distanza sono posti i rami bassi che, a differenza della siepe leopardiana, in Grattacaso, coprono completamente l’infinito, ritagliandolo via ed evitando così, o cercando di evitare, il cuor che “si spaura”? Il poeta, in questo incantevole poema – che in parte si trova anche nella quarta di copertina –, richiama contrapposte evidenze. Da una parte, proponendo di circoscrivere lo sguardo a "poche miglia", richiama l’indubbia capacità umana di affrontare una visione ampia del mondo – fisico, sociale, psicologico… –, al di là dei “rami bassi” di un circoscritto interesse (se non è addirittura, in alcuni casi, un vero e proprio disinteresse) per la vita, che per alcuni è provocato dal calare del sipario dell’immediata soddisfazione dei sensi, indotta da un materialismo-consumismo accecante degli infiniti, si tratta di un processo incosciente, di cui magari non ci si rende più conto, così accerchiati come siamo dal villaggio umano dei piaceri. Per altri, invece, un restringimento cosciente della visione significherebbe, finalmente, una pace trovata, una serenità raggiunta, un modo di riposare dalle inquietudini esistenziali – angosciante incertezza o addirittura disperazione – che inevitabilmente il vedere troppo lontano, un ampio orizzonte senza terre, induce. A quest’ultima specie appartiene il poeta, il quale da una parte è, per vocazione, chiamato a sostare nell’interezza del mondo, al centro o al margine dei suoi ampi orizzonti, dall’altra, in quanto creatura, vorrebbe invece sostare in un più immediato e semplificato esistere. Ma anche laggiù, su quello stesso orizzonte che lo rende inquieto, sul confine dell’ampiezza, vi sono “rami bassi” oltre i quali si trova l’ignoto. Si tratta di una sorta di principio di indeterminazione esistenziale, valente nell’infinitamente grande come nell’infinitamente piccolo: avvicinandosi all’orizzonte aumenta l’incertezza degli spazi, nel generarsi di nuovi orizzonti e, quindi, di nuovi confini da superare. Tale indeterminazione rende impossibile al poeta una visione certa del mondo, conviene allora sostare, attendere che nella ciclicità dell’esistenza tornino eventi favorevoli: “[…] Mantenete il ritmo / voi se credete, io invece resto fermo: / tanto ritorna prima o poi l’inverno.” (Pagina 33).
Il poeta sembra che conosca molto bene i meccanismi della vita e i destini, proprio perché la vita stessa ha suoi cicli ripetitivi (“[…] e noi dovremmo andare / ma è tutto fisso nella chiarità, / andare andare ma poi restiamo qua.” Pagina 48), nel suo scorrere stratifica memoria (“[…] / aggiungere capitoli alle trame. // […].” Pagina 54), la quale, in qualche modo, rende il poeta attento e guardingo, capace di intercettare, esperienzialmente, tra i molteplici accadimenti, quelli più significativi: “[…] Andiamo / avanti allora senza intoppi, piano, / quasi da soli per non farci male, / evitando con cura incontri e eventi.” Inoltre Grattacaso, sempre nella poesia di pagina 54, esprime molto bene incertezze e indecisioni delle proprie strategie socio-relazionali, “[…] Cosa / faccio, li abbraccio, me li tengo stretti, / accetto il rischio di una confessione, / me li allontano in fretta e me li scordo / entrato in confusione dopo un passo? […]”. Da tante composizioni della raccolta emerge l’indecisione come elemento discriminante nelle scelte quotidiane, che, per quanto spicciole, hanno sempre un riflesso profondamente esistenziale; tale indecisione, oserei dire, è uno dei leitmotiv dell’intera raccolta. Un modus vivendi che sembra essere parte integrante del carattere del narratore ed è perfettamente strutturato in modo cosciente e positivo, in quanto pone il poeta in uno stato di particolare interesse verso il mondo, tant’è vero che egli afferma: “Se tu lo vuoi, io me lo invento un giorno / che ti sembro deciso, sembro eterno, / so già che fare da mattina a sera, / […] / io guardo sempre avanti se tu vuoi, / ma solo un giorno sennò poi ti annoi.” (Pagina 71). Viene qui associato il concetto di decisione a quello di eternità, e l’indecisione all’originalità, “sennò poi ti annoi”. Interessanti associazioni, è come se le fluttuazioni esistenziali, dovute all’incertezza, fossero responsabili del nostro procedere tra gli stenti della provvisorietà temporale, e un’assunzione di decisione espanderebbe il nostro tempo all’eterno, ma una noia mortale ci prenderebbe, ci sarebbe poco di divertente nella “decisione”, in quanto, per Grattacaso, e in parte mi associo al suo pensiero, pare che l’originalità dell’uomo stia proprio nell’indecisione e nella sua capacità di scelta - in libero arbitrio, dopo il momento instabile dell’incertezza - di caricarsi delle proprie responsabilità, è come se la libertà ci rendesse mutevoli e caduchi, la transitorietà umana è il prezzo della libertà che si riflette in tutto il Cosmo, un pensiero che corre molto prossimo a quello biblico di un peccato originale dovuto alla nostra libertà, famoso agire della “prima coppia” che ci ha resi così instabili tra la vita e la morte.
La sezione con cui inizia la raccolta, intitolata UOMINI E MERLI, si apre con una poesia importante che dà l’imprinting a tutta l’opera. Nel paragone tra il saltellare solitario di un merlo nell’ombra e un sé – dell’autore – in affanno, in cerca di “miracolo” (“[…] Sto in affanno, / in cerca di miracolo, […]”), il poeta sancisce, nel confronto con una gatta – che a più riprese tornerà come simbolo di indipendenza dalle scelte e dall'affanno del mondo, che “sta a guardarlo” ostentando indifferenza, e di pacata intelligenza e sguardo attento e d’attesa, –, l’inutilità di affanni, preoccupazioni e movimentazioni, anche perché per quanto ci si affanni in azioni, si entra comunque in una sorta di stallo esistenziale “[…] / quello che parte e sempre è sulla soglia / […]”, infatti ogni dinamismo esagerato risulta avere una apparenza di staticità, come, per esempio, una ruota in rapida rotazione: “[…], sempre solo il merlo / nell’ombra salta, la gatta sta a guardarlo, / ostenta indifferenza, è la sua scienza, / sceglie lo stallo, mentre gli altri vanno, / uomini e merli, in preda al loro affanno.” (Pagina 13). Grattacaso, infatti, elabora, sempre sull’onda di un procedere tra positive indecisioni, un opposto pensiero rispetto a quello comune che vede di buon occhio il dinamismo anziché la staticità, o cerca di allontanare le proprie paure, di vincerle, elaborando un uomo forte, deciso, ma che in realtà si scopre essere sempre più debole proprio perché incapace di accogliere ciò che realmente è in sé stesso, creatura nell’ignoto: “Le mie paure me le tengo care, / le conservo sott’olio, in salamoia, pronte / per l’uso, se ce ne sia bisogno. Non sono / sano ma non voglio cura, / perché poi in fondo è meglio la paura / che un agire per sempre contraffatto, / un coraggio affannato / e senza requie. […]”. (Pagina 14).
Molto si potrebbe dire del campo espressivo dell’autore, delle vesti descrittive che indossa con velata o evidente ironia che ricorda a tratti le migliori poesie di Magrelli… ma mi avvio alla conclusione dicendo che l’intera raccolta è perfettamente congegnata e le poesie, correlate tra loro, si richiamano l’una l’altra, sia nei significati che nei suoni, nei testi non mancano assonanze e rime che, opportunamente distribuite, in qualche poema a mo’ di cantilena, amplificano una sorta di ripetitività esistenziale che emerge particolarmente da alcuni testi. Il poeta sembra volutamente ritagliare via dalla propria vita i luoghi comuni, definendo un proprio campo d’esistenza dal peso specifico minore che emerge dalla pesantezza delle convenzioni sociali, almeno come pensiero, anche se poi l’azione risulta sempre imprigionata nel recinto del buon senso della convivenza civile: “[…] / E tutti gli altri che vanno, dove vanno? / Che vita li accompagna, in quale arcano / destino il treno li abbandonerà? / Vorrei seguirli, prenderli per mano, / dirgli che il viaggio e tutto il resto è inganno, / ma resto fermo, mentre tutti vanno, / io non li seguo e loro spariranno, // per sempre spariranno dalla vita.” (Pagina 58).
Ma ciò che più mi ha colpito è una domanda che si diffonde tra i versi: perché l’esistenza, qual è il senso del vivere e del fare? Domanda che talvolta si eleva decisa come in questi pochi versi: “Il cielo e le sue stelle ed io di sotto, / sguardo ridotto, tutto è senza scopo. // Più vedo e più mi sfugge ogni costrutto: / perché zirlano i tordi, fiorisce il pungitopo?” (Pagina 66). Poesia che lega con soluzione di continuità questa raccolta con le ultime produzioni poetiche dell'autore (se ne possono leggere due qui: http://poetrydream.splinder.com/ e su questo sito come poesia della settimana). Egli, dall’incertezza delle azioni quotidiane, si muove verso l’infinito del Cosmo e, “in mutande”, rimane allibito e a bocca aperta davanti al senso – o non senso? – dell’esistenza universale: “[…] / senza pareti o stretto / come una cella, io non so capire, / […] / Intanto alla rinfusa in cerca di ovvietà / in questo posto con fiducia aspetto / si posi ad indicarmi una ragione / una stella cometa o un moscone.” (Pagina 67). Quest’ultima è la poesia che contiene il verso che dà il titolo all’opera qui proposta, “Confidenze da un luogo familiare”; vi si esprime, in grado massimo, l’attesa del poeta di una risposta al suo interrogativo esistenziale, risposta che non potrà che “arrivare” come un dono, visto che “senza pareti o stretto / come una cella, io non so capire”.
Id: 317 Data: 25/06/2010 12:00:00
*
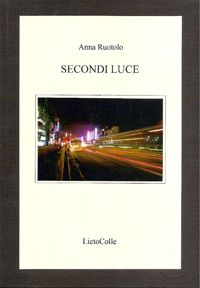 Anna Ruotolo - Poesia - LietoColle
Anna Ruotolo - Poesia - LietoColle
Secondi luce
Ma è nella poesia iniziale, intitolata “Secondo luce”, che l’autrice introduce i soggetti/temi che si dirameranno, in diversità d’infiorescenze, dal tronco principale della sua poetica, quest’ultima fortemente dialogica. Un secondo luce è la distanza che talvolta gli avvenimenti della vita, repentini e inaspettati, possono porre tra noi e il resto della nostra iniziale esistenza, una distanza enorme, come da qui alla Luna, tanta è la distanza percorsa dalla luce in un secondo, eppure la nostra vita, senza più quel cono d’ombra iniziale, arriva ugualmente a compimento: “[…] Questo è il tempo: una luce di lampi”: “[…] / Questo è il tempo: una luce di lampi, / breve, come il guizzo della terra / e manca, manca il cono d’ombra / dove si nasce, dove un po’ si vive.” (pagina 15)
Quindi il tempo “fa la parte del leone”, ma metto qui in evidenza altri due soggetti/temi che, a mio avviso, percorrono la raccolta:
- L’avvenire delle assenze, nelle partenze e nelle mancanze, e da esse sia il desiderio di attraversare ponti che attraversino le divisioni, avvicinino le assenze, provochino ritorni, sia la scelta di fermarsi all’inizio dei ponti delle partenze, delle divisioni e delle assenze, nel rispetto delle leggi del mondo o delle scelte altrui: “E’ come dirti addio / sopra il cucuzzolo del Mondo / dopo il mare fin dentro / che ci divide al ponte, / al passaggio chiarazzurro della barca.” / […]”(pagina 15).
- La bocca, gli occhi, il volto, e più in generale il corpo come luogo di donazione, il corpo come memoria, tutore, nell’assenza dell’altro/a, dei rapporti e degli amori. La corporeità è qui presentata in una accezione completamente positiva. Il corpo sembra essere il luogo della fiducia, della relazione serena tra due individui, è qualcosa di celestiale “[…] / ma il tuo corpo era celestiale / […]”. Molto bella e significativa la poesia senza titolo a pagina 26: “[…] / quasi sei un movimento di piccoli aerei / attorno l’orbita più lenta delle mie spalle. // Ma se ti chiedo come fai, perché succede / mi dici così: quando è la nascita della luce / e niente è stato ancora toccato / e il cielo s’avvicina un poco al giorno, / sono da te / per farti vedere tutto questo / […]”; a mio avviso, come dicevo, è una delle poesie più belle della raccolta, dalla quale si riconosce la verve di un poeta. Ma di tutto il corpo risalta, in modo evidente, e proposta con una certa regolarità nello svolgersi delle liriche, la bocca, con il suo colore o la sua curvatura (“[…] / Dire addio a te e – prima che sia – / a noi / a tutte le inconsolate vie della tua bocca / alle parole della pioggia sui canali / degli occhi.” Pagina 15; “[…] // All’infinito so che ti affacci sul lato occaso della bocca / e svegli il tempo / […].” Pagina 20;“[…] / quant’è bella la luce ferma / […] / agli angoli degli occhi.” Pagina 41; “[…] / Restituirmi al mare / […] / lì dove ti piaceva inventarmi / le ossa, le curvature della bocca / o un nome che mi hai dato, così / nella tua mente.” Pagina 65).
Ma il corpo è anche il luogo dal quale avvengono le partenze, è la casa che viene abbandonata: “[…] / Io sento, sento solo uno squarcio / di luce, cinque navi che partono / dalle mie costole, / questo sento. Non di più. / […]” (pagina 22). Nell’ultima sezione del libro intitolata “L’ultima nave a partire è l’abbandono”, come in un finale di fuochi artificiali, la Ruotolo, ci regala tra le più splendide illuminazioni poetiche relative al distacco e all’abbandono, a cui ogni cuore umano può, e deve, per necessità, diventare, con il tempo e l’esercizio della pratica, capace di sopportare: “Quel che può va via, / un muretto / il tuo alito libeccio / e così i granuli disciolti / dentro l’acqua. / […]” (pagina 62). “[…] / io ti ripeterò nei nomi delle cose, / nel fondo del bicchiere / dove mi hai raccolto.” (pagina 63).
Nella mia personale lettura posso dire di essere stato molto coinvolto da questa prima raccolta di Anna Ruotolo, quindi la reputo una prova ben riuscita, ma penso che ciò si possa affermare oggettivamente. La scrittura è calibrata, ottimamente inventata, descrittiva quanto basta a raggiungere l’altezza giusta da dove lanciarsi nel tema poetico, elegante, fondata sull’esperienza dei suoi 25 anni, ma di una maturità già avanzata, una scrittura che ben coniuga carattere e dolcezza femminile. Si sa che un poeta appena nato dovrà passare dalla fucina dei critici e della comunità dei poeti, che di silenzi sono spesso i maggiori dispensatori, non certo per virtù ma per negligenza e, talvolta, evidente maleducazione. Auguro alla Ruotolo di trovare pochi silenzi, ma se tali silenziosità la circondassero, sappia che la passione e la fedeltà alla propria vocazione poetica, uniti a una attenta e importante lettura della poesia di altri autori, classici o contemporanei, saranno le “voci” più importanti che nessun critico o poeta potrà sostituire, ma più di tutto il rigore verso la propria scrittura sarà quell’azione che avvicinerà il poeta alla sua più personale voce. In bocca al lupo.
[ Propngo anche, sul libro di Anna Ruotolo, un articolo/recensione di Luca Minola: Leggi ]
Id: 314 Data: 18/06/2010 12:00:00
*
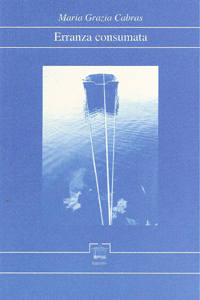 Maria Grazia Cabras - Poesia - Edizioni Gazebo
Maria Grazia Cabras - Poesia - Edizioni Gazebo
Erranza consumata
Ma è per il ricordo di coloro che ci lasciano, per custodire l’esistenza nella continuità del tempo, che ci si ostina nel tentativo di dare un senso a quel qualcosa di completamente assurdo: “Quell’ostinato voler dare un senso / a ciò che è morto / che penetra e piaga / che si fa parola / nell’attimo stesso / in cui di lei, di me / scrivo”. La parola scritta sopperisce all’assenza di voce di chi rimane senza fiato sull’abisso del non senso, la scrittura avviene come una necessità, pezza da stringere tra i denti al culmine di un dolore insopportabile: “Se scrivo è perché / non ho pace / e tremo di guerra // scrivo perché / non ho voce / ma solo mani nodose / come quelle di mia madre / e una penna che corre sul foglio // […]”.
Già nell’esergo dell’autrice, “In memoriam” (“Era come un nuraghe mia madre quando aveva paura del vento. / Si nascondeva nel cono dei suoi avi e pregava con il rosario in mano. / […]”), la Cabras stabilisce il perimetro entro il quale si svolge la sua esperienza personalissima di sofferenza, nel focolare domestico, nel territorio sardo, nell’aderenza alla potenza atavica di una fede personalissima. Sono significative e azzeccate le due poesie in sardo che l’autrice riporta a pagina 13 e a pagina 36, con tanto di traduzione italiana. La scrittura in dialetto avviene proprio in corrispondenza di momenti particolarmente dolorosi, “Dolcezza amara / che mi sfiori / […] / Sono rimasta sola. / Il mio sussulto ha il passo del sopravvissuto”, la prima, e “Ho sputato l’urlo / sulle ceneri di mio padre / ho sputato dolore al dolore / […] / Dentro la mia crepa / ho conficcato calcina e fiori”, la seconda. Il canto poetico espresso in dialetto sardo risuona come un canto tribale, è la necessità di spogliarsi, liberandosi di sovrastrutture, di intelligenze, di pacati e non più adatti ragionamenti, e scandagliare la terra del dolore a piedi nudi, a libero canto, raccogliendo la vita fino a quel momento e ripartire, sciogliendo quell’urlo nel petto, per decenza troppo trattenuto, ormai assolutamente necessario al riavvio.
“Tutto ciò che esiste / può non essere più // […]” (pagina 15), questa è la terribile sottaciuta verità della nostra esistenza, il fatto che ciò che per anni è stato il cerchio, più o meno ampio, della nostra esperienza, può restringersi, talvolta in un attimo, collassando in un punto, scomparire, lasciandoci in un altrove ignoto, dove, per istinto di sopravvivenza sarà rigenerato un nuovo perimetro vitale, a sua volta destinato al collasso, fino alla nostra definitiva dipartita.
“In questa casa / nessuno / muove l’ombra dell’aria / solo io, / di me il corpo // Sulla sedia / lenzuola riposte / in pieghe di rimembranza” (pagina 16), nuovi paradigmi esistenziali andranno elaborati, nuove dinamiche, che possano far riemergere dalla staticità dell’assenza definitiva, chi discretamente muoveva l’aria intorno a noi, riempiendo quegli spazi nostri vitali così profondamente che solo nell’assenza ci se ne può pienamente rendere conto. Così evidente come lo spegnersi di una luce nell’oscurità.
Alcuni riti sono però necessari per riemergere dal mare denso del dolore, portare lo sguardo verso chi ancora si muove, vivo, intorno a noi, e magari condivide il nostro dolore in vario modo, o per averlo già provato o per la vicinanza manifestata: “[…] Il dolore non è mai solo nostro” (pagina 17).
Tutto questo è espresso in poesie musicalmente rifinite che non restano circoscritte in un ambito puramente soggettivo o diaristico, sono canti, lamenti o urla, testi di ampio respiro, universalmente riconoscibili nell’esperienza di ognuno: arte poetica.
Id: 307 Data: 04/06/2010 12:00:00
*
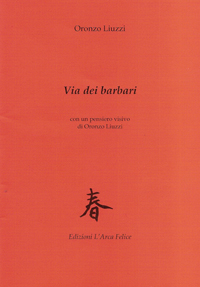 Oronzo Liuzzi - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Oronzo Liuzzi - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Via dei barbari
<si è dissolto………………………>
divinità che viaggia in incognito
<non esiste traccia…………………>
oltre il tempo e senza sogno.
invio una email:
leceneridellamore@violenza.it
…attendo……………………………
<la luce sfuma la sua luce…………>
si evidenziano i bidoni dell_indifferenza.
e lo sguardo indifeso si congela.
…attendo.
La poesia di Oronzo Liuzzi, in questa plaquette di 20 componimenti, attrae per il carattere modernista, è una scrittura che si sostiene su variegate modalità espressive – per certi versi fa venire alla mente uno scrittore quale Zanzotto, con i suoi segni grafici a integrazione dei significati sonori.
Le poesie sono composizioni da osservare, il suono da solo non completa il senso del testo, la poesia è visivamente espressa, i versi cadono in una sospensione di significato, le parole cessano suono e corso, per lasciare, nello spazio dei punti di sospensione, la possibilità al lettore di evaporare nel proprio mondo di sensi e significati. Sembra che le parole siano usate per dare intonazione a un canto, come la nota “la”, affinché il lettore possa avviare il proprio, le sospensioni lanciano le parole in una sorta di risonanza nella cassa armonica di chi legge, liberamente modulate o vibrate dal pizzicare delle parole che seguono. La lettura, in questo modo, si fa interessante e coinvolgente, sia dal punto di vista della composizione, che dal punto di vista dei significati che i testi, nell’insieme del tessuto narrativo poetico, vanno delineando. Si parla di un “vecchio vento ossessionato dall_odio delle genti”, si parla di sconfitti, “scrivo la storia degli sconfitti mi dico”, di un potere che “manovra l_impossibile”. Vi è nella raccolta una leggera brezza di divino che l’attraversa, rappresentata dal vento “che raccoglie i pensieri della storia”, e l’ammissione, dal sapore agostiniano, “non riuscirò a recepire il pensiero infinito del Dio / vivente”, presente nel mondo con la sua “bellezza divina”, che accompagna la storia dell’uomo e il suo dolore.
Il linguaggio è un gesto, “l_ombra insegue il gesto del linguaggio”, ed è inseguito dall’ombra, forse dall’ombra della modernità, per certi aspetti rappresentata dalla spersonalizzazione informatica sonora dei blog, “spengo il blog”. L’intercalare frequente di “mi dico” o "diss’io”, fa pensare a una persona avvolta, sola, nel proprio pensare, magari davanti a un monitor. Le parentesi angolari, “<” e “>”, che l’autore usa qua e là per aprire e chiudere i versi, danno, per l’appunto, una connotazione, per così dire, informatica, all’insieme della plaquette. Infatti, tali parentesi, evocano i cosiddetti TAG, marcatori usati nel linguaggio HTML per la realizzazione di siti web, i TAG vengono inseriti all’inizio e alla fine di un testo e vengono interpretati dai browsers (per esempio Internet Explorer) in modo da dare al testo un tipo di formattazione/evidenza (esempio: rosso, grassetto, corsivo, grande, piccolo, ecc.) in base al TAG utilizzato. Allo stesso modo, qui, le parentesi angolari, sembrano voler modificare il senso della frase che racchiudono affidandogli una colorazione e una dimensione aggiuntiva che altrimenti da sole non avrebbero, una sorta di metalinguaggio, che apre a significati altri.
La plaquette è corredata da un pensiero visivo dello stesso autore: tre lettere giganti dentro un carrello da spesa: la parola come merce, la parola che si compra, la parola sacrificata alla logica dell’usa e getta… una bella meditazione - libri sugli scaffali dei supermercati, purché si legga?
Grazie a Oronzo Liuzzi per questa bella prova di scrittura, singolare nel suo genere, che potrà aprire interessanti strade di lavoro poetico, che chiamo volentieri “informatico”.
Id: 300 Data: 11/05/2010 12:00:00
*
 Dimitry Rufolo - Poesia - Editrice Zona
Dimitry Rufolo - Poesia - Editrice Zona
Il diario di Ombrallegra
La poesia è un luogo da cui osservare la compostezza o il dinamismo della natura, intesa sia come esistenza fisica della materia, sia interiore movimento di sensazioni, di immaginazioni e di attese. Il poeta Rufolo investe sull’amore, sulla relazione con un altro da sé, che nel suo caso è appartenente al genere femminile, e nelle dinamiche del vissuto-presente o del vissuto-ricordo trova la parola per agevolare, nel cerchio delle sue esperienze, le sinapsi tra le parti di un mondo che tende alla disgregazione, all’allontanamento, al dia-ballo. Tuttavia Rufolo non perde una sorta di ottimismo che attinge linfa ancora da un terreno d’infanzia, dal quale è scaturita la venuta al mondo del suo albero delle idee, egli è uomo, ma con la giusta dose di puer aeternum, il bambino eterno che mantiene viva la potente gioia di vincere e crescere giocando senza mai accontentarsi del livello esistenziale raggiunto, a tratti permaloso per ciò che non ottiene.
Esistere significa scegliere e scegliere significa, lentamente, imprigionarsi dall’altra parte di un mondo che al poeta pare essere quello reale, anche se in realtà si tratta del mondo sognato nei desideri dell’infanzia, quello reale è purtroppo quello in cui realmente si trova e da cui osserva, è il lato del senex, il mondo adulto: “[…] / Sono qui / dall’altra parte del mondo reale / e più che descrivere / le mie passioni / ho l’impressione di scrivere / le mie memorie.”, pagina 41, “Le mie prigioni”.
La scrittura di Rufolo sa essere interessante e offrire spunti anche di divertita musicalità e composizione, penso alle poesie “Numbers” o “Posto in prima fila”, ma per onestà di lettura non posso non segnalare una certa sovrabbondanza di lessico che rende il dettato a tratti eccessivamente discorsivo, smorzando, qua e là, l’impeto poetico, tanto evidente in Rufolo. Penso che un maggior rigore nella composizione del verso, porterebbe a Rufolo un più appropriato riconoscimento. Consiglio la lettura di Valerio Magrelli e Patrizia Cavalli.
Id: 295 Data: 27/04/2010 22:10:32
*
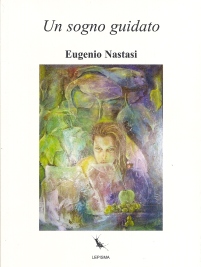 Eugenio Nastasi - Poesia - Lepisma Edizioni
Eugenio Nastasi - Poesia - Lepisma Edizioni
Un sogno guidato
Abbiamo già percorso lo stesso luogo
tante volte, estinta nelle fibre la dimora
dove attigue le voci convivono,
[…]
Ora sia il tuo passo
più cauto: a un tiro di sasso
di qui ti si prepara
una più rara scena
[…]
La vicinanza di sonorità e di contenuti rende i due testi avvicinabili e mette in evidenza l’abilità del poeta Nastasi, ponendolo in un luogo di serena vita poetica, poiché dalla solidità della più prossima tradizione, l’autore di “Un sogno guidato”, sa spiccare un volo suo proprio nel cielo della poesia contemporanea, lasciandosi alle spalle il nido e raggiungendo nuove frontiere espressive in una scrittura pulita, accerchiante, decisa, mai cedevole poiché sorretta dal pieno significato di ogni parola, quest’ultima ricercata nel campo della musicalità e della semantica. È una poesia che sa ospitare, tra i propri versi, amicizie e confidenze che seguono, talvolta, la quotidiana mutevolezza della natura, senza mai arretrare in vezzi poetici fuori calibro, e riuscendo invece a evidenziare le parti sostanziali dei sentimenti umani attraverso analogie e profonde considerazioni: “[…] lo specchio insegna che il legame / con quello che più gli somiglia / è insensato.” (Lo specchio ci guarda, pag. 24); “[…] qualcuno comincia a pensare / che non v’è porta ma muro / e solo muro.” (L’occhio del custode, pag. 23).
Nastasi sa ben marcare, e strettamente, le relazioni con il Sé poetico, aperto ad un ascolto e a un dialogo vero con il mondo, fatto di oggetti e scenari ai quali, il suo poetare, riesce a dare o a togliere valore: “[…] / Si direbbe / che niente cambia di una vita / se non distinguere / la brezza che la sveglia. / […]” (Passano accanto le cose, pag. 22).
Vi sono, inoltre, perle, o briciole, di saggezza disseminate con continuità in tutta la raccolta, seguendo le quali ci si arricchisce di significati metabolizzati dall’autore e generosamente, oltreché piacevolmente, proposti fin dalla prima pagina della raccolta, ma senza mai privare il lettore del suo spazio di elaborazione critica: “[…] / A un uomo occorre nascere / più in alto / dove una preghiera / mette a posto le cose.” (Via san Martino, pag. 36).
Segnalo inoltre la bellissima poesia dedicata al fratello Nicola “In viaggio con mio fratello maggiore”: “[…] / Mio fratello e io siamo dello stesso / segno, quanto a letture / abitiamo in camere separate. / […]” (Pag. 61).
Un poeta da leggere, soprattutto per questo suo retrogusto che si innesta nella più prossima tradizione poetica del Novecento, ma che procede ad ali dispiegate sul mare della modernità.
*
Proponiamo infine un contributo critico di Antonio De Marchi-Gherini al libro di Eugenio Nastasi:
Quello che Eugenio Nastasi ci consegna è un libro dalle varie interpretazioni possibili. Dialogo con sé stesso o con un altro/a che fa capolino . discorso e dettato poetico volutamente basso nei toni e nella cernita dei lemmi. E d’altra parte lui stesso ci facilita il compito.
Leggiamo a pag.55:”Scrivo su note basse/ chiosando i fatti della vita/ e non perdere memoria dei pensieri/ che segnano gli errori./ Note subliminali ci guidano,/ labirinto segreto/ tra il bene e il male come trama/ di un broccato./ Liberi?/ L’intreccio ci irride e debole il suono/ della tua nota/ lotta in attesa di essere seguita.”
Alcuni tracciati della poesia contemporanea sembrano passare per cunicoli forzati , per aperture ove il rovello dello spirito non cerca di riplasmarsi per delimitare o contenere.
Non è così per il vissuto e l’immaginario rappresentato in queste pagine di Eugenio Nastasi.
Lieve e sottaciuta, ma presente, un’ironia amara ci conduce ad una sorta di cadenzato passo epigrammatico. Il discorso esplorativo tiene ben presente gli ultimi esiti della psicanalisi e della psicosintesi applicata all’arte. Potremmo parlare di ‘poesia scientifica’ nella disanima dei sentimenti umani, degli umori e delle folgorazioni che appartengono e pertengono all’essere umano e alla vita quotidiana.
Insomma la parola feriale di Nastasi non è, come in molta poesia attuale, il labirinto chiuso della propria coscienza, è parola evocativa di rappresentazione della coscienza.
Leggiamo “training autogeno” (pag.41): “Riposati, mio cuore, dormi, non é/ così vicina, né legata al polso/ che batte, l’ora che può cambiare/ il corso della tua vicenda,/ niente sprona più intensamente/ l’avidità della luce/ se non la gioia e la paura di sapere; (…)”
Bisogna riconoscere ad Eugenio Nastasi un tenace lavoro di lima, di scorporo di concetti e levature, per lasciare il netto e non il lordo di certa poesia prolissa e vaniloquente.
Lavora di bulino e anche di raspa: Il respiro a volte si fa affannoso e grave, ma poi si riprende. Sotteso al testo, non poi tanto nascosta, vi è una fede cristica che lo sorregge e corrobora. In altro luogo ho parlato di somiglianza a certa poesia anglosassone per l’uso del quotidianese e per la folgorazione di certe immagini icastiche, una lussureggiante descrizione dell’animo umano e delle sue pulsioni, anche le più nascoste e dissimulate, inserite in un paesaggio interiore ed esteriore quasi metafisico.
A volte i testi paiono prose poetiche di una semplice e luminosa chiarezza. Paesaggi illuminati e compenetrati dal motivo amoroso. Viene alla mente il miglior Cardarelli dove l’intensa riflessione brucia il fondo prosastico e alimenta quel martellante recitativo, quel monologo che giustamente fu detto drammatico.
Poesia autobiografica la si potrebbe definire, ma di un autobiografismo che non ha nulla di intimistico, o quand’anche lo sfiora, lo fa con grazia leggera.
Ora sarebbe il caso di illuminare o abbuiare il lettore con altre citazioni, ma credo di aver detto l’essenziale e per il resto rimando alla lettura della raccolta, compatta e coesa nel suo dire.
Il poeta offre un lavoro che si distingue per la tendenziale organicità e completezza, mettendo in essere l’energico fluire del verso che, come limpida acqua lustrale, purifica lo sguardo e invita a seguirlo in questo suo cammino nel paesaggio interiore dell’anima e nel suo viaggio verso l’infinito. Anche se il nostro i piedi li tiene saldamente ancorati a terra, buon per lui, con alcuni punti fermi, che come dicevo poc’anzi, gli derivano da un fede cristiana e cattolica priva di dubbi, almeno nei suoi contenuti essenziali.
Id: 285 Data: 26/03/2010 16:35:26
*
 Jacopo Ricciardi - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Jacopo Ricciardi - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Il macaco
Insomma se l’uomo da una parte è sospinto verso il cielo da una potente ascesi interiore che è rappresentata dalla parola, dalla voce, dalla comunicazione, dall’altro vi è la creatura, rappresentata dal macaco – così talvolta indolente quanto irriverente ed egoista –, che pesa sull’uomo. Nel suo essere creatura l’uomo ha un’unica direzione possibile verso il cielo (“- non ho due direzioni! -”), in una unitarietà tra spirito e corpo determinata dall’amore, udibile, verificabile e sostenibile nel peso del respiro.
E' ciò che ho letto tra le righe dei versi di Ricciardi, versi tesi e visionari che hanno destato questa mia personale meditativa interpretazione.
Id: 283 Data: 16/03/2010 19:52:23
*
 Salvatore Violante - Poesia - Marcus Edizioni
Salvatore Violante - Poesia - Marcus Edizioni
Sulle tracce dell’uomo
In “Sonata ad orecchio”, pag. 12, Violante esprime il suo interessante modus vivendi ed operandi poetico: “Io non mi pongo limiti / né tattiche o raggiri / disegno ciò che capita / respiro i miei respiri / e cerco di cantarli / senz’annotare accordi / ascolto la mia anima / ne pizzico le corde: / risale un suono morbido / ansato per tremori / a volte c’è una sincope / di striduli rumori / ma sempre un soffio tenero / contiene le mie pene / rendendo caldo / il gelido racconto che contiene”.
In “Carezze usuranti”, il poeta canta la natura, capace, nel suo muoversi, di donare all’uomo, il suono della vita e il senso della sua stessa parola: “Questo mare con l’onda che cammina / io guardo / e sento della vita / il suono / che scorre a riva, / […] E sento il tempo / e il moto / e le stagioni / che fasciano la vita, / e le parole / che vestono lo sguardo delle cose / diversamente assenti, / e la natura / che scorre come un rivolo / e riporta / ciascuna vita a naturale sorte.” (pag. 19).
In questa raccolta c’è veramente un gran fermento di idee e scrittura, v’è un dire su molte cose e molti fatti, i titoli stessi dei testi sono esplicativi: La mongolfiera, Etica, Il mondo, Contadini, Gravità, Bontà, Querce, Balletti, Cronaca nera, Salmi, L’ultras, La morte, P.I.L., Un po’ di Post, Apocalisse (prove), eccetera.
Benché ci sia uno stile uniforme di composizione, si riscontra, tuttavia, una certa piacevole fantasia di scrittura. Per la maggior parte i testi sono dediti a un lirismo voluto e ricercato attraverso l’introduzione di aggettivazioni e assonanze, sia all’interno dei versi che al termine con le rime; non mancano però momenti in cui Violante si lascia andare in virtuosismi poetici simpatici, allegri e sonori, ricercando e forzatamente inserendo rime e assonanze che rendono certi testi vere e proprie filastrocche che risuonano onomatopeiche; viene la voglia di leggerle a voce alta per gustarne il gioco sonoro, come la poesia che apre la raccolta, intitolata “La gallina di città”: “[…] / Con passetti corti corti / strabuzzando gli occhi storti / canta chicchi-ricchi-chì, chirì-cchichì / poi si gonfia il suo piumaggio / come nuvola di maggio. / […]”.
Per mia onestà critica devo però dire che alcuni testi potrebbero, a mio avviso, guadagnare in forza limando qua e là alcune rime, ma sono sicuro che questo è soltanto un mio gusto personale, che non vuole intaccare, e non intacca, il valore della ricerca poetica e di linguaggio dell’autore, infatti, come tutte le attività di ricerca, si devono provare percorsi anche rischiosi, come lo sono quelli del lirismo e dell’elegia, almeno nel contesto della scrittura moderna contemporanea.
In altre parti della raccolta, si veda ad esempio l’appendice intitolata “moti e terremoti”, vi sono composizioni, a mio gusto tra le più riuscite, completamente essiccate al sole di certo tipo di rigore poetico: “resta la catalessi della gente del Sud / e lo smeriglio, questa pietra dura, / resta la storia antica di paure / la calce bianca i santi / nelle campane di vetro.”, pag. 93. Fino a spingersi, in qualche testo, a composizioni tipiche, nella disposizione delle parole e nella musicalità, della scuola poetica dell’amica Bettarini, ma con tutta la forza della personale scrittura di Violante.
Insomma una raccolta che non passa inosservata e che mostra un poeta in ricerca e che, forse, invita a fare altrettanto. Violante mi piace perché sa giocare, pur nella serietà dei contenuti del suo libro, lo sa fare modulando la forma poetica. Cosa rischiosissima per un poeta, ma lui sa mostrarsi poeta in ricerca, non teme la critica. Complimenti.
Id: 267 Data: 05/02/2010 12:00:00
*
 Franco Buffoni - Poesia - Ugo Guanda Editore
Franco Buffoni - Poesia - Ugo Guanda Editore
Roma
Mi affiderò, nello scrivere queste poche righe su “Roma”, semplicemente alle sensazioni di lettore. A mio avviso “Roma” è un libro originale, ottimamente scritto, diligentemente, con chiarezza di lingua e sottile metafora. Non sempre i testi sono di immediata comprensione, talvolta è necessario sostare sui versi al fine di penetrarne il senso, o di lasciarsi scalzare dal senso che il poeta, noto per la sua fine coda di ironia e rimando a percezioni non immediatamente evidenti, insuffla con intelligenza esemplare e totalmente piacevole. Dal punto di vista della scrittura mi pare di cogliere una fluidità che comparerei, per analogia, a una cascatella di montagna, in cui le parole, come acqua, scorrono verso un unico senso, l’unico possibile in eufonica discesa verso la pacatezza dello specchio d’acqua, il luogo del significato più ampio delle parole di Buffoni, in cui l’insieme dell’opera trova l’armonia della completezza. Sotto la limpidezza delle parole che si depositano nello specchio d’acqua, sul “fondale”, appare il senso dell’intera scrittura. Si evidenziano gli elementi contenuti nel libro. Mi pare di non sminuire la poesia di Buffoni, e anzi, (tantomeno me stesso) affermando che i sensi di alcuni testi non mi sono risultati di immediata evidenza, mi è parso perciò utile fare una prima lettura del volume senza troppo sostare sulle singole poesie, poiché, a causa della scorrevolezza del testo, mi è risultato piacevole, come si addice alla musica più bella, il solo ascolto dei suoni evocati dalle parole, incastonate nella fluidità dei versi, e della loro risonanza nella bocca o nell’aria dintorno (essendo ottima una lettura delle poesie a voce), in questo modo si è rivelato il panorama del discorso, successivamente focalizzato in una lettura più particolare.
Il volume è diviso in XI sezioni distribuite in circa 170 pagine. Le prime sezioni hanno un carattere pasoliniano, in cui “omofobia e croci celtiche, campioni sportivi arroganti e giovani disperati giocano ruoli adiacenti”, come Buffoni stesso scrive nelle note finali. Via via lo sguardo su Roma, passando dai quartieri piemontesi, “tra moderno degrado e parlata di popolo”, si “stratifica e si archeologizza, sincronico e diacronico insieme, per cogliere l’attualità in Galileo e in Pinturicchio gay, e – vòlto alla campagna romana – in Leopardi suddito della Reverendissima Camera Apostolica e in Keats, che ha già composto l’Ode a un usignolo e trasecola alla vista di un cardinale che spara in cielo.”
Della VI sezione intitolata “In quell’angusto regno del silenzio”, mi piace riportare per esteso, sperando di fare cosa gradita, la poesia iniziale, in quanto sintomatica di tutta una metodologia costruttiva di forma e contenuti:
Ho pensato a te, contino Giacomo, vedendo
Su una rivista patinata
Le foto degli scavi in Siria e Urkish,
A te e ai tuoi imperi e popoli dell’Asia
Quando intuivi immensamente lunga
La storia dell’umanità.
Altro che i Greci il popolo giovane di Hegel
O il mondo solo di quattromila anni della Bibbia
Credendo di dir tanto, fino a ieri.
Tu lo sapevi che sotto sette strati stava Urkish
La regina coi fermagli
L’intero archivio su mille tavolette
Già indoeuropea nella parlata
L’accusativo in emme. Capitale urrita
Dai gioielli legati all’infinita pazienza
Dei ricami in oro. Tu lo sapevi che poi gli Hittiti
sarebbero giunti a conquistarla,
Già loro vecchi e di vecchi archivi nutriti…
Sono stufo di preti e di poeti, conte Giacomo.
E di miti infantilmente riadattati.
Come già detto la raccolta risulta essere caratterizzata da originalità, per come l’autore riesce a intessere con abilità storica, sguardo sociale e civile, sensibilità artistica e, oso dire, rigore scientifico applicato alla poesia, le trame di un proprio pensiero e di una propria fede umana fondata sia sull'educazione alta di tipo letterario e filosofico (Humanismus) che sulla più popolare propensione verso le situazioni di vita quotidiana; quest’ultima è prevalente nella sezione finale, intitolata “Un longobardo assente”, in cui Buffoni cerca “il meno possibile di mentire su sé stesso”: “Un sorriso da Grace Kelly già ingrassata / […] / E per tutta la sera mi ha guardato / Leggere. […] / Ma odio quelle che / «Te ne assaggio un pezzettino» / E si godono la punta della mia torta / Del trancio di pizza, del mont blanc.” (pag. 164).
Talvolta le poesie lasciano il lettore sospeso in una indeterminata incertezza, in una zona di confine in cui le parole del poeta assumono caratteri descrittivi che sembrano osmoticamente passare dalla realtà alla finzione di una pittura o un affresco o viceversa. Buffoni utilizza le bellezze dell’arte per innalzarsi verso riflessioni storiche e sociali rilevanti: “Lontane su un mare piatto / Abbandonate navi in disarmo / Della marina vaticana. / […] / Nel palazzo con loggia decorata / da sette leoni passanti, / […] / Due papi in abito da giullare / Attendono il giudizio / Senza nemmeno una striscia / Di cielo che li aspetti.” (Pag. 88). Dagli scritti di Buffoni si evince un suo tipico e marcato razionalismo e un forte accento critico verso l’istituzione del Vaticano e dei suoi alti prelati. Ed ecco l’occasione di “Roma” per esortare il lettore ad una riflessione storica riguardo il rapporto tra Galileo e il Vaticano – “[…] / Vedo in ginocchio il vecchio Galilei / Dinanzi ai cardinali tronfi e bolsi.” (Pag. 89) – e contrapporre il miserrimo atteggiamento antiprogressista dei cardinali davanti al fulgore di una mente che in Galileo iniziava un rinnovamento e una rivoluzione del pensiero e della visione del mondo; pensiero e visione che nulla, come si sa, avrebbero potuto togliere all’onestà della fede, come infatti la Storia ha dimostrato nei secoli successivi. Una poesia su Galileo, forse una delle più belle del libro, è pubblicata per esteso nell’intervista (leggi).
Tuttavia, nonostante la fortissima caratterizzazione razionalista, e atea, del pensiero buffoniano, si leggono questi tre versi finali nella poesia di pagina 93: “[…] / Da uomo a uomo Gesù ti sto pregando / Ma tu dammi cenno di riscontro. / In the Pallottini Ecclesia Church. Onlus.” Versi percorsi da una piccola vena di ironia, che sembrano scritti per segnare un luogo preciso dove si è data la possibilità di vedere Gesù all’opera… ma si sa che la fede è anche un mistero di non risposta. Mi ha colpito quel “da uomo a uomo”, che forse basta a Buffoni, non avendo ricevuto risposta, immagino, per annullare la propria e le altrui fedi.
Infine, sempre dalla nota finale di Buffoni, “la IX e la X sezione riportano il libro all’arte contemporanea, per assestarsi sul Novecento di un poeta purissimo, mercante di quadri e ladro di sguardi”, siamo nella fase penniana del libro.
Insomma il libro è molto bello, sicuramente consigliabile sia per chi conosce Roma, che vi troverà luoghi e contesti noti rivisti dagli occhi di un non romano, sia per chi non la conosce, che ne vedrà i tratti salienti contemporanei e millenari nella descrizione di un attento e critico osservatore. In entrambi i casi il lettore godrà di Roma narrata in una luce di eccellenza linguistica, una Roma storica, artistica e di vita quotidiana, di umilissima gente e di eroi della resistenza partigiana e personaggi la cui vita ha accompagnato, e talvolta segnato, la storia della città eterna.
Id: 258 Data: 14/01/2010 18:53:15
*
 Gian Luca Maggiani... - Poesia - Associazione Culturale La Formica
Gian Luca Maggiani... - Poesia - Associazione Culturale La Formica
Vicino al .......
Ho sempre pensato che le feste del Natale e dell’Epifania – più volgarmente chiamata Befana – sono, oltreché feste religiose, anche le feste della più gaia fantasia, feste in cui i sogni quasi sembrano addensarsi nel cuore. Sono le feste della gioia, della nascita e della rinascita, della manifestazione della Vita nella sua purezza e nella sua potenza capace di riscattare il vecchiume. Se da una parte il Natale e l’Epifania coinvolgono per il messaggio evangelico della grazia e dell’amore di Dio che s’incarna e si manifesta a tutta l’umanità in Gesù bambino, dall’altra avviano in tutti noi un tempo propizio per la fantasia, per ridestare una serena spensieratezza e purezza e libertà di immaginazione tipiche dei bambini (puer) che eravamo e che ancora vivono in un angolo del nostro cuore. Bambini che hanno adesso la possibilità di attingere ad una esperienza di vita e ad una esperienza cerebrale di ragione e logica talvolta sana, talvolta insalubre. Fantasticare è quello che manca a molti e troppo seriosi individui del nostro tempo, come di altri passati tempi, non v’è la capacità di farlo e di farlo con una nota di serena ingenuità. E coloro che tra noi sono ancora, per età, fisicamente bambini, ci insegnano proprio questo, a fantasticare ingenuamente, attingendo da una spensierata gaiezza non ancora corrotta da quella massa esperienziale di conoscenze e “buone maniere” che si depositano nelle azioni nel corso degli anni e che rende tutto così opaco, chiude i sorrisi, abbassa gli sguardi, toglie i saluti.
E’ per questo che alla vigilia dell’Epifania, al termine delle festività natalizie vogliamo presentare un libretto scritto dai bambini e dalla loro fantasia. Vi sono immagini, figure di animali e oggetti colorati, vi sono parole semplici, scritte in terzine con rime che rimandano al canto, al divertimento. La rima fa tanto sorridere i bambini e li diverte, è il gioco delle assonanze, il gioco delle parole, della loro modulazione sonora e musicale, in questo libro associate a figure di animali e oggetti riconoscibili. Figure e parole richiamano poesia, simboli grafici che proiettano oltre la natura contingente, nel mondo bello e colorato dell’immaginazione, uno dei luoghi della poesia. Diceva Jorge Luis Borges: “Un libro è un oggetto fisico in un mondo di oggetti fisici. E’ un insieme di simboli morti. Poi arriva un buon lettore e le parole – o meglio, la poesia che sta dietro le parole, perché le parole in sé sono semplici simboli – tornano in vita. Ed ecco la resurrezione della parola. Sicché si può dire che la poesia è ogni volta una nuova esperienza. E, tutte le volte che leggo una poesia, l’esperienza accade. Ecco cos’è la poesia.” E tanto più per un bambino di tre, quattro, cinque anni, il libro altro non è che “un oggetto fisico in un mondo di oggetti fisici”. Ma questo libro deve trovare un lettore che associ suoni alle figure e ai simboli grafici in modo da incuriosire il bambino, cosicché possa capire che la parola può far accedere al mondo della fantasia e dell’immaginario, un mondo vero come quello naturale, forse ancora più vero perché intimo e personale, un mondo che avvolge di significati il mondo naturale di oggetti e che lo sorregge con ragione di scienza e ragione di favola, da cui scaturisce una forza che può sollevare l’umanità dal fango della tristezza ingenerata da una società fondata su relazioni governate dalle diseguaglianze economiche e di diritti. Un bambino che avrà scoperto che da un libro possono uscire il bello e il vero, frutto dell’esperienza e della fantasia di altri suoi simili e da esso attingere per creare lui stesso altra bellezza e verità, sarà un bambino libero, sarà un uomo giusto, che creerà la pace con l’esercizio del rispetto e dell’uguaglianza.
“Vicino al castello / c’è una tartaruga / col pennello”, “Vicino allo stivale / c’è un topo / col giornale”, “Vicino alla porta / c’è un uccello / con la torta”.
Buona Befana a tutti… ma attenti al carbone…
*
Il libro è stato realizzato dalla Associazione Culturale La Formica, con il contributo del Comune di Carrara e il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara.
Le persone coinvolte nel progetto “Amico libro” sono:
Gian Luca Maggiani, artista illustratore del libro
Maria Gemma De Angeli, insegnate della Coop. Soc. C.O.M.P.A.S.S.
Fabrizio Sbrana, fotoreporter
Maurizio Vaira, grafico
Dott.ssa Anna Pennisi, responsabile della Biblioteca Comunale di Carrara
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Primo Corsini” di Castelpoggio (MS)
Chi desiderasse copia del libro può rivolgersi alla redazione de larecherche.it, proveremo a mettervi in contatto con L'Associazione Culturale La Formica.
Id: 256 Data: 05/01/2010 12:10:09
*
 Mariella Bettarini - Poesia - Edizioni Gazebo
Mariella Bettarini - Poesia - Edizioni Gazebo
A parole – in immagini
Mi tocca questo arduo piacevole compito, presentare l’antologia poetica 1963-2007 di Mariella Bettarini. Poetessa stimata e apprezzata per la sua onestà poetica ed intellettuale, per il suo fervore e per la sua capacità critica sempre attenta ai giovani e a promuovere la buona poesia. Una scrittrice di grande valore, un’amica, una compagna di viaggio per chi non voglia perdersi nei meandri del solipsismo ostentato, dell’aggettivazione, del lirismo, della scrittura scadente. Una donna che ha saputo e sa condurre una parva acies di amichevoli scrittori verso la poesia. La conobbi intorno al 1995 e fu un incontro subito delizioso, la sua disponibilità mi conquistò immediatamente, mi aiutò a lavorare sui miei testi, mi corresse col sorriso e col rigore, ero affascinato da quel suo modo gentile ma deciso di dire il suo pensiero sulla poesia, mai annacquato da convenevoli, ma semmai sempre schietta. Il lavoro poetico della Bettarini si sviluppa su molti anni di vita, di vicende, di dolori personali e sociali, attraversa per intero gli anni del fermento ideologico del Sessantotto, fino ai giorni odierni con le sue contraddizioni. Riguardo le motivazioni di questa antologia, riporto, meglio di altre mie parole, un estratto dalla “Nota dell’autrice”: “Perché questa corposa, quasi metà-secolare antologia di versi, ad accrescere il gran mare di carte, libri, segni, tomi, riflessioni, parole, enormi o parve testimonianze [.…]. Di certo, c’è il fatto contingente di tanti miei libri e libretti da anni esauriti (ma a chi cale) e la voglia, il bisogno di ri-trovarli, ri-averli, con essi (e con me) confrontarmi come di nuovo, rivisitando questioni e ferite, anni e lustri e gli abitanti loro: pensieri, persone, emozioni, utopie, speranze, desolazioni che siano, che fossero. […] da quei primi anni Sessanta, da quando iniziai – forse mio malgrado, ma certo per intima, vitale ‘salvazione’ – l’avventura dello scrivere, soprattutto dello scrivere in versi, mediante i versi. […]”. Impossibile per me parlare, in una pagina, di quasi mezzo secolo di scrittura, cercherò tuttavia di balbettare qualcosa che indirizzi l’appassionato lettore ad un personale e più proficuo approfondimento circa il lavoro dell’autrice in questione. La Bettarini ha scritto moltissimo e sempre bene, sempre con destrezza di parola, sempre decisa e al contempo ponendo nel lettore il dubbio, nei versi scorrono domande, interrogativi, mai esclamativi – che semmai detesta – o affermazioni assolute, senza possibilità di dubbio, questi non si confanno alla sua poesia. Ella procede, in molti suoi testi, per domande, talvolta suggerendo possibili risposte; il suo è un fare quasi scientifico. E’ una poetessa, non ha una formazione scientifica, eppure nei suoi testi scorre un’anima scientifica, ragionevole, indagatrice. Ricordo ancora quando le donai copia della mia tesi di laurea in fisica nucleare, guardò tutte quelle formule estasiata, contenta: nella disposizione grafica delle formule vi vedeva una sorta di poesia, arte. Nell’antologia sono proposti testi di fine ricerca, testi che procedono sull’analogia o sulla metafora, in continuo riferimento al mondo della natura o del quotidiano, situazioni che ama e descrive in modo mai scontato, procedendo per una strada di parole che lasciano intravedere un lavoro di ricerca e di documentazione a monte della composizione. È esemplificativo, in tal senso, il suo lavoro “Delle nuvole” (1986 – ’88), Edizioni Gazebo, Firenze, 1991; ecco alcune sue parole introduttive alla citata raccolta, composta da una decina di poesie: “Ho ideato questa breve raccolta [.…] spinta da ciò che spinge e muove da sempre il fare poetico: l’osservazione, la constatazione di ciò che esiste, la contemplazione, lo stupore, e poi la lunga dimenticanza e ancora l’osservazione, la meraviglia, il rapporto cangiante fra ciò che appare e ciò che – di quanto appare – non si conosce, ossia l’ignoto […]. Non dissimile, credo, nella sua origine, la passione dello scienziato, del biologo, del chimico, del botanico, dell’astronomo. [.…] Nuvole, dunque. Nuvole “scientifiche” e – solo dopo ma insieme – nuvole “poetiche”. [.…] per potere letteralmente scrivere quanto ho scritto delle nuvole e sulle nuvole, ho sentito l’impellenza di una documentazione scientifica [.…].” Ma è con la sua prima pubblicazione, “Il pudore e l’effondersi” (1963 – 1965), Edizioni Città di Vita, Firenze, 1966, che ella dà subito l’idea di che pasta sia fatta questa giovane donna (24 anni) che si affaccia sul mondo della poesia e della vita pubblica letteraria e di conseguenza sociale (perché come ci dice Sophia de Mello, poesia è rivoluzione, è lavoro sociale). Riporto qui integralmente la poesia che dà il titolo alla raccolta:
Il pudore e l’effondersi,
le forze che contrastano in me,
il segreto spalancarsi dell’anima,
il non sempre compreso farne parte
con gli altri, tutto questo, mio Dio,
quante emozioni provochi Tu sai,
quanti affanni di vero,
quali forti domande per giungere
al proposito del sì,
alla serena sicurezza
di avere posto a frutto quanto avevo,
di poter mantenere le promesse
che in silenzio mi facevo nel cuore,
anche se quanti non le udirono
ora un poco mi fanno resistenza,
e diversa mi credono,
e restano confusi nell’inganno.
Gennaio 1964
Questa sua prima raccolta rivela una Bettarini meditativa, quasi silenziosa nella sua introspezione, capace, in pochi ben tagliati e musicali versi di dipingere situazioni interiori o esteriori, a lei prossime, di disagio, inganno, grazia o dolore. E’ interessante che in diverse poesie appaia un Tu, forse il Signore della fede cristiana: “Signore, solo Tu ed io sappiamo / della mia infanzia. Nessun altro / […]”. La Bettarini è una donna di grande fede, una fede che ha le sue radici nel Dio cristiano ma che si dilata sull’uomo, la sua è una fede che, nel corso del tempo, si espande poeticamente sull’uomo, sulla natura, sulla ragione, sulla Storia – a mio avviso è una grande fede umana (e per questo divina), vera, senza bigottismi o falsità, ottimista, una fede che sa guardare in faccia l’assoluto, con estrema umiltà e proprio per questo riceve dall’assoluto la pienezza della visione sulle piccole cose del mondo che Mariella esprime benissimo in poesia, rivelando il suo grande rispetto e la sua passione per la vita, per i più deboli, per la natura e le sue creature, con un fare (e non dispiace) talvolta francescano, ma anche, per la simpatia verso la scuola di Barbiana, ha in sé la forza pedagogica di un Don Milani, lei maestra elementare che ha saputo amare appieno i suoi bambini, donando e ricevendo anche poesia. Dalla raccolta “Balestrucci”, un racconto in versi (1998-’99), Edizioni Gazebo, Firenze, 2006, propongo la poesia iniziale intitolata “L’arrivo”: “da dove? da lontano-lontano / in viaggio / e migranti / apolidi – lontane / da noi – da qui – le rondini – / i balestrucci – questi solo di sé / benedetti Irundinidi”. Non posso non segnalare la presenza nell’antologia della bellissima poesia che nei momenti di sconforto poetico mi risolleva portandomi a “casa”, poesia tratta da “Case, luoghi, la parola” (1993-’95), Edizioni Fermenti, Roma, 1998; in particolare propongo un estratto da “La casa del poeta” (1995), in cui la Bettarini racconta il suo luogo poetico, figurato e reale: “io nel letto – sempre – nel letto / le ho scritte e le scrivevo / le scrivo / io nel letto / quasi sempre le ho scritte / le sceglievo: parole e parolette – file – covi / famiglie / le parole-mie madri / le parole mie figlie / in casa e dentro un letto / io sempre le ho covate / al caldo / dopo il male sbadata le ho incubate [.…]”. Dal punto di vista dello stile compositivo/grafico dei suoi poemi, si assiste ad una evoluzione che la porta, in una decina di anni dalla prima raccolta, ad assestare la sua scrittura su una libertà espressiva di composizione dei versi e di disposizione delle parole all’interno degli stessi, i quali si delineano sempre più privi di punteggiatura e caratterizzati dall’uso di trattini a delineare pause e parentetiche, e disposti nella pagina con andate a capo e nessuna maiuscola, una scrittura talvolta di non immediata comprensione per chi non è avvezzo alla poesia, ma che la inserisce nel filone di certa scuola zanzottiana, dalla quale però si discosta con originalità di senso. Mi piace inoltre segnalare, l’uso di parole italiane talvolta non di uso comune nel linguaggio parlato, alcune forse più utilizzate nell’area del territorio toscano, ma nonostante questo mai arcaiche o che lasciano un sapore di antico, anzi rendono i testi di una finezza e di una tipica sonorità bettariniana, oso dire con una nota di piacere. La Bettarini gioca molto sulla parola, su assonanze interne al testo che lo rendono fluido e scorrevole verso un senso che talvolta rende la poesia tagliente, altre volte ironica, altre leggera, altre ancora meditativa. Segnalo, è d’obbligo, che l’autrice si è confrontata, con successo, anche con gli haiku, pubblicando una raccolta intitolata “Haiku di maggio” (maggio 1996), Edizioni Gazebo, Firenze, 1999, riportati nell’antologia, eccone uno: trinità erba erba storna – aglio orsino erba galletta A fine antologia vengono proposte alcune note critiche di importanti critici e scrittori, e alcuni estratti di due tesi di laurea: “L’opera poetica di Mariella Bettarini”, di Maria Amelia Sucapane, discussa nell’aprile 2003 presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi La Sapienza di Roma; e “Seguace della parola. L’opera poetica di Mariella Bettarini”, di Alessia Orsini, discussa nel 2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Chieti. Ci sarebbero un’infinità di cose da dire ancora sui testi proposti in questa antologia che, in modo intelligente, presenta i lavori più significativi della Bettarini, pubblicati, come già detto, nell’arco di quasi mezzo secolo, lavori che non appartengono, ormai non più, soltanto all’anima della poetessa ma a noi tutti, appassionati del bello e del vero, in una parola dell’arte. Penso che, al di là delle parole che qui hanno cercato di dare valore ad una scrittura, sia necessaria la lettura – o, quando possibile, l’ascolto – che consiglio vivamente ad ogni scrittore e lettore de larecherche.it.
*
Integriamo la recensione di Roberto Maggiani con i contributi gentilmente inviatici dalla critica e scrittrice Franca Alaimo e dal poeta Salvatore Violante: Leggere la poesia di Mariella Bettarini nel suo svolgersi cronologico, senza pause, è come appropriarsi della storia più intima di lei, storia di un pensiero che è mutato nell’urto con la realtà, interrogandola, interrogandosi, nella ricerca dell’equilibrio, ma senza che quello faticosamente trovato ogni volta, si tramutasse in quiete o peggio quiescenza, divenendo anzi indicazione per un nuovo procedere. Si avverte farsi sempre meno invadente, mano a mano che scorrono gli anni, il fuoco dell’ideologia, così necessaria nella prima fase del suo impegno scritturale, quando doveva ancora la Bettarini prendere coscienza di sé, del suo posto nella Storia, di fronte le istituzioni, i poteri, quando doveva distruggere, e forse distruggersi, per costruire un nuovo modo d’essere donna, il suo scomodo (per tanti) modo di sentire la sessualità, di ingravidarsi, così come lei stessa scrive, d’un amore senza scopo procreativo e senza però perdere la dimensione etica. E tutto questo Mariella Bettarini l’ha detto prima con la rabbia della parola stuprata, poi con libertà della fantasia, e ancora con la consapevolezza che tutto può essere poesia: la natura, le cose, le città, i piccoli eventi, purché siano traslati oltre se stessi, purché si sia disposti a guardare tra gli interstizi della realtà dove molto mistero giace in silenzio.Così con la mano della scrittura la poetessa fiorentina ha spinto verso nuovi sensi tutto il corpo della lingua e non più per il gusto di ferirla, rivoltarla, rinnovarla, ma per affermare ciò che fin qui non era stato detto, e non per dimostrare di essere poeta, ma per vivere da poeta che fa la lingua ininterrottamente, con devota umiltà, come seguace della Parola. Così Storia con la esse maiuscola e storia con la esse minuscola, quella privata di ciascuno che pure se inconsapevolmente ha appiccicata addosso la Storia come un bozzolo, si sono incontrate in reciproco assenso e la prima, la Storia, sia pure poco nominata, è divenuta sostanza, umore che scorre a fianco, dentro la quotidianità, non meno eroica, non meno possente quest’ultima, se letta come metafora di una condizione, di un essere donne nel tempo in cui esserlo significava gregarietà e debolezza d’opinione e d’azione, di un essere, comunque, nella vita, al di là delle categorie. Ecco nascere le bellissime sessantotto poesie per Vera, una per ogni anno d’età, gioie-dolori cuciti con lo stesso filo dell’amore e della pazienza. Il linguaggio d’ora in poi, non dimentica mai la sua tenerezza, l’affettività, la cromaticità del reale, procede visionario e concreto insieme: filosofia, storia, scienza vi si intrecciano lasciando impronte lessicali, catalogazioni, classificazioni, pagliuzze varie dell’infinito svolgersi ed esserci della vita, abbracciata con amore, dolore, interrogazione, sgridata, condivisa nell’amicizia, nella passione, nel dolore e scrutata, penetrata, sposata nelle sue più intime fibre. Il periodare corre, insegue le parole che sembrano avere un’energia infantile, mobili, vivaci, zampillanti, imprevedibili: l’una chiama l’altra in un ludus-lusus che però è serio, serissimo come lo è per tutti i bambini quando, giocando, interpretano il mondo ed escono ed entrano da se stessi ed afferrano significati celati; in questo modo la più ampia libertà è stata raggiunta: le parole “raggiano…espandendosi ovunque come faville”. Dobbiamo noi tutti un grazie a questa figura di donna e poeta, perché proprio il suo non volere essere maestra di nessuno, la fa maestra di molti, perché ha trovato una voce inconfondibile, uno stile imprendibile, voli d’anima alti, perché è rimasta una vecchia-bambina vera, verissima ed una grande amica. Mariella Bettarini, donna dal cuore enormemente stanco, appare una poeta leggera, perché sa vedere il mondo più di quelli che hanno le diottrie intatte.
*
Id: 255 Data: 01/01/2010 20:24:26
*
 Antonio Spagnuolo - Poesia - Kaírós Edizioni
Antonio Spagnuolo - Poesia - Kaírós Edizioni
Fratture da comporre
“Fratture da comporre” è la sua ultima raccolta, edita, nel 2009, nella Collana di Poesia “Le parole della Sibilla” delle edizioni Kaírós, da lui stesso diretta, insieme alla bella rassegna “Poetrydream” in internet.
Riporto alcuni versi tratti dalla raccolta: “[…] / Il tuo mutamento slitta giù nel gioco delle ombre / per i riflessi inconsueti di un errore, / l’interminabile filigrana del mito / rinserrata nel corpo, / e la tua betulla sbiadisce / forse perché non crede alle mie rime / tutte impastate in controsenso. / […]”. Ecco come l’autore stesso definisce la sua scrittura in versi: “rime tutte impastate in controsenso”. Strana definizione, dato che di rime non se ne trovano nella sua scrittura. Ma la parola “impastate” esplica il motivo di tale riferimento. Difatti si trova, nella poetica di Spagnuolo, un fervore di scrittura classica e quasi lirica, vuoi nell’abbondante aggettivazione, vuoi nell’uso, qua e là, di parole ricercate che danno alle composizioni quel vago afrore di lirismo; al contempo il testo scorre, tendenzialmente prosastico, libero da schemi lirici e da rime, gradevolmente in bilico tra una scrittura classica e una scrittura moderna; in effetti in queste composizioni v’è una sorta di controsenso, un lirismo che si va via via modernizzando e un modernismo poetico che apre al lirismo. E’ in questo delicato equilibrio che si gioca, a mio avviso, la poetica di Spagnuolo, ed è una sua propria caratteristica. Le rime sono impastate nel corpo dei testi, veleggiano tra le assonanze sparse nei poemi.
Nella raccolta si snodano abili rappresentazioni figurate di pensieri e relazioni, i testi si rivolgono in continuazione ad un tu chiaramente al femminile, quindi si tratta di composizioni dialogiche, sembrano pagine rivolte ad una persona importante della propria esistenza. Il corpo è continuamente chiamato in causa. Il richiamo alle varie parti anatomiche, con i loro attributi umorali, le loro funzionalità e capacità di provare dolore, costella la raccolta e la rende palpabile e sperimentabile. Tali elementi corporei vengono talvolta proiettati da Spagnuolo in un alter spazio poetico, essi diventano quasi-metafore per esprimere le proprie percezioni viscerali, è un modus operandi che materializza pensieri e sensazioni, talvolta, appunto, in controsenso. Egli associa, alle parti del corpo, aggettivi e caratteristiche che talvolta sembrano non avere attinenza immediata se non in un ampio campo metaforico necessario al poeta per farsi ben intendere ed imprimere ai versi modulate espressioni d’intenti: “ribalto pupille”, “per non interferire allo schiamazzo dell’inguine”, “inghiotto la frequenza dell’aorta”, “le caviglie irrequiete”, “schiena impazzita”…
E’ inoltre evidente che nella poetica di Spagnuolo vi sia la memoria di un corpo giovane e vigoroso, sia d’amore che di salute, ma è un corpo che sta facendo i conti con il suo naturale procedere verso il declino: “[…] / Avrei voluto ritrovare i miei anni virili, / quelli che la bizzarria pettinava nelle stanze del sogno / ma senza più parole ho chiuso ogni poesia.”
Nell’esistenza umana ci sono molte fratture da comporre, siano esse relazioni o sogni, ciò che conta è tenere fede alla promessa, per quanto vi sia sempre il dubbio esistenziale che tutto sia forse un’illusione che ciò che proviamo e vogliamo non sia vero: “[…] / Fratture da comporre / le mie ultime promesse, / da conservare negli spazi di un’unghia / e chiudere nell’infinito sospetto / dell’illusione.”
Una raccolta importante, un lavoro delicato e da rileggere. Infine oso affermare – come nota di estrema positività, che inserisce l’autore tra i poeti del Novecento e con continuità di lavoro nel nuovo secolo – che ho trovato, nello stile di Spagnuolo, elementi compositivi di Covoni, Soffici, Bontempelli e del grande Luzi. Spero di essere contraddetto se ciò risultasse falso.
Id: 251 Data: 18/12/2009 17:30:40
*
 Alessandro Ramberti - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Alessandro Ramberti - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Inoltramenti
In “Genesi” viene in evidenza un poeta visibilmente investito dalla forza di una sorta di visionarietà poetica e religiosa. Attraverso parche metafore l’autore conduce, tra i propri versi, il gioco della meditazione, spingendolo a fondo fin nello spazio spirituale del lettore, il quale deve, in qualche modo, porsi domande insieme al poeta: “Ricordi i momenti / in cui hai iniziato ad essere […] ? […]”. Talvolta il dettato poetico si fa quasi surrealista ed enigmatico. Ramberti si muove verso una zona dell’universo umano in cui ci si trova spersi, fino al limite in cui visione e parola si dividono, il parlare diventa “bofonchiare” suoni incerti, la parola del comune pensare, in situazioni estreme, non può che essere farfuglio, perde di vista il nesso logico del suo dire. E’ forse proprio questa la missione del poeta: inoltrarsi (si veda il titolo “Inoltramenti”), per necessità di ricerca, in percorsi semantici alternativi nel tentativo di esprimere parti dell’esistenza situate sul bordo del reale inconscio umano e collettivo – per poi magari scoprire che il significato delle cose è invece altrove e ogni parola è fasulla: “Qui / fra paura e aspirazioni / bofonchiamo suoni incerti / moduliamo un la / che è appunto altrove. // Il pensiero sta / sospeso nell’enigma: / […]”..
In un libro della Bibbia, il Deuteronomio, è scritto: “Ascolta, o Israele, Jahvé è il nostro Dio! Jahvé è Uno [Echàd]”; ed “Echàd” è il titolo di una delle sette poesie della plaquette, è dedicata al padre e tratta il tema del dolore e della morte, la quale può essere lenita, per la sua nota di assurdità e angoscia, nell’affidarsi completamente “[…] / al viso infuocato / al tuono sospirato come un alito / […] / e spero oltre misura / ma ragionevolmente / perché noi siamo / la cifra del tesoro / di cui ci fai custodi nel cammino / ardente di sconfitte che redimi. / […]”.
Con i due testi “Economia biologica” e “Urna viva”, il poeta stende le sue meditazioni sul rapporto tra il corpo e l’anima. Infine, nella poesia che chiude la raccolta, intitolata “Monte Baldo”, lascia intravedere all’orizzonte, dopo il faticoso viaggio – oso dire – nella fede, un porto di approdo: “[…] rossi gli occhi / ondeggiano in perlustrazione / sussurrano un porto: / poche lettere che non si usurano […]”. Una scommessa lasciata aperta è quella di portarvi intera l’anima, che a volte rimane impigliata "[...] in questioni pratiche / […] fuori pista…”.
La copia numerata che ci è stata donata è la 105/199, ed è accompagnata, fuori testo, da un bel pensiero visivo di Francesco Ramberti, realizzato in inchiostro su carta.
Id: 250 Data: 15/12/2009 21:23:29
*
 Mario Fresa - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Mario Fresa - Poesia - Edizioni L’Arca Felice
Se tu guardi
“L’Associazione Culturale L'Arca Felice pubblica testi, spesso inediti e rari, di autori antichi e contemporanei (soprattutto filosofi e poeti), mostrando una particolare attenzione nel creare una comunicazione speculare tra le forme della poesia e le forme dell’arte visiva.
Secondo l’antico pensiero cinese, la calligrafia, la poesia e la pittura erano definite le tre perfezioni. Le opere che sapevano combinare le tre perfezioni furono considerate dai sapienti la massima espressione del pensiero e dell’arte.
L’Arca Felice intende promuovere con uno specifico interesse il rapporto fra la scrittura poetica e il segno artistico: ogni libretto, infatti, offre un dialogo fitto che si svolge tra i poeti e i pittori, le cui opere (dipinti e disegni) sono impresse fuori testo a tiratura limitata e accompagnano, come un’eco sospesa, l’apparizione della parola poetica.”
Il tentativo di queste edizioni è notevole, poiché cerca di recuperare e proporre una unitarietà tra il sapere e le varie forme artistiche che invece, all’opposto, la tendenza alla specializzazione della società moderna ha contribuito a frammentare. La dicitura che si legge sul loro sito web è sintomatica di questa ricerca di unitarietà: “L’Arca Felice - Edizioni di arte, poesia e filosofia”. Arte intesa, in particolare, come forma pittorica, fotografica e poetica. Sapere inteso come elaborazione filosofica e poetica del mondo. La poesia appare quindi, come in un sistema di equazioni, il termine simile, la variabile che unisce le due dimensioni, è il trait d’union tra arte e sapere filosofico – ed è breve, espandendo un poco i termini, il passo dalla filosofia alla scienza passando dalle proposte filosofiche di quest’ultima. Ci sarebbe da sbizzarrirsi in questa triangolazione tra arte, poesia e filosofia/scienza, ma non è questa la sede per farlo.
Ciò che quindi è interessante di queste edizioni e che esse intentano una vera sfida alla divisione delle arti e dei saperi provando – riuscendo in parte – a ricomporre le fratture, sostenendo preziose pubblicazioni, davanti alle quali, per la loro semplice ed elegante veste grafica, non si può rimanere immuni dalla tentazione di elaborare commistioni artistiche in tal senso.
I libretti sono numerati e timbrati a mano, uno a uno, stampati in un numero limitato di copie, non vengono abbandonati nelle mani avide della grande distribuzione libraria, che, proprio perché avida di guadagni, relega spesso i libri di poesia in scaffali, anticamere del macero. Queste edizioni, prive di ISBN, vengono distribuite presso biblioteche, centri di cultura, scrittori, critici e artisti, il libro/plaquette circola, e non è cosa di poco conto. La nostra redazione ha la fortuna e il privilegio di essere anch’essa un piccolo centro di questa circolazione, e sicuramente proporremo all’attenzione dei lettori ogni plaquette che ci giungerà in redazione a partire da questa di Mario Fresa.
Riporto, penso senza violare nessuna privacy del discorso personale, le parole che mi sono state rivolte dalla gentile e disponibile Ida Borrasi, che si occupa della direzione artistica ed editoriale de L’Arca Felice: “L’idea è quella di creare un prodotto dove il lavoro artigianale e manuale viene mescolato con le più avanzate tecnologie di stampa per creare un nuovo modo di vedere l'oggetto libro e di interpretarlo”; frase tra le più belle che un lettore/scrittore possa mai sentire, essa rivela un amore e una passione per l’arte a tutto tondo, non solo per la scrittura ma per l’oggetto libro in sé, il quale porta, al suo interno, come un fiore all’occhiello, schede fuori testo di artisti, pittori, fotografi, disegnatori. Le opere inserite a rotazione nelle copie numerate rendono i pezzi unici.
Le Edizioni de L’Arca Felice propongono cinque Collane dai nomi simpatici e significativi: “Anime”, “L’ora di Barga”, “Πóλoς”, “Hermes”, “Coincidenze”.
La plaquette di Mario Fresa di cui proponiamo la copertina fa parte della Collana “L’Ora di Barga”. Vi è una sola poesia e una stampa fuori testo di Matteo Fresa. La plaquette è stampata in 99 esemplari numerati, quello che ci è stato donato è il numero 81/99.
Abbiamo già parlato di Mario Fresa, sia attraverso una sua bella intervista, sia proponendo all’attenzione dei lettori una raccolta molto importante per il suo valore poetico, intitolata “Alluminio”, Lietocolle. Come detto, Fresa propone una sola poesia che da sola assume lo stesso valore di un gioiello ovattato nella sua custodia, la bella stampa che l’accompagna rende il lavoro poetico tridimensionale e modulabile.
Questa plaquette testimonia che la Poesia non risponde, non può farlo, alla logica della quantità, ma alla logica della qualità. Più volte mi sono trovato a pensare che è valsa la pena acquistare una raccolta poetica anche soltanto per una poesia che entra nell’anima in modo così significativo da trasferire da sé stessa l’intero mondo fantastico e poetico di un artista e capace di costruire o ricostruire quello del lettore. Ebbene la poesia di Fresa, quest’unica, colpisce il centro al primo colpo, ma non c’era da dubitarlo, vista l’abilità artistica/poetica dell’autore, che tra le altre cose è anche il curatore della Collana “Coincidenze”, attraverso la quale le Edizioni de L’Arca Felice offrono all’attenzione della letteratura interessanti poeti e sistemi poetici.
Infine invitiamo a visitare il sito web, sopra proposto, dal quale è possibile iscriversi per ricevere informazioni, associarsi o ricevere le loro edizioni.
Id: 247 Data: 04/12/2009 21:00:10
*
 Eunigea D’Alfonso - Poesia - Edizioni Tracce
Eunigea D’Alfonso - Poesia - Edizioni Tracce
Pulviscoli vaganti
La poesia della D’Alfonso nasce da esperienze sensoriali immediate che attivano ricordi fissati con la parola – che nella sua poesia è mezzo e non fine – parola-pennello che dipinge i luoghi dov’ella conduce il lettore, eletto a testimone di fatti e sensazioni vissute, a volte come a voler essere rassicurata circa il bene delle azioni e delle modalità del suo vissuto passato, presente e anche futuro. Vi è un filo rosso che attraversa il suo impianto poetico, l’esposizione, evidente o sottesa, di un sistema morale tipicamente cristiano, con la contrapposizione tra bene e male; non dispiacciono le sue meditazioni: “[…] Il senso di ogni bene / che vive dentro di noi, che ci guida, / frena tutto il male, lo allontana […]” (pag. 19).
Ma nel testo si percepisce anche una sorta di smarrimento: “[…] Smarrita dal caos continuo / che offre la vita […]” (pag. 13); il dubbio che s’insinua nella scelta tra l’azione-bene e l’azione-male. Ma l’autrice ha un segreto, che svela, il cuore può elaborare il male, ma se il cuore si abbandona al “[…] ritmo musicale del creato […]” (pag. 26) allora c’è speranza che il sorriso prevalga, che il male presente venga accantonato, “[…] In un abbraccio stretto noi preghiamo / il Dio che ci guida e ci fa grandi.” (pag. 26). E ancora, questa vaga impotenza verso il passato è recuperata nella vita presente che diventa il tempo da vivere in pienezza con rinnovato amore, si veda la poesia a pagina 41, intitolata “Il tempo passa…”, in cui l’ansia di voler sopprimere i segni del tempo sulla propria pelle, viene annegata nella “danza dell’amore” con la persona amata e da cui si è ricambiati per quello che si è.
La poesia che dà il titolo al libro, a pagina 15, è significativa perché dà il senso della raccolta della D’Alfonso e di che cosa sia per lei la poesia. La poesia è una percezione interiore, luogo magico, primitivo e bambino, nel quale vive il puer eterno per il quale tutto l’universo appare come qualcosa di personale “[…]Tutto l’universo lo sentivo mio […]” (pag. 15). Ma è un luogo da raggiungere, “[…] Uno scoglio piatto, ventilato […]” in mezzo al mare, un luogo dove il pensiero si dispone su più livelli, “[…]tutti i miei sensi radunati / m’hanno portata su dimensioni diverse / nel pensare […]”, in cui la mente abbandona il corpo “[…] mi son sentita priva di materia […]”, e l’anima del poeta si ritrova confusa dalle sue stesse esperienze, “[…] un minestrone ho fatto, / ritrovarne il capo è cosa vana…”. Sorge una domanda importante, “[…] il mondo è una illusione? […]”, domanda a cui è improbabile dare risposta, ma che ha il significato di una sorta di lavaggio della coscienza: si riparte dalla consapevolezza della propria finitezza, della infinita piccolezza dell’uomo nell’universo, “[…] Pulviscoli vaganti noi siamo […]”, ma anche dalla gioia di poter tornare alle certezze, fuori dal luogo del dubbio che è l’isolamento nel mondo poetico, e abbandonarsi, nella fede, a una preghiera che doni pace sulla riva dei giorni normali.
L’autrice ha una vena di riflessione di grande interesse, si colgono fervori capaci di animare il lettore e alleggerirlo del fardello della quotidianità, questo vuol dire che la D’Alfonso ha la cosiddetta vena poetica; è capace di trasferire nella poesia il reale (per dirla alla Sophia de Mello) e lo fa, in questa raccolta, toccando anche punte di buona poesia come “Un ritorno al passato”, a pagina 39, e altre. Ma, talvolta, la forma poetica scelta è un po’ ingenua, si trovano spesso scambi tra sostantivo e aggettivo, laddove si avverte invece la necessità di una lettura, e quindi di una scrittura, piana e fluida. Le poesie della D’Alfonso, sono piene di contenuti e aprono spunti meditativi piacevoli, ella apre il suo mondo interiore al lettore, ed è capace di evocare, attraverso un’azzeccata descrizione, piacevoli paesaggi e situazioni intime importanti, ma l’eccessivo, voluto, uso di una forma poetica lirica, non perfettamente tenuta in ogni parte del testo, un uso forzato, talvolta, di arcaismi, rende il sistema qua e là cedevole nella forma. A mio avviso i testi sarebbero da limare ancora più a fondo. In conclusione, il lavoro, come detto, è buono ma penso che la poesia debba stare al passo con i tempi moderni e aggiornarsi nella forma del linguaggio, rinnovo il consiglio di leggere i poeti contemporanei, dai quali prendere spunto per la forma poetica. Su larecherche.it ne abbiamo recensiti e intervistati diversi. Ma ecco, qui di seguito, per contro, un testo lirico, a mio avviso, ben riuscito:
Il ritorno del freddo (pag. 12)
Nel gelido verno
le membra si tendon
alla fiamma ridente
che vivida, allegra
scoppietta fluente
scintilla e si spegne!
Il fuoco ristora
riscalda ogni cuore
ma, fatuo e leggero
se ei s’abbandona
alla cenere torna
e calore non dona!
Allora buon lavoro, attendiamo nuove scritture.
Id: 236 Data: 27/10/2009 17:05:16
*
 Serena Stefani - Narrativa - Edizioni Joker
Serena Stefani - Narrativa - Edizioni Joker
Enfants d’Afrique
Enfants d’Afrique è edito dalle edizioni Joker nella collana di testi teatrali Panopticon, edizione italiana e francese, la traduzione in francese è di Monique Baccelli; introduce il testo la bella prefazione di Giuseppe Panella. I personaggi della vicenda sono presentati divisi in due gruppi: Bianchi e Neri. Ancora oggi il colore della pelle può modificare il destino delle persone, potenza del colore.
Da una parte l’Europa dall’altra l’Africa. La bianca Emmanuelle Krus è ancora innamorata di Loums Eto’o, incontrato in una parentesi europea di quest’ultimo, ma sia Emmanuelle che Loums hanno, rispettivamente, marito e moglie delle proprie terre, dei loro stessi colori, bianco l’uno nera l’altra. La vicenda si svolge, come la Stefani scrive in apertura del testo, in un paese dell’Africa, in un oggi senza tempo. Loums ha un progetto da sviluppare nel suo paese, dall’Europa arrivano dei finanziatori, c’è una festa in attesa dell’incontro, ma ecco che appare Emmanuelle tra lo stupore di Loums e, di conseguenza, a causa della confidenza che Loums ha con Emmanuelle, dei dignitari, rappresentanti di un governo africano che, come al solito, è molto sbilanciato verso una sorta di regime, benché si parli di Presidente della nazione e di Bene Nazionale. Non posso esimermi, di questi tempi, dal ravvisare una situazione non molto dissimile da un paese europeo geograficamente molto vicino all’Africa quale l’Italia. Leggendo certe parole messe in bocca ai dignitari del governo del paese africano, ritrovo similitudini inquietanti con la situazione italiana attuale: “(A Emmanuelle) Vede, Signora il nostro paese rigurgita di uomini di buona volontà – lo dimostrano le ultime elezioni che hanno riconfermato in modo assoluto l’amore del popolo per il Presidente e per il suo operato in nome di un forte sentimento patriottico…”, “…Esistono però pochi facinorosi mossi da sentimenti di invidia e di ingratitudine che si infilano fra la gente comune e persino nei luoghi dove si decide del Bene Nazionale. Questi qui tramano e, benché tutti i loro tentativi siano destinati al fallimento, possono offuscare per alcuni istanti l’immagine compatta e timorosa di Dio del paese.”
Si avvicendano colloqui alterni tra i vari personaggi, tra cui spicca Mehdi, giovane segretario nero di Loums e in cui Emmanuelle troverà un confidente per le sue pene d’amore. Sarà proprio Mehdi a condurla da una strega nelle cui parole misteriose risuoneranno presagi non ben decifrabili, avversi o favorevoli. Il marito di Emmanuelle, Thomas, arriva inaspettatamente in Africa per cercare di convincere Emmanuelle del suo rinnovato amore, vuole salvare il proprio figlio nel ventre di una sempre più instabile Emmanuelle, la quale, invece, avrebbe voluto un figlio da Loums; Thomas minaccerà di porre il suo veto per i finanziamenti qualora Emmanuelle non faccia ritorno con lui in Europa. Insomma la Stefani è abile narratrice e costruttrice di scene, inanella una sorta di catena amorosa, l’anello iniziale è Loums, desiderato da Emmanuele, ma Loums non la desidera più, la rispetta con grande affetto, ma sottostante le ragioni della ragione, Loums è sposato e ha figli, non vuole continuare una relazione irragionevole; Thomas, il marito di Emmanuele, la desidera ancora e soprattutto desidera ciò che porta nel suo grembo, ma Emmanuele non ne vuole più sapere, desidera soltanto Loums e un figlio da lui. Loums desidera però i soldi per il suo progetto che soltanto Emmanuelle può darle e per avere i quali Emmanuele impone delle condizioni che sono un vero e proprio ricatto per Loums, deve tornare con lei; infine Mehdi, il giovane segretario nero di Loums, sarà il figlio che Emmanule strapperà all’Africa, un figlio d’adozione.
Non svelerò qui il finale dell’opera teatrale della Stefani, dirò soltanto che lo sviluppo della vicenda ha movimenti e presagi che possono essere smossi soltanto nel palco di una terra ancestrale quale l’Africa è, nella cui terra e sotto il cui cielo non è raro tornare all’essenza delle sensazioni e dei riti interiori ed esteriori, spirituali e magici, completamente terrestri. Una fuga e una bottiglia con del liquido rosso opaco saranno i due elementi significativi nel volgere del libro all’epilogo.
Penso che la Stefani, con la sua consueta abilità linguistica, riesca a delineare, in poche pagine, un’opera teatrale degna di nota e direi soprattutto di rappresentazione, ed è ciò che auspico. I dialoghi, costruiti in modo intelligente e con abilità realistica, scorrono agevolmente e con pathos verso il centro della vicenda, il lettore rimane preso dai giochi sentimentali che si instaurano tra i personaggi principali della rappresentazione, giochi che non sono però puramente di cuore, ma anche, e forse soprattutto, psicologici, ed è proprio questo secondo aspetto a rendere l’opera interessante e a non farla cadere nel rischio di uno sdolcinato dialogare tra esseri.
Il libro è imbevuto di una tragica relazione di dipendenza dell’Africa verso l’Europa. Una terra di investimenti ma nella sostanza imprendibile, un continente potente, la cui natura spirituale riesce ad attirare e ad assorbire, riportando ad una sorta di essenzialità d’esistenza, una terra da sempre sfruttata ma indomabile.
Id: 231 Data: 09/10/2009 17:47:04
*
 Valerio Magrelli - Narrativa - Editori Laterza
Valerio Magrelli - Narrativa - Editori Laterza
La vicevita
Questo libro di Magrelli è strutturato in brevissimi racconti in cui sono narrate meditate esperienze autobiografiche tratte dalla sua vita di viaggiatore che, fin dalla prima giovinezza, per varie motivazioni, lo porta a stare in treno: “Chi sta in treno, è segno che vuole andare da qualche parte, e lo fa sempre e solo in vista di qualcos’altro. Il suo scopo, cioè, risiede altrove […] Sono i momenti in cui facciamo da veicolo a noi stessi. E’ ciò che chiamerei: la vicevita.”.
Un libro snello da leggere, riposante – come il verde attraente della copertina già sta a significare –, a tratti divertente, sa strappare sorrisi svagati. Un libello che mette in luce aspetti ironici e tragici dell’esistenza umana e della convivenza civile, a guizzi provocatorio. Ci fa soffermare su quanto mai semplici, e per questo acute, meditazioni circa il senso della storia e di eventi accaduti nel passato e che hanno nel treno un evocatore che porta sensazioni, dentro la propria pancia, e rivela consuetudini dell’Italia e delle sue gentili o isteriche convivenze. Il treno, luogo di sottili torture, di mance, elemosine e regalìe, di economia, di solidarietà, di villeggiatura, di lavoro, di egoismo, di confronto, di riposo, di autoanalisi, di visione, di confidenze, di stranezze, di scrittura, di lettura, di fastidi, di ritorno, di andata, di stupore, di tecnologia, ma non c’è treno che prima o poi…: “Il mondo ferroviario offre infiniti aspetti, ma in filigrana, nella più buia araldica, resta sempre l’immagine dei vagoni blindati. Non c’è treno che prima o poi, sia pure per un istante, non ricordi i suoi mostruosi simili. Anche in questo senso i lager sono stati dei capolinea: non tanto perché le rotaie si arrestavano contro un blocco di cemento e due respingenti, quanto perché il loro mattatoio era un ‘Finis Terrae’. […] Siamo bestiame, bestie potenziali di un potenziale luogo di sterminio.” (pag. 55).
“La vicevita” è, come dicevo, un libro che nella lettura porta svago, si legge volentieri e in un fiato, ma la sua “leggerezza” è solo apparente, ed è qui una delle caratteristiche di questa scrittura di Magrelli, sa alleggerire la pesantezza; a tratti, non so come mai, mi ricorda certi film di Woody Allen: “Non è semplice enunciare le ragioni per cui i passaggi a livello mettano tanta tristezza. La prima cosa da capire, riguarda l’angolatura sotto la quale intendiamo parlarne. […]” (pag. 96). “Enunciare”, è questa la parola chiave, a mio avviso, per questo libro. Enunciare sembra avere qui lo stesso significato dell’enunciare dei matematici: formulare con esattezza una teoria, un teorema, ogni racconto ha in se un teorema. E per dimostrare la tesi del teorema ci si attrezza con una serie di ipotesi valide, in effetti è quello che fa l’autore, in maniera più o meno evidente, in ampie parti del libro, e in modo così elegante da rimanerne stupiti, poiché ci si ritrova ad osservare una stessa stanza piena di oggetti ma in una luce nuova, dagli effetti visivi impensati.
Mi pare plausibile affermare che ciò che caratterizza la scrittura di Magrelli, anche quella delle opere poetiche, è proprio una lucidità logico-deduttiva, sostenuta da una congeniale struttura formale, che crea una atmosfera in cui dilaga il piacevole e vago afrore dell’ironia; il suo pensiero inizia come un rigagnolo d’acqua pura che incede a zig-zag, procedendo tra il blocco di ostruzioni del terreno e le parti libere arriva a disegnare una lucida scia fino al fiume del pensiero portante, già situato nella mente dell’autore e nel quale ti accoglie, ospite atteso, in barca, con tutte le dovute gentilezze, ma senza ipocrisie.
Magrelli, nella sua scrittura, si mette a nudo, talvolta le sue narrazioni sono così personali che sfiorano l’ingenuità; la sua spontanea sincerità lascia senza parole, e sereni; ad un certo punto del libro si ha la sensazione di conoscerlo e di essere a casa sua, ospite che parla di sé a cuore aperto.
Un testo, quindi, che consiglio vivamente di leggere, nella costruzione simile ad un’ “operetta”, genere teatrale e musicale in cui si alternano brani musicali e parti dialogate (con le sue coloriture di divertisement, era l’alternativa gioiosa ai toni generalmente melodrammatici dell’opera lirica) così come, in questo testo di Magrelli, si alternano parti più propriamente meditative ad altre più scanzonate.
Concludo proponendo un breve estratto del libro che mi ha molto toccato:
“[…] Sono qui seduto e leggo un poeta. Nella sala ci sono molte persone, ma non si fanno sentire. Sono dentro i libri. Qualche volta si muovono fra un foglio e l’altro, come uomini che si rivoltano nel sonno, fra un sogno e l’altro. Come si sta bene in mezzo agli uomini quando leggono. Perché non sono sempre così?” (pag. 37).
Id: 228 Data: 18/09/2009 15:33:30
*
 Gilberto Gavioli - Rivista - Edizioni del Foglio Clandestino
Gilberto Gavioli - Rivista - Edizioni del Foglio Clandestino
Il Foglio Clandestino n. 66/67
Ma per delineare qui i tratti della rivista, riportiamo un breve estratto dal sito dell’editore: “Le edizioni del Foglio Clandestino nascono nel 2005 come sviluppo, quasi inevitabile, dell’esperienza quindicinale dell’omonima pubblicazione, che si occupa di poesia, traduzione e narrativa breve. Inizialmente in veste di ‘fanzine’ [rivista appassionata/amatoriale] underground, gratfettata semplicemente, oggi il formato è quello di un agile libretto in brossura. La scelta di essere un aperiodico controculturale non è mutata, medesima è la spinta che anima ciascun numero.
La pubblicazione scaturiva, nel 1993, dalla passione per la letteratura, la scrittura e con un profondo desiderio di condividerla; la volontà è quella di avvicinare, leggere e diffondere poeti e narratori sconosciuti, riscoprire autori dimenticati, riportare la poesia verso i lettori, puntando sulla forza del testo.”
E in effetti due sono le caratteristiche rilevanti di questa rivista, è controculturale, vi si trovano contenuti di spessore, imbastiti in una cornice di autonomia culturale; La rivista è godibile in tutte le sue parti. Interessante e apprezzabile la “Piccola antologia” proposta in cui trovano spazio nuove voci; ci piace riportare la poesia di Alessio Pardi di Viareggio: “Che una banda di grigio cerchi stanza / dove l’azzurro ha ragioni di spazio / la lice immobile e bianca di luglio. / - vedi allora siamo stati bambini / nel modo giusto, giusta la maniera / di trattenere l’amore-speranza / come si trattiene un pugno di sabbia // perché il vento non conti più niente”. Inoltre “Tra gli scaffali” troviamo il poeta Ferruccio Benzoni a cura di Davide Argnani e testi di Carlo Michelstaedter, filosofo, poeta e artista Goriziano, a cura di Ivan Pozzoni. In “A fil di penna” interessanti gli interventi di Franco Romanò “Etica della scrittura nella società narcisistica” e, di Raffaello Bisso, “La libertà di espressione? Tenetevela!”, breve articolo che termina con una provocazione non da poco: “[…] Qualcuno reagisce all’idea che la libertà di espressione possa essere impedita o bloccata da una legge. Io reagisco, e male, all’idea che questa libertà possa essere ‘garantita’ per legge”, per la cui piena comprensione nell’idea dell’autore, invito a leggere l’articolo per esteso sulla rivista (pag. 7).
Importanti le traduzioni, tra cui quella di René Char ad opera di Pasko Simone, tratta da “Sulla poesia”, eccone un brevissimo estratto: “[…] Non si può cominciare un poema senza una briciola di errore su di sé e sul mondo, senza una pagliuzza d’innocenza nelle prime parole. […]”. E poi traduzioni del poeta argentino Julio Cortàzar a opera di Gianni Toti. Inoltre una bella lettera di Van Gogh al fratello Theo.
Per concludere ci pare che una rivista di tale fatta e autonomia debba continuare ad esistere, è noto l’impegno che richiede mantenere una rivista, e mantenerla ad un buon livello qualitativo, una rivista si regge soprattutto sui lettori che apprezzandola la sostengono, ed è anche noto il ruolo importante che le riviste coprono nel sostenere e nel sviluppare la cultura di un paese, allora l’augurio è che anche “Il Foglio Clandestino”, possa continuare la sua esperienza con il sostegno di molti.
Riportiamo per esteso il sommario della rivista e le modalità di ricezione della stessa:
Il Foglio Clandestino – n. 66/67 – III/2008 nuova serie
SOMMARIO DEL NUMERO DOPPIO
AFILDIPENNA:
Etica della scrittura nella società narcisista di Franco Romanò
La libertà di espressione? Tenetevela! di Raffaello Bisso
TRADUZIONE:
René Char (1907-1988) − Da ‘Sulla poesia’ (I) traduzione di Pasko Simone
Julio Cortázar (1914-1984) traduzione di Gianni Toti
TRA GLI SCAFFALI:
Carlo Michelstaedter (1887-1910) a cura di Ivan Pozzoni
Ferruccio Benzoni (1949-1997) − testimonianze di D. Palmas, M. Raffaeli
e W. Valeri − a cura di Davide Argnani
INTERVENTI
Un mistico all’assalto dei Positivismi. Carlo Michelstaedter di Ivan Pozzoni
Soste in giardino di Sergio Lagrotteria
“L’albero viola”. Poesie di bambini di Sebastiano Aglieco
22 Piccole riflessioni
SFULINGO
E. M. Cioran, ‘divorare il silenzio’ (II)
scelta e traduzione a cura di Massimo Barbaro
LETTERE:
Una lettera di Van Gogh al fratello Theo
POESIA
Angelo M. Ripellino: Qui dentro
Fernando Pessoa: Nulla implorano le tue mani... traduzione di Leonardo Eriu
Piccola antologia: A. Casari, Gilberto Gavioli, A. Pardi, A. Pibiri, G. Quartero,
E. Rodrìguez, A. Rohrwacher, M. Soriano, S. M. Tiraboschi
NARRATIVA
Gemone: Sono nato a Ceuta
Léon Bloy: I prigionieri di Longjumeau
Carola Maspes: Bar Frontiera
Centocinquantarighe: Il viaggio delle montagne di Maria F. Giovelli
L’artista: Matteo Pericoli
Il costo di questo numero doppio (118 pagine) è di 7 euro
Chi non la riceve abitualmente, può richiedere copia del nostro aperiodico Il Foglio Clandestino alla redazione, attraverso la posta elettronica o la casella postale n. 67 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi).
Grazie a tutti per l’attenzione.
*
La pubblicazione è autodiffusa, per ragioni fiscali abbiamo dovuto imporre un costo, 6 euro, e una sorta di abbonamento, ma lo intendiamo, e sempre sarà così, come una stretta di mano lungo il viaggio, un sostegno per dare energia alla nostra, comune passione e all’amore per la cultura e la scrittura; la cadenza è aperiodica, segue le energie e gli stimoli del cammino.
Un numero: 6 € – Annuale (4 numeri): 20 € – Sostenitore: da 50 €
I contributi vanno versati sul conto corrente postale n. 37 47 62 07 (compilando un semplice bollettino) intestato a Gilberto Gavioli o con bonifico con il seguente IBAN: IT43 J076 0101 6000 0003 7476 207
www.edizionidelfoglioclandestino.it
poesia@edizionidelfoglioclandestino.it
Id: 220 Data: 31/07/2009 00:57:20
*
 Luisa Contarato - Poesia - Associazione Culturale La Crosera
Luisa Contarato - Poesia - Associazione Culturale La Crosera
Uomini diVersi
Il libro inizia così: “Quando un amorino / scherzoso / scocca nel mucchio / il suo piccolo dardo / e per benevolenza / del vento / ti raggiunge / l’emozione scappa / come una belva / che ruggisce / tutta la sua voglia / di libertà / e devi lasciarla andare / per un po’ / prima di cominciare / a cercarla. / […]”. Forse l’amore è uno scherzo, forse arriva per caso, ti raggiunge nel mucchio, senza aspettartelo, quando tutto sembra portarti altrove, ma quando ti raggiunge entra nel cuore la stessa forza di una belva da troppo tempo in cattività. La Contarato parla di un’esperienza comune ma universale, parla d’amore, delle inevitabili e coinvolgenti sensazioni che possono sorgere da un mondo sopito sotto il quotidiano fluire dell’esistenza, parla del gioco di forza dell’amore, parla di relazioni in equilibrio tra la gioia e il dolore, disperse nel grande mare dell’amore, della fatica e del suo inevitabile scoccare come scintilla in una vita, amore come necessità e sufficienza, il suo inevitabile attorcigliarsi intorno a incomprensioni, l’evolversi inesorabile della delusione, di perdite e ritorni.
L’intero libro è un continuum in forma di pensieri, parole e corpi. I soggetti sono uomo e donna, alla ricerca di una diversità che possa sfociare nella sintesi che superi tutta la conflittualità di cui i “diversi”, in potenza, sono portatori. L’autrice maneggia con decisione la multiforme materia dell’amore, prova a capire gli uomini, a tratti pare li conosca, li mostra nella loro nudità creaturale, ne rileva l’arroganza, talvolta la miseria, con molta ironia, ma anche amarezza. Gli uomini qui mostrati appaiono tutti appartenere ad un medesimo ceto sociale, quello della borghesia benestante che ha cose e con esse pensa di poter abbagliare le donne: “Abbagli le donne / con qualche anello fasullo / e sorridi / sopra il tuo fuoristrada / due parcheggi d’ingombro / per dire al mondo / se per caso / non se ne fosse / accorto/ che tu nella vita / ti muovi / con ben quattro ruote motrici!” (“Suv…via”, pag. 25). Ma quando l’amore ha dalla sua anche il contesto che lo custodisce, lo amplifica, allora è come vivere una fiaba i cui contoni sono così mostrati: “Il più bel Natale / l’ho trascorso con te. / Nella notte / era caduta tanta neve / disegnando silenziosa / i contorni di una fiaba. / E noi due / più incantati / ad ogni passo / la mia mano / nella tua / dentro la tua tasca…” (“I contorni di una fiaba”, pag. 56).
Dal punto di vista dello stile poetico, è un libro che ha una sua coerenza, i versi sono brevi, scorrevoli, una certa cadenza musicale conduce l’intera raccolta. Ho potuto però rilevare, qua e là, qualche poesia più debole, in cui l’autrice cede, talvolta, al troppo discorsivo, ma nell’insieme la raccolta regge, è gradevole e mi sentirei di consigliarla a certe mie care amiche, e lo farò.
Una ultima nota, essendo il libro non distribuito nelle librerie (non ha il codice ISBN) in quanto pubblicato con il sostegno della Associazione Culturale La Crosera, e con l’ausilio di qualche sponsor che risulta in terza di copertina, qualora qualche lettore avesse il desiderio di leggerlo potrà contattare la redazione, la quale provvederà, senza impegno, a segnalare la richiesta all’autrice.
Id: 219 Data: 21/07/2009 16:31:02
*
 Francesco De Girolamo - Haiku - Gazebo Verde – Collana di testi brevi
Francesco De Girolamo - Haiku - Gazebo Verde – Collana di testi brevi
Fruscio d’assenza
“Fruscio d’assenza” ha due livelli principali di coinvolgimento, uno è quello in cui ci si lascia trasportare, sull’onda di una lettura più lesta, dalle suggestioni istintive evocate dalle forme e dai colori a cui ogni singolo haiku dà vita, perle di bellezza poetica formale; l’altro è quello in cui ci si ferma sui singoli haiku, magari in una seconda lettura, e si seguono le intuizioni/visioni profonde sulla realtà, evocate dalle metafore e dalle analogie, ci si svela la faccia nascosta del reale, quella sotto la scorza formale degli elementi naturali. Forma stilistica, lessicale e contenuti trovano, nella maestria con cui gli haiku di De Girolamo sono ricamati, una sintesi perfetta che svela armonie. Direi che De Girolamo sia trasportato, nella sua scrittura, dalla necessità di scovare le armonie universali che irradiano la loro luce sulle menti e i cuori che sanno vegliare nella notte (culturale? di valori? sapienziale?…) che ci avvinghia, in attesa che scivoli via il velo impalpabile adagiato sul reale che nasconde le invisibili parvenze delle cose. Con questi abili haiku, l’autore raccoglie le visioni parziali sul mondo in una unica e armonica totalità, la bellezza: “Piccole mani / muovono nella notte / luci segrete.”
E’ molto interessante trovare, nella parte finale del librino, una sezione intitolata “Sette haiku per Gaza”, a significare che la poesia deve sì indagare il reale, la natura, le sue intime relazioni, ma deve essere anche denuncia, verità e politica, quest’ultima intesa al modo di Sophia de Mello, che mi piace qui riportare:. “È la poesia che rende intero il mio stare sulla terra. E poiché è la più profonda implicazione dell’uomo nel reale, la poesia è necessariamente politica e fondamento della politica. La poesia cerca infatti il vero stare sulla terra dell’uomo e perciò non può estraniarsi da quella forma dello stare sulla terra che è la politica. Così come cerca la vera relazione dell’uomo con l’albero o con il fiume, il poeta cerca la vera relazione con gli altri uomini. Questo l’obbliga a cercare ciò che è giusto, questo lo implica in quella ricerca di giustizia che è la politica.”, con questo augurio, rivolto a tutti i poeti e in particolare a De Girolamo, mi sorge spontaneo un grazie per questa brevissima ma splendida raccolta che sa ricordare l’evangelico concetto che nella piccolezza può racchiudersi la grandezza della verità. Concludo proponendo questo suo splendido haiku tratto dalla sezione finale dedicata a Gaza: “Sangue su sangue, / occhi che hanno perduto / ombre d’attesa.”
Id: 218 Data: 24/07/2009 00:09:59
*
 Maurizio Cucchi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Maurizio Cucchi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Vite pulviscolari
Nella sezione finale del libro, intitolata “La traversata” – aperta da questa poesia: “Arrivo al porto con l’ansia / e la gioia dell’avventura. / E’ stato difficile. Voglio dire venir fuori / per vivere. Star dentro / per non morire, e dire: / ventre, acqua, tetto, morbido / cuore, letto.” (pag. 87) – l’autore inizia un viaggio che, per quanto breve, probabilmente della durata di una mezz’ora, simbolicamente è forse il viaggio della vita dell’uomo e della sua nascosta, perché intima, identità di poeta. I ricordi, inevitabili nella mente, si sovrappongono continuamente all’esperienza diretta dell’esistere, che talvolta tocca momenti di rara spensieratezza alleggerendo il carico della vita stessa con il sorriso, nel gioco circostante degli spruzzi delle onde, ma quando il viaggiatore guarda oltre il parapetto della sua imbarcazione, verso l’orizzonte, scende un cupo silenzio e, quasi involontariamente, lo spirito scivola in un prezioso canto, assorbito dalla vastità degli spazi, il viaggiatore, prima svagato, si ritrova poeta a pronunciare questi versi: “[…] Desideroso / di luce e terra l’orizzonte è una lama, / uno specchio che mi cancella.” (pag. 93). In apparente contrasto con “Il marinaio che scende nella botola / con uno straccio, fischiettando” e che, dopo aver svolto, fischiettando (anch’esso quindi svagato come il poeta e comunque vivente nel suo stesso spazio d’esistenza), il suo compito di accendere i motori, “[…] / si aggiusta il berretto sulla fronte / e guarda l’orizzonte, indifferente. / Sa già che presto si rivedrà il paese. // […]” (pag. 96). Il gioco di contrasti sta nel fatto che il poeta, nella novità del suo viaggio, non pensa che rivedrà il paese quasi subito, forse neppure sa quanto tempo sarà necessario, si trova quindi in una sorta di sospensione temporale, dovuta alla breve novità di quella esperienza di viaggio e di abbandono, a differenza del marinaio che governa la nave ed è fautore del proprio destino, il poeta è abbandonato ad una fluida oscillazione che lo porta a investire l’orizzonte di ampi significati e tendenze, mentre il marinaio, nella routine del suo vivere, rimane ormai indifferente, “sa” cosa c’è oltre l’orizzonte. La differenza tra quel marinaio e il poeta sta proprio nel fatto che la vita è recinto di certezze per il primo, incerto confine per il secondo, in questo si delinea quella che potrebbe essere la figura del poeta per Cucchi, una sorta di mistico della natura che sa accogliere le visioni che la mente naturale suggerisce allo spirito della mente.
Sempre in questa sezione finale, con i due versi “Ma che cos’è / il nulla?”, che prendono spunto dalla teoria dello scienziato S. Hawking secondo il quale la materia, nella forma di un buco nero, evaporerebbe lasciando il nulla, Cucchi si avvicina al confine del rapporto tra scienza e poesia: “[…] // Ho sentito la mia voce che diceva: / ‘Tutto è materia, c’è un vorticare / di materia. Fuori, dentro di noi, nel cosmo, in questo sasso / che sto gettando in mare, in quello / che tu chiami il vuoto, o che tu chiami / lo spazio. Aggregazioni varie di materia / orribili e mirabili. Campi e forze, / vibrazioni che creano /materia’.” (pag. 96). E’ molto interessante la capacità dell’autore di entrare nel vivo del rapporto triangolare tra la fisicità dell’uomo, il suo spirito e la fisicità del mondo. E’ come se la conoscenza, per Cucchi, passasse, come già accennato, da “l’esperienza /abrasiva” del mondo ruvido: “Sento le cose ruvide / addosso, mie”, “[…] / succhiare questa sola radice di terra / con ansia, sfiorare questa macchia di morchia. / […]” (pag. 89). Lo spirito dell’uomo cerca di elevarsi sulle ali di un richiamo trascendente innato, ma Cucchi rimane nella terreità azzerando tale richiamo, il poeta, dopo la traversata, è contento di sbarcare e tornare alla certezza della materialità: “[…] // e mettendo già il piede sul suolo / mi fingo a me stesso più goffo / per darmi certezza del felice attrito / col mondo, con la materia / che mi accoglie e accarezza. / Che dolcemente mi azzera.” (pag. 103). Anche dall’orizzonte, che prima sembrava condurre verso qualcosa di vasto in cui annullarsi, trascendendo se stessi, sbuca il ricordo di un tempo vissuto e materiale: “Allora ho pensato a te, / […] alzando / quel poco lo sguardo ho osservato / […] come una suggestione, / […] una forma/ […] Come una nave, / […] che rompeva l’orizzonte […] / emersa da un nero immenso tutto.” (pag. 98).
Ma sia chiaro che la materialità di Cucchi non è materialismo ma anzi egli condanna l’eccesso come degradante e sottraente attrito personale con le cose rendendo superficiale il contatto con esse: “Perché l’eccesso – dico io – distrae, / rende discreto, occasionale, / il tuo attrito vivo con le cose / e ti sottrae, così, vita, valore.” (pag. 102). Nella stimata sezione del libro intitolata “Il denaro e gli oggetti”, Cucchi parla del rapporto con le cose: “[…] / Le cose, vedi, si nutrono di noi, ci assorbono / […] Ma oggi di meno, sempre meno, perché / siamo altrove, schermati. […]” (pag. 69); esse sono diventate oggetto di consumo, non più consumate e assorbenti le nostre vite: “Gli oggetti […] / Erano fatti per resistere, durare anche oltre noi; / […] / Oggi sono […] / impermeabili, scivolano via / di mano, viscidi, io stesso / nel processo del tempo destinato / a questo oceano sgargiante di immondizia”. (pag. 73).
Ho analizzato più a fondo, in queste poche righe, una parte del libro che molto mi ha colpito, perché penso che essa sia l’epilogo dell’intera raccolta, ma molti sono gli interessanti percorsi di pensiero che l’autore propone nelle sette sezioni in cui è suddiviso “Vite pulviscolari”. Ho toccato soltanto alcuni aspetti, che non esauriscono, neppure in minima parte l’ampiezza della poetica di Cucchi. “Vite pulviscolari” è da leggere e rileggere, lascia dell’umano in tasca, se così si può dire, apre la soglia dello spirito del lettore sulla fisicità del mondo, mostrando le cose, gli oggetti, e i loro scenari come inestricabilmente connessi all’uomo, ai suoi sentimenti e al suo pensiero, restituisce valore al mondo, converte lo spirito a un possibile equilibrio fatto di naturalezza. Un libro sul quale ci si può adagiare sereni per approntare un tentativo di slancio verso un probabile, quanto mai soggettivo, slancio di trascendenza ben saldata nella materialità, oltre l’orizzonte degli eventi dove la realtà conosciuta perde consistenza, fondata su scale infinitamente piccole e ripugnanti: “[…] / Ma come darti torto? Eppure / è solo questione di scale, rapporti, microscopi: / solo questione di noi.” (pag. 37).
Id: 207 Data: 26/06/2009 00:49:53
*
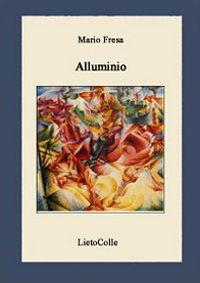 Mario Fresa - Poesia - Collana Aretusa – LietoColle
Mario Fresa - Poesia - Collana Aretusa – LietoColle
Alluminio
Penso che “Alluminio” sia un titolo che richiami la materialità delle poesie di Fresa. L’alluminio è un metallo lucido, riflette, ma di una lucidità leggermente opaca adatta a ricordare quello situazione di luce che bisbiglia dalle palpebre socchiuse in uno stato di dormiveglia nel quale sembra avere avuto luogo il contatto con un mondo immateriale e fluttuante, a tratti vorticante, nel pensiero del soggetto narrante e colloquiante con un mondo di fantasmi, di ricordi, di sensazioni esperite e rinnovate nello stato temporale dell’ora-qui-adesso in cui vengono accolti i “solenni doni” di un “sonno breve” portatore di un presagio di allegrezza che verrà; forse uno stato di dormiveglia indotto da una sorta di depressione esistenziale, di quelle che ci accompagnano, di tanto in tanto, con un corredo di tristezza latente. Rivelatrice di questa situazione interiore potrebbe essere l’epigrafe iniziale al libro, di Ugo da Massa, che recita così: “Ma quanta gioia pare ‘l mio tormento”, che si collega perfettamente alla poesia finale in cui pare realmente che il tormento alla fine dischiuda una sorta di gioia: “Tenue, così, come uno sguardo / labile, magro; / dunque abbàssati nel sonno breve, / l’allegrezza verrà, / non pronunciata, come un esatto, docile bisbiglio. // Dunque tu accogli solenni doni: / pazientemente qui bisogna / rilegarli nella notte dell’ascolto, // nell’alluminio delle superbe luci.”
La poetica di Fresa si innesta perfettamente, a mio avviso, nella sua epoca, un’epoca scientifica, ma anche incerta, in cui la scienza stessa, in certo modo, è portatrice, nei suoi paradigmi fondanti, di tale incertezza, basti pensare al mondo atomico e subatomico, in cui regna la fisica quantistica con il principio di indeterminazione che modifica completamente la nostra percezione classica della realtà: le particelle non seguono più traiettorie precise, ma si muovono entro nuvole di probabilità, hanno comportamenti bizzarri e possono quello che a livello macroscopico non è possibile, a causa dei principi più marcatamente deterministici che lo regolano. La poesia di Fresa ha un comportamento simile ma opposto. La materia della sua poesia ha un aspetto puntuale e di precisione, se si leggono i singoli versi questi risultano scolpiti, hanno un senso logico, scorrono, sono nitidi di sintassi e di significato, ma se allarghiamo lo sguardo sul panorama della sua poesia troviamo un mondo altro, indistinto, ben calibrato ma, in certo qual modo, percettibilmente fumoso, in cui la logica non segue più causa ed effetto; i pensieri sembrano uscire dalla zona inconscia, da strati profondi: elaborazioni casuali della mente.
Nel mondo quantistico-poetico di Fresa escono particelle di senso dal nulla, così come, nella fisica quantica del mondo reale, si possono materializzare particelle dal vuoto, le quali, se non trovano un supporto energetico per prendere forma di materia stabile, tornano nel nulla dal quale sono emerse; tale supporto energetico, nelle poesie di Fresa, risulta essere il mondo delle sensazioni e dei pensieri, l’emotività del poeta, la sua cocente riflessione affettiva: “Poi mi chiedevi un dono, un orologio per contare / le formiche degli assalti, le feste vinte / da un angelo leggero: / una ressa d’introvabili parole che invitava / all’ingegnoso salto nel buio. / Era un docile lamento che imbrogliava la vista / dei giganti: io ti guardavo / ansiosamente stringere la mano / dei penultimi confini.”
Concludo sottolineando lo straordinario coraggio di questo giovane poeta, che ha saputo affermare, almeno in questa raccolta, una poesia di non immediato senso compiuto, legando a se il lettore più esigente, che sa accettare la sfida di un poetare di ricerca che vaga sul confine estremo della percezione e del senso della realtà, in cui nuovi paradigmi poetici sono necessari – penso soprattutto alla lingua poetica.
Id: 191 Data: 29/05/2009 01:17:09
*
 Giampiero Neri - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Giampiero Neri - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Paesaggi inospiti
L’intelligenza analitica di Neri riesce quindi a soddisfare la mente logica e il pensiero emotivo, senza interrompere mai, neppure da una sezione all’altra del libro, e, oserei dire, neppure da un libro ad un altro, quella tessitura leggera tra i vari poemi che li rende nel complesso armoniosi, e che emergono dall’unica e unitaria opera che è la vita stessa del poeta e che traspare dai suoi scritti come meditativa, protesa a ciò che ancora è da esperire nel presente/futuro ma che allo stesso tempo attinge in modo notevole dalle esperienze del passato.
Un elemento molto interessante di questa raccolta – a mio avviso una caratteristica dell’intera opera poetica di Neri – è la forte interconnessione tra il paesaggio umano, fatto di persone e relazioni e luoghi, quali case e strade, e il paesaggio naturale, fatto di animali e ambienti di natura dove essi vivono. Da notare che Neri in gioventù tentò, a Milano, dove la famiglia si trasferì, di portare a compimento gli studi di Scienze Naturali, mai terminati a causa dei problemi economici in cui versava la famiglia, Neri dovette trovare un lavoro e abbandonare gli studi. Ecco quindi che la rilevante connotazione naturalistica delle sue poesie trova giustificazione nella sua mai sopita passione per le scienze naturali, già prefigurata nel bellissimo titolo “Paesaggi inospiti”. La tendenza del poeta ad una analisi quasi scientifica dell’ambiente che lo circonda, si rivela come qualcosa di assolutamente attraente, egli riesce, abilmente e in modo coinvolgente, da osservatore (come farebbe un naturalista), ad avvicinarsi ad animali e ambienti naturali per descriverne, in pulitissimi versi, le caratteristiche fisionomiche e comportamentali; ma il poeta non è uno scienziato che deve scrivere trattati molto lunghi ed fare pubblicazioni sovrabbondanti di termini assai desueti per chi non è del mestiere, egli, in quanto poeta, ha il dono della sintesi fulminea e della libertà di movimento tra i vari livelli del creato, che non è soltanto animale e vegetale, ma è anche umano-sociale e umano-storico. Ha quindi, rispetto a un naturalista, la libertà di porre sul foglio la sua visione d’insieme del tutto, proponendo così uno sguardo unitario sul mondo naturale e sociale.
Nella prima decina di poesie di questa breve raccolta, vi è la descrizione di paesaggi naturali in cui l’unico punto di osservazione è quello del poeta-naturalista, attento osservatore, si ha l’impressione di essere da lui accompagnati in questo silenzioso stare tra l’erba, “Dagli spalti del dosso” in cui “il paesaggio si apre sulla pianura” sotto il cielo in cui volteggia la poiana: “Di questi boschi in partibus infidelium / è abbastanza comune la poiana, / dove qualche spuntone di roccia / e mozziconi di sassi / che si alzano da terra qua e là / offrono asilo e protezione.” Ad un certo punto, esattamente come in una scena teatrale, si affaccia sull’ipotetico palco del libro, la figura di un ragazzo: “Si era affacciato alla terrazza / quel ragazzo sui trampoli. / Stava sul suo aereo sostegno / come un dio campagnolo, / sembrava felice della sua prodezza.”; da lì in poi iniziano ad emergere, dal passato, vicende umane abilmente dispiegate da Neri nei suoi versi: “Via Mainoni odorava di biscotti / appena sfornati. / La grande vetrina della posteria / esponeva due figure di burro / […] / Anno che va, anno che viene, / continuava per qualche giorno il teatro / anche di sera, nella vetrina illuminata.” Via Mainoni ricorre spesso nel libro, è il luogo della memoria, dove, molto probabilmente, si svolse la prima giovinezza di Neri. La maggior parte della narrazione poetica è al passato (si contano su una mano le poesie al presente): “Dalla cucina della casa / di via Mainoni / si vedeva la linea dell’orizzonte / e sullo sfondo una strana costruzione / fra radi alberi, / come una grande macchina scoperta / ferma sulle colline.” Come si può notare il poeta tiene in garbato equilibrio la descrizione dei luoghi dell’uomo e dei luoghi naturali, due realtà, quella umana e quella della natura, che si contendono l’esistenza; è rilevante la spontanea tendenza della natura a esistere nei luoghi umanizzati in cui cerca di riprendere spazi di precedente appartenenza, o inesistenza: “Nella strada che ai lati / ha qualche pianticella di robinia / facevano commerci / i giovani studenti. / Un francobollo delle isole Svalbard, / se mai sono esistite / quelle lontane isole, / l’aveva comperato un ragazzo.”
Il poeta, nel corso della raccolta, è come se preparasse una scena teatrale, dove fare apparire persone attraverso il ricordo, e delle quali talvolta, di poesia in poesia, come di scena in scena, se ne segue la storia: “Nella stessa casa / al numero 5 di via Mainoni / abitava una famiglia milanese. / Una ragazza con uno strano nome / e un giovane allievo della Guardia. / Era difficile vederlo / ma nelle cerimonie ufficiali / portava la bandiera.” In una successiva poesia, si legge: “Di quel giovane alfiere / portabandiera nelle parate ufficiali / non si può tacere il mutamento di rotta / nelle fasi finali della guerra. / era stato accolto nelle file opposte / che andavano ingrossando a vista d’occhio.”
Via via che la lettura procede, le poesie diventano scene sempre più investite di esperienza umana. Il poeta vive la sua giovinezza proprio a cavallo della guerra, da cui non può certo non essere influenzato nel ricordo. Il libro si avvia alla conclusione con alcune poesie che lasciano la scena all’”amico del paradosso”: “Quel fumatore di tabacco nero / preside dell’Istituto Carlo Annoni / era finito nel cerchio di Nomadelfia. / Si lasciava dietro una storia / […] / Soltanto il suo sodale / l’amico del paradosso / era sembrato immune al contagio, / come un indizio della sua diversità.” Tale personaggio sembrerebbe essere un professore della scuola da lui frequentata in gioventù; riporto, a tal proposito, una nota di Daniela Marcheschi sulla vita di Giampiero Neri: “Frequenta con scarso profitto i primi anni dell’Istituto Magistrale ‘Carlo Annoni’ di Erba, dove, peraltro, ha la fortuna di incontrare Gino (Luigi) Fumagalli, un professore di lettere a cui resterà legato con sentimenti dapprima di ammirazione e, in seguito, anche di amicizia. Alcuni detti e atteggiamenti memorabili – per esempio "Mi darete un mondo speciale" – di quest’uomo dal forte impegno umanitario e politico, nel Partito d’Azione, avranno una eco negli scritti di Neri”. Nelle poesie conclusive, Neri traccia, con versi decisi, una linea che parte da quegli anni adolescenziali e lungo la quale prende forma la descrizione della vita di un soggetto che a tratti pare essere il suddetto professore, a tratti pare essere lo stesso autore, in una interessante commistione di identità, tipica di un allievo verso un maestro di idee e di vita. In questo senso Neri non sembra essersi mai sganciato da quella importante figura della sua giovinezza e anzi col passare degli anni essa rimane, dopo aver contribuito a plasmare la visione del mondo del Neri adolescente, certezza e riferimento per una linea di vita e di pensiero.
Un’opera poetica, questo “Paesaggi inospiti”, davvero ben riuscita. Nella sua brevità, una settantina di poesie, rimarrà sicuramente un libro su cui si avvertirà la necessità di tornare, sia come esempio di sobrietà di scrittura poetica, sia per imparare a rivivere i propri ricordi con quell’asciuttezza emotiva tanto caratteristica di Neri.
***
Pubblichiamo di seguito un importante contributo critico di Antonio De Marchi-Gherini, pervenutoci il 12 marzo 2010:
Se dobbiamo crederci, Paesaggi inospiti, dovrebbe essere l’ultima fatica poetica di Giampiero Neri, e titolo mai fu più calzante per i tempi e i luoghi, del corpo e dello spirito, che viviamo in questo primo scorcio del nuovo secolo e del terzo millennio dell’era cristiana.
Come nelle precedenti raccolte, più volte rimaneggiate, accorpate, limate; ‘Paesaggi inospiti’ non è terra di spreco. Si ravvisa una levigatezza di linguaggio e una strutturale e sapiente sintassi classica che è merce rara di questi tempi ,sia in prosa che in poesia.
Linguaggio dicevo, e d’altra parte già sottolineato da più parti, ridotto alla pura essenza, non solo controllo dello scialo verbale ma anche emozionale, questa è la cifra stilistica di Neri, che ne fa un caso unico nel panorama della poesia contemporanea italiana.
Non è neppure regione di canti salmodianti o di tiritere, tanto per riempire pagine, anche se una religione laica, una pietas per gli uomini, gli animali e le cose è ben presente; religione intesa come ‘religo’: tenere insieme, prima che il tempo cancelli tutto.
Il poeta scava minuziosamente in profondità alla ricerca dell’eterna sorgente dell’essere e dell’esserci , qui e ora, con il suo carico di memoria dolente ed euforica ad un tempo. Un euforia particolare, quella gioia che scaturisce per improvvise folgorazioni di memoria che una via, un monumento, una piazza, anche solo una nenia o un profumo, ci riporta magicamente indietro nel tempo, ladro dalle mani rapaci.
Con un amore quasi maniacale, parrebbe che il nostro si trovi più a suo agio con gli animali che con gli esseri umani, e come dargli torto. Queste creature, a volte indifese, non sanno commettere le atrocità che l’uomo d’oggi come quello di ieri è capace di mettere in atto.
Amore per gli animali, anche se a volte usato come pretesto descrittivo, per raccontare altro, che ricordano il Guido Gozzano dei ‘Colloqui’.Ma le sue poesie, da sempre, fanno venire alla memoria le nature ‘morte’ di Morandi. Spoglie all’osso ma con una luce sempre crescente, cambio d’angolo, aggiustamento di prospettiva o ‘occhio di bue’, per illuminare zone d’ombra.
Eppure , pur nel verso libero, le sue poesie hanno un ritmo, una musicalità interiore, il suo, però, è un solfeggiare a togliere, più che a mettere. Quasi a scolpire una sintesi nel granito, più che a scrivere, conscio che tanto rimane poco o nulla di tutto l’affannarsi a vivere e a scrivere.
Per dirla con Paul Valéry: “Quello che colpisce in lui e ce lo rende vivo, è la consapevolezza di sé; dell’essere interamente raccolto entro la propria attenzione; e l’acuta coscienza delle operazioni del pensiero, coscienza così volontaria e così esatta che può fare dell’Io uno strumento la cui infallibilità dipende soltanto dal grado di coscienza che egli ne ha”.
La vita di ognuno diventa paradigma del male e della sofferenza universale: “La madre non ne aveva sopportato il lutto,/ ed era stata trovata annegata/ nella piscina della villa,/ i suoi gioielli in ordine sul bordo/ senza nessun messaggio”. E qui un dolore atroce, quando il poeta aveva solo diciotto anni, dolore che si sommava ad altro dolore di cui, dopo un rovello durato una vita, Neri è riuscito a ‘liberarsi’ calibrando il tiro al millimetro. “Quella mattina di novembre/ aveva visto l’arrivo di suo padre/ davanti alla scalinata del Terragni./ Nell’abbracciarlo la bicicletta era caduta a terra,/ ‘se erano tutti da ammazzare’/ aveva detto ‘doveva essere l’ultimo’”.
Ma come sfuggire all’idea che: “A sentire il contadino/ che guidava il carretto/ l’asino sia stato colpito / da una pallottola vagante/ Si era trovato sulla scena/ di un crocevia conteso/ negli ultimi sussulti della guerra/ e come un eroe di Metastasio/ vi era condotto a morire.” Questi versi, che idealmente chiudono la trilogia iniziata con “L’abito occidentale del vestito” (1976), seguita poi da “Armi e mestieri”(2004) che includeva e arricchiva “Teatro naturale” (1998), hanno la forza quieta della memoria che resta tale come sigillata in istantanee senza tempo, che forse ingialliranno un poco, ma, sia pure con il pudore del nascondimento e la rappresentazione mimetizzata di un “bestiario sociale”, hanno la peculiarità di ridare dignità e senso ai fatti e alla realtà vissuta ma sempre presente.
Il poeta però é cosciente che tutto scorre, o come direbbe un buon buddista, tutto è impermanente, ma lo sforzo e la “fatica” della scrittura è proprio questo remare controcorrente per risalire al punto alfa, da dove nascono e si generano tutti gli eventi del destino personale, epperò universali se è vero, come amava ripetere David Maria Turoldo, che ogni uomo è un’esperienza unica e irripetibile, con tutto il suo carico di eventi, di gioie, di sofferenze, insomma quella che con un termine abusato, ma che trova pochi sinonimi, si chiama vita.
Antonio De Marchi - Gherini
*
Id: 189 Data: 22/05/2009 13:34:53
*
 Guido Ceronetti - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Guido Ceronetti - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Trafitture di tenerezza
Guido Ceronetti è nato a Torino nel 1927. Vive in Toscana. E’ di grande rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, ecc.) sia dall'antico ebraico (Sacra Scrittura), per Einaudi ha tradotto “I Salmi” e “Qohélet”.
“Trafitture di tenerezza” è una “[…] piccola antologia personale di traduzioni in versi, esigua raccolta di frammenti e di schegge, se sarà presa per quel che vuol dire, dovrebbe essere accolta come aiuto a pensare, la bellezza della parola e dell’immagine invaselinando l’accesso difficile al sepolcrale segreto dei mondi che il verso contiene […]”, così si legge nell’introduzione dell’autore.
L’antologia ha circa 130 pagine ed è stata realizzata pescando “[…] nel fiume di quel che ho fatto e dato in mezzo secolo di pubblicazioni, dal latino, greco antico e dimotikì, ebraico biblico e lingue moderne […]”; alcuni testi sono pubblicati per la prima volta.
Vi troviamo traduzioni di Eraclito, Machado, Kavafis, Artaud, Apollinaire, Owen, Racine, Shakespeare, Weiss, Blake, Virgilio, Celan, Rimbaud, Mallarmé, Rilke, Zola, Orazio, Marziale, Sofocle pezzi tratti dall’Antico Testamento – Giobbe, Isaia, Geremia, Qohélet – e finanche la traduzione del bellissimo prologo del Vangelo di Giovanni: “[…] // Un uomo, inviato di Dio, sorse / Era il suo nome Ioànes. / A fornire la prova era venuto / Così che per suo tramite noi tutti / La Luce da lui preannunciata convincesse. / La Luce non era lui: da lei venendo / Annunciava. / Finché la Luce vera / Nel mondo apparve: quella che fa / Di ciascun uomo una luce. / Ma nel mondo da lei plasmato / Nel mondo del suo apparire / Passò e non fu notata. / […]”, che invito a confrontare con la più famosa traduzione della “Bibbia di Gerusalemme” (Giovanni 1, 6-10) che contiene la altrettanto bella traduzione ufficiale della Chiesa Cattolica, vidimata dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Il lavoro del traduttore, come dicevo anche in altra recensione, non è facile, è anzi lavoro carico di responsabilità, in particolar modo verso coloro che non conoscono la lingua da cui proviene il testo tradotto. Immagino in particolare i testi provenienti dall’ebraico o dal greco antico, dominio di pochi e ferrati studiosi.
Sicuramente Ceronetti mette un personale accento interpretativo nelle sue traduzioni. Non conosco l’ebraico, ma ho modo di confrontare traduzioni dal francese e capire che Ceronetti interpreta e addolcisce i versi cercando il senso dell’insieme, il leitmotiv portante, costruendo la frase, talvolta deformandola, secondo la logica sintattica della lingua in cui è tradotta, ecco un esempio con una poesia che amo molto, “L’Éternité”, di Arthur Rimbaud: “Elle est retrovée. / Quoi? – L’Éternité. / C’est la mer alléè / Avec le soleil // […]”, che Ceronetti traduce così: “Riconquistata è l’Eternità. / Il mare e il sole insieme / Sono spariti // […]”, e che io avrei invece tradotto così: “E’ ritrovata. / Che cosa? – L’Eternità. / E’ il mare in comunione / Con il sole // […]”.
Una bella e godibile antologia, impegnativa per la varietà di autori e testi proposti, quantunque siano ben addomesticati da Ceronetti, uomo di straordinaria erudizione e di fine sensibilità umanistica.
Id: 188 Data: 19/05/2009 14:33:54
*
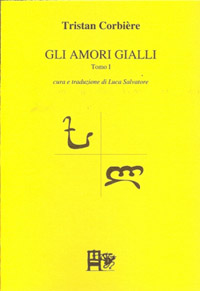 Tristan Corbière - Poesia - Edizioni del Foglio Clandestino
Tristan Corbière - Poesia - Edizioni del Foglio Clandestino
Gli amori gialli – Tomo I
Cura e traduzione di Luca Salvatore
Quando si legge una raccolta di poesie tradotte, in questo caso dal francese all’italiano, e tali poesie piacciono, cioè risuonano nel lettore dense di musica e significato, allora gran merito va anche al traduttore, non solo al poeta. La traduzione di Luca Salvatore, condotta sull'originale del 1873, è puntualmente letterale, conservando la punteggiatura e l’ortografia del testo originale; il traduttore non si occupa tanto di mantenere la rima, presente nei testi di Corbière, quanto invece di far passare, nel sistema linguistico in cui è tradotta, la musicalità dei significati delle parole, sia nella loro singola specificità di senso, sia nel loro concatenarsi ad altre all’interno di un poema, attraverso assonanze che nell’insieme danno ritmo al testo e rendono al meglio lo spessore poetico dell’autore. Salvatore ha quindi effettuato una traduzione piacevole e intelligente, semplice, fluida e trasparente. Non si può certo tralasciare di sottolineare la piacevolezza della veste grafica di questo volumetto giallo, tomo I, de “Les amours jaunes”, edito, in trecento copie numerate, dalle stimate edizioni del Foglio Clandestino, con testo originale a fronte.
Del bretone Tristan Corbière, riporto qui di seguito alcune brevi ma interessanti indicazioni biografiche. Il nome del poeta è lo pseudonimo di Édouard-Joachim Corbière, nato a Morlaix il 18 luglio 1845 e morto, d’artrosi e tisi, il 1 marzo 1875.
Tristan ebbe una vita vagabonda. Si stabilì a Roscoff in una casa di proprietà dei suoi genitori. Gli abitanti del paese lo soprannominarono l’“Ankou”, cioè “lo spettro della morte”, a causa della sua magrezza e della sua andatura dinoccolata. Il poeta, che sognava di essere marinaio, non potrà soddisfare il suo desiderio di imbarcarsi su una nave, ma amerà il mare con passione.
Persona eccentrica lo si troverà vestito da donna o da mendicante, o ancora, nel corso di una visita a Roma, porterà a passeggio al guinzaglio un maiale travestito da vescovo, durante i festeggiamenti del carnevale ai quali assistette il Papa.
La sua musa fu la giovane attrice parigina Armida Josefina Cuchiani, che Corbière ribattezzò “Marcelle”. Sì nutrì delle opere dei maestri del Decadentismo francese, quali Hugo, Baudelaire e Musset.
Pubblica nel 1873, a spese del padre, la sua unica raccolta di poesie, “Les Amours jaunes”, che passa inosservata. Tristan, che non conosce alcun successo nel corso della sua vita, è una scoperta postuma di Verlaine, che gli consacra un capitolo del suo saggio “Les Poètes maudits” (1883). “Les Amours jaunes” si trovano anche ben collocati nella raffinata biblioteca di Des Esseintes, il protagonista di “À Rebours”: la sua presenza nell'opera di Huysmans contribuirà a far conoscere Corbière ad un più vasto pubblico.
La raccolta “Gli amori gialli” ha una forte connotazione di modernità: essendo Corbière di dieci anni più anziano di Rimbaud, ne sembra il precursore, per un certo stile di rottura degli schemi classici. La sua opera poetica è incisiva, saggiamente complessa e stimabile, incomprensibile a tratti nella sua genialità un poco visionaria; si capisce come non abbia avuto il giusto successo ai suoi tempi, così come non lo ebbe il più famoso Rimbaud, entrambi debitori al poeta Verlaine che seppe riconoscere i semi della modernità, sia nell’opera di Rimbaud che in quella di Corbière.
Tristan fu intimamente apolide, ma allo stesso tempo pienamente inserito nell’anima della propria patria, nella sua cultura; un suo poema molto bello recita così: “[…] // – La mia patria… il mondo intero; / E, dato che il pianeta è rotondo, / Non temo di vederne la fine… / La mia patria è dove la pianto: / mare o terra, sotto la pianta / Dei miei piedi – quando mi reggo in piedi. // - Quando sono coricato: la mia patria / E’ il letto solo e pesto / Dove stringerò tra le mie braccia / La mia metà, come me senz’anima; / E la mia metà: è una donna… / Una donna che non ho. // […] // – Dovunque morirò: la mia patria / S’aprirà, senza che io la supplichi, / Quanto basta per il mio sudario… / D’altronde un sudario: a che serve? / Visto che la mia patria è sotto terra / le mie ossa ci andranno da sole…”, (tratto da "Paria", pagina 271)
La scrittura, per Corbière, pare uno specchio davanti al quale egli riceve, riflessi, i propri tratti somatici, uno specchio che riflette una realtà interpretata dai sensi dello scrittore, e rimandata al lettore in una sorta di auto-giudizio, qualche volta impietoso, come ad esempio nel già citato testo “Paria” o in “Il rospo”. Il termine “paria” viene attribuito a persone di infima condizione sociale, che vivono nell’isolamento rispetto alla maggioranza (emarginati); egli attribuisce a sé stesso tale termine, ma lo fa evocando, con versi caratteristicamente sincopati e incisivi, una sorta di evangelica positività: “[…] // Il mio pensiero è un soffio arido: / E’ l’aria. L’aria mi appartiene ovunque. / E la mia parola è l’eco vuota / Che non dice niente – ed è tutto. // […]”. In “Il rospo” si identifica con l’omonimo anfibio: “[…] // – Un rospo! – Perché quest’ansia, / […] / Usignolo del fango… – Orrore! – // Buonasera – quel rospo sono io” (pagina 103). Commovente l’affermazione “Usignolo del fango”: se da una parte Corbière pare identificarsi, a causa delle sue condizioni esistenziali contingenti, con il rospo in quanto abitante del fango, dall’altra egli si sente intimamente diverso rispetto a tale rimando visivo, si direbbe l’opposto, un usignolo, essendo questo, in quanto volatile, capace di librarsi liberamente nell’aria e ben lontano dalla fanghiglia, habitat del rospo. Ma egli, probabilmente, riflette nella figura del rospo la visione che pensa che gli altri si siano fatta di lui, in quanto il rospo gracida, mentre l’usignolo ha un canto piacevole e il cui ascolto è auspicabile. Egli è poeta dal canto di un usignolo mentre il mondo intorno lo tiene invisibile a terra disgustosamente gracidante nel fango.
Nel giovane Corbière v’è una sorta di urgenza di scrivere, come se la Gloria, tanto cercata nella scrittura, non attenda il domani; nella poesia egli trova una motivazione di vita e la redenzione dalla miseria, il suo personale riscatto, vi vede la gloria perché è la sua intima vocazione: “[…] // Oh, la primavera! Voglio scrivere! / Passami il mio mozzone di matita / - Il mio mozzone di matita è la mia lira - / E – qua – io mi sento una saetta. // Alla svelta!… Ho visto, nel mio delirio, / Venire a sfamarsi nella mano / La Gloria che voleva darmi una scorsa! / - La Gloria non aspetta domani. - // […] // Avremo soldi a palate / Quando avrò corretto le mie bozze! / - Per vivere, bisogna arrangiar quattrini… // […] // A me la prova d’immortale / Dei grandi poeti che ho letto! // […]”, (tratto da “Un giovane che se ne va”, pagina 87). Ma, ahimé, si sa che la poesia raramente dà il pane quotidiano, e anzi ha lasciato alla fame molti poeti. Soltanto diversi anni dopo la sua morte arrivò la gloria, egli fu riconosciuto e stimato poeta. Come già accennato Verlaine, nel 1883, di lui scrisse: “Tristan Corbière fu Bretone, uomo di mare, e lo sdegnoso per eccellenza, aes triplex. Bretone, cattolico che prova poco la sua fede, ma credente ossessionato; marinaio senza averne la spocchia e soprattutto la sete insaziabile, ma votato furiosamente al mare che solcava solo quand’era in tempesta, incredibilmente focoso sulla più focosa delle cavalle. (Di lui si raccontano prodigi d’imprudenza folle). Incurante del Successo e della Gloria al punto da avere l’aria di sfidare quei due imbecilli, senza mostrargli un briciolo di pietà!
Passiamo sopra l’uomo, che fu grandissimo, e parliamo del Poeta. Come rimatore e come prosodista non ha nulla d’impeccabile, cioè a dire di disgustoso. […] Gli impeccabili, quelli sono… un po’ di tutto. Legno, legno e nient’altro che legno. Corbière era fatto di carne ed ossa, semplicemente”. Bellissima descrizione, ma devo dire che non sono pienamente d’accordo, mi si perdoni la presunzione, su ciò che afferma Verlaine sul fatto che fu “incurante del Successo e della Gloria”, anzi, la sua ansia esistenziale aveva come unica meta e sfogo, a mio avviso, la gloria e il successo, che non significa certo bramosia, ma anzi mi pare che gloria e successo possano essere una possibile conseguenza naturale di uno spirito inquieto e un’intelligenza acuta.
Tristan Corbière è un poeta dalla scrittura decisa, che sa affondare con ironia e determinazione la sua parola nei punti nevralgici della propria esistenza, un poeta che sa guardare a sé stesso con sarcasmo, simpatia e serietà, le cui poesie sono dense di significati esistenziali, assolutamente da leggere a piccole dosi o tutte d’un fiato.
Id: 183 Data: 30/04/2009 20:32:10
*
 Carmen Grattacaso - Poesia - Edizioni Gazebo
Carmen Grattacaso - Poesia - Edizioni Gazebo
Il sospetto e la lusinga
L’intelligente e quanto mai azzeccata riflessione sulla poetica dell’autrice, che avvia alla lettura della raccolta, a cura dello stimato professore e poeta Luigi Fontanella, e intitolata “Tra l’osare e il ritirarsi”, mi pare che possa essere presa a parafrasi del titolo della plaquette. Fontanella scrive: “[…] sarei tentato di definire la poesia di Carmen del ‘disamore e della disillusione’, ma sarebbe una definizione tutto sommato riduttiva, ché subito la sinuosità della versificazione di questi suoi testi coinvolge e conquista il lettore. […]”. Una sinuosità non tortuosa né ambigua né ingannevole ma che invece procede sicura, dal primo poema fino all’ultimo, trasportando il lettore, attraverso l’asciuttezza dei versi, nel mondo di una donna, madre premurosa e donna d'amore, “[…] // Un intero mondo per un quadro incompleto / da appendere quando nessuno guarda / su una parete obliqua.”, (pag. 11). Se c’è una effettiva diversità tra l’uomo e la donna, è nella capacità decisamente preminente di quest’ultima, rispetto all’uomo, di saper accogliere e soffrire per amore. L’accoglienza, in particolare, è dono quasi istintivo connaturale alla sua potenzialità di essere madre: “Come una madre sulla porta di casa / coprirei di premure il mio prigioniero, / incautamente trascinando via l’anima / dal suo posto tranquillo”, (pag. 10). Correlata alla sua particolare propensione all’accoglienza vi è il suo saper patire per amore, che equivale al saper molto amare, e quindi, a mio avviso, di nuovo, la capacità di essere madre, ruolo che la donna sa vivere in modo completo, anche senza avere necessariamente vissuto la gravidanza fisica, amando fino a trasformarsi in qualcosa d’altro, cedendo la propria parte di vita al soggetto d’amore e collocandosi nel giusto ruolo, onde arrivare a vivere da un punto di vista privilegiato le trame della commedia umana: “Grazie a te mi trasformo / in un’attrice non protagonista. / Cammino, ti sto dietro, / recito le battute. // E’ un compito importante: esserci / per mostrare te, / unico commediante.”, (pag. 16). Nella trasformazione, che è poi un tentativo di incontro, ci si può ritrovare, dantescamente parlando, a fermarsi nel bosco delle diversità e delle incomprensioni, ma prima di perdersi completamente, rischiando di non incontrarsi più, ci si può fermare: “[…] // Mi fermo nel bosco / […] / sepolta dagli abbandoni, / tremante nell’accoglierti.”, (pag. 21). Soltanto nell’abbraccio ritrovato tra i corpi, “Un corpo. L’altro”, si ricompone il mondo che si era oscurato dietro il muro, “abitato dolore venirmi nel profondo”, è la pace ciò che piace, “Così mi piace. A fare pace”, “la casa ridiventa casa / […] / il cuore è cuore”.
Carmen Grattacaso narra al lettore, in poche e vigorose poesie, i suoi umori, che appaiono sempre pacati e sereni, come a voler dare un senso di vita alle vicende anche di abbandono e divisione. Ma la cosa interessante è che queste poesie sembrano riflessioni personali, pagine di un diario dell’anima, con le sue propensioni e strategie, intelligenti e faticose, talvolta rare oasi di unione con un tu, vi si leggono sentimenti, ma la loro sapiente esposizione in versi, ben pesata nelle parole, fino alla nitidezza di ogni pagina scritta, rende e amplifica nel lettore una sorta di serenità, regalando pagine di accorta e sapienziale poesia: “Non è la notte che mette buio nelle case. // Sono le porte / quando si chiudono forte / alla nostra richiesta di entrare.”, (pag. 30).
Id: 180 Data: 17/04/2009 01:23:56
*
 Michelangelo Tocci - Poesia - Editrice Nuovi Autori
Michelangelo Tocci - Poesia - Editrice Nuovi Autori
Di aria e di vita
In molti testi di Tocci viene evocata la figura del bambino, che egli trova in sé stesso o vede trasferito in reali sembianze fanciullesche che descrive: “[…] / Poi quella lacrima dopo una lunga corsa finì / a terra, il bambino la guardò a lungo, forse egli vide davvero in quel momento, la sospensione / della vita fra cielo e terra.”, (Fra cielo e terra, pag. 18). E negli elementi naturali, costantemente presenti, come panorama di uno stato onirico latente e persistente in tutta la raccolta, trova la via del ritorno allo stato e alle sensazioni iniziali della vita: “Mastica la pioggia per sentire l’odore del fiume. / Stringi in petto emozioni rare per ascoltare il tuo / lontano canto di bambino. / […]”, (L’uomo che sognai, pag. 19).
Come dicevo, ci sono sicuramente, nella raccolta, molti elementi principe per una poesia nostalgico/esistenziale: lacrime, pioggia, pelle, carezze, alba, battiti, odori, dolori, bagliori, respiri, destini, fiumi, amori, viaggi, tempo, dune, morte, cielo, notti, inquietudine… Mi pare tuttavia di trovare una eccessiva verbosità all’interno di ciascun poema, tipica, più che della poesia, di una scrittura diaristica occasionale che non bada alla forma e alla sostanza quanto alle sensazioni, le proprie, e non trova, ma forse non lo necessita, un concreto e fattivo riscontro in altri (almeno dovrebbe averlo trovato tra coloro che hanno editato il libro, questione in cui non voglio entrare, perché troppe sono le variabili che regolano la pubblicazione di un testo, anche, naturalmente, a discolpa degli editori), per un possibile e oggettivo lavoro di limatura dei versi, al fine di ridurre i testi all’essenza del linguaggio, tanto necessaria affinché la poesia sia buona poesia. Tocci ha sicuramente capacità di scrittura, ma devo essere onesto con questo libro, dicendo che un buon lavoro di ripulitura avrebbe reso brillanti molti testi, invece offuscati da una sorta di “pignoleria descrittiva” (che affligge gran parte della poesia dilettantistica) – tale ripulitura avrebbe ridotto i testi almeno del cinquanta per cento. Riporto qui alcuni versi estratti da poesie molto più ampie, versi che a mio avviso, da soli, sono poesie incisive, quasi delle massime esistenziali: “[…] // Un giorno ti sveglierai, immaginando la tua / ombra a spasso per cieli e terre dove mai posasti / il tuo timido guardare. // […]”, (Padri, pag. 12). Inoltre: “[…] // Raggiungerò la felicità contando i drammi, i / terrori e le certezze del cuore. // […]”, (Mi raccontai al di qua della soglia, pag. 17). “[…] // Mi ritrovai vecchio, a inseguire cuori che / battevano.”, (pag. 24). “Mille abbracci per consolidare una vita. / Mille vite per abbracciarne una. / […]”, (pag. 25). “[…] / Vita di giorni rari, che ti perde e ti ritrova, là / dove la tua ricerca è cominciata.”, (pag. 26). Infine una bellissima poesia: “Luna piena di una notte, in cui ascoltai / il caldo soffio del mio respiro. / Un respiro caldo, come quella tenue luce / che mi apparteneva. / In mezzo alla grandezza di quella notte, mi / sentii piccolo ma vivo di navigare in / quell’universo immenso.”, (pag. 30).
In conclusione i miei più vivi complimenti a Tocci che osa confrontarsi con la poesia esistenziale, e non me ne vogliano gli editori se consiglio, talvolta, un più deciso e rigoroso, nonché lodevole, lavoro di editing sui testi pubblicati.
Id: 174 Data: 06/04/2009 23:45:56
*
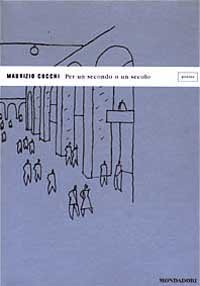 Maurizio Cucchi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Maurizio Cucchi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Per un secondo o un secolo
Il viaggio non è più possibile ormai, forse è andata persa quella spontanea enfasi di avventura, rimangono visioni nelle rughe: “L’oscillazione è semplice: tra avventura e angoscia. Ma chi è più forte: chi se ne va o chi resta? Ecco l’idea, estrema, dell’inoltrarsi. […] Però si intrecciano tra memoria e sogno queste visioni nelle rughe […]”.
Il poeta è forse più portato a compiere viaggi nel silenzio della luce, nelle forme, nei colori e nella semplicità di gesti congiunti, viaggi che avvengono in continuazione, senza sosta e senza una apparente meta. Ma, a ben vedere, una meta pare esserci, ed è la pace, una sorta di beatitudine che deriva dalla pausa dopo il molto andare a vuoto. Bellissima la poesia “Da Rimbaud – Al Cabaret Vert – le cinque della sera”: “Camminavo da una settimana e le mie scarpe erano a pezzi. / Sono entrato in città e al Cabaret Vert / ho chiesto pane, burro e prosciutto tiepido. / Ho steso le gambe sotto il tavolo verde, beato, / […] / ma che incanto quando la ragazza dai seni enormi e dagli occhi acuti / mi ha portato il prosciutto in un piatto colorato! / […] / e mi ha riempito un boccale immenso con la sua bella schiuma / dorata da un ultimo raggio di sole”.
Si può leggere l’intera raccolta alla luce della ricerca dello “star bene”, cioè della pace, una pace nello “schifo”, parola o concetto che sovente appare nel libro; la pace come bellezza, armonia che scaturisce dallo star bene con le persone, con sé stessi, è semplicità di intenti, virtù talvolta assente nel cuore dell’uomo, e del poeta in particolare, assenza che sbilancia verso il disagio e l’angoscia: “Cerchi le vette formidabili, le luci polari, / le bianche vastità dell’avventura, / ma poi trovi il ghiaccio dentro / e un buco nel cervello / ti crea il panico, ti disorienta / tra il bancone del bar e il portone di casa. / […]”.
Appaiono, inoltre, in questa breve ma intensa raccolta, molte interessanti sfaccettature della psicologia umana. In particolare mi ha colpito la forte connotazione, mi si passi la parola, "egoistica" dei testi, nel senso che attraverso di essi l'autore rivolge molta attenzione alle proprie percezioni, più o meno emotive, tendenza così esplicitata: “Non ho voluto mai sapere il contenuto, / la trama, il meccanismo del giocattolo. / Neppure da bambino, indifferente / agli ingranaggi, a quello che c’è dentro. / Ma per fortuna non sono più / l’esangue fanciullo sparuto / e mi ha salvato l’egoismo”. Materialità, sensazioni, affetti, amicizia (“[…] Ma la materia, / Marco, è solidissima e lieve, / che quasi vola nelle forme / astratte o di pasta, vivide / dei suoi colori, nel gioco / dei suoi fili che vagano / e si intrecciano. / […]”), tutto è rivolto a sé, come verso un unico grande attrattore, il centro di un universo che appare in disagio. A questo centro viene riportato ogni debole tentativo di fuga: “Chi è quello che va lassù, / lento sulla cresta a mento basso, / sagoma ombrosa che si accende di sé?”. Ma questa sorta di egoismo cosmico dell’uomo, viene trasfigurato dalla musicalità dei versi che diventano, per il poeta, una sorta di danza liberatoria che lo conduce verso un sé stesso nuovo, dove l’amicizia o l’amore sono il lago dell’incontro dei fiumi che scorrendo, costretti, giungono, dalle gole impervie dell'io, a sfociare, con i desideri più intimi, in una sorta di unità ritrovata: “Questa volta ho sognato / che ci siamo persi in due / nell’incubo nebbioso, / accogliente, della periferia / […]”. Ma tale pace sembra avere soltanto un carattere transitorio. Un bel libro, consigliato in particolare a coloro che vogliano imparare la scrittura in versi a partire dal proprio vissuto quotidiano, imparando da quella acutezza e quella nettezza tipica di Cucchi: “M’infilo nel portafogli del mio letto / come una carta d’identità scaduta. / Amo, del resto, questa mia fronte spaziosa / che giorno per giorno immagino e coltivo”.
Id: 169 Data: 20/03/2009 15:46:51
*
 Cesare Benedetti - Poesia - Ed. Ss.ma Annunziata
Cesare Benedetti - Poesia - Ed. Ss.ma Annunziata
Il tempo breve
Lo conobbi nel 1989, quando, ventunenne, mi convertii alla fede cristiano-cattolica. Arrivai, perfetto sconosciuto, nella sua parrocchia, animato da un fervore giovanile evidente, e trovai questo parroco dai modi semplici e cordiali, attento e capace di un grande ascolto. Mi accolse nella sua comunità. Da allora molte vicende sono accadute, tra cui quella di scoprirci legati non soltanto per la comune fede in Cristo risorto ma anche per l’amore verso la scrittura poetica. Un giorno mi regalò un libro intitolato “Il tempo breve”, l’unica sua raccolta poetica stampata, almeno fino ad oggi. E’ un diario che annota, in modo pacato, il fluire delle sue percezioni, di uomo e di sacerdote, nello scorrere delle stagioni che, ciclicamente, procedono e che metaforicamente simboleggiano le stagioni della vita. La sua poesia è talvolta un sussurro. E’ ricorrente una sorta di ritorno alle origini, all’infanzia e alla giovinezza, racconta di elementi naturali genuini, di alberi, di stelle, di paesi, di vicende umane legate alla terra, parla di gente umile, di contadini, di persone che vivono la loro vita nel segreto della loro anima, dove egli, per grazia ricevuta, per ministero di confessore amorevole e capace di un ascolto profondo, ma anche per propria dote, riesce a entrare in punta di piedi, sapendo sempre alleggerire quel carico di stanchezza e di sconforto, capacità di cui è pregna la sua poesia: “Se lacrime scenderanno / calde a irrigare volti / e cuori che l’arsura / di bruciate stagioni / ha pietrificato, / rivivranno le pietre / per dar forma alla casa / che l’insonne insipienza / ha impedito di sognare: / casa sulla roccia / costruita sulle volute / leggere di una Parola / seminata dal vento / per farne edificio d’Amore”.
Non mancano poesie più severe, non certo di condanna ma di domanda, perché questo è il modo cristiano di portare l’uomo alla conversione, verso una qualità di vita che sia rispettosa della dignità personale e altrui: non attraverso una imposizione dogmatica, ma con una domanda ben posta alla ragione, alla coscienza libera di ogni individuo; così, in “Un pessimo affare”, denuncia l’asservimento della propria spontaneità alle tendenze consumistiche del tempo moderno : “Dove prendi, amico, / i soldi per gli stivaletti / all’ultima moda? // Dove prendi energie / per questo totale asservimento? // Finanziariamente parlando / contrattare la libertà / è un pessimo affare; / non si compra / perché non ha prezzo, però si può vendere / e per meno di trenta denari”.
Ma soprattutto in questo libro si rimane affascinati dall’amore di un uomo verso il proprio Dio. Un uomo carico della sua umanità. E’ forte, in Don Benedetti, ed è evidente nei suoi testi, la necessità di essere uomini interi, con i propri limiti e le proprie aspirazioni più sincere, sia all’inizio che durante il cammino di fede, il quale diventa, man mano che si procede, il luogo di incontro con la persona di Cristo, a significare che Dio non necessita di santi ma di uomini che, inconsapevolmente, e quindi umilmente, diventino santi nel dono di sé e del proprio carico di debolezze a Dio: “[…] // Era pur questo / il tempo di consocerti; / era pur questo / il tempo breve d’amarti / e d’amare. / Io come ragno nella sua tela, / Tu come goccia di rugiada / a illuminarla: / stella del mattino imbrigliata / nel mio piccolo firmamento”.
Come è nello stile di vita di Don Cesare, non mancano vibranti poesie di denuncia dell’ingiustizia: “Si spegne morendo / ogni giorno la voce di chi…/ non ha voce // E’ la morte il silenzio dei poveri / la morte la loro vendetta / la morte la loro vittoria / perché Dio prenderà in prestito / le loro mani tese. // E’ la morte dei poveri / il giudizio del mondo, / la voce di Dio / il loro silenzio”. Un poeta, un sacerdote, ma soprattutto un uomo capace di stupirsi e di porsi le stesse domande, sia all’inizio che nel mezzo del proprio cammino, a significare che mai si arriva ma sempre si parte: “Tendo l’orecchio / alla sera, dimesse / sono le voci del giorno / mentre fuori / non è rimasto / che il latrato dei cani / al chiarore freddo / della luna / ed il rumore di un treno / che fugge lontano / nel buio della notte / verso l’alba / di un altro giorno”. Un sentito grazie per quella fede sincera che ha saputo trasmettermi e coltivare, ancora oggi nella lettura di queste belle poesie e in particolare in questa, intitolata “Grazie”, un canto: “Ti ringrazio, Signore / per il profumo / che hai dato / alle viole; / per le spine / che lasci / alle rose; / per l’azzurro / del cielo / che hai donato / al mare; / per il candore / che hai donato / alla neve; / […] / per la vita / nel tempo / che hai dato / alle cose; / per la vita / nell’eternità / che hai donato / anche a me. // Ti ringrazio, Signore / per il profumo / che hai dato / alle viole…”.
P.S. Il libro non è distribuito. Chi desiderasse leggerlo può rivolgersi alla redazione de larecherche.it: redazione@larecherche.it , provvederemo in qualche modo.
Id: 167 Data: 17/03/2009 23:00:04
*
 Franco Buffoni - Narrativa - Luca Sossella Editore
Franco Buffoni - Narrativa - Luca Sossella Editore
Più luce, padre
Abbiamo già avuto modo di leggere, su questo stesso sito, un’intervista allo scrittore Franco Buffoni (si veda tra le interviste). Una persona gradevole e ospitale che ci ha entusiasmato con il suo carattere franco, appunto, con la sua fervida intelligenza, la sua sana ironia e la sua vasta cultura.
“Più luce, padre”, come egli stesso ci disse, è il libro che avrebbe voluto scrivere da sempre. Egli espone, in un dialogo serrato tra nipote e zio, la sua Weltanschauung, una visione del mondo che, senza mezzi termini, espone con eleganza formale. Come il sottotitolo ci enuncia, è un trattato su Dio, la guerra e l’omosessualità. In relazione a tali tematiche bisogna riconoscere a questo scrittore il coraggio di andare contro il pensiero dominante di perbenismo che talvolta soffoca le coscienze, cristiane e non cristiane.
Con ferma convinzione espone, in quasi duecento pagine, idee che difficilmente, andando in chiesa, ascoltando i nostri attuali governanti, o semplicemente leggendo le riviste dozzinali più comuni, possiamo trovare. Alla domanda del nipote: “Quindi Mussolini fece bella figura nel 1936, ma la sua sorte era già segnata?”, risponde lo zio, nel quale l’autore si identifica: “Purtroppo era segnata la sorte dell’Italia, soffocata dalla propaganda (solo così si spiega l’entusiasmo per l’aggressione all’Etiopia coi vescovi cattolici benedicenti), con un capo del governo senza opposizione…”.
Il suo narrare è, a tratti, volutamente altezzoso e provocatorio, riuscendo a far convergere, in questo modo, l’attenzione del lettore su tematiche fondamentali, storiche, sociali e morali: “[…] Ti stavo dicendo che l’esperienza dei soviet è finita male perché mancò la possibilità che fosse una libera scelta anche per chi sarebbe venuto dopo. Da qui la rigidità […] Il comunismo può essere solo il frutto di una libera scelta. E questo vale per atlantide, la città del sole, il regno di utopia. Sono quarant’anni, vedi, che io tento di capire le ragioni dei marxisti. E dei cattolici. Per una volta vorrei che si ascoltassero le mie […]”. Come si fa a non rimanere coinvolti da questo libro che all’inizio appare ostico ma che, pian piano, dona riflessioni acute e decisamente fondamentali sul nostro essere individui e persone sociali? Buffoni si mette dalla parte dell’uomo, chiede uno stato di diritto e non uno stato etico, uno stato che garantisca diritti per tutti, al di là delle convinzioni di fede politica o religiosa, uno stato universale dell’uomo e per l’uomo in cui tutti abbiano pari opportunità di realizzare le proprie convinzioni positive. Il nipote chiede: “E le tue [ragioni] quali sarebbero?”, lo zio risponde: “Mi verrebbe da risponderti al solito modo, esaltando l’importanza della separazione e dell’autonomia del potere esecutivo dal legislativo e dal giudiziario. Ma non basta. Perché stato di diritto non significa soltanto questo. Nella sua evoluzione in stato costituzionale di diritto significa anche tutela dei diritti fondamentali degli individui, sanciti, per l’appunto, dalla costituzione. E le maggioranze politiche non possono violare certi diritti e libertà (discriminando una minoranza, una comunità religiosa, un certo orientamento sessuale). In questo quadro ‘democrazia’ non significa affatto potere assoluto della maggioranza […]”.
E’ molto interessante il capitolo intitolato “Verso una spiritualità atea”. Il nipote, esausto dalla quantità di tematiche affrontate e sapientemente legate dallo zio, si esprime così: “Se ti dicessi che non lo trovo più il filo logico, sono convinto che tu ripartiresti dall’inizio: omosessualità, guerra, onore, stato di diritto, ateismo, facoltà cognitive, governo transazionale. E siccome sono esausto, ti dico di sì. Così puoi sfogarti sulla politica estera americana.”; ormai il libro è alle ultime battute e si raggiunge, a mio avviso, l’apice del pensiero buffoniano: “[…] C’è un enorme lavoro intellettuale da compiere anche insieme a molti cristiani – e persino a numerosi sacerdoti sensibili e intelligenti – onestamente in cammino verso altre e più alte forme di spiritualità”. Quindi una sorta di chiamata alle armi per costruire insieme, tutta l’umanità, senza prevaricazioni di sorta o chicchessia, un nuovo e più progredito stato sociale: “[…] Sostegno assoluto alla ricerca scientifica e alla diffusione con ogni mezzo della cultura scientifica […]; abolizione degli oroscopi dai programmi delle tv di stato; sostituzione nelle scuole di stato del corso confessionale di religione con corsi di storia delle civiltà culturali; analisi del concordato attualmente in vigore tra stato italiano e stato vaticano. E naturalmente diritti civili. […]”.
Buffoni non ha certo peli sulla lingua, un libro che non risparmia trasalimenti, vi si leggono pensieri forti. Tematiche usualmente approcciate con paradigmi cattolico-cristiani, vengono affrontate dal punto di vista ateo e razionalista, ci si trova messi sotto sopra, poiché, volenti o nolenti, in questa nostra Italia, siamo pregni di pensiero cattolico, la qual cosa ha aspetti positivi, sicuramente per l’amore universale che viene propugnato, ma che, quando degenera in bigottismi, può diventare la più devastante delle ideologie. In relazione agli omosessuali: “La mentalità corrente, fomentata dalla Chiesa Cattolica, recita che noi dobbiamo essere ‘accolti’. Prova a vedere come ti accolgono se ti presenti per mano al tuo compagno e dici che sei felice e vorresti costruirti con lui una vita normale, e magari che sei disponibile ad adottare un minore…”. Ebbene, è noto che i peggiori razzismi spesso hanno il loro miglior humus in seno alle comunità cattoliche, si vedano, nel corso dei secoli, le persecuzioni agli ebrei, agli omosessuali, ai neri, e a tutti quegli stati sociali che, contrariamente a quanto insegnato dal Cristo, vengono relegati ai margini della vita di fede.
Il libro si conclude con una bellissima lettera del nipote allo zio. Una sorta di autocritica dell’autore messa in bocca al nipote, un quasi colpo di scena finale che dà il merito a Buffoni come di colui che cerca veramente quale sia la strada più giusta ed equa verso un vero progresso dell’umanità, uno stato sociale che accolga le istanze delle sue molteplici varietà ideologiche e culturali: “[…] ma non pensi che i nemici principali, oggi, possano essere altrove e si annidino magari nella superficialità, nella sordità etica, nel conformismo e nell’indifferenza? […]”.
Un libro di grande attualità che dovrebbe essere fatto leggere nelle scuole, affinché le giovani generazioni non compiano gli errori storici e sociali illustrati nel libro, abituandole a non lasciarsi abbindolare dalla propaganda di chi grida più forte.
Infine segnalo che “Più luce, padre” ha vinto il Premio “Giacomo Matteotti” 2008, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ottobre 2004 per commemorare l’ottantesimo anniversario della scomparsa di Matteotti. Ecco le motivazioni del Premio: “In un fitto susseguirsi di dialoghi Franco Buffoni, noto poeta e autorevole docente universitario, affida a uno zio e a un nipote, come in un antico teatro che tende alla catarsi, una catena di domande e di chiarimenti che riguardano alcuni dei problemi più fitti e intricati del nostro tempo: dalla religione alla guerra, da una nuova idea della sessualità alla violenza dilagante fra i giovani, dalla cecità del fascismo alla luce di una diversa ragionevolezza. Ne deriva un trattato, insieme acuto e appassionato, sulla conoscenza e sulla libertà dell’uomo del nostro tempo”.
Id: 166 Data: 08/03/2009 17:58:27
*
 Insel Marty - Poesia e Prosa - Edizioni Gazebo
Insel Marty - Poesia e Prosa - Edizioni Gazebo
I Resti lo Splendore
Insel Marty conduce il lettore in un percorso a tratti un poco ostile per chi non si intende di filosofia, di religioni orientali e di Vecchio Testamento. Ma sicuramente ha la capacità di destare nell’animo vibrazioni armoniche fondamentali, attraverso un’asciuttezza di concetti e persuasive riflessioni che sembrano nascere dall’esperienza dell’autrice, dal suo probabile aver esperito, in qualche modo, ciò di cui tratta; con fare deciso propone sue tesi e sintesi, spaziando nel mondo della filosofia greca e trovando unioni/disunioni col mondo della filosofia orientale.
Ma ciò che di questo libro colpisce sono i testi poetici che accompagnano il discorso filosofico e che in qualche modo ne sono coronamento e riflessione ultima nonché intuizione di una più profonda verità sulle cose, percepita e percepibile soltanto, a mio avviso, dalla poesia, come se essa fosse una sorta di mistica: l’Essere rivela sé stesso nella poesia e il poeta diventa imprescindibile chiusura di una complessità che altrimenti si attorciglierebbe a spirale su sé stessa. Semplice e al contempo geniale questa riflessione: “La letteratura è l’ombra della parola. Ma l’ombra è così intima alla luce”. Quindi la parola come ente che riflette, luminosa, la luce dell’Essere, e il “sistema letteratura”, con tutte le sue complessità, è ombra della parola alla luce dell’Essere, parola che vive di per sé stessa senza necessitare dell’ombra ma che comunque, per il semplice fatto di essere alla presenza della luce, la rende presente, non come necessità, appunto, ma come conseguenza di contorno. E ancora: “scrivendosi prendono luogo le parole / si prendono il foglio il tavolo la stanza / anche la strada sotto / e al di là quella che sale al colle / […] // l’aria non la occupano / in lei esalano la forma”.
Penso che scrivere filosofia in poesia sia una cosa che richieda una decisa maturità filosofica, una elevata percezione dell’ontologia dell’esistenza e una grande austerità nell’uso della parola. I versi di Insel Marty sono levigati, puliti, grandemente evocativi, si insinuano come vanghe ben poste sotto le zolle del reale, scalzandole e ribaltando il terreno per preparare una nuova semina: “fascio d’ombre boscose / le nubi di un giorno finito / ma rasoterra traluce a specchio / d’acqua con luna / che ancora non c’è / - riverbera ogni seme del buio // la notte volge gli occhi in sé”.
Quasi a chiusura del libro v’è un bellissimo capitolo dedicato alla musica: “[…] A questo punto della strada vi dirò che la cosa curiosa, ma forse scontata, è che la frase di Jung, ‘la psiche è musica’, mi si è dispiegata nient’affatto metaforica, bensì estremamente realistica […] cantano il frigo e l’autoclave, l’acsensore e il caterpillar […] il vicinissimo aeroporto emette profondissimi Karghiraa” (essendo il Karghiraa una tecnica mongola di emissione vocale di una nota bassa insieme ad armonici acuti...).
Quindi un libro non immediato, ma semmai ben ragionato e sul quale ragionare, insieme all’autrice, in una interessante dialettica, senza l’attesa di una schema scontato.
Id: 163 Data: 03/03/2009 21:04:18
*
 Gabriella Gianfelici - Poesia - Pascal Editrice
Gabriella Gianfelici - Poesia - Pascal Editrice
La notte innocente
Uno sorta di stupore pervade tutta la raccolta, ma, essendo calibrato sulla personale esperienza di vita dell’autrice, non è mai inutilmente esaltante, esso sembra nascere dalla capacità, quasi inaspettata, di rivivere il passato liberato dall’eventuale peso di dolore: “[…] Non so da quanto ci conosciamo / non ricordo se ti ho amato mai / è nuovo l’intreccio dei corpi. / […]”, (pag. 66).
Sono, inoltre, particolarmente ben riuscite, le quindici poesie iniziali della sezione intitolata “Infanzie nel vento”, in cui Gabriella introduce il lettore, con assoluta pacata serenità, nella stanza di una bambina che aspetta la morte nel suo letto di ospedale: “Sto per entrare in una minuscola stanza. / Ascolto voci di bimbi che piangono / […] / Sento la mia ansia aumentare / ma respiro forte ed entro / convinta e serena.”, (pag. 15). Con la bambina avviene uno scambio, Gabriella le legge alcune poesie, tra cui alcune sul vento, la bambina è contenta; poi scrivono insieme, e infine: “[…] / La saluto con un bacio. / Mi dice in un sussurro: ‘Torna’”, (pag. 22). La triste dipartita: “Ti ringrazio, Fosca, / piccola poeta, poetina. / […] / il tuo vento mi aiuterà / per altre notti / che verranno.”, (pag. 23).
Concludo affermando, molto semplicemente, una sensazione che mi ha accompagnato per tutta la lettura, e cioè che la poesia della Gianfelici è fluida, segue rivoli di sincerità, l’autrice è serena perché sa cosa dire e non attende certo consensi o plausi per poterlo dire. Buona lettura.
Id: 159 Data: 13/02/2009 22:10:29
*
 Valerio Magrelli - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Valerio Magrelli - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Poesie (1980-1992) e altre poesie
Il poeta, dal più semplice quotidiano, riesce a estrapolare riflessioni importanti, ed in questo, Magrelli, appare mirabile, la sua poesia è vivace, dotata di ironica destrezza, talvolta allegra talaltra più pensierosa; i versi sono limpidi e precisi, quasi come scolpiti.
In questo volume sono raccolti tre libri di poesia: “Ora serrata retinae” (Feltrinelli, 1980), “Nature e venature” (Mondadori, 1987), “Esercizi di tiptologia” (Mondadori, 1992) e altri versi.
Magrelli rivela, nei suoi versi, una notevole vastità culturale e sembra voler disvelare la sua esistenza quotidiana al lettore, lo fa con una capacità cognitiva e di introspezione da fare invidia; nelle sue poesie propone sovente delle analogie tra sé e il mondo che lo circonda, visto anche nei suoi aspetti “minimi”, queste sue giustapposizioni mettono in luce la sua grande capacità autocognitiva e sono espresse con notevole acutezza, mai scevra di austerità ma al contempo senza omettere una certa ironia. Egli, quasi giocando, propone similitudini in forma di considerazioni, capaci di esplicitare meglio ciò che sta vivendo, come volesse rivelarsi pienamente al lettore, dal quale pare egli voglia farsi conoscere : “L’imballatore chino / che mi svuota la stanza / fa il mio stesso lavoro. / Anch’io faccio cambiare casa / alle parole, alle parole che non sono mie, / e metto mano a ciò / che non conosco senza capire / cosa sto spostando. / Sto spostando me stesso / traducendo il passato in un presente / che viaggia sigillato / racchiuso dentro pagine / o dentro casse con la scritta / “Fragile” di cui ignoro l’interno. / […]”, (“L’imballatore”, pag. 262). Si vorrebbero scrivere poesie allo stesso modo, con lo stesso registro di scorrevolezza, immediatezza e spontaneità percettiva che, sebbene tenute a bada dallo spessore culturale e dalla raffinata scrittura che caratterizzano l’autore, colpiscono chi legge, esemplificatrice di ciò ed acutissima è la poesia in copertina: “Io cammino fumando / e dopo ogni boccata / attraverso il mio fumo / e sto dove non stavo / dove prima soffiavo”.
La poesia di Magrelli sa prendere il lettore, sa affascinare e coinvolgere, proprio perché, come già detto, apre finestre sulla vita del poeta, sulle modalità stesse della sua scrittura. Le poesie assumono, via via, una componente diaristica importante, specialmente le ultime, dove addirittura la poesia diventa prosa, pagina di diario. La sua ironia riesce a guadagnargli simpatia, per certi versi ricorda la polacca Wislawa Symborska, con i suoi toni un po’ beffardi ma sempre sinceri, spontanei, veri, mai né sopra né sotto le righe, netti ma mai troppo ammaestrati.
Per Magrelli la poesia sembra avere anche un potere descrittivo di ricomposizione, nel senso che riesce a riordinare, in qualche modo, “le immagini che la precedono” e a presentarle al lettore in una “figura bella”, facendo “bella figura”: “Una poesia che ricomponga / le immagini che la precedono / è figura per eccellenza. / E’ il comportamento dell’uomo / davanti alla sua fantasia. / Fare bella figura / vuol dire fare / una figura bella, il disegno che restituisca / all’oggetto le sue linee, / i suoi contorni al pensiero”, (pag. 92). Ma la poesia è anche intuizione, mezzo di descrizione che rivela, prima di tutto al poeta, qualcosa ch’è ignoto: “Io non conosco / quello di cui scrivo, / ne scrivo anzi / proprio perché lo ignoro. / […] / Per me la ragione / della scrittura / è sempre scrittura / della ragione.”, (pag. 93). Scrivere poesia è “un atto delicato” che mai cavalca l’onda di un mero sentimentale modo di percepire il mondo senza tenersi ben saldi alla zattera della ragione, cioè ad una analisi attenta, critica e ben ponderata del mondo, e i versi di Magrelli proprio questo denotano, delineandosi mai banali ma, anzi, di vasta portata e ampio respiro, moderni.
Id: 148 Data: 09/01/2009 18:21:09
*
 Silvia Tamberi - Poesia - Edizioni Del Cerro
Silvia Tamberi - Poesia - Edizioni Del Cerro
Quello che mai
Tamberi, con questa sua nuova raccolta, ha fatto un salto importante verso la maturità della sua espressione poetica, riuscendo, in circa centoventi pagine, a delineare un percorso in versi degno di essere annoverato, a mio avviso, per la sua schiettezza, tra i più belli e significativi che la poesia italiana di questa prima parte di secolo può vantare; affermando ciò sono cosciente che potrei esprimere un giudizio soggettivo per quel che riguarda lo stile compositivo, ma sono invece sicuro di oggettività per quanto riguarda l’importanza dei contenuti e delle tematiche trattate dalla Tamberi, connotati da una forte carica introspettiva.
Le poesie sono lunghe e articolate, ognuna potrebbe essere smembrata, per la densità di significati, in decine di aforismi di notevole impatto. L’autrice ha capacità di silenzio, ascolto e osservazione, sia di se stessa che del mondo che s’aggira intorno al luogo dal quale è osservatrice quasi costretta, luogo che pare favorito quanto sofferto: “Questo accadere inaspettato / questo non succedere sorprendente / a cui cercare una giustificazione. / Questo presente / così scoordinato da questa età corrente / e da questo stare vivendo / in cui dover trovare un equilibrio / come una voglia di vivere impedita / un’impossibilità d’andare / una normalità ostacolata / che quasi stupisce. / […]”, (“Contraddittoriamente”, pag. 77).
Tamberi riesce ad intessere una maglia di versi che, seguendo il ritmo cadenzato di una certa ripetitività, mai annoiante, fuori luogo o meramente insistente, conducono il lettore ad una sorta di autoanalisi esistenziale inducendovi un pensiero rasserenante e propositi per un nuovo inizio, in spirito e azione. Essa, attraverso una particolare capacità di introspezione, sembra raggiungere un punto di vista privilegiato sul mondo, riuscendo a innestarsi nelle sue fessure di silenzio e a raccontarne i non sensi, le frette, i deliri insani, gli attimi, le lontananze, i ritardi, le sensazioni, i sogni, le somiglianze, i percorsi, i singhiozzi, i sobbalzi, il mistero: “Accade nell’anima / un succedere violento e impetuoso / così diverso dalla realtà. / Accade nell’anima / che un dolore nuovo / e inaspettato / vi scivoli / che una delusione / vi si annidi. / Accade nell’anima / che una serenità insperata / entri ad abitarvi / per attimi che sembrano infiniti. / Accade nell’anima / che all’improvviso / un dolore si dissolva / una paura svanisca. / […]”, (“Accade nell’anima”, pag. 86).
Sebbene siano molte le riflessioni e le suggestioni che il libro estrae dall’anima, non aggiungo altro, sperando vivamente che i lettori possano seguire il consiglio di leggere questa raccolta di poesie che verrebbe voglia di regalare ad ogni persona cara, anche se non dedita alla poesia, per la semplicità espressiva e la pregnante forza riflessiva: “[…] / Quando m’arresto / e non vorrei / e aspetto poi / di superare ostacoli / e proseguire ancora. / Quando di tutto / e altro ancora / farò versi / per cantare / ogni agire / ogni fare.”, (“Quando”, pag. 115).
Id: 146 Data: 01/01/2009 20:29:23
*
 Giacomo Leronni - Poesia - Manni Editori
Giacomo Leronni - Poesia - Manni Editori
Polvere del bene
A mio avviso la poesia di Leronni è semplice, netta. Esperienze e idee si rincorrono unendosi e disgiungendosi in una sorta di caleidoscopica euforia. Nel corso della narrazione poetica, una delle parole più frequenti è la parola “ombra”. Pare che l’autore ponga il suo dire in una zona rarefatta d’ombra, alla ricerca della giusta tonalità per esprimere con discrezione la sua visione del mondo, ma ombra porta con sé luce, necessaria, appunto, per porre in essere l’ombra.
Altro elemento che caratterizza la sua poetica è la rilevante componente dialogica che si esplicita praticamente in tutte le poesie; v’è sempre un “tu” verso il quale il poeta si sposta col pensiero e con la narrazione. Sicuramente, nel pensiero cosciente dello scrittore vi sarà, a personificare quel “tu”, una persona conosciuta, reale, magari amata, ma che metaforicamente, a mio avviso, rappresenta l’anima di tutti coloro che prenderanno in mano il suo libro e si avventureranno nella lettura dei suoi versi. Trovo conferma, anche se parziale, a questa prospettiva, nella nota finale alla raccolta, dove Leronni si esprime così: “[…] preferirei che il lettore, eventualmente, si chiedesse non tanto cosa il poeta avrà voluto dire, quanto piuttosto cosa, con lui, è disposto ad ascoltare”. Si può a ragione dire che quella di Leronni è una poesia scritta per coinvolgere il lettore, o addirittura per trascinarlo, data talvolta la forza dialogica, in un ascolto e una meditazione, assorta e visionaria, del mondo reale, per questo si dà un gran da fare con le parole. I versi ben lavorati, sintatticamente e formalmente, hanno capacità evocativa, un uso prolungato di aggettivi, opportunamente incastonati, rende il testo simile alle immagini di un sogno che appare, dapprima, disordinato e senza senso, ma che poi, appena desti, dopo un primo momento oscillante, si agganciano alla mente razionale, mostrandoci il suo vero senso, una rielaborazione quasi esorcizzante di esperienze vissute.
Quella di Leronni è una poesia che privilegia e invoca la sera – quindi non una oscurità totale –, luogo e ora di ombra in cui il gioco del buio di rendere visivamente tutto il mondo uguale, diventa preponderante: “Reca la sua luce insonne. / Foglie ne raccolgono lo sguardo / ma il suo passo è altro dal loro. / Cristalli: le sue parole. / Germogli di quel sereno / che non dichiara i suoi confini. // A volte basta una voce perché la mano eluda il gelo: / i sensi sgusciano oltre l’argine / saggiano nardo e fuoco. / Lei non è qui / ma in fondo è vera: col suo volto / inesorabile avanza la sera”.
Ma l’ombra non è soltanto un elemento poetico del libro, è in realtà ciò che il libro aspira ad essere, un luogo non soleggiato, una frescura sul calore della complessità dell’esistenza la quale percorre i suoi lidi in modo anche doloroso e talvolta infame; in questo senso la raccolta assume la connotazione di un luogo momentaneo di conforto e ristoro, e chiuderlo, terminata la lettura, è come chiudere un parasole una volta calata la sera, non serve più, ma è servito: “Questo libro procede lentamente / si lascia accompagnare da chiunque / non ha mete da toccare, annota / […] Non lascerà / tracce difficili da cancellare / non renderà favori, non servirà / allo svago dei bambini / né scalzerà le bibbie degli adulti. // […] / Farà poca fatica chi l’incontra / meno ci vorrà a dimenticarlo / […]”.
Sono molte le poesie che citerei, ma non è possibile per ovvi motivi. Consiglio di leggere il libro per intero, con calma, facendo pausa tra un capitolo e l’altro, per avere il tempo di far depositare le suggestioni, come quelle di un sogno molto reale, che l’autore abilmente delinea.
La raccolta fila, per così dire, liscia, per quanto l’elemento oscurità sia sempre sul limite della luce pronto ad inglobarla; ma alla fine del percorso, Leronni, trasla il lettore nella penombra verso una zona di luce, aprendo al conforto del bene; alcune oscurità erano soltanto brutti sogni, il mondo della veglia è luminoso, basta aprire le serrande, l’amicizia ne è garanzia: “[…] // Nella penombra del bene / quando il corpo tergiversa / e cede la fitta del pensiero / giungi all’osso della comunione. / La voce ricalca il desiderio / che hai visto vivere, temere: / una bellezza esiste / gli amici garantiscono per te”.
Una noticina per l’autore, non essendo il tipo di versificazione fondato sulla rima ma semmai su assonanze diffuse in tutto il testo poetico, eviterei completamente anche le pochissime facili rime che, raramente, si incontrano nella seconda parte del libro, rischiano di far perdere momentaneamente quota alla buona coerenza compositiva di cui il libro può senz’altro vantarsi.
I nostri complimenti, con l’augurio di nuovi slanci verso una crescente maturità poetica.
Il libro ha vinto, per l'opera prima, il premio "Alessandro Contini Bonacossi", 2009.
Id: 145 Data: 31/12/2008 23:26:17
*
 Salvatore Mingione - Poesia - NarrativaePoesia
Salvatore Mingione - Poesia - NarrativaePoesia
lecosechesento.it
Con queste mie parole non voglio assolutamente, in nessun modo, almeno cosciente, denigrare questa raccolta di testi che tanto mostrano la passione dell’autore per la vita e per l’arte, che pare proprio, quest’ultima, poter rendere piacevoli anche i momenti faticosi e cupi dell’esistenza ed esaltarne le gioie. L’autore ha sicuramente la capacità di una forza narrativa che potrebbe penetrare molto a fondo nella realtà dei sentimenti umani, descrivendone sia i tratti nevralgici che lieti, semplicemente trasformando la sua narrazione poetica in una narrazione prosastica, nella forma di racconto breve, acquisterebbe, a mio avviso, in incisività e pertinenza di linguaggio.
Nonostante queste mie riflessioni più critiche vi sono nel libro diverse perle poetiche, ne segnalo qui una, intitolata “Paura”: “Mentre il vento scivola via / la penna a sfera colora di blu la carta / e una lampadina / […] / illumina il foglio / donandogli ombre e riflessi / […] / di draghi d’argento / cavalieri misteriosi e neri / e nel cielo lampi e tuoni tetri / risvegliano la tua antica paura. // Ma poi / nella stanzetta / un raggio di sole amico / e i draghi / i cavalieri / giacciono inermi / una spada di luce dolce e celeste li ha sconfitti”.
Si sa che la poesia richiede dedizione e lavoro, impegna, è come la nascita, ogni nascita non è improvvisa, richiede scelte. Far nascere una poesia richiede una scelta ben precisa sia nel linguaggio che nello stile di “montaggio” del linguaggio, se così si può dire. Allora concludo con un “buon lavoro”, e rimango in attesa...
Id: 141 Data: 15/12/2008 17:41:28
*
 Anna Belozorovitch - Poesia - Greta Edizioni - Collana Girovaghe dell’anima
Anna Belozorovitch - Poesia - Greta Edizioni - Collana Girovaghe dell’anima
Cinque passi
Spesso si trovano guazzabugli artistici, tentativi di unioni d’anime che hanno sensibilità espressive e compositive differenti, con risultati pessimi, scialbi, incapaci di creare quella sintesi di elementi atta a superare il dualismo iniziale fino ad arrivare ad una forma artistica che trascende gli elementi iniziali, non è il caso di queste due donne che riescono, in poche pagine a miscelare, con eleganza e nessun tipo di ostentazione artistica, una calibrata sequenza di immagini e poesia. Fotografie in bianco e nero, scatti effettuati dall’alto, che ritraggono una fanciulla dai capelli lunghi, che indossa i soli pantaloni, scalza, su un terreno compatto, e che si muove attorno a un vassoio lucido come uno specchio posato a terra, probabilmente sotto un albero che lascia cadere le sue foglie. Fotografie che sono simbolo e metafora di un viaggio, a partire dalle sensazioni iniziali, preparatorie alla partenza (“E non mi dite ch’è l’età, / e non mi dite ch’è il momento, / non crederò a nulla che non vedano i miei / occhi, […] / Io voglio tutto mio e nuovo”) fino al viaggio stesso, con i suoi passi, le sue pause, le sue meditazioni e un probabile arrivo rappresentato dall’unica fotografia in cui la ragazza rivolge lo sguardo in alto, ed ha tra le mani, adagiato sulle ginocchia, il vassoio, come a far intendere che ha compreso l’illusione della realtà, ovvero l’illusione di muovere l’anima attraverso lo spostarsi del corpo da luogo a luogo, del finto muoversi verso mete che sono illusorie; la bellissima poesia associata a questa ultima immagine è anche l’apice del percorso narrativo del libro: “E sento d’essere arrivata. / E sento che ogni cosa inizia ora. / Non c’è alcun viaggio che io debba fare, / non c’è alcuna vera meta, / nulla da conquistare, da raggiungere… Non c’è. / C’è solo il bagliore della’aurora. / E sono io, sono io la strada, / ed è la vita che percorre me”.
La Belozorovich è una poetessa che già conosciamo, su questo stesso sito abbiamo recensito il suo ultimo libro “L’uomo alla finestra”, Besa Editrice, inoltre ne abbiamo pubblicato una intervista; con questo testo conferma, in sole cinque lunghe poesie, la sua grande anima poetica e soprattutto conferma la sua fisionomia di scrittrice, fatta di versi chiari, semplici. Anna Belozorovich, senza una eccessiva e ostentata ricercatezza nel linguaggio, riesce, dalla profondità del suo meditare l’esistenza, a donarci versi capaci di sollevare il velo da qualcosa di essenziale nelle nostre vite e a riportare il pensiero, e oserei dire anche l’azione di vita, del lettore alle cose che realmente contano; come fuoco le sue parole insistono, e, dopo aver incenerito come inutili fuscelli i pensieri superflui che si accalcano intorno alla mente, vanno ad incendiare o ad alimentare le fiamme di quella parte lignea del nostro essere, continuamente a rischio di spegnersi.
Ci sono versi di forte ascesi: “Il mio viaggio è senza mappa / senza percorso stabilito, tappa intermedia, / senza aspettativa, quindi senza tragedia. / Il punto dove sono / non esiste. / Non potrei mai essere triste, / non lascio nulla. / io voglio sempre e solo oltre. / Io spero sempre ancora il dopo.”
Leggendo le sue poesie si arriva a pensare che forse l’asceta dei tempi moderni è il poeta e che, forse, per poter essere poeti bisogna tornare essenziali, veritieri, abbandonare le menzogne con cui giornalmente la nostra mente affatica il cuore: “Dove andare? […] / Io ora voglio solo verità”. Una ricerca che passa dalla partenza, dal muoversi che è un andare ma che in realtà è un restare poiché “sono io la strada”, “Io apro gli occhi, senza questionare: / su ogni cosa c’è il segno della mano / che ha dipinto l’alba e colorato il giorno”, versi bellissimi che aprono al divino, all’immenso, alla trascendenza dell’uomo che, per quanto possa essere oltraggiata, sia nel pensiero storico da talune ideologie, sia di fatto da un consumismo sfrenato, che è assai peggiore del tentativo ateista di annegarla nello scientismo, sempre emerge dal cuore dell’uomo come una primula portatrice di speranza: “Poi l’alba. / Un’alba come ogni mattino, ma diversa. /[…]”.
Note per l'acquisto del libro:
Il libro non è di facile reperibilità nelle librerie, poiché sprovvisto del codice ISBN, è pubblicato nella collana "Girovaghe dell'anima", a cura di Susanna Strapazzini, Greta Edizioni; a proposito di tale collana, sul sito della casa editrice, si legge: "Una collana minimalista, pulita, per lasciare il giusto spazio ad artisti e autori, curata con amore e professionalitàda un artista visiva: Susanna Strapazzini. Attraverso questa collana la Strapazzini ci conduce verso i luoghi dell’anima, raccontandocene visioni e sensazioni". L’Editore Christina Magnanelli
Chi volesse acquistare il libro, il prezzo di copertina è di soli 9 euro, può richiederlo alla casa editrice o direttamente all'autrice, scrivendole a questo indirizzo e-mail: anna.belozorovitch@tiscali.it , a questo stesso indirizzo è possibile rivolgere domande all'autrice e approfondirne la conoscenza.
Id: 134 Data: 12/12/2008 20:30:23
*
 Francesco De Napoli - Poesia e Prosa - Vari
Francesco De Napoli - Poesia e Prosa - Vari
Contagi - Nel tempo...
“Contagi”, edito dal Centro Culturale “Paideia” di Cassino (Epigrammi)
“Nel tempo – A Ženja”, dismisuratesti, Frosinone (Poesia/Narrativa/Saggio)
“Per una cultura del libro”, Edizioni Eva, I Colibrì (Saggio)
(“Novità espressiva e ricchezza di contenuti nell’Opera di Francesco De Napoli”, Silvano Demarchi, Edizioni Eva, I Colibrì)
Francesco De Napoli è nato a Potenza nel 1954. Ha pubblicato numerose opere sia di poesia che di narrativa. Un amore profondo per la letteratura lo conduce, in questi anni, a comporre testi di intelligenza poetica e di saggistica analitica veramente sorprendenti, mi riferisco in particolare al molto interessante librino intitolato “Per una cultura del LIBRO”, Edizioni Eva, I Colibrì, nel quale egli tratta dell’effettiva “organizzazione della cultura nel nostro Paese”; riporto alcune righe per far fiutare al lettore l’intento e l’ampiezza del suo scritto: “[…] Come ogni libro, così ogni biblioteca ha una storia, annotai: non si sfugge! Preferisco credere in una biblioteca imperfetta, incompiuta, carente e difettosa, ma a misura d’uomo: che riproduca tutte le virtù e i vizi, i meriti e le manchevolezze del genere umano […]”.
Inoltre segnalo due suoi libri dalle dimensioni esigue, sobri nella veste grafica, ma che, fin dall’inizio della lettura trascinano come in un gorgo narrativo da cui è gradevole farsi trascinare e dal quale non si vuole sfuggire; una giostra di sensazioni e meditazioni accompagna il lettore lungo tutte le pagine, che scorrono velocemente. Si tratta di libri con al più una sessantina di pagine: “Contagi”, edito dal Centro Culturale “Paideia” di Cassino e “Nel tempo – A Ženja”, dismisuratesti, Frosinone.
“Contagi” è una raccolta di una cinquantina di epigrammi, dalla quale traspare la sagace verve di geniale scrittore di De Napoli; si viene conquistati dalla sua sottile ironia, talvolta comica, che pervade ogni singolo componimento che, come uno strale di parole, entra nel vivo di questioni sociali e quotidiane mettendone in luce il lato tragicomico: “Li credevo amanti / di Platone / e di Zaratustra. // Accedervi, / un autentico mistero. // Ho indagato: / è solo / un istituto / di bellezza…”. Sono epigrammi che ricordano i pamphlets, testi brevi con intenti polemici, in cui la vis polemica non è fine a se stessa o generata sull’onda di un estemporaneo moto di rabbia ma sembrerebbero nascere da una visione disincantata su vizi e vezzi del mondo contemporaneo. Attraverso un piacevole moto intellettivo, De Napoli, elabora nei dettagli il testo, riuscendo, in poche righe, a incidere in modo forte e chiaro sul lettore, conducendolo verso una conclusione a sorpresa, nella quale espone il suo pensiero come con una sorta di sorriso che traspare dalle parole, che mai sono impertinenti o inadeguate alla stesura di un elaborato ed efficace pensiero sul tema trattato: “I fascisti / dichiarano la guerra, / il capitale / vende fuoco e ferro, / i comunisti / tutti giù per terra”.
Talvolta sovverte, a sorpresa, il punto di vista che va per la maggiore su certe tematiche, ponendosi in quello diametralmente opposto alla grande massa popolare che accetta uno status quo senza troppo pensare: “E’ smisurato / l’egoismo di quanti, / per religiosità, / rinunciano ai beni terreni / in cambio / della vita eterna”.
“Nel tempo – A Ženja” è invece un librino apparentemente innocuo, ma che invece si rivela essere uno scritto magnifico, praticamente un piccolo saggio sul poeta russo Evgenij Evtušenko, per gli amici Ženja, e tra gli amici figura l’autore De Napoli, il quale, in una felice giornata del lontano 1986, si trova a passeggiare per Cassino con il grande poeta enfant prodige, raccogliendone alcuni interessanti e stuzzicanti pensieri sul suo rapporto, all’interno del suo Paese, con il potere da una parte e il popolo dall’altra. Riporto qui, perché bene esprimono il leitmotiv del libro, le parole di recensione di Virginia Longo (fonte: literary.it): “[…] E se per decenni Evtušenko è stato dipinto da una critica di parte come un poeta di regime, mentre per altri rimane invece il caposcuola della destalinizzazione, dobbiamo riconoscere a De Napoli il grosso merito d’aver ritrovato il bandolo della matassa, dando finalmente ‘a Cesare quel che è di Cesare’. In sostanza, lo studioso cassinate chiarisce i motivi più riposti della questione, a cominciare dal fatto che nel lungo periodo della guerra fredda esistevano esclusivamente i due blocchi contrapposti, e non c’era alcuno spazio che chi, pur credendo nel socialismo, come Evtušenko, auspicava l’avvento d’una terza via. Era una posizione estremamente scomoda, perché invisa sia ai fautori del comunismo brezneviano, sia ai paladini del capitalismo più sfrenato […]”.
Infine, per una più approfondita indagine sul pensiero e sull’Opera di Francesco De Napoli, segnalo “Novità espressiva e ricchezza di contenuti nell’Opera di Francesco De Napoli” di Silvano Demarchi, Edizioni Eva, I Colibrì.
Id: 132 Data: 17/11/2008 21:03:09
*
 Nelo Risi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Nelo Risi - Poesia - Lo Specchio - Mondadori
Né il giorno né l’ora
"Né il giorno né l’ora" è un capolavoro di poesie in versi concatenati, una “libera scrittura quasi in prosa”, come lo stesso Risi afferma. Un libro docile, in cui ancora, come nel suo precedente "Ruggine" (2004), v’è il tema del tempo, inesorabile ma non invincibile; il tempo è saggezza e riflessione, e porta l’uomo a una nuova visione della vita; la morte stessa, all’apice di una esistenza, può essere vista in una nuova e allettante prospettiva, e forse se ne può dare una nuova definizione: “[…] un nuovo dizionario ci vorrebbe / per comprendere la morte / come nuovo elemento di vita”. Il poeta parla tra sé e sé, non sa né il giorno né l’ora, “Un’età più che rispettabile / davvero si stenta a superarla […]”, in cui qualcosa avverrà, “[…] ancora per poco e tutto / sarà leggenda in famiglia […]”; egli vive la sua vita con la consapevolezza dell’approssimarsi della fine della propria esistenza terrena, “[…] Anima che farai / ora che il corpo se ne va…”, ma nel poeta non v’è ansia poiché la sua è una razionale e meditata presa di coscienza del fatto che “[…] non è più il mio tempo / non ha più il mio spazio: al cerchio / per chiudere manca un trattino / […]” ma quel trattino è ancora pieno di potenziale.
E’ un libro intimista, ma con quella caratteristica propria di Risi di sapersi parte integrante di un mondo che da sempre lo chiama in causa e verso i cui guasti si orienta criticamente; le poesie sono pensieri su sé stesso e sul proprio rapporto con il mondo, esposti con umiltà e intelligenza. Risi non ha una voce che grida e sparge epiteti, ha invece una voce seria e serena che sa dire ciò che manca al mondo che lo attornia, per quanto egli ormai, un po’ per scelta, un po’ per causa di forza maggiore, talvolta se ne allontani, poiché non c’è ascolto verso “l’antica sapienza”, depositata dalla vita stessa in coloro che, come il poeta, han vissuto molti anni e vedono ormai il mondo da “[…] / Oltre il mare dove inizia l’erba / con promesse di pascoli e di costellazioni / […]”. Risi denuncia il non ascolto come un male del tempo moderno, il mondo non ascolta la voce dei propri “nonni” che hanno visto qualcosa che non si doveva vedere, nel dolore e nella disperazione di giorni tristi, ormai lontani ma sempre pronti a crollare sulla giovinezza stolta, “[…] Dov’è finita l’antica sapienza / venerata e tirannica quando i nonni / pur tacendo imponevano silenzio / chi mai oggi ascolta più? / […]”. Risi vive in prima persona l’esperienza dell’esclusione, in un mondo veloce e accelerato non a misura di coloro che iniziano ad avere il “fiato corto” e restano indietro, “[…] / ti appoggi al muro fa spalliera / neanche un angelo che ti accompagni”; parole commoventi, tristi, che attendono risposta. Egli ha dalla sua la notorietà e la capacità della Parola, può scrivere i suoi pensieri, e in questo modo, lodevolmente, dà voce a tutti quegli uomini e quelle donne che stanno nell’ombra senza quell’angelo che li sostenga e che li aiuti quando il fiatone li assale, volendo ancora rincorrere quelle piccole speranze che da sempre volano nell’aria tersa del loro cuore.
E’ vero che “la vita gli scorre sopra” ha un “fazzoletto di vita che gli resta” ma ha ancora “una legittima richiesta: / auspica energia per delle vecchie speranze / quasi presumesse una seconda giovinezza / tale da scuotere l’Europa / dalla ben nota inerzia / tuttora capace di un centro / - vecchia quercia asfittica / la si vorrebbe alta nel cielo / e il più possibile chiara”.
Se da una parte vi è la tendenza del poeta, mai sopita, a intervenire con il suo pensiero in relazione alle schizofrenie dell’epoca moderna, dall’altra vi è invece una delusione che lo porta ad escludersi dalla falsità del dire e del fare, “un vaneggiare di parole / […] / si riuniscono parlano di amori / […] / non posso che tacere / frasi fatte […]”.
Infine un bellissimo testo, intitolato “Continuare…”, rappresentativo dell’anima del poeta e della sua piena sintonia con la vita, e in cui si manifesta appieno la sua libertà e il suo pieno ascolto alla verità: “[…] / Ho vissuto con fiducia nel reale che non sento / il bisogno di portare con me niente / ho acquistato negli anni il piglio / di preservarmi dai vuoti dai richiami / del sociale dal come valutare gl’incontri / lasciare al mezzo una conversazione le spalle / al banale limitare gl’inviti o a mattino inoltrato / fischiettare Mozart staccando la spina per cogliere / l’istante di vero che talvolta mi dà luce”.
Un libro consigliabile per l’ampia veduta sul mondo di oggi, di una persona che ha attraversato quasi un secolo di vita e ha maturato saggezza dal suo sempre cercare e mai saper sostare in comoda solitudine ai margini degli eventi, un libro che offre uno sguardo sereno sulla vita che giunge al suo apice, che sa ascoltare la “Voce delle cose / […] / una vertigine dall’invisibile / al visibile che affiora”.
Id: 130 Data: 14/11/2008 21:53:14
*
 Davide Rondoni - Poesia - Mondadori - Lo Specchio
Davide Rondoni - Poesia - Mondadori - Lo Specchio
Apocalisse amore
Apocalisse amore è un percorso che si sviluppa con una abilissima costruzione dei versi e con l’uso di parole di una semplicità piacevole, ma accostate in modo così armonico e fluido da, oserei dire, tirare su poesia dalla quotidianità del vivere, fatta di situazioni e contesti che tutti conosciamo e di cui, ogni giorno, facciamo esperienza, a partire dalla famiglia, dai figli, dalle città dove viviamo e che visitiamo, alle persone che ci avvicinano, che avviciniamo e che ci sono care, agli avvenimenti che caratterizzano il nostro tempo, dalla poesia per Pantani a quella in memoria di don Luigi Giussani. E’ un libro che ci si sente molto vicino proprio per quel profondo senso di umanità di cui è pervaso, la scrittura di Rondoni disegna i tratti amari della vita come i tratti gioiosi e riesce ad evocare le necessità più impellenti del vivere, quali l’amore e gli affetti, estraendole da quella sorta di ripostiglio dove qualche volta sono relegate: “[…] / Amare è l’occupazione / di chi non ha paura”.
Si ravvisa la necessità della relazione come un tratto ontologico dell’essere umano: “[…] / e non voglio andare nel buio / senza un volto negli occhi - -”. In alcuni testi, il poeta, tocca corde molto profonde, semplicemente accostando, con abilità di scrittura, le stesse parole che usiamo per costruire quei vuoti discorsi che di tanto in tanto ci avvinghiano, parole che qui invece diventano taumaturgiche e portano a riflettere su tematiche ed esperienze fondanti il nostro essere umani di passaggio su questa terra: “Se tu mi abbracci / io richiamo tutte le vie / del mio corpo / […] / se mi abbracci / mi fai intero, ritornato”.
Ci si sorprende, durante la lettura, a soffermarsi su alcuni passaggi enigmatici quasi mistici, ma che, in successive letture disvelano, sottese alle parole del poeta e attraverso rivoli di purezza intellettuale e artistica, una intuizione e una conoscenza più profonde dell’essere delle cose, come è il caso, a mio avviso, di questi bellissimi versi: “Come manchi tu / non manca niente / di ciò che ha nome // tu manchi / come la gioia / che nessuno sa chiamare”.
Un libro che mi sento di consigliare vivamente, sia per lo stile compositivo, assolutamente moderno e ben calibrato, sia per la capacità di scuotere il pensiero e smuovere lo spirito dalla molle assuefazione in cui talvolta si immerge: “[…] / e non c’è nessun eroe qui, niente / di puro e di imbattibile, / solo il rumore del respiro dei compagni / cancellati nella tenebra // […]”.
Id: 125 Data: 31/10/2008 16:56:10
*
 Gian Piero Stefanoni - Poesia - Edizioni Gazebo
Gian Piero Stefanoni - Poesia - Edizioni Gazebo
Geografia del mattino
Qualche giorno fa, in libreria, con gioia e stupore, tra gli scaffali risaltava il celeste di questo libro delle edizioni Gazebo. Trovarlo in libreria a Roma è cosa non banale visto che la casa editrice è di Firenze e, per quanto sia di notevole valore nel panorama della piccola editoria, non è normalmente distribuito, spettando così all’autore collocare i propri testi tra gli scaffali all’attenzione dei lettori più attenti. Il testo è comunque ordinabile direttamente alla casa editrice, il cui sito internet si trova indicato all’inizio di questa pagina.
Leggendo i primi versi di questa raccolta poetica si delinea l’idea di essere di fronte ad un poeta di notevole maturità formale. Si procede nella lettura soltanto mantenendo la concentrazione che si addice alla più complessa poetica. Le sue poesie non peccano certo di immediatezza e anzi sono molto elaborate e lavorate di cesello fin nei minimi particolari, nessuna parola è lasciata a se stessa, ma tutte incastonate le une nelle altre generano una vera e propria geografia di stile fatta di descrizioni attente di luoghi, di azioni, di finalità e motivi delle azioni. Cose e oggetti, nel mondo poetico di Stefanoni, sembrano assumere la loro realtà e verità dagli attributi che esse possiedono, dai quali sono scolpite e rese reali, non sembrano cioè avere una realtà oggettiva al di là del fenomeno, nel senso kantiano, che le manifesta: “Il colore placa la figura, / ne motiva il tratto, domina l’affanno. // Incalza, nel ritorno caldo del segno / e vaga, compiuto, mutato elemento. // Qui ha gioco la bellezza. / Diventa acqua, circolo, / corrente che all’occhio semina. // Come palla lanciata, come arancia, / passando, perché deve passare. / Con ali che sappiamo”. Vi è, in questa scrittura, un naturalismo singolare, insistente, il poeta ha cento occhi ed effettua attente panoramiche degli spazi che lo circondano: “[…] / Così noi variamo e gemiamo // l’uno all’altro lo stesso specchiare, reali sotto un cielo reale, / in accompagnamento a quel che pare un lamento // semplicemente solo un segnale, / un’attesa in sommovimento / dal cui dorso cade la pioggia”.
Citazioni poste all’inizio di alcune poesie esplicitano il percorso e i riferimenti dell’intera raccolta “Geografia del mattino - e altre poesie”, in particolare è rivelatrice una di esse composta da tre versi di Andrea Zanzotto: “Forse è tempo di metter gli occhiali / per diventar familiari / con le distanze e i puntigli del vetro”; ed è infatti molto puntigliosa la poetica di Stefanoni, rischiando, a tratti, di diventare didascalica, un po’ troppo scientifica, impregnandosi di un verismo che sacrifica, a mio avviso, in taluni passaggi, scioltezza e rilassatezza verbale, caratteristiche riconducibili ad una chiara scelta stilistica.
E’ un libro maturo che può piacere o non piacere, ma, al di là del gusto personale, è sicuramente ottima poesia, in cui il rimando di assonanza tra le parole è ben calibrato e ne rende piacevole la lettura.
Per l’accuratezza della scrittura consigliamo la lettura di questo libro a coloro i quali pensano che la poesia sia sentimentalismo ed estemporaneità.
Id: 121 Data: 16/10/2008 19:23:08
*
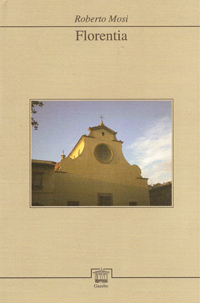 Roberto Mosi - Poesia - Edizioni Gazebo
Roberto Mosi - Poesia - Edizioni Gazebo
Florentia
Roberto Mosi è nato a Firenze nel 1942, dove vive. E’ impegnato nel volontariato, con particolare riguardo al campo della cultura e dell’educazione degli adulti.
Firenze, una città di bellezza impareggiabile in cui, come disse la poetessa portoghese Sophia de Mello Breyner Andresen, che ivi ebbi la fortuna di conoscere, “a Firenze la proporzione dà il sorriso alle cose”. E il sorriso di tale armonica bellezza traspare dai versi di Mosi, il quale, nelle “note dell’autore”, all’inizio della silloge poetica, afferma: “Attraverso le piazze / ricerco pagine di storia, / immagini di vita, / l’idea della bellezza”. In questi brevissimi versi è il sunto del percorso poetico del libro di Mosi, un percorso che non tralascia di descrivere, innestate nello splendore della città, le zone d’ombra, tanto evidenti per chi vuole osservare; sono le povertà umane che a Firenze, come in altre città d’Italia, hanno i loro luoghi: “Maria alla finestra / chiama i passanti, urla i rumori, parla di storie d’amore. // Eri l’infermiera / nei reparti del manicomio. // Abiti oggi il mondo dei folli, / le tue parole incrociano / storie di donne legate alle corde dei letti, / docce gelide, elettroshok per cura. // La finestra d’improvviso / si chiude, rimane l’eco / sospesa sui gas dei motori”. Nel corso della lettura si coglie la sensibilità di un cuore, quello del poeta, che passa nei luoghi della città Florentia e con attenzione sa osservarla, annotando fatti, situazioni, azioni, voci, la sua presenza sembra non modificare mai la scena, anche quando egli stesso si trova ad esservi coinvolto, la descrive con oggettiva attenzione e intelligenza poetica. Mosi percorre spazi e segue le linee delle vite che ivi si sviluppano e compiono le loro azioni necessarie. La vista del poeta riesce a modularsi tra percezione panoramica e particolare di oggetti e vite. La sua poesia è, in un certo senso, geometrica, segue linee precise, come un ragno tesse la sua tela poetica con precisione e determinazione: “Sulla strada di casa attraverso la sera / piazza dell’Annunziata. / Novanta passi è lunga la piazza / trenta le colonne, otto bambini / in fasce, tondi bianchi di smalto, / sessanta le api per il Granduca // […]”.
Il percorso del poeta non si snoda soltanto attraverso luoghi ma anche attraverso il tempo, nel suo sostare, talvolta, apre, nella memoria propria e del lettore, squarci temporali, nel tentativo di non perdere la memoria storica, nel corso travolgente dei fatti sociali che caratterizzano il nostro tempo e che chiudono e dimenticano le lotte e gli ideali in scatole poste nei solai dell’informazione: “Il salotto buono di Firenze / appare in bianco e nero, / i colori delle storie di Vasco: / le tute blu arrivano da Rifredi / la polizia è schierata, sbuca / dai portici la camionetta, / picchiano forte i manganelli, / si grida in coro pane e lavoro. // Le Giubbe Rosse sono sbarrate, / i poeti scomparsi. / La musica è delle sirene, / i versi le urla degli operai”; e non solo della città: “[…] // Una bandiera rossa / sullo scaffale più alto / avvolta dal silenzio del tramonto”.
Una bella prova poetica, sostenuta da una nettezza esemplare dei versi (cifra stilistica comune a chi è pubblicato da questa piccola ma importante e necessaria casa editrice) e da un dosaggio calibrato tra sentimento e verismo.
Id: 118 Data: 11/10/2008 18:18:55
*
 Aurelia De Martin Pinter - Poesia - Fermenti – Collana Iride
Aurelia De Martin Pinter - Poesia - Fermenti – Collana Iride
I rifugi dell’essere
Vi sono parole, sensazioni, argomenti sui quali l’autrice insiste in maniera decisa, sicuramente voluta, pagina dopo pagina si ha la sensazione di leggere sempre la medesima poesia che si dilata ed espande fino a lambire, poi avvolgere e scongelare, i significati celati nel cuore, rifugio dell’essere, verso il quale essa conduce il tu che gli spetta dalla vita, quello stesso per cui freme nell’attesa (“Ha il sapore prezioso / di fragole non ancora colte, / il languore galoppante / di allettanti porte socchiuse, / il tepore di lunghi brividi / preludio di carezze d’amore / e mi morde / dolcemente / inesorabilmente dentro; / l’attesa di te.”) e con il quale intreccia i suoi passi “lungo il sentiero dell’essere”, è quel tu unico e destinato a entrare nel luogo dove abitano il suo nome e i suoi occhi, a cui chiede fin dall’inizio “[…] / parole scrivimi accorte / sulle pareti del cuore”.
E’ interessante notare come, insistentemente, si trovi, in gran parte delle poesie, un accenno al tempo, al quale associa parole che lo connotano in modo, di volta in volta, diverso, come se esso fosse il gran nemico sotto il quale si sfalda l’esistenza ma dal quale il poeta ha trovato scampo nel rifugio dell’essere, verso cui conduce la propria e, forse, anche l’altrui esistenza. Il tempo lascia solchi profondi, spezza sillabe, riannodate dallo sguardo di un volto amato; il tempo ha anche rari silenzi, pause, dove avvengono incontri; il tempo ha pieghe anguste dalle quali sgusciano, di nascosto, frammenti della vita che si ricompongono fuori dalla sua morsa; il tempo incalza e non dà tregua; il tempo, nelle notti, ha forme sfumate e con le quali l’anima bambina gioca; il tempo è un crocevia dove le cose si annodano in modo irrisolvibile; infine il tempo rapisce i volti amati, ma esso nulla può nel rifugio dell’essere, luogo atemporale, dove tali volti hanno il loro respiro vitale.
Id: 109 Data: 16/09/2008 16:40:18
*
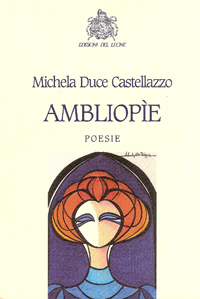 Michela Duce Castellazzo - Poesia - Edizioni del Leone
Michela Duce Castellazzo - Poesia - Edizioni del Leone
Ambliopìe
V’è, in tutta la raccolta, come un filo di disagio serpeggiante che rischia di far implodere, in ogni istante, la sua scrittura, che pare scorrere come sull’orlo di un burrone sempre pronto a inghiottirla; tale disagio sembra scaturire dalla contrapposizione della coscienza del poeta della sua necessità di scrivere (“Scrivere per portare alla luce / […] // Scrivere per urlare ragionatamente // […] // Scrivere come si abbaia alla luna // […] // Scrivere per durare.”), con la lucida comprensione che la scrittura è un dono che non può sottostare alla volontà dello scrivente: “Nessuno può dar voce / a queste parole logore. / la penna è già scarica. //[…]”. Quindi, a mio avviso, è un disagio che rende merito alla scrittura dell’autrice, la parola, infatti, appare, in questa raccolta, come una entità difficile da “imbrigliare” su un foglio al fine di obbligarla a esprimere ciò che l’anima percepisce e vive nell’ambiente della propria esistenza: “Come far emergere / le parole e i suoni / gli echi magici e le memorie sommerse / custoditi con tanta inutile gelosia? // […]”.
Una bella raccolta di poesie, scolpita e decisa sì, ma anche rivelatrice di quell’instabilità esistenziale per la quale il poeta è condannato a stare sempre in bilico su un non ben definito precipizio, ma con il coraggio della profonda consapevolezza di una propria vocazione all’incontro con la parola poetica. Ci piace pensare che il soggetto, nella poesia che segue, sia proprio la parola poetica: “Se t’incontrassi / nella nebbia / lungo il burrone / o in piena notte, / anche chiudendo gli occhi / non barcollerei.”. Molto bella, in questo senso, è anche la poesia che a tratti recita così: “Sull’orlo del margine / è più difficile stare / sempre al limite dell’indecisione / ma senza esitare. // […] // Cerco casa sull’orlo del margine / senza il nome sulla porta / né cancelli o recinti / in una valle aperta / dove poter sostare e ritornare / che chiara e nitida / si distingua nella nebbia / per tutti quelli che potranno arrivare.”
Infine dobbiamo ricordare che questa raccolta è pubblicata in una piccola collana di poesia delle Edizioni del Leone, curata dal poeta Paolo Ruffilli che riesce sempre ad avere occhi attenti per i più delicati soffi di poesia che altrimenti non avrebbero foglie da far frusciare onde farsi sentire.
Id: 106 Data: 04/09/2008 20:43:17
*
 Franco Marcoaldi - Poesia - Einaudi
Franco Marcoaldi - Poesia - Einaudi
Il tempo ormai breve
Il tempo pare non esistere, almeno nel senso di tempo che scorre come, metaforicamente, l’acqua di un fiume, ma semmai esso sembra nascere dalla interpretazione mentale di processi che hanno origine nel vivo della natura delle cose, le quali sottostanno a leggi evolutive ben definite di maggiore probabilità di accadimento, siano esse leggi sociali, umane o fisiche. In sostanza è la mente che registra e interpreta come uno scorrere quello che in realtà è un evolvere: “[…] // La sola, reale misura del tempo, / affonda in una cripta profonda dell’io: / a suo imprevedibile gusto / questa misteriosa potenza / solleva il passato, anticipa il nuovo, / sconquassa il presente. E la mente? / La mente registra – turbata e impotente.”
Nel libro v’è una mestizia di fondo che nasce dalla coscienza di un tempo insondabile nella sua ampiezza, da cui il tentativo di cogliere appieno i frutti dell’esistenza, prima che degeneri nel nulla. Il “carpe diem” è d’obbligo in una visione esistenziale che si tira fuori dalla speranza dell’eternità propria della fede cristiana. A differenza di San Paolo, che invita, nella Prima lettera ai Corinzi, a comportarsi come se il mondo futuro ed eterno fosse già presente “Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve; […]”, Marcoaldi, posto fuori dalla credenza cristiana della resurrezione, trova invece, nella medesima attenzione al tempo breve della vita, l’anelito ad amare “con struggente attaccamento / il palpitante, momentaneo resto.”
“Si tratta di tornare da luoghi / dove mai siamo arrivati. Di pensare / pensieri così a lungo sopiti / da essersi ormai inabissati. / […] / Di cominciare a vivere, / ecco di cosa si tratta.”
Ma la speranza di scampare alla morte rimane sempre accesa e, pur discosto dalla fede, trova una possibile soluzione alla morte con le stesse modalità della fede cristiana, l’amore: “Che dici? Se ti abbraccio forte / forte, ho qualche chance in più / di scampare dalla morte?”. Il poeta è come se corresse su un binario parallelo e guardasse i gesti di coloro che stanno nel treno dell’eternità e provasse a tirarne fuori una tutta personale partitura esistenziale per squarciare quel velo sull’eternità.
Id: 105 Data: 04/09/2008 20:19:53
*
 Filippo Rolla - Poesia - Memoranda Edizioni
Filippo Rolla - Poesia - Memoranda Edizioni
Aforismi distratti
“Ossa / stanche / nel diluvio / dell’esistenza.”, versi brevissimi che sono lampi di poesia fine, levigata, somiglianti, per rimanere in tema, a scatti fotografici, che in frazioni di secondo rubano un mondo, lo impressionano per sempre; nelle poesie di Rolla le parole, fulminee, fotografano un contesto, una sensazione, una percezione dell’anima, ma, in un certo senso, le poesie/fotografie sono sfuocate e si mettono a fuoco soltanto nella sensibilità del lettore attento che stampa le immagini sulla carta sensibile della propria anima alla luce della propria visione del mondo: “parole / àfone / di… / discorsi / silenziosi.”
E’ pubblicato da una piccola casa editrice a cui è legata una ancora più piccola libreria chiamata “Libri Nascosti”, si trova a Ronchi di Massa-Carrara e vive di piccola editoria, una impresa non facile in un mondo editoriale commercialmente travolgente. In bocca al lupo.
Id: 102 Data: 21/08/2008 19:03:07
*
 Franco Buffoni - Poesia - Donzelli Editore
Franco Buffoni - Poesia - Donzelli Editore
Noi e loro
Vi sono, specialmente nella prima parte del libro, ambientazioni paesaggistiche in luoghi di natura incontaminata di spiagge mediterranee o paesi del Maghreb, dove i suoni, gli odori e i giochi di ombre e luci nei vicoli rendono la narrazione degli incontri umani decisamente coinvolgenti, risvegliando una sopita passionalità nel lettore.
L’autore entra nell’intimità delle persone, le affianca, le assorbe e, nella poesia, le eleva: “[…] / E sei sano come un dio / Sei quasi bello, col profumo / del tuo amore / Vuoi riempire la mia casa?”.
Nel libro si legge e si vive l’esperienza di un omosessuale e si vede con i suoi occhi il mondo che lo circonda e dal quale è guardato in modo decisamente schizofrenico. Vi si vive la naturalezza dell’attrazione tra due persone dello stesso sesso come una forma affettiva possibile e che non può in nessun modo essere alla base di pregiudizi verso gli individui: “Ti bacerò questa sera ragazzaccio / Bacerò / Le tue labbra miele birra / Di focaccia / E una croce di Sant’Andrea / Sarà il tuo corpo disteso supino, / In penombra la faccia.”
Le forme dell’amore e della bellezza sono molteplici e sarebbe folle non tentare di abbattere ogni discriminazione fondata sull’affettività. Buffoni, con questa raccolta, avanza nella terra della tolleranza e chiede, ma anche già porta in sé stesso, il superamento del tempo di inutili e scomposte chiusure: “Una lunga sfilata di monti / Mi separa dai diritti / pensavo l’altro giorno osservando / Il lago maggiore e le Alpi / Nel volo tra Roma e Parigi / (Dove dal 1966 un single può adottare un minore). / Da Barcellona a Berlino oggi in Europa / Ovunque mi sento rispettato / Tranne che tra Roma e Milano / Dove abito e sono nato.”
Id: 100 Data: 28/07/2008 02:04:02
*
 Dante Maffia - Poesia - Passigli Editori
Dante Maffia - Poesia - Passigli Editori
Al macero dell’invisibile
Maffia ha uno sguardo molto attento, proprio perché ha la coscienza che il tempo della tautologia può essere alle porte, non già soltanto come processo storico e culturale, ma anche nella stessa lingua poetica, v’è il rischio di cadere in una spirale avvolgente verso il già detto, ed è proprio questa sua coscienza che lo libera e lo centrifuga fuori da questo rischio: “Il terrore che tutto sia stato detto, / ripetuto in più lingue e in varie epoche; / che tutto sia passato e ritornato / e s’approssima il tempo della tautologia. // […] // Per i tanti millenni da venire di cosa vestiremo i nostri sogni? / Sento la noia dell’eternità / come un pantano di melma.”
In questo libro c’è, abbastanza evidente, una analisi dello stato sociale contemporaneo e dei comportamenti che hanno caratterizzato il passato delle azioni umane che, in qualche modo, in maniera quasi scontata, si ripeteranno; egli, quindi, manifesta una sorta di veggenza nel suo tentativo di descrivere un futuro non già temporale ma evolutivo: “Coleranno a picco i palazzi, / la deriva avrà un suono lungo / sdolcinato di ruggine, / il sapore disfatto delle carogne. / E nessuno s’accorgerà del mutamento: / i bus viaggeranno, la luna / s’affaccerà normalmente per deliberare / su qualche fiore morto. / E chi invocava il silenzio o sperava / nella rivolta s’accorgerà / che le saracinesche dei negozi / s’apriranno puntuali / e le acque dei fiumi / andranno verso il mare.” Il poeta sferra un netto colpo all’indifferenza verso le guerre che infestano il mondo, eventi segnati da distruzione e morte, ma che non modificano il tran tran quotidiano di un contesto sociale lontano dal luogo dove accadono, né la natura delle cose che continua, imperterrita, a seguire le sue leggi eterne ed immutabili.
Il non senso e l’assurdità della guerra, sono denunciati anche in quest’altra, bellissima, poesia: “Perché avrebbe dovuto andare al fronte? / Per chi? non aveva mai sentito nominare / Piave, Tagliamento / e le montagne lo mettevano a disagio. // Sparare su un altro? / Per prendergli poi la casa? / Aveva la sua, fabbricata / mattone su mattone con le sue mani. // E gli altri a dire che i codardi, / solo i codardi agiscono così.”
In questo mondo rosso di sangue e nero di non senso vi è una oasi di verde, la famiglia; Maffia è padre ed ha un amore profondo per le figlie, amore che lo rasserena e attraverso il quale trova l’ingresso in una sorta di giardino dove ristorarsi di tranquillità rituffandosi nelle acque limpide della propria fanciullezza: “[…] // Così potemmo visitare il luogo / dove nascono le favole. / Venimmo a sapere che lì / non conoscono la morte. // C’era anche l’aquilone / che da bambino mi sfuggì di mano. / […]”, oppure “Rivedo la mia infanzia nei tuoi occhi / e tutte le città di buio che fanno ressa / nel mio cuore si dissolvono a un tuo gesto. / sei bella come un orizzonte acceso / da un vento di luce avido di sogni, / buona come il pane.”
“Al macero dell’invisibile” è una raccolta di una densità di contenuti ampia e profonda, ogni singolo testo apre porte su mondi e pensieri che hanno panorami aperti e neppure facilmente risolvibili in poche parole; nonostante questo, Maffia riesce, con intelligenza poetica, a ridurre all’essenza quelle vastità di problematiche, riassumendo in pochi versi domande poste a fondamenta del mondo naturale, sociale e umano. Talvolta, attraverso la sua capacità di mostrare la deriva dell’evoluzione sociale verso l’assurdo, arriva ad indicare anche modalità per una possibile soluzione a tale deriva, modalità che indicano, spesso, direzioni semplici e scontate, esattamente opposte alle azioni che introducono all’assurdo, e incredibilmente la loro ovvietà le rende quasi invisibili.
Maffia è un poeta che dovrebbe essere maggiormente conosciuto e letto anche da chi non è del “mestiere”, i suoi testi rendono la poesia piacevole, e non è cosa ovvia per un poeta. E' un libro che ha un grande valore ed è consigliabile la lettura anche per chi vuole scrivere poesia ma ancora si sente cedevole nel legare le proprie sensazioni e intuizioni alla scrittura in versi: Maffia mostra come sia possibile mantenere un linguaggio semplice e ben articolato ed esprimere al meglio le proprie visioni sulle cose e gli eventi.
Id: 97 Data: 28/07/2008 01:33:03
*
 Roberto Costa - Poesia - bufferia – buffaggini varie e poesia
Roberto Costa - Poesia - bufferia – buffaggini varie e poesia
l’aria in tasca
Per quanto minuto, il libro, e anzi proprio per questo, ci pare doveroso recensirlo, ogni sia pur piccolo refolo di poesia ci pare sia degno di nota. Le poesie di Costa hanno un ritmo baldanzoso, come vuole essere appunto una buffaggine, libera da calcoli e procedente a ritmo scherzoso: “Un PAZZO ha fermato / i LAVORI // non / permetto / che / si / tocchi / l’alberello / mio alberello / gioia vera del / mio / cuore / la / più / bella / na na na na na na na / son / spiegato / ?! // […]”. V’è, nella raccolta, una piacevole spavalderia che sorprende il lettore.
Pare quasi un diario di sensazioni ed emozioni annotate da una persona in corsa, che salta da un capo all’altro di varie situazioni e contesti: “Avere la luna tra due dita / e non poterlo dire / (consunzione di un esilio con le orecchie / come vento fra i tetti) / immobile / su i sassi / non poter essere / stare / fotogramma incendiantesi / alla globale insaputa”.
Nel suo metaforico andare spedito tra i versi, incontra personaggi di ogni sorta: “A leggere in fondo a un vagone / poesie al finestrino / lo trovai un inverno / Siediti capociurma, disse / […]”, oppure “Nel giardino vi trovo / a dividere un pane e la domenica / […]”. Poco importa se tali personaggi sono reali o immaginari, poiché ogni fatto o panorama descritto è comunque filtrato e mostrato in prospettiva dall’occhio del poeta che tutto trasforma in simpatica buffaggine, anche se talvolta amara. In alcuni tratti della lettura però si può tirare un sospiro di sollievo, un attimo di sosta prima della nuova corsa.
La piccola raccolta, senza neppure i numeri di pagina, è interessante per quanto ci pare anche necessario, prima di arrivare ad una genuina originalità espressiva, che l’autore debba lavorare maggiormente per coniugare l’innovazione verbale con una forma stilistica adeguata. Attendiamo nuovi lavori.
Id: 93 Data: 22/07/2008 19:19:52
*
 Valerio Meledandri - Poesia - Casa Editrice Ismeca
Valerio Meledandri - Poesia - Casa Editrice Ismeca
La bella vista della camera 70
“La bella vista della camera 70” è un cofanetto che include un disco video DVD e un libretto stampato: è un videolibro di poesia. Inserendo il disco in un normale lettore DVD si può godere della lettura/recitazione dei testi poetici.
Sono poesie ben scritte, che si leggono/ascoltano con piacere anche per la loro ampiezza quasi narrativa ma che, attraverso un sapiente lavoro metrico e di ricerca della parola, hanno una gradevole e godibile musicalità nei versi. L’abile uso della parola fa trasparire una serietà di scrittura non comuni. Si avverte che l’autore possiede la lingua in maniera adeguata e la usa nello scorrere del testo con sapienza, riuscendo, nell’accostamento musicale delle parole, a evocare sensazioni piacevoli e continuità di discorso poetico. V’è coerenza di composizione in tutto il (video)libro. L’importanza dei contenuti e l’acutezza delle intuizioni esistenziali è esaltata dalla serenità con cui le parole accompagnano il lettore/ascoltatore. L’autore ha confidenza con la lingua e questo gli permette l’utilizzo di parole desuete se non addirittura di porsi sul confine del neologismo.
La musicalità sembra essere un elemento importante nell’ascolto del mondo di Meledandri a tal punto che si ritrova nella interessante e bellissima poesia intitolata, per l’appunto, “Musicalità”: “Piove, piove mentre incerta è l’ora, / piove un’acqua sanguigna di deserto; / le gocce bussano discrete / sulla sorellanza di tegole antiche, / tutto pare ascoltarle / poiché tutto tace /religioso e meditante. // Liquida è la musica, / ancestrali le note, / acuto il profumo della terra. / Non v’è altro suono, altra voce / che ci parli un po’ del mondo, / dedichiamo a noi stessi / questa profondissima dolcezza”.
L’autore manifesta una rilevante e fine sensibilità nei riguardi della natura e delle relazioni che intercorrono tra l’umanità e le cose naturali, piante e animali. Bellissime sono le poesie “Una solida ragione”, “Lazzarina” e “Trilogia del cane”.
“Una solida ragione” è una poesia che si legge spontaneamente almeno due volte di fila, una volta per godere della sua musicalità, l’altra per seguirne il ragionamento. Inizia così: “Ieri ho amputato un ramo al callistemo. // Non ha detto che non voleva, / non ha maledetto le ragioni umane / […]”.
Anche sul fronte esistenziale, strettamente umano, manifesta una sensibilità affinata, probabilmente, sul dolore che il vivere, inevitabilmente, ci riserva. Anche l’aspetto trascendentale rimane sempre molto immanente e legato alla materialità, vi è un forte disagio verso coloro che dovrebbero rappresentare in qualche modo la spiritualità del perdono e che spesso invece conducono inesorabilmente verso la cupa sensazione di una condanna certa: “[…] / Io sono qui / e a questo punto sono giunto / senza l’essenziale patrocinio / di Santa Madre Chiesa, / a massi poderosi o in minuto ciottolame / perduto, dove lo ricordo poiché mai / si perde un Dio per caso. // Lo straordinario smarrimento / si compì tra fogli di giornale ed esauste omelie, / […] / Sempre cosciente della esistenziale emorragia, / non m’adeguai comunque all’operaia operosità / dell’ape comunista, / ma neppure spiccai il volo/ chiedendo in prestito ali e leggerezza / ai fantastici miracoli di Esculapio od Ireneo / […]”. Ma l’autore, abilmente, prende tempo e ragiona, allarga lo sguardo e vede, “nel grande deposito antistante l’Aula del Giudizio”, le molte domande relative ai veri crimini dell’uomo, arrivando così a convincere del fatto che forse il peccato personale vada riproporzionato: “[…] / Recupero il mio, i miei e le mie, / parte del nostro e nella dovuta proporzione del vostro, / potrò infine entrare nell’Aula estrema / dove m’attendo non un Giudicante / poiché mai ho peccato ponendomi al fianco / di signori della guerra o imbrattandomi / di umano mercimonio o sottraendomi / al dovere dell’uomo per l’uomo / […]”.
Un videolibro molto interessante e godibile in un semplice ascolto, anche senza guardare necessariamente le immagini. Per quanto riguarda il video, a mio avviso, sarebbe stato meglio evitare lo scorrere dei testi sulle immagini e l’alternanza di una variegata esposizione di fotografie con l’immagine dell’attore Alessandro Maggi che legge, sarebbe stata preferibile. Ma questa è una minuzia in relazione alla ottima stesura dei testi.
Id: 87 Data: 02/07/2008 21:19:52
*
 Dimitry Rufolo - Poesia - Altromondo Editore
Dimitry Rufolo - Poesia - Altromondo Editore
Pensieri a banda larga
La poesia sembra essere, per Rufolo, un bicchiere pieno, che compare così spesso durante tutto il libro, un bicchiere che è simbolo di solitudini e sbronze inutili, almeno all’apparenza, è un bicchiere in una casa vuota, in un cuore stanco, in una voce spenta e in un sole che non sorge: “La casa è vuota / il bicchiere è pieno / il cuore è stanco / la voce è spenta / il sole non sorge / […] / ma ogni giorno / spero di stupirmi”. La poesia di Rufolo sa essere ironica, di una ironia che non ha humor ma, semmai, amarezza, è il tentativo di tornare a una integrità attraverso lo smantellamento di luoghi comuni; egli vede dove si potrebbe arrivare ma prende atto del fatto che là non ci si arriverà mai, che sempre la mappa che può portarci a casa è quella che usiamo per qualcosa di più immediato che soddisfa la nostra esigenza subitanea, il tutto e subito del mondo contemporaneo contagia finanche i poeti che perdono la via: “Sai che c’è? / Che io conoscevo la grandezza / io non sapevo perché / in ogni posto dove ho vissuto / trovavo gente della notte. / […] / Lasciamo amori veri / per panini solitari e bicchieri di notte. / E versiamo lacrime sincere / e vino falso / su panchine di piazza / pur di pensare di essere poeti / ma siamo solo perduti / e ci asciughiamo il naso / nell’unica mappa / che può portarci a casa”.
V’è, nei suoi testi, una rabbia più che comprensibile, come una nebbiolina che si desta al mattino nel freddo pungente, un monito che avanza, pur nelle divagazioni amorose che lo trascinano, anche queste, nello sconforto; così nella poesia intitolata “L’odio”, egli pronuncia una sorta di anatema: “Fate ammenda e inchinatevi / voi che di tutta la vita / vivete la scorza. / Voi che la notte avete paura / […] / Voi che della vita guardate solo l’apparenza / […] / Voi che ostentate conoscenze da retro di copertina / voi che conoscete le cattedre / ma non i banchi / voi che non conoscete / l’umidità avvolgente / delle panchine pensanti / nei paesi sconosciuti. / Quando anche voi dormite / e non sognate altro / che sogni altrui”.
La poesia di Rufolo ha inoltre una forte connotazione sociale, egli scorge i punti deboli delle consuetudini sociali e ne mette in luce l’incoerenza, come nella poesia “Ruoli”, che è, a mio avviso, una delle poesie più belle del libro, per costruzione e contenuto e dove l’autore mette sotto accusa la fretta e l’incapacità di fermarsi davanti al prossimo: “Un uomo aspettava al crocevia / […] / E non aspettava nulla di incredibile / era lì e pensava: / ‘Non è strano un uomo solo ad un crocevia?’ / Una donna passò veloce / poiché il semaforo era verde / ed il tempo era poco / ed aveva così tante cose da fare. / passò e lo vide / ed i loro sguardi si incrociarono / ma il tempo era poco / ed il semaforo verde / oltrepassò l’incrocio / […] / L’uomo attraversò la strada / ma non riuscì ad attraversare la notte. / La donna fece tutto quello che doveva / ma non riuscì ad essere felice”.
Un altro elemento importante nella poesia di Rufolo è la natura, essa crea i contorni delle scene ed è, in alcuni testi, il centro e il significato metaforico di un’idea. Così un pesce agonizzante sulla spiaggia simboleggia il cuore del poeta. Impressiona come egli non intervenga a modificare lo stato delle cose naturali, ma, in modo quasi indiscreto, osserva, succhiando il significato vitale, l’armonia sostanziale dei soggetti naturali: “Ho visto due coccinelle / vicine su un tronco nudo / di un albero del parco. / Le ho viste così vicine / che mi sembrava si stessero baciando / […] / Mi siedo sulla panchina di fianco / accendo una sigaretta / e mi metto comodo, / non penso che vedrò niente di meglio oggi, / […] / Continuo a guardare quel bacio così puro / e mi vergogno di essere così indiscreto”.
In conclusione “Pensieri a banda larga” è un libro abbondante di contenuti, che rivela un’acutezza e una capacità narrativa dell’autore non comuni. Nonostante questo mi permetto di annotare qualcosa in relazione alla costruzione dei testi, sulla versificazione. Mi pare che la scelta di scrivere le poesie centrate nella pagina e non allineate a sinistra, sia una pessima scelta che fa sì che, a prima vista, il libro prenda una connotazione di scrittura adolescenziale. Talvolta i versi hanno parole sovrabbondanti che rischiano di affossare l’intuizione. C’è da lavorare più a fondo sulla forma dei versi, alle volte vi sono ripetizioni di parole che non aggiungono nulla ad un’idea già perfettamente espressa. Nella poesia è necessario un rigore maggiore, al fine di non pubblicare libri che piacciono soltanto all’autore. La poesia va oggettivizzata con capacità autocritiche coraggiose in relazione alle modalità di scrittura. Non è male sottoporre i testi, prima della pubblicazione, a persone qualificate e notoriamente “rompiscatole” e critiche. Nonostante questo, consigliamo il libro, poiché riconosciamo nell’autore capacità rilevanti di scrittura, per quanto sia necessario un affinamento. Il libro trascina fino all’ultima pagina, suscitando nel lettore la curiosità verso i componimenti che si susseguono. Per essere alla sua prima esperienza letteraria, autodidatta, ci pare che ci siano le condizioni per un bel salto avanti nella poesia, ma attenzione la prossima pubblicazione dovrà essere ripulita, pena il rimanere relegati in uno stato di poesia eccessivamente soggettiva, e si sa che la critica non perdona. I nostri complimenti e in bocca al lupo.
Id: 81 Data: 17/06/2008
*
 Fabio D’Aprile - Narrativa - Joker Edizioni
Fabio D’Aprile - Narrativa - Joker Edizioni
Soffio interrotto
Un testo costruito, nella sua essenza, in modo dialogico e intimista, ma che sotto sotto si rivela essere un monologo appassionato delle molteplici anime dell’autore, alla ricerca di risposte che, ahinoi, solo la vita a lungo termine può dare. Egli scava nell’anima e nel pensiero per ben 61 pagine di intensa scrittura. Nelle prime pagine, a causa della tragicità del costrutto linguistico, viene la tentazione di abbandonare la lettura; pare che i soggetti dialoganti (che risultano essere uno stesso soggetto monologante) sia sull’orlo di una personale tragedia vissuta e ancora non ben rielaborata, ben lungi quindi da una soluzione esistenziale. E in realtà nel testo si arriva a una conclusione che giustifica la non esistenza e la bontà dell’essere mai nati. Nel dolore, che è sicura dote della nascita, vien da pensare che sarebbe stato meglio non essere mai nati. Il filo logico, seguito nel corso del libro, ha un che di amaro, ma è un punto di vista sulla vita che vale la pena considerare: “Chiunque sia convinto che la sua storia sia importante o è un narcisista o ha sofferto molto”. D’Aprile scrive ma nega la veridicità della scrittura: “[…] ritengo che tutti gli scrittori non siano altro che imbroglioni. […] Si concedono all’istituzione letteraria per incassare qualche buona provvigione”. In questo senso si ravvisa, nel testo, una certa schizofrenia latente, che emerge nelle “curve” seguite dalla scrittura, rischiando di buttare fuori strada il lettore, ma forse è un effetto voluto.
Tra i pensieri oscuri che s’innescano in maniera naturale è lodevole il tentativo di soluzione che l’autore assiduamente cerca e talvolta trova all’interno dei suoi ragionamenti introspettivi, i quali scorrono come un fiume in piena ma circolando sempre su se stessi come un serpente affamato e impazzito perché non trova la preda: “Il cuore non ha bisogno di prove, batte un ritmo suo, autonomo, che impone la poesia e nessuno lo può fermare. Così come non si può fermare sbuffo animale per il troppo impeto che è dato al suo capire”.
In uno dei rari momenti di lucidità del discorso, come uscendo da una nube oscura e forse tossica, D’Aprile dà la sua indicazione per arrivare alla conoscenza di sé stessi: “Se davvero vuoi conoscerti meglio, getta la penna, posala in mano ad un bambino e fatti fare un ritratto”; la via per comprendersi c’è, ed è uscire da sé, per guardare la propria immagine negli occhi puri e semplici che la vita offre fin dall’inzio, quella stessa che sembra essere negata al figlio che emerge dall’anima verso la fine del libro.
Il testo è ben scritto e fila liscio, anche se il pensiero alle volte si arrovella su se stesso. Si ritrova nel testo un qualcosa che vagamente ricorda Dostojevski nel suo “Ricordi dal sottosuolo”. Come esordio non è male, l’autore mette in mostra la sua ampia cultura classica e cerca di rendere colto il testo; forse un suggerimento si può dare e cioè di mettere maggiormente in luce la propria personalità, semplificando la scrittura e il pensiero, smorzando la costruzione un po’ ricercata della frase, a favore di concetti più immediati e spontanei che lascino emergere la vera anima dello scrittore, quella che abbandona mode e vezzi per navigare nel mare calmo della scrittura, ma che non per questo non può parlare di tempeste.
Id: 75 Data: 28/05/2008
*
 Luigi Fontanella - Poesia - Rosellina Archinto Editore
Luigi Fontanella - Poesia - Rosellina Archinto Editore
Oblivion
Questa sua raccolta di poesie, scritta nell’arco di un settennio, tra il gennaio 2000 e il dicembre 2006, si apre con l’interessante capitolo intitolato “Fiori”, dove si leggono poesie dedicate ai fiori (Anemone, Camelia, Dalia, Geranio, Giacinto, Margherita, Rosa canina e Violetta) come altrettante figure femminili, con una scrittura che rende partecipe il lettore della sua confidenza con questi elementi naturali e rappresentativi, probabilmente, di altre relazioni umane: “Possiedi, Camelia, quella perfezione / d’amore che io non seppi far mia. / […]”.
Il libro ha sicuramente una nota di merito, si legge volentieri e semplicemente, si ha quasi la sensazione di esserne gli autori: “Era tanto che / come stasera / non sentivo questo /soffio di rinnovata primavera. tanto che non m’appropriavo / di questo albume calmo di rinascita… / dov’ero stato tutto questo tempo? / […] / Tutto quanto abbiamo amato intorno a noi / non cesserà mai d’esistere.”
Le poesie di Fontanella sono “leggere”, volendo mettere in risalto, con tale aggettivo, la dote dell’autore di esprimere, con semplicità di linguaggio e senza perdere la maestria del poeta, caratteristiche salienti ed evidenti della scena, del soggetto o dell’azione rappresentata. In tutta la raccolta, si avverte, e non dispiace, una caratteristica confidenza dell’autore con il lettore. Le sue poesie sono simili a un diario di situazioni, presenti o passate (si affaccia spesso al davanzale del ricordo), a cui si accompagnano percezioni e pensieri personali che il poeta condivide con chi legge; questo suo aprire al lettore (che diventa ospite tra i suoi versi) le porte dei propri pensieri, spesso legati ai ricordi, spiazza per la disarmante semplicità e assenza di ricercate complicanze poetiche. Specialmente nell’ultima parte del libro, le poesie di Fontanella fanno pensare a testi scritti in maniera occasionale (ma non lo sono), dettati dall’esigenza di fissare idee, è come trovarsi per caso tra le mani il diario di una persona che l’aveva nascosto da qualche parte con l’intenzione di non farlo leggere ad alcuno: “Ripenso a quei giocattoli abbandonati per distrazione, o per uso consunto, in coni d’ombra domestici; vecchi giocattoli che non riemergeranno più da quel loro silenzio; giocattoli muti, non più ravvolti in fasce innocenti”.
“Oblivion” significa oblio e dimenticanza, un titolo azzeccato che tradisce subito il carattere del libro che, come un diario, appunto, ha un vago sentore di nostalgia e di andati e dimenticati vissuti, rievocati dalla parola e dall’odore delle pagine dello stesso diario: “Torna indietro, se puoi, / anima in abiura, guàrdati / attorno in quest’aurora di bambini / adunati a riva, guardando al mare / per i loro destini. […]”. E s’intona bene, la tonalità e la atonalità di questo libro, con la variegata e omonima musica di Astor Piazzolla: “Oblivion”.
Id: 67 Data: 09/05/2008
*
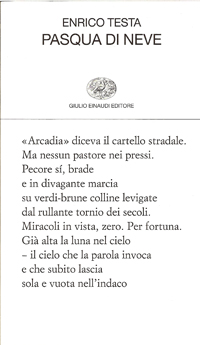 Enrico Testa - Poesia - Edizioni Einaudi
Enrico Testa - Poesia - Edizioni Einaudi
Pasqua di neve
Testa propone, attraverso i suoi versi ben orchestrati e con varietà linguistica lodevole, una visione del mondo disunita, in cui le varie parti cadono in un conflitto irreparabile che lo destina inevitabilmente alla rovina: “[…] / E loro, strinati dalla primavera improvvisa, / sempre lì a chiedersi / se siano alleati, o nemici, / i libri, i fiori, le luci fugaci, i soffi vischiosi, le voci / dolci acute invadenti / nascoste nelle cortecce o nelle fessure, / e per quanto tempo potranno ancora durare / le imposte cadenti marce di salmastro… / […]”.
Un bel libro, una bella prova di scrittura legata alla vita, ai gesti del quotidiano – in parte si evincono dal libro le abitudinarie azioni dello scrittore. Egli parte sempre da scene e azioni esteriori ben precise per condurre verso i processi intellettivi e affettivi da cui scaturisce il suo pensiero.
Id: 61 Data: 22/04/2008
*
 Milo De Angelis - Poesia - Mondadori (Collana Lo Specchio)
Milo De Angelis - Poesia - Mondadori (Collana Lo Specchio)
Tema dell’addio
Milo De Angelis è abile poeta, impressiona la sua maturità stilistica e la pesantezza con cui avanza la sua parola, sulla quale appoggia decisamente tutto il significato di cui è foriera, parola che come radice affonda nel terreno della lettura configurando nel lettore riferimenti esistenziali irremovibili. D’altra parte le sue parole si compongono agili tra i versi in una dinamica e agilità di chi sa quello che dice, cosa non ovvia di questi tempi.
Id: 53 Data: 04/04/2008
*
 Emilio Zucchi - Poesia - Passigli Editori
Emilio Zucchi - Poesia - Passigli Editori
Tra le cose che aspettano
Nel suo procedere denuncia alcune parti del sistema sociale vigente: l’ipermercato, i “lobotomizzati digitali”, gli idrocarburi, le “orecchie paraboliche”, gli “occhi elettronici” lungo la via di casa, e tutta una serie di tendenze sociali che rendono l’uomo indifferente mentre le cose attendono la restituzione di una integrità tradita, del loro ruolo iniziale e sostanziale.
In una seconda sezione della raccolta Zucchi parla di schiene nere, pugni neri, labbra africane, bambini di madri africane cariche di merci, tutti simboli di un rapporto con il mondo, con la natura, ormai corrotto dalla modernità. E’ una società che ruota fuori asse.
Nell’ultima parte del libro, “Appennino”, si allontana dal mondo di questa stessa modernità sbilenca per proiettarsi nel mondo naturale della montagna, dove si trova una pace che scaturisce dal ruolo integro che ancora le cose possiedono pur nell’apparente terribile ciclo di vita e morte, di vittima e di carnefice: “Lo scheletro di pecora spolpato, / a ridosso del masso ricoperto / di ruvidi licheni, dentro l’alba / d’autunno fende gemiti / al vento. […]”. Ma è proprio nelle piccolezze, che alle volte ci sfuggono, disattenti come siamo, che si riflette l’immensità e la chiave della serenità: “[…] Un passero s’approssima per bere […] / in quella mite sete ora placata, / tutto l’immenso cielo”.
Id: 48 Data: 21/03/2008
*
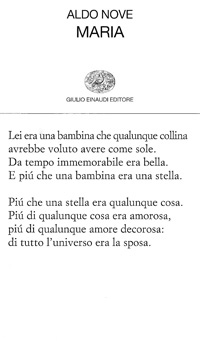 Aldo Nove - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Aldo Nove - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Maria
Nel suo percorso narrante Nove ha la capacità di mettere in luce i sentimenti e i pensieri dei fatti che avvengono lungo la narrazione evangelica, come se avessero una loro soggettività; lo stesso Angelo che porta l’annuncio, davanti a Maria trova il suo stesso senso. La quarta poesia, dove il poeta descrive l’annunciazione, è un capolavoro, è l’Angelo che parla lungo i ventotto versi: “Dentro di te si compia ora il mistero. / Tu sai: senza di te, non era vero / l’inizio. Tu, lo inveri. Io non ero / senza di te. Sì, c’ero, ma non ero // davvero. Come tutto. Tu sei il senso. / Io sono qua nella tua casa immenso. / Ho deposto le ali. Ti conosco / da sempre. Sono la luce del bosco, // il raggio che al mattino dà la vita: ma solo tu sei la luce infinita. / Da te avvierà ogni cosa il suo percorso: / tu sei l’acqua del mare, io solo un sorso. // […] // Tu sei ciò che sarà e che io divento”.
Il poeta è abile nel procedere talvolta con affermazioni che tenta subito di allargare nel significato, come un cerchio d’onda sull’acqua che cerca di prendere dentro tutto il lago ma che inesorabilmente si smorza, per quanto ampio sia, così il poeta cerca di allargare i confini del senso delle parole e del loro naturale limite, riuscendo nell’intento, utilizzando talvolta il gioco di accostare parole dal senso opposto. In questo modo riesce a rendere il grandissimo mistero di Maria, del Figlio che concepisce, del suo amore verso di lui. “Così che tutto in te miracoloso / fosse compreso, e tutto fosse sposo / di te che eri soltanto una bambina / che ha per confine dove si sconfina // […]”; e “[…] Canto / che avvolge la tua stanza come manto di luce che s’irradia nell’incanto / del ventre tuo che diventando santo // è fragile e possente e le distese / attorno a te degli alberi e le stelle / dormonoi nel tuo ventre, in te discese. // […]”.
Un pensiero spetta anche a Giuseppe: “Giuseppe. Era il suo sposo. Sulla terra / così sancito. Matrimonio e guerra, / custodia del bestiame, paradiso / spezzato, sogno d’unità diviso // […] // Un uomo ed una donna uniti come / un verbo che diventa un solo nome: quel nome è dentro te, e ora sei tu, / è dentro la tua carne, ed è “Gesù””.
In conclusione è un poema importante che penso sia molto interessante da leggere, almeno per chi ama la poesia, per l’abilità di scrittura ma anche per la profondità di pensiero. Nove, in questi pochi versi, riesce veramente a rendere naturale ciò che è da sempre uno dei più grandi misteri: la figura di Maria e del suo concepimento. Chi è credente troverà sicuramente un rinnovato slancio verso il mistero dell’amore di Dio.
Id: 47 Data: 20/03/2008
*
 Giulio Bogani - Poesia - Edizioni Gazebo
Giulio Bogani - Poesia - Edizioni Gazebo
Dovere d’allegria
Da segnalare la bellissima introduzione al libro scritta dall'autore: "Mi risulta difficile distinguere la ricerca di una giustizia sociale o il peresguimento d'un ideale, dalla ricerca d'un sorriso o dal perseguimento d'un amore: credo che siano lo stesso volto coerente, gli stessi occhi d'un identico irrinunciabile sogno". Quella di Bogani è la poetica dell'esistenza, dell'essenza, dell'oltre l'evidente, del non omologato: "Non abbiamo ritratti / né rifugi / né rapporti. // Ma il mio calore esiste / ed è fuori casta". Ed esprime bene la vita, un viaggio, una migrazione, un piacevole "vaso rotto dal vento": "Come la goccia / sospesa sulla cannella / e il suo futuro infrangersi / così questo viaggio / il vaso rotto dal vento".
Id: 45 Data: 11/03/2008
*
 Sebastiano Aglieco - Poesia - Il Ponte del Sale
Sebastiano Aglieco - Poesia - Il Ponte del Sale
Dolore della casa
E’ una poetica della vita e della speranza, che continua nonostante la morte: “[…] ti accoglieranno i bambini come / hanno fatto oggi: / ‘Ben tornato, maestro / faremo del nostro meglio’. / Contro la cattedra / stretto nei loro corpi luminosi, in coro. / […]”. L’autore è maestro elementare e fa esperienza del bene che le relazioni umane vere – come quelle che esprimono i bambini nella loro genuina freschezza davanti alla vita e alla morte della quale ancora non possiedono la dolorosa sensazione travolgente – possono realizzare lenendo i dolori più gravi: “[…] I bambini si mangiano la morte”.
Nel libro compare spesso un “tu” a cui l’autore si rivolge in maniera dolce ma decisa, come in un resoconto davanti allo specchio nel quale vede riflessa l’immagine di se stesso come sunto di un contesto familiare che sono le proprie origini. E’ un percorso nella memoria e nel presente che la memoria può dirigere, il poeta innalza preghiere come inni: “Sciogli le acque della sera / verso il mare, mostraci scarpe / sgangherate, un abito provvisorio per / viaggiare. […] / Questo lo accetterò, questo lo capirò: / essere nel tempo, staccati e / passeggeri, simili e distanti / nella vicina preghiera”.
La parola, e quindi la scrittura, diventa via di possibile ritorno alla serenità che precedeva il dolore: “Alla parola ho chiesto tutto / la strada del ritorno e / la formula per sedare il vento […]”, ma c’è “[…] una separazione / in cui, a volte, un dio c’intrattiene […]”, “E allora si faceva incontro un compagno / il più silenzioso, il meno lusinghiero / […] / veniva con passo lento e gli si sedeva accanto / talmente leggero che una volta lo scambiò / per un uccello. Lo guardava, ecco tutto / o gli asciugava il pianto”.
E’ una raccolta complessa nella scrittura, infatti talvolta il verso è colloquiale ma allo stesso tempo, innestato nell’insieme del testo poetico, conduce dentro costruzioni logiche articolate in cui è necessario mantenere con attenzione di mira il soggetto della frase. Una gradevole prova di scrittura, pensandoci bene la sensazione è simile ad un giro sulle montagne russe.
Id: 42 Data: 07/03/2008
*
 Giuseppe Bisegna - Poesia - Aletti Editore
Giuseppe Bisegna - Poesia - Aletti Editore
E poi cominciò a raccontare...
“E poi cominciò a raccontare…” è un libricino di sole 38 poesie che, data la brevità dei testi, sono quasi dei pensieri scritti, o semplici constatazioni, ci sono infatti ben tre poesie così intitolate. I testi non sono solipsistici ma anzi hanno un carattere di apertura rilevante, tipico della giovane età dell’autore che si apre al cosmo sociale e affettivo e osserva, interroga e presenta al lettore le sue proprie esperienze e visioni del mondo.
Ci sono testi molto interessanti, come la stessa poesia che apre il libro - “La luce bianca della lampada / si argenta sull’icona / il legno rimane opaco / come noi a volte” – e spunti di riflessione, come il suo paragonare la mente ad un vascello con vele grandi e fragili e la fantasia come a un vento impetuoso e continuo, una bella figura che fa capire quanto il poeta sia potentemente preso dalla forza della fantasia che trascina la sua mente per l’oceno delle invenzioni, dalla quale non può divincolarsi a meno di non ammainare le vele del pensiero, e mi pare che nelle sue poesie egli talvolta lo faccia, giocando di fantasia ma anche fermandosi nella razionalità osservativa e affrontando tematiche fondamentali quali: l’essere dell’uomo e il suo destino - “[…] e lì dove infuria la baldoria / dove non c’è ora / e nulla si posa / mi metterò al centro / in religioso silenzio // provocando ilarità e sgomento // per voi / che nulla sapete / ma siete votati all’eterno”; la bellezza e l’importanza del vivere ora e serenamente – “[…] Sembra si viva una sola volta. / Ho messo la sciarpa e la giacca io esco”; l’importanza dell’amore universale – “Solo se amiamo / non una donna, non un uomo o cane o gatto / […] siamo felici / […] siamo forti / allora vale la pena di arrabbiarsi, / ne abbiamo il diritto”; la capacità di cambiare prospettiva per migliorarsi – “Fu un buon fabbro / quando seppe cosa prova il ferro // quando prima arde / e poi è battuto”.
Bisegna ha inoltre un forte senso del sociale e denuncia con le sue poche parole, come solo una immagine fotografica sa fare, alcune situazioni di disagio sociale, scoprendo l’anima di ripetitive linee notturne di autobus che trasportano militari, oppure mettendo in luce il disagio dei cosiddetti barboni, o la vecchia che manda cattivo odore da un posto dove nessuno si è più seduto, o le donne violentate, o i bambini sofferenti, tutti come quel Dio messo in croce.
In due interessanti testi egli traccia il suo pensiero su che cosa sia scrivere; un testo si trova all’inizio del libro e una alla fine, quest’ultimo intitolato “La macchia” è la chiave di lettura del primo dove il poeta parla del dovere di stare all’erta, perché tra le tante lettere che ogni tanto compaiono addirittura si può riuscire a leggere significati compiuti: “Piccole frecce che ci guidano / a provvidenziali ripari / Quando fuori piove”; il secondo testo è invece a mio avviso il più bello della raccolta in quanto a composizione formale e contenuto e mi permetto di riportarlo per intero: “Quella A l’ho messa io / e nessuno mi ha detto di farlo. / Nessuno è intervenuto / nessuno ha controllato / nessuno ha ricavato interesse / nessuno ne ha pianto / nessuno ha avuto danno, fortemente illuso / sono stato per un infinitesimo libero, / libero di condizionare le sorti di questa pagina / libero di macchiarla / di essere fuori luogo – dentro questo luogo – / Io solo sono intervenuto, fortemente illuso”.
E infine il poeta rivela la sua gradevole visione unitaria del cosmo: “[…] quanti battiti percuotono / questa alchimia / perché tutto pulsa / dai cuori alla terra”.
Non posso però esimermi, per una analisi completa del libro, dal rilevare una certa mancanza di unitarietà stilistica nella composizione formale dei versi. La punteggiatura, non sempre ben calibrata, rischia di far affondare alcuni bei testi della raccolta. Inoltre alcuni sgradevoli errori ripetuti (spero di battitura) mi fanno pensare ad un insufficiente lavoro di editing da parte dell’editore. Ma nel complesso la raccolta regge e rivela un poeta interessante, quindi il consiglio che vorrei dare è semplicemente quello di lavorare con più rigore sulle modalità di versificazione in modo da rendere i testi formalmente unitari.
Id: 41 Data: 05/03/2008
*
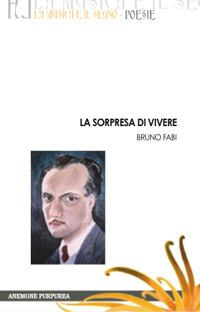 Bruno Fabi - Poesia - Anemone Purpurea Editrice
Bruno Fabi - Poesia - Anemone Purpurea Editrice
La sorpresa di vivere
Ma per quanto riguarda la poesia non direi che il successo sia il medesimo. Questo libro, sicuramente degno di essere pubblicato, non esalta. Ci sono alcune poesie di gradevole lettura, ma nella sostanza il libro non convince. Il versificare è talvolta impacciato da inopportuni capovolgimenti tra soggetto verbo e oggetto. Alcuni versi sono indeboliti da parole inadatte e la poesia non decolla, come se non riuscisse a penetrare la scorza dell'anima che legge appesantita dalla quotidianità. La poesia deve essere penetrante e capace di sollevare il cuore e portarlo in un dove misterioso, al di sopra della pesantezza del reale.
Per funzionare il libro avrebbe dovuto essere più lavorato, direi ripulito, e lasciare poesie tipo questa: "Quando capii che tra noi era finita / mi trovai in un paese sconosciuto / più lontano di non so dove. / Allora mi incamminai per questo viaggio / lungo come la vita".
Il solo fatto di essere intelligenti, filosofi, letterati e scienziati, non significa essere poeti.
Id: 40 Data: 02/03/2008
*
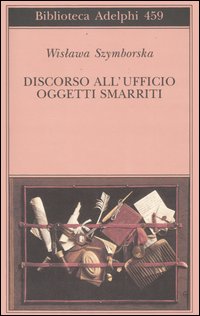 Wislawa Szymborska - Poesia - Adelphi Edizioni
Wislawa Szymborska - Poesia - Adelphi Edizioni
Discorso all’ufficio oggetti smarriti
E’ quindi arduo fare la recensione dei testi di una poetessa tanto stimata e di chiara fama. Vorrei allora semplicemente portare all’attenzione un tipo di poesia che offre una visione alle volte non comune della realtà umana.
Uscì sulla scena della poesia il 14 marzo 1945 con una poesia pubblicata su un supplemento settimanale del quotidiano di Cracovia “Dziennik Polski”. In quella poesia voleva dar conto di quanto fosse difficile esprimere in modo adeguato la mostruosità dei criminali hitleriani: “Voglio definirli con una parola: / com’erano? / Prendo parole comuni / rubo dal dizionario, / misuro, peso e controllo - / Nessuna è quella a adatta … La nostra lingua è impotente, / i suoi suoni d’un tratto – sono poveri. / Cerco con uno sforzo della mente, / cerco quella parola – ma non la trovo. / Non la trovo”.
La Szymborska riesce a cogliere sfumature del “paesaggio sociale” che difficilmente si trovano in altri poeti. E’ come se ella riuscisse, con ali misteriose, a librarsi oltre la terrazza (solo di poco più in là) dalla quale noi tutti vediamo lo stesso panorama e a rimandarci la descrizione dello stesso con noi inseriti come parte del tutto, mettendo in luce con vera e gentile ironia quelli che sono i lati, talvolta ridicoli, del nostro affannarsi ed agire quotidiano: “Progetto un mondo, nuova edizione, / nuova edizione, riveduta, / per gli idioti, ché ridano, / per i malinconici, ché piangano, / per i calvi, ché si pettinino, / per i sordi, ché gli parlino”.
La sua poesia sa dare valore agli aspetti più minuti della realtà, è come una ricercatrice che con lente e spazzolino va a cercare, nelle pieghe della storia, intesa anche nel senso immediato dei minuti che passano, i residui della nostra grossolanità, cercando di ridare dignità a persone o cose nascoste o abbandonate dietro la piccolezza dei numeri se rapportati a statistiche sociali più ampie: “Scrivilo. Scrivilo. Con inchiostro comune / su carta comune […] / […] / La storia arrotonda gli scheletri allo zero. / Mille e uno fa sempre mille. / Quell’uno è come se non fosse mai esistito: / un feto immaginario, una culla vuota, / un sillabario aperto per nessuno, / aria che ride, grida e cresce, / scala per un vuoto che corre giù in giardino, / posto di nessuno nella fila. / […] / Sullo spiedo di filo spinato / ondeggiava un uomo. / Si cantava con la terra in bocca. Una leggiadra canzone / sulla guerra che colpisce dritto al cuore. / Scrivi che silenzio c’è qui. / Sì”.
La sua ironia è dalla parte del popolo che talvolta, nella sua ignoranza, non riesce a cogliere l’entusiasmo di un mondo intellettuale e scientifico in rapporto ai fatti contingenti della povertà. E così s'interroga sul senso che possa avere la scoperta di una nuova stella, quando sotto il cielo succedono cose ben più gravi:
Hanno scoperto una nuova stella,
ma non vuol dire che vi sia più luce
e qualcosa che prima mancava.
La stella è grande e lontana,
tanto lontana da essere piccola,
perfino più piccola di altre
assai più piccole di lei.
Lo stupirsi non sarebbe qui affatto strano
se solo ne avessimo il tempo.
L'età della stella, massa, posizione,
tutto ciò basta forse
per una tesi di dottorato
e un piccolo rinfresco negli ambienti vicini al cielo:
l'astronomo, sua moglie, parenti, colleghi,
atmosfera rilassata, abito informale,
si conversa soprattutto di temi locali
masticando noccioline.
Una stella magnifica,
ma non è un buon motivo
per non brindare alle nostre signore
assai più vicine.
Una stella senza conseguenze.
Ininfluente sul tempo, la moda, l'esito del match,
il governo, le entrate e la crisi dei valori.
Senza riflessi su propaganda e industria pesante,
sulla laccatura del tavolo delle trattative.
In sovrappiù per i giorni contati della vita.
A che serve qui chiedersi
sotto quante stelle nasce l'uomo,
e sotto quante dopo un attimo muore.
Nuova.
- Mostrami almeno dove sta.
- Tra il bordo della nuvoletta bigia sfilacciata
e quel rametto, più a sinistra, di acacia.
- Ah, eccola - dico.
Id: 38 Data: 24/02/2008
*
 Erri De Luca - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Erri De Luca - Poesia - Giulio Einaudi Editore
Opera sull’acqua e altre poesie
In effetti leggendo una sua biografia sembra quasi che egli abbia privilegiato altre scelte, non già quella di essere uno scrittore (tantomeno di poesia) ma piuttosto una persona che vive l'esperienza della vita fino a scelte lodevoli e quasi estreme. Scrive dall'età di vent'anni, è nato nel 1950 e ha pubblicato il suo primo libro in Italia nel 1989 (Non ora non qui). Ha abbracciato l'azione politica respingendo la carriera diplomatica, ha lavorato come operaio qualificato alla FIAT, poi muratore in Francia, Italia e Africa, nel periodo del conflitto balcanico è conducente di convogli umanitari verso la ex Iugoslavia a destinazione della popolazione bosniaca. Da autodidatta ha imparato lo yiddish e l'ebraico per tradurre la Bibbia, si dichiara non credente ma dedica ogni giorno un'ora di lettura alla Bibbia. Eccetera.
Ebbene una figura quanto mai particolare e lontana dalla noia di una vita borghese. Una persona che uno vorrebbe conoscere dal vivo e verificare se è vera!
Leggendo le pagine del libro qui proposto, si trovano testi che sono poesie di vera liricità, come quella riportata sulla copertina, la quale da sola varrebbe l'acquisto del libro: "Chi ha steso braccia al largo / battendo le pinne dei piedi / gli occhi assorti nel buio del respiro, / chi si è immerso nel fondo di pupilla / di una cernia intanata / dimenticando l'aria...".
Ma nella raccolta si trovano anche testi dove l'autore inciampa, come egli stesso afferma, in un versificare che è: "linee che vanno troppo spesso a capo". Meglio sarebbe stato pubblicare una raccolta di testi decisamente in prosa. Vi è in questa silloge una eccessiva ricercatezza intellettuale nell'area culturale biblico/ebraica, come a farne sfoggio, questo, a mio avviso, pone i testi fuori dall'ambito poetico, rischiando di annoiare. Dalla poesia ci si aspetta qualcosa di diverso, qualcosa che è, per l'appunto, mare aperto, forse un po' di timore ha tenuto l'autore troppo vicino alla terraferma. Anche i grandi editori hanno le loro misteriose simpatie.
Id: 36 Data: 17/02/2008
*
 Valentina Ferranti - Poesia - Edizioni Il Filo
Valentina Ferranti - Poesia - Edizioni Il Filo
Penelope Rossa
Le sue poesie scuotono il profondo e, nella loro essenzialità, cantano il canto di un arcano sentire, che ha le sue radici in un inconscio collettivo, tanto antico quanto il mito di Penelope.
I versi della Ferranti sono incisivi, di forti contenuti emozionali, ma abilmente contenuti e controllati da una intelligenza di donna che pervade il libro; l'autrice rivela il mondo come è appunto visto al femminile, cambia il punto di vista a chi, come me, uomo, lo vive come specchio dall'altra parte, a chi, come lei, donna, diversa da lei, lo vive nel segreto del suo dolore d'amore, di vita quotidiana, di piccoli fatti e avvenimenti quasi banali, dando voce e respiro a tutte le donne che non riescono o non possono esprimersi, le sue poesie sono una pausa nel correre delle emozioni, un tentativo di capire e dire l'amore che lega il femminile e il maschile e che, a sbalzi, declina o dà gioia: "Sbuccio mele, / pelo carote e sedani / ... / E nessuno mi guarda: / assenza d'amore". Il suo dire rivela l'esperienza terribile della solitudine, quasi imposta dall'altro sesso che, come Ulisse per Penelope, è assente, lontano immerso in un viaggio di cui non si sa.
La Ferranti prende a piene mani la sua esistenza e si fa forza e crede che da sola può modificare il suo destino, ciò che la circonda, e rivendica la forza creatrice della femminilità: "...Per credere / Sotto un carico di stelle / Alla forza creatrice delle mie mani. / Sono una donna / Tra femminismo e femminilità / Saggezza e civetteria / Dedizione e forza / In bilico su un filo / Tra libertà e amore / Creiamo sempre tutto noi / Come i nostri ventri gonfi".
Tutte le liriche della raccolta sono convincenti, ma due, in particolare, a mio avviso, sono veramente capolavori di forma e contenuti tali da pescare molto in profondo nell'anima del lettore e definendo il leitmotiv di tutta la raccolta: quella intitolata "5 ottobre 2006", la prima poesia del libro, e quella intitolata "Penelope rossa" che dà il titolo all'intera silloge.
Naturalmente, essendo l'autrice alla sua prima esperienza di pubblicazione, qualcosa si può dire per aiutarla a indirizzare al meglio il suo lavoro di scrittrice. Come lei stessa ha affermato scrive le sue poesie di getto, non ritoccandole, questo fatto è sicuramente notevole e colpisce, specialmente ascoltando la lettura dei suoi testi che per quanto essenziali nelle parole, evocano immagini precise e importanti, ma prendendo sott'occhio il testo scritto, subito si rivela una certa disuniformità di versificazione e stile di stesura. A mio avviso i testi più convincenti, in quanto a forma, e questo è un semplice consiglio da lettore, sono quelli scritti più semplicemente utilizzando la normale punteggiatura, esattamente come la poesia "Penelope rossa", in quanto l'autrice non ha certo bisogno di stupire o attirare l'attenzione in altri modi, essendo i testi pregni di contenuti ed essendo già importanti e azzeccate le parole che usa.
La casa editrice che l'ha pubblicata è sicuramente meritoria di questo perché si sentirà parlare ancora di Valentina Ferranti, ma un consiglio di lavoro formale, di ritocco, più approfondito ai testi è sempre auspicabile da parte di una casa editrice verso i propri autori, specialmente se alla prima pubblicazione, e che voglia proporre poesia di qualità.
Nota della redazione: La Recherche propone questo testo con sincero entusiasmo in quanto nel mondo della poesia si assiste spesso ad uno scialacquio sovrabbondante di parole in libri stampati alla meno peggio, con case editrici che "lanciano" letteralmente nuovi ignari autori nel mondo della carta stampata senza garantire un buon livello di qualità ed è raro trovare scrittori esordienti come questa autrice che abbiano un simile talento poetico.
Id: 24 Data: 19/01/2008
*
 Marco Amendolara - Poesia - Plectica Editrice - Bishop
Marco Amendolara - Poesia - Plectica Editrice - Bishop
L’amore alle porte
Nelle ultime pagine del libro si legge una breve intervista di Olga Chieffi all'Autore, il quale, alla domanda "Quali sono gli obiettivi dello scrivere per te?", risponde: "Per me la scrittura dovrebbe cambiare le cose e ricordare, ricordare sempre. La rapidità della vita non consente a nessuno di scherzare con la memoria. Quando si scrive, si cerca molte volte di interrogare il passato e il futuro". Questa visione della scrittura è infatti quello che traspare dalla lettura della sua variegata silloge poetica, Amendolara ha sempre davanti a se, nel mare del fluire quotidiano, mosso talvolta dal soffio del dolore, il faro della memoria, che non è solo ricordo di eventi passati ma piuttosto una speciale lente attraverso la quale vedere nuove, e più profondamente, le "cose" dell'oggi, tra le quali troviamo gli affetti, l'amicizia, l'amore; tre poli, questi, in relazione profonda e osmotica. Si percepisce, nello scorrere i testi, il tempo che è andato, non come una sequenza di fatti ma una totalità di eventi avvenuti che pare ancora adesso avvengano; il poeta scrive facendo trasudare dalle righe dei suoi versi la sua "serietà", difficilmente egli si concede il gioco nella poesia, o meglio la poesia è cosa seria, è memoria e, come già detto, la rapidità della vita non consente di scherzare con la memoria.
La scrittura di Amendolara riesce a cambiare le cose? Dal mio punto di vista oserei dire che le cose reali "prese" nel suo campo visivo, vengono cambiate nel loro essere stesso, trasfigurate diventano mezzi attraverso le quali egli penetra il reale stesso e, in esso, la sua passione amorosa, per scivolare così in una relazione profonda con il soggetto del proprio amore: "Invidio quel bicchiere / ... / perché incontrerà le tue / labbra, e vorrei essere anche / il vino che tu diventi, / ti beve ed è bevuto".
In queste pagine si legge un mondo che trascorre e lascia dietro di sé tutto ciò che è stato, la paura di perderlo per sempre, la memoria che se ne va definitivamente risucchiata nella morte: "E' la paura della morte / che mi rende pazzo, / la paura di essere luogo buio e putrefatto, / non provare più affetto, / non poter pronunziare il tuo nome, / non avere neanche un ricordo, / non sognarti / e fare di me, da sogno, realtà".
Dal punto di vista del versificare, il testo ha una caratteristica snellezza e musicalità senza il ricorso alla rima o ad altri astrusi meccanismi poetici. I suoi versi sono asciutti, brevi, mai sovrabbondanti, chiari. Le parole evocano ciò che è situato oltre il loro significato formale, agganciano qualcosa dal profondo e lo elevano alla luce della mente.
Id: 23 Data: 18/01/2008
*
 Giuseppe Conte - Poesia - Mondadori (Collana Lo specchio)
Giuseppe Conte - Poesia - Mondadori (Collana Lo specchio)
Ferite e rifioriture
Leggere questa raccolta di poesie di Conte è una bella esperienza. La sensazione che ho riportato, leggendo i primi testi, è quella di essere di fronte a una persona fervente, dinamica, solare, in lotta con le leggi di invecchiamento che la vita, alla quale l’autore si riferisce in continuazione come il tu del suo dialogare, vuole imporre ai corpi e alle vicende quotidiane. Leggendo la sua raccolta mi è venuto spontaneo pensare all’analogia tra la vita e un grande fiume alle cui sponde il poeta cerca di ancorarsi riuscendo, talvolta, a rimanervi saldo, a non scorrere con la corrente impetuosa verso la foce, ma, nonostante lo stringere i denti, ne è sopraffatto, e anche in questo scorrere, che in breve tempo lo avvinghia allontanandolo da quella che è la sua prestante giovinezza, il poeta riesce a gioire, a creare, a fare del suo andare con le acque il suo luogo di vita e a dialogare con il fiume stesso. Il poeta non è mai vinto dalla vita ma anzi vi sale in groppa come a un destriero e corre per i suoi vasti paesaggi: riesce a vedere i dintorni a coglierne la bellezza, a ricondurli al ricordo e a riviverli nell’esperienza della sua giovinezza: “Credevi di andartene, ma io / ti ospito troppo bene in un cuore / feroce e ragazzo, che niente ha domato, / che conosce troppo bene la tua carezza / e come rinasci fenice dalle tue ceneri”. Dalla poesia di Conte traspira un forte senso morale, il tentativo, la buona intenzione di una morale, ma, ahimè, è una bella lotta, c’è un bel da fare a vincere le proprie aspirazioni al piacere, alla caducità spicciola del pensiero e dei gesti, propositi di pochi attimi che ricadono nella sua gioia smodata per l’esistenza, accompagnata dai più belli e immediati intrattenimenti che la vita possa offrire. Il poeta è un uomo che conosce il soffrire e non ne è vinto e anzi lascia capire che egli proprio tutto ha amato della propria compagna Vita “i rami secchi e in fiore”, un uomo tenace “un uomo sempre offeso e mai vinto”, che ama la poesia e trova in essa la sua redenzione: “Questo il mio nuovo canto”. Egli cerca nel canto poetico di meditare, di concentrare le sue energie per riuscire a capire la strada da percorrere, la via di fuga che lo salverà ancora una volta dalla barbarie del tempo che tutto sbiadisce, e cancella il sogno tanto lusinghiero dell’amore: “E per te, Giuseppe, nel tuo inverno / quali sogni ti dicono che ancora / verranno primavere, verrà Amore? / Quali falò divamperanno, quali / torce accenderai per compiere / nel secolo che inizia / il cammino che ti rimane? / Quali sogni, quali stelle lontane?”. Ci sono poesie veramente belle che ridestano la forza di camminare nel quotidiano, nonostante il piattume del consumismo tenti si assuefarci: “Lo Spirito che ci genera / come uomini e ci dà il canto / ama la materia e il suo grembo / come l’amò all’inizio, quando / la penetrò con un moto / vorticoso e veloce / finché fu / luce”. E nonostante la vita sia alle volte implacabile, l’inverno, freddo e ingordo di luce, è il preludio ad una nuova primavera, ci dice “che è possibile riavere / dal niente forme, profumi, colori”; v’è sempre la speranza che solleva l’anima del poeta affranta dal tempo che inesorabile scorre portando con sé la giovinezza. Infine ci sono poesie immancabili per un poeta, quale Conte si presenta, in cerca del bene, poesie contro la guerra, contro la morte: “Ora so che la guerra è il disonore. / Non è mai giusta, non è mai utile. Non credeteci / quando ve lo dicono”. Qualcosa mi sento comunque di dirla a Conte, perché la perfezione non è di questo mondo, per quanto banale tale affermazione è quanto mai vera, mi pare che in certi tratti la sua poesia sia eccessivamente in corsa dietro le sue sensazioni, fatica a seguirlo, a correre appresso ai suoi slanci di vita, è alle volte più occupato a dialogare con la vita che non a prendere sotto braccio la poesia, sarà questo uno dei motivi per cui egli si sente un po’ traditore della poesia? “Ma ritorna, ritorna, Poesia. / Oso invocarti e sperare. / Seduto sulla sponda del torrente in secca ad aspettare / e ancora tra le rovine a cantare”. Ci sono alcuni versi che potevano essere semplificati. Ma d’altro canto queste critiche che ho in sordina mosso alla sua raccolta, sono anche ciò che danno merito a Conte rispetto a tanti complicati poeti che nell’eccessivo rigore diventano alieni ai più che vedono nella poesia qualcosa di limpido e, soprattutto, leggibile e comprensibile. Quindi questo è uno dei pochi libri poetici che consiglio di cuore anche a lettori meno esperti di poesia.
Id: 19 Data: 08/01/2008
*
 Anna Belozorovitch - Poesia - Besa Editrice
Anna Belozorovitch - Poesia - Besa Editrice
L’uomo alla finestra
Un passaggio a mio avviso molto importante della raccolta in cui la Belozorovitch dalla sua giovane età pare dire alle generazioni più mature: Abbiamo bisogno di coerenza, noi ne siamo capaci...pur nel negativo oserei aggiungere.
Ma come tutti i giovani anche la Belozorovitch si fa alle volte trasportare dalla baldanza del versificare, scadendo qua e là in rime poco azzeccate; forse in alcuni passaggi potevano essere evitate alcune un po' troppo facili consonanze, ma questo non toglie nulla al suo gradevole senso narrativo.
Id: 13 Data: 31/12/2007
*
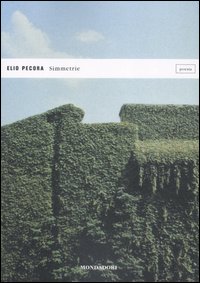 Elio Pecora - Poesia - Mondadori (Collana Lo specchio)
Elio Pecora - Poesia - Mondadori (Collana Lo specchio)
Simmetrie
Nel suo ultimo lavoro poetico, ‘Simmetrie’, si legge un poeta molto elaborato nella scrittura e nel pensiero, alla ricerca di una possibile via di fuga dal reclusorio della materia corporale ma che, nello stesso tempo, è affezionato al luogo della sua detenzione; talvolta il suo versificare è misterioso e assorto, come se il poeta si perdesse in meditazioni sue personali che scrive sul foglio non tanto per comunicarle a probabili lettori ma quanto appunto per meditare in sé stesso. La maggior parte dei testi sono snelli e quasi narrativi, molto interessante e articolata è la poesia che apre il libro, ‘La stanza’: “E’ una stanza il corpo: / nido-cella-recinto. / Abito in cui bastarsi, / da non potersi assentare un istante. / Gabbia d’ossa e di arterie di dove assistere al mondo…”. L’anima, imprigionata nella stanza del corpo, cresce ed evolve nella vita, nelle esperienze relazionali e in particolare amorose, ed è proprio colpa del corpo l’insazietà dell’amore che la pervade: “Corpo mai sazio, mai quieto. / Un amore al giorno cercando l’amore…”; un corpo, dal quale si assiste, ivi rinchiusi, alla corsa di altri corpi, di altre anime imprigionate anch’esse, e per questo lontane, un corpo che può provare a fermare gli altri corpi, alla ricerca della compagnia di cui necessita l’abitante della stanza fatta di vene e arterie, ma che il poeta vede pur nella sua piccolezza corpuscolare come un “Eco di echi infiniti. / Corpuscolo che reca l’universo / e lo sostiene…/…Sede del ritornare e dell’addio”.
Decadenza e infinita piccolezza del nostro esistere suggeriscono di andare insieme in cordata, uniti in un male comune: “Di tanti ognuno comprende nel buio cuore / l’urgenza estrema di questo andare insieme, / l’uno a fianco dell’altro…” e “la paura di essere cacciati / da un recinto indifeso” e nel contempo “cercare nel chiuso / un buco, una crepa”. Di tanto in tanto si presenta nella raccolta una sorta di un dualismo di tendenze e desideri; in tal modo il poeta, a mio avviso, rivela la necessità di vivere pienamente la vita che gli è stata data anche se dall’altra parte si rende conto della inutilità di tale esistenza, situata “dentro un immenso vuoto / … / Quale voce accompagna? / quale mano conduce?”. L’uomo è capace di vivere la felicità, momenti reali che può esperire con il cuore, ma anche allora v’è il dubbio insufflato da una domanda che porta mestizia: “Ma è possibile che questa felicità, / così colma, comprenda anche tutti i disagi, tutti gli assilli?”, si deve esistere perché è bello ma senza “disperare della brevità, / … / Dentro la contentezza sapere che finirà”.
Nella parte centrale del libro Pecora cambia registro linguistico e passa a una poesia in prosa, piccoli racconti di vita quotidiana che lasciano ammirati per la fantasia che rivelano, per le astruse invenzioni che usano i sogni per il loro ingresso nel mondo e ci si chiede se Pecora queste esperienze le abbia vissute, se i personaggi e i sogni siano reali accadimenti, o storie sentite da amici e conoscenti, un dubbio che lascia il piacere, qualche volta, a un lieto fine come nel breve testo intitolato ‘La naia’.
Nella sezione finale intitolata ‘Per altre misure’, affronta il tema della piccolezza dell’umanità e delle vicende umane che sono importanti alla nostra misura ma che in relazione alla vastità cosmica sono così inconsistenti: “Tutta qui la faccenda. Farneticano, / patiscono. Niente di più. Disagi / per di più strasentiti… / Dentro un tutto che non è più di un granello / nel mondo che ruota, / nella galassia sfilacciata”; e poi l’accusa alla folla di uguali che “parlano la lingua della loro testa, / delle loro viscere, ma è una lingua / soltanto loro e per essa si mostrano”; e l’umanità che nonostante tutto resta vigile, anche se, a detta del poeta, inutilmente, con una voglia irresolubile, pencolando sull’abisso, lo stesso delle stelle. Infine in ‘Doppio movimento’ Pecora mette in evidenza il dualismo dell’esistenza “…nella sazietà / temere la fame, sospirare nella contentezza. Così, da per tutto. / Non un attimo di sosta. Sempre una guerra, / un contrasto. Profumi che divengono fetori, / polpe che infradiciano, / parole come baccelli svuotati”.
Dell’amore parla mettendosi nei panni di una ragazza appoggiata a un albero con il suo ragazzo, dove vorrebbe rimanere senza misura di tempo “fino a che è dato / senza orologio e senza calendario”. L’amore perno di un’esistenza, la cui assenza può portare disperazione e aprire vuoti, ma anche l’amore è schizofrenico: “Il suo amore è pieno di odio, / il suo odio è pieno di amore”.
Che cosa si può dire a Elio Pecora che già non gli sia stato detto sulla sua scrittura? Non fa forse piacere continuamente sentire complimenti e ricevere lusinghe di ben riuscite poesie? La persistenza della gioia forse dipende da noi, forse la tristezza che la gioia porta in nuce è essa stessa possibilità di nuova gioia, come un seme nella polpa, va seminato e annaffiato, forse quel negativo nel positivo, quel buio che scaturisce dalla troppa luce va osservato con pupille preparate, affinate, e allora, forse, quella stanza potrà essere aperta ma dipende da noi, l’intenzione di trovare quel varco è sacrosanta ma ogni stanza ha una porta, basta aprirla. Un libro la cui lettura vogliamo vivamente raccomandare.
Id: 12 Data: 24/12/2007
*
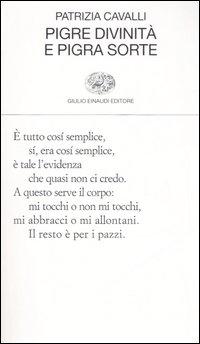 Patrizia Cavalli - Poesia - Einaudi (2006)
Patrizia Cavalli - Poesia - Einaudi (2006)
Pigre divinità e pigra sorte
In questa sua ultima raccolta la Cavalli rivela, ancora una volta, il suo essere vera "Signora della Poesia", con quel suo versificare elaborato e pregno di satira sapienziale, è capace di arrivare al nocciolo di questioni esistenziali, quasi volesse farsi spazio a gomitate tra il chiasso del mondo moderno e consumista per dire la sua, obbligata da se stessa a scrivere per non lasciare la voce alla tracotanza del potere governante dei luoghi dove essa vive e all'ignoranza che invade le strade della sua città, anzi, delle strade in prossimità della sua abitazione, "E ciabatta ciabatta per le scale... / Andiamo, non si resta. Qui non si resta. / Eh no qui non si resta. Perciò andavamo per le strade alla vendetta. / Voglio vendetta, mi bucano le gomme, / ... / Pagherò l'agenzia investigativa / voglio vederlo in faccia quel bel tipo, / ... / E se dicesse - Aò, che vòi da me, oggi te rode?".
La Cavalli poi, visto che sta scrivendo, va oltre e analizza, scienziata improvvisata, lo spazio, il tempo, l'amore, le ambizioni della propria vita che spesso non sono quelle che avrebbe voluto che fossero, "Avevo altre ambizioni, sognavo / altre giustizie, / altre armonie: ripulse / superiori, predilezioni oscure, / d'immeritati amori regalìe", oppure "Il mio paesaggio che credevo sconfinato / ... / ora arrivata ai margini lo vedo: chiuso / orticello calpestato e spoglio, forse / per troppa cura soffocato... / E allora / spoglia anch'io andrò nel ricco mondo, anche se temo il suo ferroso chiasso..."; ma infine essa si rivela essere una donna non tanto di scienza quanto di conoscenza, quella che arriva dalle sue camminate (o scorribande) nei dintorni del suo ambiente domestico dal quale la Cavalli analizza e indossa la città, immersa nei suoi amori nei cui occhi vede il resto dell'umanità, incontra la bellezza, la ferma incredula, immergendosi in una contemplazione lucida del proprio pensiero.
Dalle sue poesie traspare l'idea che forse la Cavalli pensa che il mondo sociale potrebbe essere più attento a rispettare l’individuo e la sua esigenza di riservatezza e di spazi che per lo più vengono concessi, per i quali invece rivendica la necessità del diritto e non tanto della concessione (si legga la bellissima e lunga poesia "Aria pubblica").
La Cavalli non si concede, né nella vita privata (difficile entrarvi in contatto: non risponde mai alle lettere) né nella poesia. Il suo fare un po’ aristocratico che traspare dai versi li rende ancor più attraenti. L'impressione è che conceda i suoi versi a noi lettori solo perché questa è la necessità dello scrittore ma se potesse sono sicuro che li terrebbe per se stessa, troppo belli, troppo lucidi perché possano essere toccati dal popolo chiassoso delle strade.
Id: 11 Data: 17/12/2007
*
 Roberto Mussapi - Poesia - Mondadori
Roberto Mussapi - Poesia - Mondadori
La stoffa dell’ombra e delle cose
Mussapi è capace di accarezzare il lettore con i suoi versi che infondono certezza, simpatia, amore: "Non hai bisogno di conoscere il buio / e le ombre della selva e il velo della luna, / io sono qui, ai confini, tra la città e la campagna / accanto alle soffitte e sotto il cielo, / c’è luce nei miei occhi, ti fa luce / nella tua mente nel sonno e nel buio / l’amore che mutò la mia natura / dalle vette celesti alle ombre cupe, / io ali chiuse, Bubo Bubo, custode."
Un poeta cosciente che la poesia può portarlo in un altrove diverso da ciò che il mondo propone, nuove strade e nuove visioni delle cose: "E non ci sono più Ulisse, e Don Chisciotte, / e Dante, e D’Artagnan, e i Moschettieri... / Andati via, / bruciati dalla poesia". Un altrove che talvolta può essere oscuro e condurre alla "distruzione della trasparenza"...ma sempre si può ritornare all’azzurro nel ritorno alle proprie origini "e subito di nuovo tutto azzurro come un tempo", anche se la paura è in agguato, la paura di essere nessuno: "e anche accanto a lei e a tutte coloro / che per trovare lei avevo abbracciato / per sempre ebbi paura d’essere nessuno". Ma la cosa interessante è che è una poesia che rivela un poeta che non solo entra in relazione con il mondo ma anche e soprattutto porta in sé serenamente la coscienza della necessità della relazione con i propri simili, ecco che traspare dalle sue pagine una certa amorevolezza verso le donne ma anche verso coloro che portano via la sua amata, colei che lui stesso ha protetto dalla morte e ha mantenuto in vita affinché qualcun altro potesse goderne la vicinanza mentre il poeta continua la sua vita là ai confini tra la città e la campagna: "piansi quando lui la baciò e portò via. / Ma ero stato io a tenerla in vita, / nel lungo sonno e nella silente attesa, / perché tornasse al vostro reame".
Il finale della raccolta che solitamente non si rivela io qui lo riporto ed è questo: "Ascoltami, amico, fu quello il prodigio, / resistere al nulla, credere al ritorno". Sono entusiasta di questi versi che sono una vera voce di speranza.
Id: 9 Data: 15/12/2007
