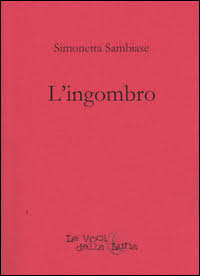Subìta e portata in un carico che va perdendo di senso, la vita un ingombro o noi un ingombro alla vita alla vita più non rispondendo? Nella piena di questa interrogazione tutta la riflessione critica di donna prima che di autrice di Simonetta Sambiase, operatrice culturale di Reggio Emilia al suo quinto libro di versi (vincitore del Premio Renato Giorgi de "Le Voci della Luna" che così l'ha editato). C'è una spina infatti negli uomini e nelle donne che fuoriescono da queste pagine, dalle piazze e dai margini di campi e stanze, che sembra interromperne il tempo nella consegna delle crepe, nel "ghiaccio sottile" di città e periferie anonime, di cuori fermi in una disintegrazione (come giustamente la definisce Maria Luisa Vezzali nella prefazione) che nell'assenza di un racconto e di una politica adeguata si fagocita nel rancore. Ecco allora in una temperie di reticenze -e di ipocrite indifferenze- l'alimento del timore tra residenze difficili e nuove provenienze, la violenza (maschile evidentemente) che si ripropone tra le generazioni in una sopraffazione che non fa differenza tra corpi delle donne e paesi. Ecco, soprattutto, la lotta contro una morte che si affaccia spesso a ricordarci quanto invecchiamo male, a partire come detto dalle comunità, dai luoghi urbani, nell'ingombro appunto di dinamiche e sentimenti che non si spiegano se non nella velocità delle cancellazioni, di identità trascorse e senza lingua, di solitudini allora nell'inganno dei trucchi e degli incontri in cui il sacro stesso rischia di perdersi nel sapore di una rassegnata rabbia ("Riposaci in pace nei tuoi miseri,/o dolce Signora"). E allora la parola che ancora può dirsi si risolve nel riflesso spezzato di una lirica che si attorciglia nelle immagini delle proprie evocazioni, delle continue ora accoglienti ora respingenti personali risonanze (secondo una prolissità come "correlativo linguistico dell'ingombro"come direbbe ancora la Vezzali), nel sospiro, nel sorso sovente amaro di versi che tentano nel corpo a corpo d'andamento prosastico che li guida quella dicitura che li rompa e con noi, con lei ci liberi da quell'impasse di malia che non ci spiega se non nel vacuo sopravvivere di mortificate passioni. Così non può non assumere un che di etico per la spinta morale che la incalza questa scrittura profondamente incarnata nelle figure di una meditazione ogni giorno alla prova di un mondo che la supera non muovendosi più su domande e dinamiche consuete. Nel disconoscimento, tutti "sperduti con la qualità della stessa fame", resta aggrappata alla terra, a dirla anche "in dialetto/ così da ricordare dove siamo", a spiegarla al figlio (o almeno a provarci) nella macchina di male "che gli si muove attorno" spesso nascosto dietro chi dovrebbe proteggerci. Perché in realtà (si veda il bellissimo testo dedicato al poeta palestinese Ashraff Fayadh) gli ultimi, i martiri, noi stessi nell'ottundimento dei nostri stessi demoni sono "la noia di questa cultura" e solo tagliarsi negli altri, può renderci, rendere onore nell'amore all'unico corpo cui siamo chiamati. Eppure, a proposito di demoni e d'amore, è nel rovello di un presente nel passato che non cancella i suoi fantasmi, che li ripropone entro nuove e insopprimibili vesti il graffo invisibile di un ingombro che va a dispiegare un secondo tempo del libro per scrittura forse anche più suggestivo perché più personale. Il riflettore infatti volgendo su se stessa riporta tutta la fatica di una donna "spaziente e stanca", seppure come da carattere nell'indice di una prossimità viva, "madre della compassione e dell'insoddisfazione" nel privato di un amore e di una casa come terra d'esilio, pronta a mordere la verità di un amore affannato ("Ho peccato di te/ che chiami casa questa patria d'ombre"). Di qui la riflessione, che si allarga a un femminile violato nelle sue aspirazioni (il matrimonio anche come fonte di sofferenza nell'atrocità dei silenzi), che si impone nel solco di una fioritura che si può rivelare piuttosto un abbassarsi di fronde di terra che reclama la sua acqua ("forse sono le mie catene che si preparano alla guerra"). Nel dubbio che ritorna nel conto del passato si impongono allora, in un discorso che probabilmente però vale per tutti, le immagini degli errori che stampandosi addosso ci accompagnano riflettendosi nelle stanze e ovunque, al di fuori, nelle strade e nelle piazze. E che nella Sambiase un occhio ancora ben vivo va a scuotere nella posa di giovani donne e giovani uomini nei naturali riti di incontri, di passioni pronte a dirsi nella freschezza di sensi ed anima ma che pure non risarcisce se è vero che nella colpa, e nella mancanza di perdono, il cuore nella sua trappola rischia la secca, o quantomeno l'insonnia così presente in questa poesia dentro notti dense di spiriti e voci dal pozzo di favole che più non sono. Nell' ironia e nell'attaccamento a un'esistenza che non fa sconti il tempo appare dunque sospeso tra un desiderio di vincersi verso i "verbi nuovi" che affacciandosi agli occhi chiamano a rompere ancora nel bene dell' amore l'ambiguità delle ripetizioni ( e "gli occhi chiamano spesso a voce alta") e la tentazione contraria nel "millennio di inutili anni" (in una vita che più non è la stessa nel vuoto del ciclone che ogni giorno ci attraversa) della consegna per sopravvivenza al "fracasso/ai difetti" di un moderno che più non ci contempla. La coscienza ci appare dunque, in conclusione, l'ingombro, la guida vera di questo dettato coinvolgente, senza infingimenti e nel pieno sempre di un'interrogazione che non affretta i passi ben salda nella consapevolezza che solo nel dar luce al proprio ascolto l'uomo può sollevare se stesso.