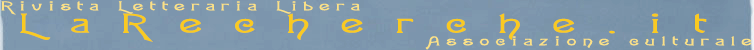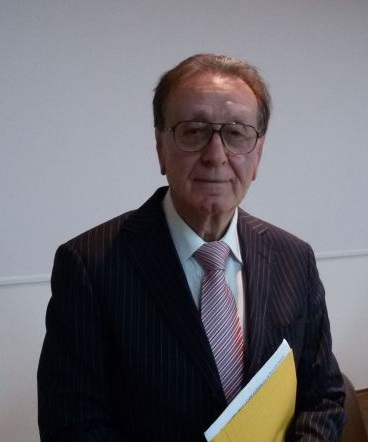Guido e Valentino Brunetti (1)
Neuroscienze, medicina e giurisprudenza
Le neuroscienze, la medicina e il diritto sono un campo di ricerca che indaga il rapporto tra il funzionamento del cervello e la norma giuridica. In particolare, questo settore cerca di analizzare l’influenza delle neuroscienze nella comprensione del comportamento umano, delle emozioni e dei processi decisionali nell’intento di salvaguardare l’integrità psico-fisica della persona. Le neuroscienze possono concorrere poi alla valutazione delle capacità di intendere e volere dell’autore del reato, fornendo utili elementi sulla struttura e il funzionamento cerebrale.
Negli ultimi anni, gli studi in materia hanno avuto un considerevole sviluppo. Alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di una “rifondazione” del diritto penale attraverso l’acquisizione delle nuove conoscenze neuroscientifiche.
La storia del rapporto tra neuroscienze, medicina e diritto, pur tra ricorrenti aspetti di conflittualità evidenzia una situazione di stretta correlazione. Per il medico, deviare dalla norma significa non tanto trasgredire una condotta giuridica, ma una norma interna alla medicina. Il punto di profonda convergenza riguarda lo stesso ethos: riconoscere a ciascun essere umano la capacità di “chiedere sia l’aiuto terapeutico che la protezione della norma” (Dalla Torre). Proteggere l’integrità psico-fisica della persona è infatti l’obiettivo fondamentale sia della medicina che del diritto.
In realtà, l’enorme sviluppo delle neuroscienze e delle scienze mediche mentre apre prospettive affascinanti solleva inquietanti problemi. L’intervento dell’uomo sulla vita umana nel contesto neurobiologico e medico incide nella sfera più profonda dell’essere e mette in questione lo statuto neurobiologico e il futuro dell’umanità.
Il timore avanzato da molti studiosi è che il potere scientifico abbia raggiunto il livello di “rottura” e possa costituire una “minaccia” per l’umanità. Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche “lecito”, per cui il progresso non è automaticamente “benefico” per l’umanità.
Sorgono in maniera prepotente rilevanti questioni etico-giuridiche. C’è la consapevolezza di un progresso neurobiologico e medico che esige con urgenza principi normativi capaci di dare indicazioni di liceità nella ricerca medica, nella diagnostica e nella terapia.
Storicamente, l’esigenza di una riflessione critica in medicina è avvertita fin dalle sue origini. “Il miglior medico è anche filosofo” è il titolo di uno scritto dei tempi di Galeno. E’ a partire dall’indagine di Socrate che la stessa filosofia si è alimentata e ispirata alla medicina e ai suoi metodi. Come potrebbe infatti il medico sapere- scrive Thibon- che cosa ha il malato dal momento che non sa che cosa “egli è”? La conoscenza scientifica non è conoscenza dell’uomo né è in grado, secondo Jaspers, di dare “direzione” alla vita. Già il medico padovano Macoppe (XVIII sec.) scrive che il medico deve cercare di essere sempre vago e prudente nel formulare una diagnosi sul decorso della malattia. Solo così egli potrà affrontare l’incertezza che caratterizza la sua azione medica e l’angoscia connessa con tale incertezza.
“Nella Tua eterna provvidenza- è la preghiera di Mosé Maimonide (1135-1204)- tu hai scelto me per vigilare sulla vita e sulla salute delle tue creature. Sostienimi in questa importante impresa affinché io possa essere di giovamento all’umanità”. Questo testo sottolinea che anche le grandi religioni storiche esprimono un’alta concezione normativa per l’attività del medico.
Ma è soprattutto oggi che si pone con grande necessità la ricerca di norme guida. Nell’ampio campo d’indagine che viene a schiudersi su questo terreno, occorre anzitutto considerare la Costituzione che ammette il principio della salvaguardia della vita, dell’integrità fisica e della salute della persona umana (articoli 2 e 32). Debbono poi richiamarsi le disposizioni che attengono alla legittimità della sperimentazione e ai trattamenti sanitari obbligatori.
Circa la sperimentazione clinica sull’uomo di nuovi farmaci è prescritto l’accertamento della loro composizione e della loro innocuità. Una importante funzione della legge è infine svolta dalle norme di deontologia professionale.
Al centro dell’attività medica si colloca il principio del consenso ai trattamenti sanitari per cui sono da ritenere illegittimi i trattamenti sanitari extraconsensuali, non sussistendo “un dovere di curarsi” se non nei limiti di cui all’articolo 32 della Costituzione.
E’ di tutta evidenza che l’indagine storica sin qui condotta sottolinea non soltanto il fondamentale rapporto tra neuroscienze, medicina e diritto, ma anche una chiara evoluzione dalla bioetica alla biogiuridica quale passaggio necessario per la ricerca di norme sicure e condivise nel contenere modalità di intervento in campo medico e neurobiologico.
Compito del diritto non è porre divieti all’attività dei medici, ma fissare limiti per orientarne la libertà e la responsabilità.
________________
(1) Dedico questo saggio alla memoria del mio amatissimo figlio Valentino, giovane avvocato penalista, coautore del testo, sottratto alla vita in maniera prematura e immediata da un destino crudele e irrazionale. (G.B.)
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore guido brunetti, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.